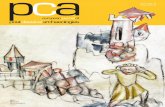Potere e rivoluzione. Antinomia del realismo ribelle
Transcript of Potere e rivoluzione. Antinomia del realismo ribelle
125
RILETTURE Potere e rivoluzione.Antinomia del realismo ribelle
La verità astratta non esiste. La verità è sempre concreta.Lenin, Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica
Allorché parliamo in termini astratti della contraddizione tra libertà e ugua-glianza o tra libertà dell’individuo e giustizia sociale, finiamo per dimenti-care che tali lotte non si svolgono nel cielo delle idee astratte. Non si tratta dilotte tra gli individui in quanto tali e la società in quanto tale, ma tra gruppidi individui facenti parte della società, ognuno dei quali cerca di promuo-vere ordinamenti sociali favorevoli e di ostacolare l’affermazione di ordina-menti sociali sfavorevoli a se stesso.
Edward Carr, Sei lezioni sulla storia
Niente si fa senza errori, e soprattutto una rivoluzione.Lev Trockij, Scritti militari
Prologo. Di sé e degli altri
«È regola elementare, ma che però molti ignorano o dimenticano, che, vo-lendo studiare un uomo, bisogna aspettare che egli non sappia di essere stu-diato»1. La «regola elementare» di Gaetano Mosca ben si capisce. Induce,nel nostro caso, a calibrare il contributo autobiografico oggetto di questo
Michele Chiaruzzi
1. G. MOSCA, Ciò che la storiapotrebbe insegnare. Scritti discienza politica, Giuffrè, Mi-lano 1958, p. 728.
Non è facile sintetizzare la personalitàintellettuale di Edward H. Carr. Secondoun’immagine convenzionale fu unpensatore realista e incline al cinismo,affascinato dal potere, dalla violenzarivoluzionaria e dalle forze oggettive chemuovono la storia, ma fu anche – aleggere con attenzione la sua opera – unutopista e un sognatore, un teorico dellasocietà che credeva nel progresso e nellaragione. Di sicuro fu – rispetto al mondopolitico-culturale a lui coevo, col qualespesso si scontrò polemicamente – unfuori posto e un ribelle, uno spiritosolitario e sovente controcorrente, unintellettuale capace di grandi intuizioni edi grandi abbagli, in grado tuttavia diri!ettere criticamente sui propri errori.
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 125
126
RIVISTA DI POLITICA 1
2. Il commento cita da edizio-ni originali e tradotte poichéscritto tra Cambridge e SanMarino. Laddove privi di rife-rimenti, i richiami sono al-l’Autobiografia di Carr. Since-ra gratitudine a Luciano Can-fora per l’incoraggiamento.3. Alcuni stralci dell’autobio-grafia sono stati resi da PieroArlorio alle pp. XXIX e XXXIdelle Sei lezioni sulla storia diCarr, tradotte da C. Ginzburgper Einaudi nel 1966. Furonoimpiegati da R.W. Davies nel-l’introduzione alla secondaedizione italiana.4. Il profilo di maggior respirosu Carr è di J. HASLAM, TheVices of Integrity, Verso, Lon-don 1999. Appena precedenteè lo studio di C. JONES, E. H.Carr and International Rela-tions, CUP, Cambridge 1998,che ne affronta la teoria inter-nazionale. M. COX (a cura di),E. H. Carr. A Critical Apprai-sal, Basingstoke, Palgrave2000, include un saggio di S.WHITE, The Soviet Carr, sul-l’impedita ricezione di Carr inUnione Sovietica, prima, e laquasi indifferenza nella Fede-razione Russa, dopo. Valevolebibliografia è in E. H. CARR,Utopia e realtà. Un’introdu-zione allo studio della politicainternazionale, a cura di A.CAMPI, Rubbettino, SoveriaMannelli 2009, cui si ri-manda.5. Salvo che per passaggi auto-biografici sparsi e diffusi, sonoaltri due i luoghi principali incui Carr si racconta: l’intervi-sta con R. GOTT, E. H. Carr’sRussia, in «The Guardian»,November 25, 1978, p. 9 e E. H.CARR, The Russian Revolutionand the West, in «New Left Re-view», I/111, 1978, pp. 25-36.6. s. COLLINI, E. H. Carr: Hi-storian of the Future, in«Times Literary Supple-ment», March 5, 2008, giudi-zio temperato in ID., CommonReading, OUP, Oxford 2009,p. 156.
commento2. Qui l’uomo non è semplicemente dagli altri studiato ma da sé di-rettamente si studia. Questo genere storiografico riguarda un processo mne-monico specifico che implica, in modo peculiare, lo sforzo del ricordo, diavere presente nella memoria. Appoggiandosi così alla memoria, ne puòsfruttare o subire le caratteristiche essenziali com’è la creatività. La memoriaè appunto creativa. In difetto di dati, li crea. Rammentarlo è un precetto va-levole anche nel caso dell’Autobiografia scritta da Carr (1892-1982) due anniprima di morire, qui tradotta e commentata per la prima volta nel nostro
idioma3. Non va dunque trascurata la preliminareavvertenza, per i volenterosi, di vagliare quel chegli altri, i biografi, hanno scritto di Carr4. Ciò ser-virà anche a correggere questo commento. Essotraccia quel che egli disse di sé, attingendo oltrel’Autobiografia e affrontando un tema che attra-versa la vicenda di questo studioso: l’antinomia frapotere e rivoluzione5.La sua fu peraltro un’esistenza memorabile, am-messo che non tutte lo siano. Diplomatico per ilRegno Unito (1916-36), professore di politica in-ternazionale in Galles (1936-47), vicedirettore ededitorialista del «Times» (1941-45), infine, dopoanni di ricerca indipendente, storico a Oxford(1953-55) e poi Cambridge: uomo di lettere e stu-dioso di politica per la vita. «Uno dei più impor-tanti intellettuali britannici del ventesimo secolo»,è stato scritto6. Il «primo vero storico del regimesovietico»7. È interessante, vent’anni dopo la finedell’Unione Sovietica, ripercorrere una vita coevaa quella complessa e tesa vicenda. Al suo studio si-stematico Carr si avviò ormai ultracinquantenne
nel 1944, terminando, nel 1977, all’età di 86 anni, il quattordicesimo e ultimovolume della Storia della Russia sovietica, magnum opus fra altre minori8. Èoggi utile ascoltare un uomo che, con tale dedizione, cercò di scrutare in pro-fondità i lunghi albori di quella storia, vivendo appieno il corso tumultuosodella sua epoca con gli uomini che ne furono parte. È un mondo singolare,così vicino, così lontano.
Rivoluzioni e celebrazioni
Il 22 aprile del 1970 Giorgio Napolitano era al teatro Eliseo. Si svolgeva,gremitissima, la seduta pubblica del Comitato centrale e della Commis-sione di controllo del Partito comunista italiano. L’occasione era solenne,dedicata alle celebrazioni del centenario del «teorico e artefice della primagrande rivoluzione socialista», Vladimir Il’i Ul’janov detto Lenin. Si trat-tava di varie iniziative, «nessuna delle quali può essere intesa come un mec-canico adempimento di un obbligo rituale». «Non celebriamo un rito»,disse l’oratore. Citò dunque «esigenze di maturazione e di chiarezza, sete diconoscenza, volontà di confronto» e «un atteggiamento positivo di ricerca».Di Lenin ricordò «la sua vita, la sua attività di elaborazione e direzione»,
7. I. DEUTSCHER, Heretics andRenegades, Hamilton, London1955, p. 94.8. E. H. CARR, History of SovietRussia, 14 voll., Macmillan,London 1950-1978; trad. it.Storia della Russia sovietica,4 voll., 10 tomi, Einaudi, To-rino 1964-1984, vol. I. Com’ènoto, la versione italiana diquest’opera segue una diversascansione da quella inglese.Consiste di 6175 pagine resenel corso di un ventennio daundici traduttori. Il titolo è in-gannatore, coprendo l’opera,in verità, un momento e untema della storia della Russiasovietica invece immediata-mente restituito dal titolodella sintesi successiva: TheRussian Revolution. FromLenin to Stalin (1917-1929),Macmillan, London 1979;trad. it. La rivoluzione russa.Da Lenin a Stalin (1917-1929), Einaudi, Torino 1980.
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 126
127
RILETTURE
9. G. NAPOLITANO, L’insegna-mento di Lenin nell’esperienzae nella prospettiva del PCI, in«Critica marxista», Quadernin. 4, 1970, p. 3.10. Il giudizio su Aron è di A.PANEBIANCO, Raymond Aron,in «il Mulino», a. LX, n. 455,2011, p. 511; la citazione com-parve su «La Stampa» del 23aprile 1970 a p. 14.11. Cfr. E. H. CARR, Storia dellaRussia sovietica, cit., vol. I, pp.25-26. 12. B. KNEI-PAZ, Trockij: rivo-luzione permanente e rivolu-zione nell’arretratezza, in Sto-ria del marxismo, progetto diE. J. HOBSBAWM, G. HAUPT, F. MA-REK, E. RAGIONIERI, V. STRADA, C.VIVANTI, 4 voll., Torino, Einau-di 1980-1982, vol. III, p. 133.13. L. CANFORA, La madre dellaverità, in M. AYMARD, L. CAN-FORA, G. GALASSO, A. PROSPERI,C. VIVANTI, Historía. Saggi pre-sentati in occasione dei ven-t’anni della Scuola Superioredi Studi Storici, Aiep, San Ma-rino 2010, p. 57. 14. Cit. in J. HASLAM, ‘We Needa Faith’. The Historian E. H.Carr, in «History Today», vol.33, n. 8, 1983, p. 36.15. M. M. LITVINOV, Note for aJournal, A. Deustch, London1955; trad. it. Cremlino segreto,Mondadori, Milano 1956, p.19. Carr ebbe ragione, consen-tendo il giudizio di R. SCHLE-SINGER, Litvinov’s Ghost, in«Soviet Studies», vol. 7, n. 4,1956, pp. 373-83. Pare poi sipentì d’aver associato il suonome a quel documento; cfr. E.S. DANIELSON, The Elusive Lit-vinov Memoirs, in «Slavic Re-view», vol. 48, n. 3, 1989, p.482. Il passo è discusso in L.CANFORA, La storia falsa, Riz-zoli, Milano 2008, p. 124.
nonché «le sue letture filosofiche e teoriche». Ne facevano, a suo giudizio,«una grande, straordinaria figura del socialismo europeo e della culturaeuropea»9.Dalle colonne di «Le Figaro» un interprete di questa cultura, Raymond Aron,«autore dallo stile indisponente per gli spiriti semplici», celebrava anch’eglima a suo modo: «Ha gettato le fondamenta di una società nuova; ma l’edifi-cio non rassomiglia all’immagine che ne aveva disegnato il suo primo archi-tetto»10. Edward Carr studiò per un trentennio della sua vita quasi secolarequelle fondamenta, gettate appunto da un uomo considerato di «irripetibilegrandezza» e «immenso sapere». «L’uomo dell’azione», grande soprattutto«come stratega politico e tattico politico», spinto ad annotare, nel novembre1917, che è «più conveniente ed utile fare l’“esperimento della rivoluzione”che scrivere su di essa»11. Carr, da parte sua, non poté e non volle altro chesolo scrivere di quell’esperimento. Lo fece però con tale laboriosità e passioneda lasciare egli stesso un imponente esito, le 6175 pagine della Storia dellaRussia sovietica, «la più importante opera sulla rivoluzione russa e i suoi svi-luppi»12. È forse alla passione che tale mole d’impegno deve molto. D’altrondela mancanza di questo sentimento non giova al lavoro dello storico bensì loaggrava. «L’atarassia senza passioni non è la migliore, ma forse la peggiorecondizione per scrivere storia»13.Oggi la storia «viva» dell’esperimento sovietico è terminata da un ventennio.Carr ne fu profondamente affascinato e a momenti finanche suggestionato ingioventù, perlomeno a giudicare da alcune delle sue parole autobiografiche:«Ascoltavo Litvinov a Ginevra, ammirando la sua denuncia dell’ipocrisia oc-cidentale sul disarmo […] ed ero completamente prosovietico». Aveva tro-vato quella fede che nel 1930, durante la grande depressione, rivendicavacome necessaria, a fronte della crisi del sistema capitalista:
Non abbiamo altre convinzioni che un vago fatalismo. Dovremmo ri-cominciare a credere in noi stessi, trovare dottrine meritevoli d’esser di-fese, cause meritevoli d’esser combattute, missioni meritevoli di com-pimento. Il fascino dell’indifferenza e il culto della futilità soccomberanno;e noi cesseremo d’essere disfattisti. Ma nel frattempo abbiamo bisognod’una fede, o in ogni caso un feticcio passabile14.
Mai perse tuttavia il rigore dello studioso e il senso ultimo della sua impresa,quando, negli anni, maturò la sua missione: la conoscenza. Proprio nell’in-troduzione al diario del diplomatico sovietico ciò ben si rivela: «Nonostantele perplessità che suscita, questo documento è degno di pubblicazione. Seb-bene contenga passaggi che sono sicuramente spurii, è giusto che sia pub-blicato nella sua integrità, affinché sia possibile, al lettore dotato di sensocritico, giudicarlo»15.Cercò dunque di comprendere l’esperimento sovietico e penetrarlo nei suoimeandri, rischiando, come uomo e come storico, anche odio e ostracismo.Da «barone rosso» a «eminenza sinistra»: sono stati pure questi gli epiteti ri-voltigli, vivide espressioni di sentimenti acuti e violenti, emersi dalla coltredelle buone maniere inglesi. Mossi infine per colpirne non solo l’esistenzama anche la memoria, trascinata nell’agone della lotta politica con altri mezzi.Fu questo il caso della polemica scatenata da una dilaniante recensione ap-parsa il 10 gennaio 1983, circa un anno dopo la sua scomparsa e all’appros-
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 127
128
RIVISTA DI POLITICA 1
16. Cfr. N. STONE, Grim Emi-nence, in «London Review ofBooks», vol. 5, n. 1, pp. 3-8, e lesette lettere di replica succe-dutesi fino al 5 maggio succes-sivo. Stone, professore a Cam-bridge, fu consulente dellaThatcher.17. E. J. HOBSBAWM, lettera alla«London Review of Books»,vol. 5, n. 3, 1983. Vi è un giu-dizio anteriore di Carr sul la-voro di Needham: «Quella cheprobabilmente verrà conside-rata la maggiore opera storicacomposta a Cambridge nell’ul-timo decennio, è stata scrittadel tutto al di fuori del dipar-timento di storia, e senza rice-vere da esso alcuna assistenza»;E. H.CARR, Sei lezioni sulla sto-ria, cit., p. 161.18. Tugnolo è oggi autore di E.H. Carr al «Times» durante laseconda guerra mondiale, in«Storia e problemi contempo-ranei», n. 36, 2004, pp. 127-48,e di La Gran Bretagna, la guer-ra mondiale e l’Europa. E. H.Carr editorialista del «Times»,in «Contemporanea», n. 2,2004, pp. 247-62.19. Cfr. I. MONTANELLI, Ilgrande storico e giornalistaEdward H. Carr, in «Corrieredella Sera», 14 marzo 2001, p.41 e ivi la lettera di Tugnolo. 20. G. NAPOLITANO, L’insegna-mento di Lenin nell’esperienzae nella prospettiva del PCI,cit., p. 12.21. P. TOGLIATTI, Gramsci, Edi-tori Riuniti, Roma 1967, pp.160-1.22. Pensato per il lettore co-mune e a mo’ d’introduzionedell’History of Soviet Russia,questo libro di 231 pagine nonè, a ben intendere, una merasintesi dell’opera maggiorepoiché, spiega Carr, «la diffe-renza di dimensioni e scopi si-gnifica che si tratta di un’operasostanzialmente nuova. Ben dirado una frase del testo origi-nario ricompare immutata inquesto lavoro»; E. H. CARR, Larivoluzione russa, cit., p. IX.
simarsi delle elezioni, poi sbaragliate da Margaret Thatcher16. Sarà allora, inuna lettera in risposta a quell’«esercizio di prosa diffamatoria», prorotta daicomposti ambienti di Cambridge, che Eric Hobsbawm definirà la Storiacome «l’impegno più notevole di erudizione storica intrapreso da un singoloin Gran Bretagna a memoria d’uomo», paragonabile a Science and Civilisa-tion in China di Joseph Needham17.Proprio a proposito di quelle e altre polemiche un giovane laureando pisano,Emiliano Tugnolo, scrisse a un ex-studente a Cambridge di Carr: Indro Mon-
tanelli18. Nel «Corriere della Sera» Montanelli sidisse ignaro e stupito di quelle polemiche, sensa-tamente attribuite all’«invidia che la cultura acca-demica doveva nutrire per questo suo confratelloche sapeva, come nessun altro, avvincere il let-
tore». Tra alcune naturali semplificazioni, convinto che «la sua propensionee formazione erano quelle di un liberal-conservatore», egli parlò da lettoredella Storia carriana «nelle sue grandi linee, intatta e intangibile», fondatasu «ricostruzioni definitive, sulle quali non ci sono “revisionismi” da ope-rare». Carr, a suo parere, aveva dimostrato «di capire i motivi che avevanoprovocato la rivoluzione bolscevica e le speranze che aveva suscitato la suainiziale edizione leninista»19.Nel teatro romano di via Nazionale, durante le celebrazioni del centenario diLenin, Napolitano volle allora soggiungere: «Più ancora, guardando oggi aquel che l’opera di Lenin ha rappresentato nello sviluppo storico dell’uma-nità, non se ne può non cogliere la dimensione universale». L’esplicito ri-chiamo fu alle celebri parole di Togliatti, tratte da «uno dei suoi scritti piùalti»20: «L’opera di Lenin ha mutato il corso della storia, ha aperto un’eranuova nello sviluppo degli avvenimenti mondiali. Tale è la realtà. L’opera diLenin deve essere collocata, analogicamente, sullo stesso piano su cui si puòcollocare l’opera della Rivoluzione francese. Dopo la Rivoluzione francese ilmondo cambia; cambia il modo di pensare degli uomini. Anche dopo Leninil modo di pensare degli uomini cambia. Dopo Lenin noi pensiamo tutti inmodo diverso da come pensavamo prima»21.Per Carr fu esattamente così. Quel momento gli trasmise, lui dice nell’Auto-biografia, «un senso della storia che non ho mai perduto e che mi trasformò,molto tempo dopo, in uno storico». A rigore, dunque, la rivoluzione produrràil suo storico; il quale, come Togliatti, pose quell’analogia a incipit e bilanciodel sommario della sua «storia grande», come chiama la Storia della Russiasovietica per distinguerla dalla seguente riduzione nella Rivoluzione russa22:«La rivoluzione russa del 1917 ha costituito una grande svolta storica, e saràprobabilmente considerata dagli storici futuri come il massimo avvenimentodel secolo XX. Come la rivoluzione francese, essa continuerà ancora a lungoa essere oggetto di giudizi nettamente contrastanti: salutata da alcuni comepietra miliare dell’emancipazione umana dall’oppressione passata, e denun-ciata da altri come crimine e catastrofe»23.Lenin, capo della rivoluzione proletaria e dello stato sovietico, creatore dellaTerza Internazionale, incarna appunto per Carr «l’unione di una fondamen-tale semplicità di idee e di carattere con il fanatismo ideologico e l’estrema de-cisione al momento dell’azione [che] ricorda molto da vicino Robespierre».Ma costui non è solo «un grande rivoluzionario», al pari del francese cui è pa-ragonato. È «forse il maggiore di ogni tempo»24.
23. Ibidem, p. 3. 24. E. H. CARR, Storia dellaRussia sovietica, vol. I, cit., pp.25-26.
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 128
129
RILETTURE
25. E. H. CARR, Storia dellaRussia sovietica, cit., vol. IV,tomo 6, p. XI.26. E. H. CARR, La rivoluzionerussa, cit., p. IX.27. Cit. in J. HASLAM, E. H.Carr and the History of SovietRussia, in «The HistoricalJournal», vol. 23, n. 4, 1983, p.1023. Cfr. J. JOLL, Gramsci,London, Fontana 1977.28. H. J. MORGENTHAU, The Po-litical Science of E.H. Carr, in«World Politics», vol. 1, n. 1,1948, p. 134.29. E. H. CARR, Utopia e realtà,cit., p. 94.30v Cfr. E. H. CARR, From Na-poleon to Stalin and other Es-says, Basingstoke, Palgrave2003, p. 183.31. R. NIEBUHR, Nations andEmpires, Faber and Faber,London 1959, p. 131.32. La definizione è ispirata daL. CANFORA, Totalità e selezionenella storiografia classica, La-terza, Bari 1972.
C’è però un fatto che muove una riflessione ulteriore. Se le due rivoluzioni ei suoi protagonisti sono eventi comparabili, incomparabile è invece per Carril lavoro dello studioso che all’epoca vi si dedica: «Nessun tentativo di scri-vere la storia della rivoluzione francese fu seriamente compiuto prima chefosse trascorso mezzo secolo da quell’avvenimento». Egli non attese quel cin-quantennio che gli studiosi dell’altra rivoluzione aspettarono. Da qui unaconsiderazione apparentemente vacillante, legata alla magnitudine di scri-vere tale storia del presente: «La mia impresa è stata forse temeraria»25.Come che sia, del processo storico che segnò l’ascesa e il declino dell’UnioneSovietica, Carr, ucciso da un cancro, non conobbe l’esito. Non seppe della vi-cenda finale di una grande potenza che, coinvolta in un conflitto egemonico,avrebbe sorpreso ancora il mondo, consegnando alla storia un epilogo im-previsto: la resa pacifica. Per lui la conclusione della storia sovietica resterà«avvolta nelle nebbie del futuro»26.
Un realista ribelle?
James Joll, studioso attratto da Gramsci, ebbe a definire Carr «il nuovo Ma-chiavelli»27. È questa un’associazione che, ogni volta piegata alle intenzioni dichi la propone, ricorre con tutta la sua carica d’ambiguità. Hans J. Morgen-thau la mosse a parziale diminutio di Carr. Per lui, interessato al Carr teoricodella politica, s’era a tal punto arrischiato sull’irta strada del realismo dalsembrargli, infine, un «Machiavelli senza virtù»28. Formula memorabile epenetrante, discutibile, e tuttavia testualmente ponderata. Fu difatti Carrstesso a porre le lezioni ricavate dal fiorentino come «pietre angolari» delsuo trattato sul realismo politico nelle relazioni internazionali, un corrosivobestseller di grande circolazione29.Quel realismo, nelle sue mani, doveva essere l’antidoto alle patologie del po-tere, incluse quelle celate dalla più invisa a Carr tra le ideologie e le dottrine:il liberalismo conservatore e il principio del laissez faire. Considerati i prin-cipali responsabili della crisi del suo tempo, innescata dall’anarchia del ca-pitalismo, essi erano latori di un’antitesi fra libertà e pianificazionesocio-economica che egli giudicava falsa30. Eppure gli effetti di quell’antidotoagiranno, quando agiranno, con variabile approssimazione nel pensiero diCarr, deviati da quella spinta che, a voler seguire il capzioso e durevole para-gone fra i due, porta Carr ad assomigliare al Machiavelli del Niebuhr: un«realista ribelle»31.In effetti, l’Autobiografia restituisce i tratti salienti di una vicenda personalemovimentata non solo dagli eventi straordinari che attorno ad essa accade-vano, bensì da una caratteristica intrinseca di quella personalità: la «sensa-zione d’essere uno fuori posto, un pesce fuor d’acqua».Fuori posto è Carr a Cambridge, durante gli studi classici di storia anticagreca e romana al Trinity College. Da quegli anni sorge il ricordo di momenticruciali che affiorano nelle sue note. Uno di questi completa la «rivelazioneaffascinante» su totalità e selezione nella storiografia, allora vissuta e svelatanell’Autobiografia32. Esalta, chiarendola, l’acquisizione successiva dello stu-dioso maturo sul relativismo storiografico, i cui prodromi s’annunciano al-lora, inattesi, ai tempi in cui affrontò «quindici o venti libri» sulle guerrepersiane: «Non mi capitò mai di chiedermi per quale caso, o per quale pro-
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 129
130
RIVISTA DI POLITICA 1
33. E. H. CARR, Sei lezioni sullastoria, cit., p. 17.34. L. CANFORA, La storia falsa,cit., p. 54, nota 33.35. Dostoevsky, 1821-1881. ANew Biography, Allen &Unwin, London 1931; The Ro-mantic Exiles. A NineteenthCentury Portrait Gallery, Vic-tor Gollancz, London 1933;Karl Marx. A Study in Fana-ticism, J. M. Dent, London1934; Michael Bakunin, Mac-millan, London 1937; trad. it.Bakunin, RCS Libri, Milano2002.36. Cit. in R. W. DAVIES, Dallecarte di E. H. Carr, in E. H.CARR, Sei lezioni sulla storia,cit., p. XXVI.37. E. H. CARR, Michael Baku-nin, cit., p. 435 e ID., From Na-poleon to Stalin, cit., p. 52, incui a p. 155 si legge anche unbilancio critico sulla «leg-genda di Bukharin», trattatocome figura avulsa dalle con-crete durezze della rivoluzionee della guerra civile e dunqueattraente perché accettabile, eaccettabile proprio perché in-nocuo. A differenza d’ogni al-tro bolscevico ha «un registroperfettamente pulito, perchéperfettamente vuoto. Indossasolitario l’aureola dell’inno-cenza».
cesso di selezione, quei fatti particolari erano sopravvissuti tra la miriade difatti che un giorno avevano dovuto essere noti a qualcuno, fino a diventare ifatti della storia. Ho il sospetto che ancora oggi uno dei motivi di fascino dellastoria dell’antichità e del Medioevo consista nel fatto di dare l’illusione chetutti i fatti storici siano a nostra disposizione e facilmente raggiungibili: l’ir-ritante distinzione tra i fatti storici e gli altri fatti del passato scompare, inquanto i pochi fatti a noi noti sono tutti fatti storici»33. È quella che LucianoCanfora ha chiamato «l’illusione dei modernisti, che nella storia antica siatutto chiaro»34. Il che, nella storia, non è quasi mai.Fuori posto è Carr al Foreign Office. Nel 1916 vi accede, appena ventiquat-trenne. Tre anni dopo è nella delegazione inglese delle conferenze di pace diVersailles e in quelle interalleate successive. Poi, nel ’20, a Parigi, segretarioall’ambasciata britannica. Diplomatico di carriera dal novembre del ’21, inquattro anni diventa secondo segretario in Lettonia, incaricato d’affari nel’26 e nel ’28 a Riga. Lì si riverbera, in vari riflessi, il suo «esprit de contra-diction» – come lo chiama. Spirito che ravviva il suo rifiuto di credere, con lamaggioranza, che la rivoluzione – quell’esplosione imprevista e incompresadai più – «fosse un fuoco di paglia e che i bolscevichi non potessero durarepiù di una settimana o giù di lì – finché i rinforzi sarebbero arrivati». Intui-sce imprecisamente la sfida portata da quegli eventi, ma tanto gli basta pergiudicare la reazione ad essi come «ottusa, cieca e stupida». È allora, lavo-rando al servizio diplomatico di Sua Maestà, bastione del tradizionalismobritannico, che ha esperienza del «mondo orientale» e gradualmente si av-vince al profilo della figura che durevolmente lo affascinerà: il ribelle.È interessato da coloro che non si lasciano vincere dall’ordine delle cose, at-tratto dal moto umano che per lui s’incarnerà negli intellettuali russi dell’800«i quali non erano per nulla rivoluzionari in alcun senso stretto». Volgendosialla sua educazione classica e ai suoi primi scritti si può dire che Carr sia plu-tarcheo. Come lo scrittore di Cheronea anch’egli abbraccia il genere biogra-fico. Nello studio dell’esistenza individuale, di cui il personale e il privatosono elementi rivelatori, e quindi essenziali, riposa la base della sua sensibi-lità all’uomo, cioè ai limiti e alle fragilità personali. Sensibilità che, alla fine,è forse il tratto imperituro e fondamentale del suo lavoro storiografico e delsobrio confronto con quella vicenda umana detta politica. In sua assenzamanca vera comprensione storica perché latita una consapevolezza: è infinel’uomo in azione l’unità analitica fondamentale del tempo in divenire, a luiignoto nel procedere e a tutti sempre parzialmente celato lungo i misteriosipercorsi che segnano l’intrattabile realtà della politica.Così, per sei anni, tra il ’31 e il ’37, scrive di vite parallele che sono quelle diDostoevskij e Herzen, Marx e Bakunin35. Se dice dei primi due come «gli au-tori che mi hanno influenzato più profondamente», pur col primato di Do-stoevskij, svela però il ripudio per quei latori di «una “poesia malata”», comeHousman e Eliot, i quali, ai suoi occhi, tramandano l’improprio abbandonodell’uomo al destino, corroborando un principio di pessimismo e dispera-zione di cui anche Orwell sarà maestro, e sono perciò considerati esemplar-mente: «Nessuno dei due è un ribelle»36.Ribelle è invece colui al quale si mostra più affezionato, l’anarchico Bakunin,«in teoria il più fanatico sostenitore della libertà e l’individualista più inte-grale che sia mai vissuto», ovvero «il più grande tra tutti i rivoluzionari russiprima di Lenin»37. Costui resta, indelebile, a segnare la memoria di Carr at-
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 130
131
RILETTURE
NI, Common Reading, cit., cap.12, ultima d’innumerevoli si-mili.42. E. H. CARR, Studies in Re-volution, Macmillan, London,1950.43. J. HASLAM, Introduction, inE. H. CARR, From Napoleon toStalin, cit., p. XVIII.44. I. B. (Isaiah Berlin), recen-sione di Studies in Revolution,in «International Affairs», vol.27, n. 4, 1951, pp. 470, 471. 45. M. COX, Introduction, in E. H.CARR, The Twenty Years’Crisis,1919-1939, Palgrave, Basin-gstoke 2001, p. XLIII, liquidaWight come «un conservatorenient’altro che ostile a Carr».Qualsiasi cosa intenda, per leelezioni politiche britannichedel 1950, ossia l’anno prece-dente a questo scritto, Wight re-dasse un testo manoscritto, rin-venuto da chi scrive, di cui ri-mangono quattro cartelle con-fuse tra le sue carte e recanti unsemplice titolo: «Come votare,1950». Il «riepilogo provviso-rio» [tentative summary] di uncomplesso e articolato ragio-namento, peraltro tipico di que-sto studioso, è significativo nel-la sua schematizzazione finale:«1. In base a un principio mec-canico: vota Labour; 2. In basea un principio morale: vota Li-beral; 3. In base a un principioescatologico: vota Liberal».Ugualmente indicativa è una ta-bella a doppia entrata, succes-siva, che registra tre «pro» e sei«contro» a un voto conserva-tore. Di questi ultimi, due sonoimmediatamente indicativi:«Nessuna reale differenza conla politica economica del La-bour, spesa e livello di tassa-zione»; «subdolo scivolamentoverso gli interessi dell’industriae contro gli interessi della clas-se operaia». Il sesto punto è de-terminante per un uomo comeWight: «Perdita definitiva diautostima». Cfr. M. WIGHT, Howto vote, 1950, s.d., Wight Pa-pers/59, British Library of Po-litical & Economic Science, p. 4.
traverso il volume che fu giudicato «la miglior biografia di Bakunin finoradisponibile»38. Il suo autore lo ricorda nitidamente, parlando due anni primadi stendere l’Autobiografia: «Il libro non vendette, eppure direi che in uncerto senso fu il migliore che abbia mai scritto. Era un uomo molto interes-sante. Ascolterò sempre qualsiasi cosa su Bakunin. Non ha alcun seguito inquesto paese. Persino nel periodo in cui l’anarchismo attraeva un certo inte-resse, era sempre verso Kropotkin, quell’uomo così noioso»39.È proprio in questo libro che Carr sceglie d’esaltare, in epigrafe, un passo delleConfessioni bakuniane inviate a Nicola I di Russiadalle prigioni della fortezza di Pietro e Paolo, pro-gettata dal Trezzini. Sono dunque parole che eglimedita particolarmente. «C’era nella mia naturaun difetto capitale: l’amore del fantastico, delle av-venture straordinarie e inaudite, delle imprese sve-lanti orizzonti illimitati e di cui nessuno puòprevedere l’esito»40. In questa citazione forse sirapprendono i rivoli di paradossi e contraddizioniche attraversano, più che la biografia del bolscevicoanarchico, quella dell’«intellettuale come realista»cui Carr è stato associato fino ai tempi nostri41.Fu anche un celebre nativo della Riga che a Carrdiede il primo contatto con il «mondo orientale» aparlare di quel realismo. «I. B.» si firmerà, recen-sendo gli apprezzati studi carriani sulla rivoluzione,portatori di «chiarificazione storica» dalla portata«quasi unica nel mondo di lingua inglese»42. Costuiera Isaiah Berlin che soggiungeva: «Il signor Carrnon lascia dubbi sulla sua scelta. Malgrado il freddogiudizio e la scrupolosa erudizione, egli non è solointeressato ma profondamente incantato da coloroi quali comprendono la natura del potere e sannocome lottare per ottenerlo e come usarlo quando l’hanno ottenuto, i Welthi-storisch individui che fanno la storia; e prova una correlata mancanza di sim-patia verso quelli che, causa il fallimento del carattere e dell’intelletto, cadononella corsa, o, ancor peggio, neppur l’iniziano, oppure, di tutto più grottesco,s’allontanano al galoppo in direzione sbagliata».Si tratta, in altri termini, della sua «sensibilità alla trascendenza del poterenella politica»43. L’osservazione che, per l’appunto, preme a questo studiosochi «fa la storia» – qualunque cosa ciò significhi – e non chi la subisce; ma perchi non trascura la versione elitistica della vicenda umana, la storia è anche,forse soprattutto, storia di minoranze che comandano su maggioranze e diqueste minoranze, presto o tardi, il cimitero.Una chiosa di Berlin spostava però, radicalmente, l’asse di discussione suCarr: «Non è mai contrario a stendere un manto protettivo sugli estremisti,per quanto maldestri o folli li possa ritenere»44. È questo un giudizio che atratti rimanda a un commento appena precedente di Martin Wight. Era voltoa discutere The New Society, libro in cui Carr, ricorda lui stesso, affrontava perla prima volta «la natura della storia e la relazione del passato col presente».A differenza di Berlin, Wight non era uomo ostile45. «Il signor Carr sostieneun argomento di vecchia data, tuttavia d’un rilievo morale fondamentale,
38. M. KARPOVICH, Carr: Mi-chael Bakunin, in «The Ame-rican Historical Review», vol.44, n. 2, 1939, p. 381. Idemsentire per G. STRUVE, Reviews,in «The Slavonic and East Eu-ropean Review», vol. 16, n. 48,1938, pp. 726-28.39. Cit. in R. GOTT, E. H.Carr’sRussia, cit. Significativo è ilgiudizio argomentato da Carrin From Napoleon to Stalin,cit., p. 127. Riconosce a Kro-potkin «sincerità, devozione eperseveranza» ma infine lo ri-tiene «un leone domato, un redella giungla addomesticatodall’Inghilterra vittoriana»,uomo tutto sommato «lieve-mente fatuo, un signor Chee-ryble della rivoluzione. La suastatura è in qualche modo noneroica ma domestica. An-drebbe ritratto […] coi coloridi Dickens, non quelli shake-spiriani».40. Cit. in E. H. CARR, Bakunin,cit., p. 7.41. È la definizione di S. COLLI-
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 131
132
RIVISTA DI POLITICA 1
46. M. WIGHT, Problems ofMass Democracy, in «The Ob-server», September 23, 1951,p. 7.47. E. H. CARR, The Russian Re-volution and the West, cit., p.33. 48. Cit. in R. GOTT, E.H.Carr’sRussia, cit.49. M. WIGHT, Problems ofMass Democracy, cit. Il riferi-mento a Hitler non è malevoloo casuale. È questo un contoaperto tra Carr e i suoi criticiche chiarisce lui stesso nel-l’Autobiografia, concludendo:«Penso fu non prima del 1938,dopo l’occupazione dell’Au-stria, che iniziai a pensare aHitler come a un serio peri-colo. Ero assai cieco, non v’èdubbio».50. Così ne dà sintesi A. CAMPI,Introduzione, in E. H. CARR,Utopia e realtà, cit., p. VII.
quando afferma che per più di un secolo i lavoratori hanno imparato dallaclasse media che gli uomini lavorano solo per fini materiali egoistici e nonper il bene della società, e che se disoccupazione e privazione sono usi legit-timi della “frusta economica” del datore di lavoro contro il lavoratore, alloralo sciopero, lo sciopero bianco e l’assenteismo sono legittimi per il lavoratorecontro il datore»46.È in parte ciò che ribadirà Carr trent’anni dopo: «Non riesco comunque aconsiderare il proletariato occidentale, la progenie del capitalismo borgheseoccidentale, come latore della rivoluzione mondiale nel suo prossimo stadioe, a questo riguardo, presumo di non essere un marxista». Per lui era chiaroche «oggi [1978], in Occidente, il proletariato – nell’accezione marxiana deltermine, ossia gli operai organizzati dell’industria – non è rivoluzionario, eforse costituisce una forza addirittura controrivoluzionaria»47. L’esito era evi-dente: «L’intero sistema sindacale è integrato nel sistema capitalista. È indissidio coi datori di lavoro nel sistema perché vuole una parte maggiore deiprofitti. Non vuole danneggiare i profitti»48.La perplessità di Wight riguardava piuttosto il rapporto di Carr con la di-mensione del tempo storico, oggetto d’attenzione in quel volume. Nel suo«interesse clinico» per la storia, pensava Wight, nulla restava delle tensionifra passato e futuro. Alludeva alla zelante spinta verso il futuro della filoso-fia carriana e, con ciò, muoveva in punta di metafora una critica che sembraannunciare quella di Berlin, già riportata: «[Carr] non si domanda quantodel carico e dell’equipaggio sia necessario mantenere a bordo per giustificareil viaggio. Il viaggio è tutto, e ad ogni modo ora è in corso. “Non so perché lostiamo facendo”, disse Hitler una volta, “so solo che devo farlo. Si perde ilpassato e si conquista il futuro”»49.Così, il realismo senza aggettivi attribuito a questo liberale vittoriano, pro-fondamente ottimista e fautore di un «radicalismo democratico-progressi-sta»50, trascura il «difetto capitale» del realista ribelle. La sua rivolta soventetracima proprio contro quel principio di realtà ancorato all’«essere», al «sem-pre così». Avanza con decisione un principio di progresso che attinge ancheal regno delle idee. Propone un «dover essere» che non è tecnico-pragma-tico ma che di volontà trascende o piega la necessità e, con essa, il suo corol-lario operativo, la prudenza. Carr non è alieno da quella prospettiva diemancipazione che certo canone realista considera astrusa. Al contrario: lastoria si può costruire e anzi va costruita con ragione.Spicca un passaggio contro la «cauta concezione conservatrice» di KarlPopper, nella cui prospettiva «la posizione della ragione corrisponde, difatto, piuttosto a quella di un funzionario dell’amministrazione statale in-glese». «Anch’io, ai miei tempi, ho lavorato nell’amministrazione statale»,ricorda Carr.
Ma questa subordinazione della ragione alle condizioni poste dall’ordineesistente mi sembra, a lungo andare, del tutto inaccettabile. Non è inquesti termini che Acton pensava alla ragione, allorché proponeva l’equa-zione rivoluzione = liberismo = regno delle idee. Nella storia umana ilprogresso […] si è attuato fondamentalmente grazie all’audacia e allatempestività di individui che non si limitavano a cercare d’introdurremiglioramenti qua e là, ma avanzavano in nome della ragione conte-stazioni radicali dell’ordine esistente e dei suoi presupposti espliciti o
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 132
133
RILETTURE
51. Cit. in R. GOTT, E. H.Carr’sRussia, cit.52. M. WIGHT, Problems of MassDemocracy, cit. T. DEUTSCHER,E. H. Carr – A Personal Me-moir, in «New Left Review»,I/137, 1983, p. 5, confermerà:«Non era un riformista». Quel«futurista» s’intende come«chi guarda avanti»; viceversa,sarebbe parola malposta perchi rimanda le sue influenze inprimis al Dostoevskij ripudiatoda Burljuk, Kru ënych, Ma-jakovskij e Chlebnikov nelloSchiaffo al gusto corrente delleavanguardie futuriste del 1912:«Gettare Pu!kin, Dostoevskij,Tolstoj, ecc. ecc. dal VaporeModernità»; cit. in S. VITALE (acura di), L’avanguardia russa,Mondadori, Milano 1979, pp.26-7.53. E. H. CARR, Storia dellaRussia sovietica, cit., vol. IV,tomo VI, p. XII. Cfr. T. DEUT-SCHER, E. H. Carr, cit.54. Ibidem, p. 375.55. Cfr. I. DEUTSCHER, The Bol-shevik Revolution 1917-1923.A Review Article, in «Interna-tional Affairs», vol. 27, n. 2,1951, pp. 204-7. Ex-collabora-tore dell’«Economist», Deut-scher era in quegli annil’autore affermato di Stalin: APolitical Biography, OUP,London 1949; trad. it. Stalin,Longanesi, Milano 1951. Famacementata dalla trilogia troc-kijana pubblicata tra il 1954 eil 1963 e tradotta anch’essa daLonganesi. 56. E. H. CARR, Storia dellaRussia sovietica, cit., vol. I, p.239. Cfr. I. DEUTSCHER, TheBolshevik Revolution 1917-1923, cit., p. 239.
impliciti. Mi auguro che venga un giorno in cui gli storici, i sociologi ei teorici della politica […] riacquistino il coraggio necessario per svol-gere questo compito.
È in nome di questa ragione, non teleologica bensì umana, che Carr com-prende e sostiene chi arrischia, sul tavolo della storia, il tentativo di estendereun controllo razionale e responsabile sul destino dell’uomo e sul quale i cri-tici insistono. La fiducia in questo progresso resterà l’ultimo, e fino all’ultimo,suo baluardo intellettuale: «Non esiste più», dirà nell’ultima intervista; «que-sto è uno dei problemi. Le cose cui non credi, cessi di praticarle. Il cambia-mento ti spaventa e allora inizi a guardarti indietro»51. Ecco perché al nettodel pungente contesto storico in cui quelle opinioni germogliarono, il Carrpiù profondo, «pesce fuor d’acqua», o forse controcorrente, lo si può im-mortalare anche con le parole di Wight: «Nello spirito egli è un futurista e unrivoluzionario»52.
Il rovescio della rivoluzione
Carr è stato uomo d’ampi e profondi interessi che ben si evincono dalle noteautobiografiche qui commentate e scritte su richiesta di Tamara Deutscher.A questa sua collaboratrice riservò «l’ultimo tributo» di riconoscenza nel vo-lume finale dei quattordici della Storia53. Era il 30 novembre del 1977, set-tantesimo anniversario della rivoluzione russa. Carr aveva steso leconclusioni: «La rivoluzione russa del 1917 realizzava ben poco degli obiet-tivi che si era posta e delle speranze che aveva suscitato»54.Quasi trent’anni prima era stato il marito della Deutscher, Isaac, già impe-gnato negli studi sovietici, a recensire su «International Affairs» il primo vo-lume della Storia, quando «uno studio di quella magnitudine sullarivoluzione russa non era ancora stato pubblicato in nessuna lingua»55. Ciòche più lo colpì fu un «passo fondamentale», dimostrazione della capacitàanalitica dell’autore. Era laddove colse il «grande merito» di «mostrare ilcambiamento continuo del bolscevismo», ossia mostrarlo «non come unagamma statica di concezioni e metodi bensì come una risultante sempre mu-tevole d’idee e circostanze, intenzioni, e realtà». Cita però a sintesi dell’im-pianto del trattato un ruvido passo di Carr, intenso, nutrito di quel sistemad’idee che nella logica del potere interno e internazionale affonda i pilastri delproprio reggimento analitico: «Il nuovo regime – che si rivelava come la dit-tatura non d’una “vasta maggioranza”, ma d’una minoranza risoluta [deter-mined minority] – si trovava così isolato in mezzo a una popolazione ruraleindifferente e spesso ostile, e circondato da un mondo capitalista che, seppurediviso da una lotta intestina, era unito contro il bolscevismo. Lenin non am-mise mai apertamente – e forse neppure internamente – che quelle sue spe-ranze erano andate deluse»56.È questo, per Carr, un segno lasciato dall’Ottobre ’17, poi impresso dal par-tito rivoluzionario sullo stato e sull’effettiva struttura costituzionale nellaquale si rovescia: «Gli sviluppi del periodo che va dalla rivoluzione d’ottobrealla morte di Lenin possono ricondursi principalmente a tre: accrescimentoe concentrazione dell’autorità del partito nelle mani di pochi; trasformazionedel partito da organizzazione rivoluzionaria diretta al rovesciamento delle
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 133
134
RIVISTA DI POLITICA 1
57. E. H. CARR, Storia dellaRussia sovietica, cit., vol. I, p.181.58. Rapporto affrontato da A.PANEBIANCO, L’automa e lo spi-rito, il Mulino, Bologna 2009.59. I. DEUTSCHER, The Bolshe-vik Revolution 1917-1923, cit.,p. 207. 60. J. HASLAM, Carr, EdwardHallett, in «Oxford Dictionaryof National Biography»,2004; online edn, May 2007[http://www.oxforddnb.com/view/article/30902, accessed27 Aug 2011]. 61. È questo il giudizio di Carrcit. in R. W. DAVIES, EdwardHallett Carr 1892-1982, in«Proceedings of the BritishAcademy», vol. 69, 1983, p.487.62. I. DEUTSCHER, Heretics andRenegades, cit., pp. 101, 103,105, 106. Noto è il bilancio diCarr sul politico georgiano:«Stalin fu il despota più spie-tato che la Russia avesse cono-sciuto dai tempi di Pietro, e fuanche lui un grande occiden-talizzatore»; E. H. CARR, La ri-voluzione russa, cit., p. 197.63. E. H. CARR, Storia dellaRussia sovietica, cit., vol. I, p.845.
istituzioni esistenti, in nucleo dirigente d’un apparato governativo e ammi-nistrativo; conseguimento d’una posizione di monopolio mediante l’elimi-nazione degli altri partiti»57.Si può certo riferire anche a Carr «l’incrollabile osservazione fondamentale»posta da Gaetano Mosca nel proemio alla Teorica dei governi: «La chiave deigrandi segreti della storia, la conoscenza esatta delle cause prime che hannodeterminato il fiorire o la decadenza delle grandi civiltà umane, si debbanosoprattutto rinvenire nello studio delle loro classi dirigenti». L’inclinazionedi Carr, mente cresciuta tra Cambridge e la diplomazia britannica, è per l’artedi governo. La sovversione dell’ordine esistente gli interessa non tanto in séma quale prodromo alla successiva ricostituzione statale, necessariamentenelle mani della classe dirigente. Da qui il meticoloso interesse verso le isti-tuzioni, sovente criticato, che con le azioni individuali e le imprese collettivestanno in un dinamico rapporto d’inaudita complessità e mai noto a pre-scindere58. Da qui una visione della politica non edulcorata né fiancheggia-trice, che lo porta a rivelare, secondo Deutscher, «quanto limitata fosse lavittoria del bolscevismo e quanto portasse in sé i semi della sua disfatta mo-rale»59. Conviene però notare una cosa.Quando termina il primo studio sullo stato rivoluzionario sovietico, nel climapolitico che segue il blocco di Berlino e la guerra di Corea, Carr, l’ex-diplo-matico, ha lasciato da circa tre anni la cattedra di politica internazionale poia lui intitolata. Sta vivendo dei proventi dei suoi scritti, quasi come un «re-ietto»60, dopo le polemiche del triennio al «Times». Se Deutscher sembra quiconcentrarsi sulla dimensione interna della politica (portando, per lui, il re-gime «in sé» la propria disfatta), Carr considera invece la dimensione inter-nazionale altrettanto decisiva. Lì, nell’arena della politica di potenza, dove«non esiste la società internazionale, ma un club senza regole significative»61,il regime è «circondato» da stati ostili: non ha sicurezza e deve garantirselacon ogni mezzo. La vita internazionale impone alla repubblica sovietica ilruolo di stato in lotta in un mondo di stati. L’internazionalismo rivoluziona-rio cede all’interesse nazionale e alla sua più ovvia definizione: la necessità disicurezza per la propria sopravvivenza.Proprio sulle relazioni internazionali Deutscher insisterà, commentando iprimi cinque volumi della Storia e criticando «una concezione per la quale ilregime sovietico guadagnò la propria raison d’être quando scoprì la sua rai-son d’état». Considerare la rivoluzione russa un processo storico essenzial-mente nazionale, e in tale confine giocoforza conchiuso dalla realtàinternazionale, era dunque la presunta debolezza del «realismo storico» diCarr: «Egli pensa in termini di arte di governo e l’arte di governo è nazio-nale». Così, era un «prisma stalinista», ergo distorto, quello che riflettevaquesta pragmatica attenzione allo stato sovietico e i suoi nemici. «Il signorCarr è molto rispettoso delle politiche e – talvolta – sprezzante verso le idéerivoluzionarie e i principi»62.Brest Litovsk, il trattato di pace del marzo 1918, è naturalmente il caso cru-ciale, laddove quella crisi «portò al culmine l’insoluto dilemma delle rela-zioni della Russia sovietica col mondo; il dilemma di un’autorità che aspiravaad agire al tempo stesso come forza motrice della rivoluzione mondiale ecome potere sovrano di uno stato in un mondo di stati; e fu in questo periodoche vennero gettate le basi durature della politica estera sovietica»63. È l’at-tenzione alla politica leninista enfatizzata da Carr a dimostrare per Deut-
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 134
135
RILETTURE
64. I. DEUTSCHER, Heretics andRenegades, cit., p. 102.65. E. H. CARR, Sei lezioni sullastoria, cit., p. 158.66. E. H. CARR, Storia dellaRussia sovietica, cit., vol. IV,tomo VI, p. XII.
scher che «egli coglie molto più acutamente gli argomenti dell’espedientepolitico a fronte di quelli dell’idealismo rivoluzionario», impaziente com’è«verso utopie, sogni, e agitazioni rivoluzionarie»64.Di certo, Carr lo storico non confuse le cause generanti con gli eventi gene-rati. Oggi sappiamo che quello ritratto da Deutscher non è l’uomo infinesvelante la propria preferenza per gli «utopisti». Non è lo studioso convintodel declino occidentale che coltiva la sua «inverificabile utopia» che «forzee movimenti nuovi, di cui non possiamo ancora immaginare i lineamenti,stiano germinando sotto la superficie, qui o altrove». Non è neppure quelloche parla dell’espansione della ragione in termini singolari, «giacché espan-sione della ragione significa, in sostanza, l’emergere alla storia di gruppi,classi, popoli e continenti che finora ne erano esclusi»65. Così, infine, nellecritiche a un ribelle realista, si riannoda il paradosso di un uomo costante-mente «fuori posto» ma certo di un fatto: «La storia non sta ferma; e nep-pure lo storico»66.
12E0115_RdP_04_2011:12E0115_RdP_04_2011 7-03-2012 9:53 Pagina 135