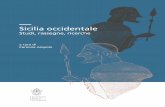Preservazione e valorizzazione dell'identità storico-culturale del territorio: lo sviluppo...
Transcript of Preservazione e valorizzazione dell'identità storico-culturale del territorio: lo sviluppo...
!!!!Corso di Laurea in Economia Aziendale !Tesi di Laurea
!!
Preservazione e valorizzazione dell'identità storico-culturale del territorio: lo sviluppo attraverso l’enogastronomia.
!!
Relatore Prof.ssa Alessia Bernardi! Laureando Alvise Giovannini Matricola 837281 ! Anno Accademico 2013/2014
!!
!
!!!!!!!!!Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno
aiutato nella realizzazione della Tesi, in particolare
la relatrice Alessia Bernardi per il supporto e la
guida datomi nella stesura dell’elaborato e il Centro
Studi Slow Food per i dati forniti.
!!!!!!!!!
INDICEI. L’enogastronomia : cultura trasversale 1. Com’era. 1.1 Esordio 1.2 Punti di scontro e d’incontro 1.3 Dalla fulgida ristorazione alla “révolution” del Cibo 1.4 Il 1800 e il turismo gastronomico 1.5 La cucina nel regime fascista e la cucina contemporanea
2. Com’è oggi.
2.1 Boom della cucina
II. SlowFood : esperienza e valorizzazione
1. Dalla geografia del gusto al gusto della geografia 2. Enogastronomia : camminare le campagne 2.1 Buono Pulito e Giusto 2.2 Diversità e omologazione: il libero mercato della “spreconomy” 2.3 I Presìdi3. I numeri di Slow Food: il successo dei valori
3.1 Gli associati
3.2 I partecipanti al Salone del Gusto
3.3 Le vendite di SlowFood Editore
III. I Presidi nel Veneto : i punti di forza
1. Vicenza
1.1 Il riso di Grumolo delle Abbadesse
1.2 L’asiago stravecchio di Malga dell’Altopiano dei Sette Comuni
2. Padova
2.1 La gallina Padovana
IV. I numeri del turismo enogastronomico :
1. Gastronomia come fattore di turismo V. Conclusioni
!
INTRODUZIONE
!Lo sviluppo e il rilancio del territorio sono temi che vengono trattati frequentemente sia
dal mondo della ricerca che dal mondo della politica.
In questo lavoro si ipotizza come l’ enogastronomia e le tipicità del territorio siano in
grado di fungere da leva per il rilancio dell’economia del Veneto, individuando i mezzi
che possono essere utilizzati a tale scopo.
Le produzioni tipiche, grazie anche al contributo di organizzazioni, come lo Slow Food,
ricoprono un ruolo sempre più rilevante in quanto sono in grado di rappresentare il
territorio e la cultura, riproponendo tecniche a basso impatto ambientale nel rispetto
della natura. Inoltre, la crescente sensibilità ambientalista è un fattore di rilievo nelle
economie degli ultimi anni che non può essere di certo ignorato e ciò fa in modo che
l’attenzione dell’opinione pubblica si sposti sempre più verso questi tipologie di
produzione rispettose dell’ambiente incentivandone lo sviluppo e la diffusione.
Per rispondere alla domanda se e come le tipicità possano essere messe a servizio del
territorio al fine di rilanciarlo, il percorso è stato articolato in cinque capitoli.
Nel primo capitolo si introduce il concetto di enogastronomia andando a ripercorrere
l’evoluzione di questa dagli albori fino ai giorni nostri. Un breve excursus che ha lo
scopo di orientare il lettore nella comprensione di come l’enogastronomia risulti essere
un elemento determinante delle nostre società così come delle nostre economie.
Nel secondo capitolo ci si concentra su quello che l’ enogastronomia è oggi,
focalizzandosi sull’esperienza di Slow Food e su come la cultura e i valori da questa
trasmessi abbiano indirizzato i consumatori verso un utilizzo e una scelta più attenta e
diversa rispetto a quella degli anni precedenti.
Nel terzo capitolo si analizzano tre produzioni presidiate da Slow Food, evidenziandone
le criticità positive e negative, lo sviluppo e il rilancio socio economico del territorio di
riferimento.
Nel quarto capitolo si studiano gli andamenti della ristorazione e del consumo dei pasti
fuori casa degli ultimi anni e l’influenza dell’enogastronomia rilevando l’incidenza che
questa ha avuto nell’economia degli ultimi anni soprattutto sotto il profilo turistico.
I. L’ENOGASTRONOMIA : CULTURA TRASVERSALE
!Punto di partenza di questo elaborato sarà quello di comprendere il motivo che ha spinto
chi scrive a trattare tale argomentazione.
Il cibo in economia è sempre stato presentato come un bene primario, di consumo, e,
quindi, non durevole, il quale, nel gesto del consumo stesso, viene ad esaurire la propria
utilità. Tale concetto è prettamente legato ad una visione sterile di quello che in realtà è
il cibo, un insieme di valori, opportunità e potenzialità che negli ultimi anni sono state
in grado di manifestarsi al mondo e che oggi non possono essere ignorate, soprattutto
dalle economie sviluppate. Basti pensare a semplici esperienze che viviamo
quotidianamente domandandoci, ad esempio, cosa ci spingerebbe a cenare in un
ristorante e a spendere somme decisamente superiori al valore di un semplice prodotto
se il cibo stesso fosse semplice soddisfazione di un bisogno, o, ancora, chiedendoci
perché, anche in tempi di crisi come quelli che si stanno vivendo in questi ultimi anni,
sia proprio il settore enogastronomico a rialzare l’economia italiana e a risentire meno
questa recessione. Al fine di poter rispondere in maniera esaustiva è necessario
comprendere prima di tutto cosa sia realmente il cibo indagando ciò che è stato, che è e
che sarà. 1. Com’era
Nel raccontare quello che è stato il percorso evolutivo dell’enogastronomia nei secoli, è
importante prendere atto di un concetto importante, ossia che il Cibo (che indicheremo
d’ora in avanti con lettera maiuscola al fine di enfatizzarne l’importanza tanto unica
quanto distintiva e per connotare sia gli alimenti che le bevande) è cultura: se ad un
primo impatto ciò possa risultare di semplice intuizione, in realtà la comprensione di
questa affermazione presenta molte difficoltà dovute alle diverse sfaccettature del
termine che devono essere tenute in considerazione per una corretta analisi.
Infatti, il Cibo è cultura, in primis, quando viene prodotto, perché l’uomo non sfrutta
solo ciò che la natura gli fornisce come, invece, provvedono a fare tutti gli animali, ma
crea il proprio nutrimento; in secundis esso è cultura quando viene consumato perché,
sia l’individuo (in quanto onnivoro è libero di consumare ciò che lo soddisfa) che la
società, decide di cosa nutrirsi in relazione alla dimensione economica e nutrizionale del
gesto, ai valori che questo investe e al significato che vuole trasmettere. Questo concetto
risulterà tanto più chiaro leggendo i paragrafi seguenti relativi all’evoluzione
dell’enogastronomia negli anni.
1.1 Esordio
Fino al 10.000 a.C. l’uomo era poco più che un predatore: viveva procacciando animali,
pescando pesci, cogliendo frutti da alberi e radici dai terreni. Le prime pratiche
gastronomiche nacquero con l’arrivo del Neolitico (circa 1.000 anni più tardi) quando,
da nomade, l’uomo scelse di divenire sedentario, cominciando a coltivare la terra e
addomesticare gli animali per assicurare la crescita alla sua specie. Nacquero da questa
necessità l’agricoltura e l’allevamento del bestiame. In un primo momento l’uomo si
limitò a seguire le regole imposte dall’ambiente, successivamente le modificò,
introducendo coltivazioni al di fuori delle aree originarie, definendo così una differenza
tra quella che chiamiamo Natura e quella che, oggigiorno, identifichiamo con Cultura.
A questo seguì, con il trascorrere degli anni, la crescita dell’uomo e delle sue tradizioni,
alle quali si accompagnarono la crescita delle abilità di elaborare i prodotti e di lavorare
ciò che la Natura era in grado di offrire: si ottennero così pane, birra, vino, nuovi
alimenti di fondamentale importanza tanto che queste conoscenze arrivarono ad esser
vissute come tratti distintivi dell’essere uomo, mito da raccontare e tramandare.
Si pensi, ad esempio, ai poemi omerici come l’Iliade o l’Odissea dove gli uomini
vengono descritti come “mangiatori di pane”, o, in maniera altrettanto simile in
Gilgamesh (il primissimo testo letterario a noi noto trascritto in Mesopotamia all’incirca
4000 anni da) dove il protagonista esce dal suo stato di minorità attraverso la scoperta
del pane). Il Cibo, quindi, è cultura, è essenza dell’uomo, ed è tale quando la tradizione
(l’insieme di tecniche, saperi e valori) incontra l’ innovazione (una realtà nuova, da
tramandare).
!1.2 Punti di scontro e d’incontro
Come abbiamo visto Natura e Cultura sono concetti distanti, perché portano con loro
delle ideologie, o, meglio, dei pensieri che guardano a due culture ben differenti. Con il
trascorrere degli anni l’uomo divenne sempre più civile (rappresentazione della cultura
per eccellenza è la civiltà che si fonda su quest’ultima), <<rappresentandosi fuori dalla
Natura, ma essa stessa è un modello culturale consapevole, una scelta intellettuale
alternativa>> tanto da manifestarsi, lo vediamo nella storia, nella differenza tra 1
“barbari”e romani, gli uni orientati alla Natura, gli altri alla Cultura. Quando, a seguito
delle invasioni, i costumi e gli usi si vennero ad unire, ad incontrare in un punto unico,
lo stesso avvenne per queste due culture, le quali si tradussero poi in quello che oggi
chiamiamo Medioevo, una cultura nuova, non solo in termini di evoluzioni, scoperte e
arti, ma anche (e soprattutto) in termini alimentari, definendo una tradizione che ancora
ai nostri giorni riconosciamo come “europea”. Tale fusione fu in grado di porre nel
medesimo piano Cultura e Natura, basandosi sulla complicità e reciproco sostegno
dell’economia agraria (coltivazione) e dell’economia forestale (predazione), generando
una varietà di risorse e generi, ricchezze del patrimonio gastronomico europeo che
tutt’ora lo rendono unico ed apprezzato in tutto il mondo.
Ma nel Medioevo non nacque solo una nuova cucina (vedremo che la cucina è ciò che
riassume in sé la cultura), ma anche una serie di importanti atteggiamenti nei confronti
del cibo che sono divenuti determinanti per la definizione di tecnologie e di modi di
pensare che ancora oggi ci accompagnano. Sono questi i concetti di “modificare il
tempo”, di comandare la stagionalità cercando di uniformare il tempo (obiettivo che
tutt’ora è rimasto nella nostre necessità e anche nei nostri ideali, si pensi all’Eden
biblico, paradiso terrestre in cui è sempre primavera e i prodotti sono sempre freschi).
Per fermarlo, vengono quindi perseguiti due metodi: il primo punta alla diversificazione
cercando di differenziare le colture allo scopo di avere sempre prodotti freschi man
mano che i mesi cambiano (due casi sono emblematici; il primo è portato
dall’esperienza di Jean de la Quintinye, giardiniere del re Luigi XIV di Francia, il quale
racconta che il re, nel suo giardino di pere, ne aveva 500 di ogni specie e tipo per
potersi garantire sempre prodotti freschi, il secondo, esposto dal “Trattato degli alberi”
di Giovanvettorio Soderini il quale, appunto, espone, dopo attenti studi, i periodi di
migliore impiego alimentare e utilizzo per ciascuna specie coltivabile del tempo). Il
secondo è la conservazione la quale ha lo scopo di garantire in maniera analoga alla
Montanari, Il cibo come cultura, 2005, p.13. Massimo Montanari è docente ordinario di Storia 1
medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, dove insegna anche Storia dell'alimentazione e dirige il Master europeo "Storia e cultura dell'alimentazione". Insegna anche all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
precedente prodotti freschi in tempi diversi ma attraverso la cura del prodotto. (in questo
ambito vengono impiegati il sale aceto, olio e zucchero evolvendosi poi con il
trascorrere degli anni nell’uso del freddo allo scopo di rispettare la natura originaria
prodotti, si pensi a tal proposito ai frigoriferi).
Oltre a modificare il tempo l’uomo medioevale si pone un’ulteriore obiettivo, quello di
“modificare lo spazio”: se da un lato il tempo presentava un problema per lo più del
popolo che lo adottava al fine di garantirsi la sopravvivenza (ne è chiaro esempio la
conservazione), dall’altro lato il ricco sostituì questa necessità attraverso la ricerca di
alimenti freschi da tutto il mondo (scriveva a tal proposito Cassiodoro, Ministro del re
Teodorico che <<solo il semplice cittadino si accontenta di ciò che fornisce il territorio.
La tavola del principe deve offrire di tutto e suscitare meraviglia solo a vederla>>) e
questo atteggiamento non è certo lontano da quello che ci offre oggi il villaggio globale,
ossia la possibilità di poter avere ogni giorno pietanze di ogni stagione e da ogni parte
del mondo).
Oltre che per le nuove necessità e scoperte, il Medioevo è diventato un nodo importante
per la cucina come oggi la conosciamo anche per il fatto che, in tale periodo, con il
notevole frazionamento politico dell’Italia che col tempo si fece sempre più rilevante, si
svilupparono lentamente usi e tradizioni gastronomiche molto differenti tra loro: è da
qui, infatti, che nacquero le prime cucine regionali, sebbene tale concetto risulti
differente da quello che viene attribuito oggi al termine.
!1.3 Dalla fulgida ristorazione alla révolution del Cibo
Il XVI secolo fu il periodo di spicco del Rinascimento italiano, sia sotto il profilo
artistico-culturale che sotto quello della cultura gastronomica e delle “maniere a tavola”:
nacque una vera e propria cerchia di specialisti del servizio e delle preparazioni
culinarie, predecessori della moderna brigata di cucina e di sala. Questi inventarono i
primi utensili da tavola come bicchieri individuali, posate, stuzzicadenti. Emblematica
è, a tal proposito, l’opera di Bartolomeo Scappi, che pubblicò il più grande trattato di
cucina del tempo il quale includeva oltre mille ricette e trattava degli strumenti di cucina
e di tutto ciò che doveva conoscere un cuoco rinascimentale di alto livello.
Con il matrimonio di Caterina De’ Medici con il futuro re di Francia Enrico II, però, il
centro dell’attività gastronomica si spostò da Firenze a Parigi. La nuova regina portò
con sé un importante numero di cuochi, pasticceri e professionisti di varie discipline che
trovarono in Francia un terreno fertile dove far diventare grande la cucina del Seicento e
del Settecento. Il XVII secolo vide la nascita, quindi, della cucina classica francese,
codificata per prima dal cuoco professionista François Pierre de La Varenne nel suo
libro “Le Cuisinier François”, del 1651. È qui che si trattano per la prima volta le basi
di una vera e propria cucina, delle metodologie, di una cultura da insegnare su cui
imperniare la tecnica e l’abbinamento dei sapori. È in questo periodo che si viene a
segnare un punto importante per la storia della gastronomia che oggi conosciamo: fino a
questo momento, infatti, il cuoco tipico della cultura premoderna è un artista
irrispettoso delle qualità originarie del prodotto. L’idea di una cucina “naturale” (nel
senso di cucina legata all’identità dei prodotti) che s’instaura in questo periodo sovverte,
invece, questa immagine e propone una nuova idea, un nuovo concetto di cucina che
risulta, come vedremo, tanto più vero e forte ai giorni nostri.
Verso la fine del Seicento, quindi, si cominciò a dare più importanza alla qualità dei
prodotti più che alla quantità, e non solo in termini gastronomici, ma anche nel campo
delle bevande: la Francia offrì notevoli spunti di novità, primo fra tutti la produzione di
un vino spumante partendo da un vino di Champagne; nel 1688 Dom Perignon inventò
il metodo champenoise per produrre lo Champagne, bevanda che tutt’oggi risulta essere
legata a valori di ricchezza qualità e prestigio.
È importante ricordare nel nostro percorso che, poiché il cibo è cultura e il Settecento è
il secolo dei Lumi e della Rivoluzione Francese, anche nella gastronomia si avvertono
forti movimenti di trasformazione che precedono e seguono i fatti politici. Cucinare, è
attività umana per eccellenza e in quanto gesto che trasforma il prodotto di Natura in
qualcosa di costruito, ossia in Cultura, è incarnazione della cultura stessa, tanto che
illuminati e filosofi del tempo (come Claude Lévi-Strauss) utilizzano proprio il concetto
di cucina come metafora per i presentare i loro scritti, il concetto di crudo , di Naturale,
appunto, contrapposto a quello di cotto, civilizzato, di Cultura. Rifiutare la cucina
assume, quindi, un significato di contestazione della “civiltà” (si pensi all’eremita il
quale rifiuta il cibo cucinato e si isola dalla popolazione). “Dimmi cosa mangi e ti dirò
chi sei” continua Anthelme Brillat-Savarin nella “Fisiologia del gusto”. Il Cibo, infatti,
ha importanti implicazioni psicologiche: il modo di mangiare rivela la personalità di una
società ed è espressione diretta dell’appartenenza sociale poiché il modo di alimentarsi
deriva da una determinata tradizione e al tempo stesso la rivela. La qualità del cibo ha
quindi un forte valore comunicativo ed esprime immediatamente un’identità sociale.
<<Siamo quello che mangiamo>> scrisse qualche anno dopo Ludwig Feuerbach, e non
sbagliava, alimentandoci tendiamo a costruire il nostro corpo come un’abitazione, lo
custodiamo e lo rendiamo sano grazie a ciò che mangiamo abitualmente, e ne
allunghiamo il periodo di vita. Erroneamente siamo soliti non dare grande importanza
all’alimentazione, concependo questa attività come un qualcosa di necessario, utile per
la nostra sopravvivenza, senza però interessarci di come essa influenzi la nostra persona
per diversi aspetti, la salute in primis, i nostri valori e la nostra cultura in secundis.
!1.4 Il 1800 e la cucina moderna
Verso la fine del XIX secolo avvenne la grande trasformazione nel mondo della
gastronomia: nacque la ristorazione moderna attraverso l’incontro tra Auguste Escoffier,
mago della cucina, e Cesar Ritz, genio dell’imprenditoria; segnandone così il decollo.
Alberghi transatlantici e treni cominciarono a diventare elementi fondamentali di un
movimento nuovo che prese piede in tutto il mondo, il turismo, guidato e accompagnato
dalla gastronomia. Ritz affrontò il problema imprenditoriale aprendo grandi alberghi di
lusso in ogni parte d’Europa, ed Escoffier si incaricò di sviluppare e istruire al meglio il
settore della ristorazione, perno fondamentale di queste strutture, organizzando il
personale di cucina in “brigate”, impostazione che ancora oggi è seguita nella moderna
ristorazione.
Il XX secolo, era di grandi mutamenti storici e di elevato sviluppo tecnologico così
come quello scientifico, ha profondamente mutato la società, con imprevedibili
influenze in ogni attività umana, compresa, ovviamente, la gastronomia. L’avvento
dell’automobile muta pure il profilo del turista, tanto che nel 1900 viene pubblicata la
prima “Guida Michelin”, nata in Francia al fine di illustrare le caratteristiche dei
ristoranti di qualità presenti sul territorio e dedicata ai c.d. “gastronomadi”,
automobilisti-gastronomi, che accompagnano al piacere del viaggio la soddisfazione di
gustare nuove esperienze culinarie.
Anche in Italia vi fu, seppur limitato, un certo fermento gastronomico, testimoniato
dalle differenti pubblicazioni del periodo, venne infatti pubblicata nel 1909 “La nuova
cucina delle specialità regionali” di Agnetti Vittorio dove, per la prima volta, vengono
riportate ricette di tutte le regioni italiane.
!1.5 La cucina nel regime fascista e la cucina contemporanea
Il ventennio fascista instaurò in Italia uno stile di vita basato sulla frugalità e sulla
semplicità. A prescindere dal fenomeno della cucina futurista, che rappresenta un
movimento più artistico che culinario vero e proprio, si verificò un appiattimento della
cucina nazionale, che, chiusa nei suoi regionalismi, rimase piuttosto sobria e lontana da
frivolezze e lussi. Tuttavia, nel 1929 l’editore Umberto Notari pubblicò il primo numero
de “La Cucina Italiana”, periodico avente come proposito quello di considerare la
buona tavola non solo attraverso la presentazione di ricette e piatti, ma anche come
fatto sociale. Gli anni del boom economico postbellico (1950-1960) portarono grandi
innovazioni nella vita di tutti: ogni casa poté godere di frigoriferi, di forni, di cucine a
gas, di elettrodomestici multiuso e si modificarono di conseguenza (in maniera
profonda) i metodi di cucinare.
Secondo elemento di grande importanza fu l’entrata della donna nel mondo del lavoro:
questo sconvolse i ritmi della vita familiare e della figura della donna come custode
della cultura gastronomica (che invece resta tipica nella maggior parte dei paesi poveri
legati in gran parte all’economia agraria), inoltre il modo di mangiare subì cambiamenti
radicali, l’attività culinaria tese ad uscire dall’ambito domestico, divenendo i ritmi più
rapidi e allontanando così il concetto di Cibo da quello di cultura, relegandolo ad una
funzione meramente nutritiva e di scarsa importanza.
Con gli anni ’70, però, si delinearono tre filoni gastronomici paralleli volti a riscoprire il
valore del Cibo: il primo orientato alla riscoperta delle tradizioni regionali, con un
rilancio dell’artigianato alimentare locale, legato soprattutto all’incredibile aumento del
turismo di massa e al conseguente incremento dei festival gastronomici e delle sagre
paesane.
Il secondo guarda, invece, all’adozione di modelli di cucina rapida, sana e attenta alla
dietetica, che utilizza sistemi di cottura innovativi.
Il terzo, che prende il nome di “Nouvelle Cuisine”, ovviamente di stampo francese,
viene introdotto in Italia da Gualtiero Marchesi che lo lancia durante gli anni ‘80, dopo
aver fatto molta esperienza in terra francese, attraverso la pubblicazione de “La mia
nuova grande cucina italiana”, libro in cui raccoglie le ricette più rappresentative della
sua cucina creativa.
Sebbene questi filoni ebbero gran successo e trovarono ampi consensi, ad oggi quello
che perdura e, anzi, sembra affermarsi sempre più, risulta essere quello di una cucina
legata alle tradizioni regionali, ai prodotti della terra e a quei Cibi che, grazie alla loro
storia e a ciò che trasmettono sono in grado di “riscaldare il cuore”.
2. Com’è oggi 2.1 Il boom della cucina: tra cultura e spossesso
Nel contesto odierno, dove la vita di ognuno di noi è regolata da tempi frenetici, sarebbe
facile pensare che il Cibo, con tutti i suoi connotati visti in precedenza, non sia più in
grado di comunicare quello che in realtà porta con sé a causa della scarsa attenzione e
importanza che l’uomo gli conferisce, e ciò in realtà si è manifestato: a partire dai
processi di industrializzazione che hanno spossessato il cibo dei suoi valori attraverso
preparazioni di tipo industriale a favore del vantaggio economico, arrivando
all’esasperazione di questo attraverso forme di “propaganda mediatica” passando per
programmi di culinaria in ogni media (quello che alcuni non esitano a definire
<<pornografia agroalimentare>> , ossia Cibo trattato senza consapevolezza) come i 2
programmi Tv , i Blog di cucina, le radio e le pubblicità; la nostra mente ha lentamente 3
assimilato il concetto che il Cibo sia solo un bene da scambiare nei mercati, da
commercializzare, da presentare agli spettatori in competizioni che premiano le velocità
di preparazione e non l’importanza dei prodotti,riducendo la comunicazione del cibo, il
suo linguaggio.
Se da un lato tutto ciò risulti essere evidente, altrettanto chiaro risulterà agli occhi di chi
legge che, grazie soprattutto a questi processi che hanno risvegliato nell’uomo
l’interesse nei confronti della gastronomia, nel medesimo tempo si sono risvegliati con
questi anche la necessità di riscoprire i valori della propria terra e del Cibo stesso, così
come la necessità di una maggiore attenzione per il prodotto e l’ambiente: tale
“corrente” e il perché questa negli ultimi anni si stia affermando sempre più, risulterà
“Oscar Farinetti ospite da Andrea Scanzi a #Reputescion”. Youtube video. Postato da “La3 - 2
Social Media Channel”. Aprile 07, 2014. https://www.youtube.com/watch?v=d8TeEuQAW00
A tal proposito si riporta il successo di programmi di culinaria quali “Masterchef Italia” in 3
Tabella 1.
tanto più chiara attraverso la lettura dei capitoli successivi in relazione al successo
ottenuto da “Slow Food” e indagando l’influenza del settore enogastronomico
nell’economia nazionale.
Tabella 1. Share (percentuale) “Masterchef” stagione 1, 2, 3 .
Fonte: AUDITEL, Ascolti Masterchef Italia (2014) 4
!!!!!!!!!
I dati sono stati rielaborati dall’autore dopo una raccolta effettuata da diverse pubblicazioni4
II. SlowFood : l’esperienza e la valorizzazione
1. Dalla geografia del gusto al gusto della geografia Come già detto, negli ultimi anni si è passati, per così dire, dalla geografia del gusto al
gusto della geografia (sebbene una non abbia sostituito l’altra, tutt’ora, infatti, esistono
in contrasto fra loro).
Le conoscenze del territorio, degli ambienti e delle risorse locali hanno sempre
costituito un dato essenziale della cultura alimentare: si è visto come in passato vigesse
il concetto di “universale” il quale si manifestava attraverso la presentazione a tavola di
tutti i prodotti, di varietà di ricette, provenienti da ogni parte del mondo. Il “regionale” e
il “locale” non avevano, invece, lo scopo di valorizzare le cucine di territorio, il
concetto, come lo intendiamo noi oggi, nasce invece negli anni recenti, tanto che si può
dire, senza esitare, che <<è questa regionalità [. . .] a fare, oggi, la forza della cucina
italiana, a renderla non solo competitiva ma più attuale di altre>> . Il gusto della 5
geografia non appartiene, quindi, al passato ma agli ultimi due secoli caratterizzati da
una vera e propria maturazione culturale sviluppatasi inizialmente durante il periodo
dell’industrializzazione: l’avvio dei processi di omologazione e globalizzazione dei
mercati e dei modelli alimentari ha provocato una nuova attenzione alle culture locali,
alle “cucine regionali”, alle radici; il “cibo di territorio” diviene così Cibo di valori, in
grado di indebolire le differenze sociali: anche per questo la “cucina regionale” è una
cultura più nuova che antica (ricordando sempre che cultura è dove s’incontrano
tradizione e innovazione).
Al fine di comprendere meglio tale evoluzione che risulta essere essenziale per definire
l’incidenza della stessa all’interno dell’economia italiana, è importante seguire il
percorso che ha portato allo sviluppo di una delle più grandi e importanti associazioni
gastronomiche odierne quale è Slow Food.
Si può dire che è grazie alla fondazione dell'associazione Arcigola che la cucina 6
regionale odierna nasce e si costituisce come vero e proprio valore da diffondere. Per
Montanari, Il cibo come cultura, 2005, p.1145
1986, Langhe, Piemonte, Arcigola nasce come convivio di poche persone appassionate della 6
cultura materiale, volto ad operare sul territorio promuovendo il diritto al piacere, perseguendo uno scopo, ossia riportare dignità al cibo, considerando di questo ogni aspetto, dalle persone ai luoghi, dai processi alle implicazioni culturali
promuovere i propri ideali il gruppo iniziò, come era solito scrivere Luigi Veronelli, a
<<camminare le osterie>>, <<camminare le cantine>> e <<camminare le
campagne>>, ovvero ad immergendosi totalmente nella dimensione del Cibo, al fine di
comprenderne ogni momento e ogni attributo, dall’origine dello stesso fino al suo
consumo; poiché <<c’era tanto da sapere oltre al sapore>> 7
Pochi anni dopo, nel 1989, il movimento, grazie alle numerose adesioni ricevute e alla
rapida maturazione del pensiero, mutò il proprio nome: nacque così all’ Opéra Comique
di Parigi il Movimento Internazionale Slow Food e ne venne sottoscritto il seguente
Manifesto, rappresentazione del pensiero stesso:
“Questo nostro secolo, nato e cresciuto sotto il segno della civiltà industriale, ha prima inventato la macchina e poi ne ha fatto il proprio modello di vita. La velocità è diventata la nostra catena, tutti siamo in preda allo stesso virus: la Fast Life, che sconvolge le nostre abitudini, ci assale fin nelle nostre case, ci rinchiude a nutrirci nei Fast Food. Ma l'uomo sapiens deve recuperare la sua saggezza e liberarsi dalla velocità che può ridurlo a una specie in via d'estinzione. Perciò, contro la follia universale della Fast Life, bisogna scegliere la difesa del tranquillo piacere materiale. Contro coloro, e sono i più, che confondono l'efficienza con la frenesia, proponiamo il vaccino di un'adeguata porzione di piaceri sensuali assicurati, da praticarsi in lento e prolungato godimento. Iniziamo proprio a tavola con lo Slow Food, contro l'appiattimento del Fast Food riscopriamo la ricchezza e gli aromi delle cucine locali. Se la Fast Life in nome della produttività ha modificato la nostra vita e minaccia l'ambiente e il paesaggio, lo Slow Food è oggi la risposta d'avanguardia. È qui, nello sviluppo del gusto e non nel suo immiserimento, la vera cultura, di qui può iniziare il progresso, con lo scambio internazionale di storie, conoscenze, progetti. Lo Slow Food assicura un avvenire migliore. Lo Slow Food è un'idea che ha bisogno di molti sostenitori qualificati, per fare diventare questo moto (lento) un movimento internazionale, di cui la chiocciolina è il simbolo.” 8
Petrini, Cibo e libertà, 2013, p.30. Carlo Petrini si occupa di enogastronomia dal 1977 sui 7
principali periodici e giornali italiani, ha partecipato attivamente alla nascita del Gambero Rosso, inizialmente inserto mensile del Manifesto. Ha fondato la "Libera e Benemerita Associazione degli Amici del Barolo", che divenne nel luglio 1986 Arcigola, e poi Slow Food, mantenendo forti legami col Gambero Rosso e con la rivista La Gola. È ideatore di importanti manifestazioni ormai di rilievo internazionale come Cheese, il Salone del Gusto di Torino e la recente manifestazione Terra Madre, giunta nel 2010 alla quarta edizione, che si svolge a Torino in contemporanea al Salone del Gusto. Ha curato l'edizione della Guida ai Vini del Mondo ed è stato curatore della Guida ai Vini d’Italia. Come giornalista ha collaborato tra le altre testate con l'Unità e La Stampa; dal 2007 è una firma di Repubblica.
Il Manifesto è stato sottoscritto dai delegati provenienti da Argentina, Austria, Brasile, 8
Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ungheria, Venezuela
Nell’anno seguente venne tenuto il primo congresso di Slow Food proprio a Venezia, al
quale si accompagnò la pubblicazione di “Osterie d’Italia”, una guida volta a
promuovere il mangiar-bere alla scoperta dell’Italia: la lettura aveva lo scopo di
raccontare la cucina di tradizione regionale in un viaggio attraverso 1700 tappe
all'insegna della convivialità e dei piaceri dello Slow Food. Con il trascorrere degli anni
e con il successo sempre più diffuso, vennero anche aperte nuove sedi in tutta europa
dalla Germania alla Svizzera.
Il 1994 fu un anno importante nella storia dell’associazione: venne organizzata la
manifestazione “Milano Golosa”, banco di prova per quello che divenne pochi anni
dopo il “Salone del Gusto” (prima edizione nel 1966 a Torino), evento fondamentale in
cui l’associazione promuove la diversità e i propri valori esponendo le tipicità dei
territori.
Anni dopo, Slow Food s’impegnò attivamente in una molteplicità d’iniziative: nel 1999
in una raccolta di firme in difesa del patrimonio enogastronomico italiano per chiedere
la revisione del regolamento europeo Haccp per la prevenzione dei pericoli di
contaminazione alimentare; nel 2000, anno importante sia per Slow Food che per il
Cibo, prese il via il progetto dei Presìdi, interventi mirati sul territorio volti a
salvaguardare e rilanciare piccole produzioni artigianali a rischio di estinzione (come
vedremo tale progetto rappresenta tutt’ora uno dei fulcri del movimento e, in quanto
tale, verrà analizzato più nel profondo); nel 2001 poi vi fu una rapida evoluzione del
movimento, s’inaugurarono i nuovi siti internet di Slow Food ; venne lanciata la 9
campagna “No gm Wines” contro la commercializzazione in Europa di viti transgeniche
e si stilò il Manifesto in difesa dei formaggi a latte crudo. Elemento importante fu
inoltre la nascita di un nuovo progetto educativo per adulti che venne ad avviarsi in
questo stesso anno, il “Master of Food”, che si tradurrà qualche anno dopo più
ampiamente nella scelta di educare gli individui in maniera completa sul Cibo e ciò che
esso rappresenta attraverso l’istituzione dell’Università di Scienze Gastronomiche.
Nel 2002 a Torino durante la quarta edizione del Salone del Gusto, i partecipanti
raggiunsero quota 138.000 e durante la manifestazione vennero presentati i primi 30
Presìdi internazionali, costituendo nell’anno seguente la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus, al fine di sostiene i Presìdi e l'Arca del Gusto.
Sito italiano http://www.slowfood.it e inglese http://www.slowfood.com9
Nel 2004 la Fao riconobbe ufficialmente Slow Food come organizzazione no profit con
cui instaurare un rapporto di collaborazione. Nello stesso anno s’inaugurò la rinnovata
Agenzia di Pollenzo (Cn) che ospitò la prima Università di Scienze Gastronomiche,
riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca allo scopo di ridare dignità
alla gastronomia anche in campo accademico.
Nel 2005 si riunirono in Sicilia gli Stati Generali dei Presìdi Slow Food italiani per
lanciare una grande campagna a favore delle produzioni artigianali eccellenti che
rischiavano l’estinzione.
Infine il 10 dicembre del 2009 si tenne in tutto il mondo la prima edizione del Terra
Madre Day, uno dei più importanti eventi collettivi di celebrazione del cibo buono,
pulito e giusto il quale si tradusse in più di 1000 appuntamenti in oltre 150 Paesi da tutto
il mondo che coinvolsero oltre 2000 comunità del cibo e circa 200.000 persone.
Questo breve excursus ha rilevato come il concetto di regionalità sia stato in grado di
evolversi e diffondersi negli anni recenti in maniera rapida ed esponenziale e ha
introdotto quelli che sono i punti cardine della visione supportata dal movimento Slow
Food che si tratteranno in maniera approfondita nei paragrafi successivi.
!2. Enogastronomia: camminare le campagne
In un contesto come quello appena presentato urge considerare il fatto che alcuni
soggetti, facendosi portavoce della cultura territoriale, l’hanno promossa e tutt’ora la
promuovono e sponsorizzano al fine di garantire una dignità a quei prodotti che
rappresentano il patrimonio culturale di molti territori. La Fondazione Slow Food per la
biodiversità onlus si adopera per perseguire tali obiettivi. Per fare questo negli anni il
pensiero dell’associazione si è sviluppato ed imposto attraverso una serie di punti
cardine.
2.1 Buono, Pulito e Giusto
Il primo punto di partenza si presenta come un trittico che nelle economie moderne si
sta sempre più affermando, in termini di valore d’impresa e di vantaggio competitivo, e,
in un certo senso, ciò era intuibile grazie al successo che questo ha avuto nell’ambito
della cultura enogastronomica. Il Cibo, in primis, dev’essere Buono, in termini di
qualità e di gusto che è in grado comunicare, inoltre, dev’esserlo in termini di piacere, di
esperienza che sa trasmettere, considerando, come ripetuto ormai molte volte, che il
Cibo è cultura, e una cultura non può essere fine a sé stessa ma, invero, dev’essere
contestualizzata, in relazione alla realtà che la circonda. Un cibo può essere buono in
America ma non in Italia, in Cina e non in Africa .10
Se da un lato è facile pensare che un Cibo regionale, trattato nel territorio secondo le
tradizioni, sia un Cibo buono, ottenuto attraverso modalità rispettose dell’ambiente,
dall’altro sarà altrettanto facile comprendere come, attraverso l’industrializzazione
subita in questi ultimi anni, le colture siano state sottomesse da processi meccanici e
chimici volti a massimizzare e ad assicurare le produzioni. Pertanto, al fine di ritrovare
il vero valore della regionalità così come l’intendiamo, è necessario liberare il Cibo,
andando a riscoprire il valore di una produzione sostenibile, rispettosa dell’ambiente,
dalla coltivazione, dal produttore fino al consumo finale: è questo ciò che s’intende per
un Cibo Pulito .11
Ma proprio perché la cultura passa attraverso il Cibo, le modalità con cui questo viene
prodotto devono essere rispettose della cultura stessa, ossia delle persone che la
coltivano. È da ciò che si arriva a definire il terzo ed ultimo punto di questo filone che si
focalizza nel concetto di un Cibo Giusto, ossia ottenuto senza sfruttamenti, nel rispetto
delle persone, con retribuzioni adeguate e prezzi rispettosi del consumatore,
valorizzando solidarietà, equità e condivisione . 12
!2.2 Diversità e omologazione: il libero mercato della “spreconomy”
Se il primo punto visto in precedenza si focalizza soprattutto su quello che il Cibo è in
senso stretto e sui suoi valori intrinsechi, il secondo si focalizza sul contesto in cui il
Cibo si trova a essere inserito. Nei mercati odierni il libero scambio regola le
Ad oggi sono numerosi i produttori che hanno orientato alla qualità i loro metodi di produzione 10
al fine di fornire esperienze uniche e volte alla fidelizzazione della clientela
Sarà nota a chi legge la sempre maggior attenzione che negli ultimi tempi i produttori volgono 11
ai processi sostenibili in termini ambientali per l’ottenimento di vantaggi di lungo periodo in termini di immagine e di competitività
Altro concetto che ritorna nelle economie odierne in quella che definiamo col termine di 12
“sostenibilità sociale”
transazioni, ogni bene viene scambiato e in ogni parte del mondo. Ma questo processo
che oggi chiamiamo anche “globalizzazione” ha portato con sé un’attitudine
all’omologazione delle merci e dei prodotti che ha interessato il Cibo stesso
radunandoci tutti, appunto, in un grande villaggio globale. Se da un lato questo potrebbe
essere giustificato dalla ricerca ossessionata dell’efficienza che proprio attraverso
standardizzazioni ed economie di scala è in grado di raggiungersi, dall’altro lato è
sicuramente noto come questo sistema in realtà si traduca in numerosi sprechi su tutti i
livelli. È per questo motivo che per giungere realmente a tale obiettivo l’alternativa che
si pone è quella di perseguire la Diversità al fine di costituire un sistema più “sano”,
efficiente e volto al futuro: basti pensare alla Natura stessa la quale ci insegna che <<un
sistema con un alto tasso di biodiversità ha maggiori possibilità di sopravvivere,
evolversi e propagarsi, è più fiorente ricco, in grado di affrontare le avversità che gli si
parano innanzi>> . Diversificare significa inoltre diffondere cultura, e generare 13
rispetto per le altre identità, significa, quindi, riportare alla luce quelle tradizioni che un
sistema ormai quasi totalmente industrializzato ha saputo farci dimenticare. Ma si noti
un particolare: accettare la Diversità non significa tornare al passato abbandonando il
libero mercato, significa piuttosto costruire un futuro consapevole partendo da questo.
2.3 I Presìdi
Abbiamo chiarito come il Cibo debba essere (BPG), così come il mezzo con cui questo
debba essere portato a conoscenza di tutti (Diversità), ma l’oggetto non è ancora stato
definito. A tal proposito sarà esemplificativo quanto riportato dalla Fondazione Slow
Food per la biodiversità Onlus nel suo statuto. La Fondazione s’impegna a:
“Sostenere, finanziare, promuovere ed organizzare il progetto dell’Arca del Gusto, secondo il relativo Manifesto; favorire la creazione di Presìdi, adoperandosi per la loro affermazione e visibilità al fine di valorizzare progetti per la salvaguardia di prodotti in via di estinzione e per promuovere lo sviluppo economico e civile delle aree interessate; organizzare tra i soggetti residenti nelle aree interessate dal progetto dei Presìdi corsi e seminari per la formazione di una nuova cultura dello sviluppo rurale e del territorio”
Un’arca del gusto che ha lo scopo, quindi, di salvare il pianeta dei sapori, il cui carico è
composto da prodotti d’interesse alimentare, di qualità particolare (definita dagli usi e
dalle tradizioni locali), legati a un territorio, alla memoria, all’identità di una comunità,
Petrini, Cibo e libertà, 2013, p.5813
realizzati in quantità limitate e a rischio di estinzione ricordando che tali profili variano
in relazione alle diverse realtà locali delle comunità che li conservano. Si tratterà,
quindi, non solo di prodotti storici, ma altrettanto di identità nuove che meritano di
essere conosciute.
Per fare questo Slow Food s’impegna attivamente nel riunire in Presìdi i migliori
produttori artigianali per mettere in luce le eccellenze della produzione nostrana,
sostenendo coloro che stanno ponendo le basi per la futura tradizione attraverso una
studiata interazione tra il settore non profit, con le sue caratteristiche, e quello profit.
Il sistema dei Presìdi prevede, infatti, l’utilizzo di metodologie caratteristiche del settore
profit: dopo l’individuazione di produzioni agroalimentari da difendere, l’associazione
mette in rete i produttori locali promuovendo la nascita di forme associative (consorzi,
cooperative, associazioni di produttori, quella che viene definita una vera e propria
“Rete”) le quali si fanno carico della produzione e, in parte, della distribuzione dei
prodotti.
!3. I numeri di Slow Food: il successo dei valori
Fino ad ora si è trattato di ciò che sono stati e sono oggi i punti di forza, la storia e la
filosofia legati a Slow Food, ma, al fine di supportare quanto detto e di indurre il lettore
ad accettare il fatto che quanto trattato non riguarda solo la dialettica bensì un insieme
di valori che sempre più stanno prendendo piede nella nostra società, si riportano in
questo paragrafo una serie di confronti numerici tra serie storiche relative al numero di
associati a Slow Food, di partecipanti al Salone del Gusto e di vendite di libri da parte di
SlowFood Editore.
È opportuno, a tal proposito, contestualizzare i dati per una chiara e corretta lettura degli
stessi: in primis in termini di economia italiana, la quale, soprattutto negli anni più
recenti, ha visto sempre più sostituire il settore secondario (di cui il Nord-Est ne è stato
rappresentante in tutti questi anni) con quello terziario; è anche a causa di tale motivo
che numerose attività volte al benessere degli individui quali SPA, centri benessere e,
appunto, “ristorazione Buona Pulita e Giusta” si sono diffusi oggi più che mai.
In secundis si rileva come i dati presentati siano inseriti in un contesto economico del
tutto particolare che ha influenzato l’intera Euro-zona e che tutt'oggi in Italia si risente
in maniera rilevante , pertanto, sebbene a prima vista si rilevi un trend decrescente nei 14
dati che si presenteranno è essenziale rilevare come questo non rappresenti
necessariamente un andamento negativo, soprattutto se confrontato con i dati di settore.
3.1 Gli Associati
Negli anni il progetto ha visto un enorme espansione e ridefinizione delle proprie
caratteristiche sia in termini di partecipanti che di obiettivi: nel 2009 si contano 30390
soci attivi che negli anni seguenti hanno visto un continuo aumento tanto da raggiungere
nel 2011 il picco di 34884 soci. Sebbene nell’anno seguente vi sia stata una leggera
contrazione, è importante rilevare come il trend si sia rapidamente rialzato nel 2013.
Analoghe considerazioni si possono fare per le condotte che tra il 2009 ed oggi hanno
seguito un trend positivo salvo un importante calo tra il 2009 e il 2010.
Tabella 2. Soci Slow Food e condotte dal 2009 ad oggi
Fonte: dati forniti da Slow Food Centro Studi, (2014)
!
Ci si riferisce agli effetti della crisi economica manifestatasi nel 200814
3.2 I partecipanti al Salone del Gusto
Il Salone del Gusto ha da sempre rappresentato per Slow Food l’evento più
rappresentativo nel quale promuovere i propri ideali e il proprio lavoro, è quindi
importante notare come questo si sia evoluto negli ultimi anni sebbene i dati disponibili
siano pochi, soprattutto per il fatto che l’evento ha ricorrenza biennale; ciononostante si
nota come il trend sia più che positivo passando da un numero di espositori di 910 a
1000 e di visitatori da 200000 a 220000 tra il 2010 e il 2012.
!Tabella 3. Espositori e visitatori al “Salone del Gusto”
Fonte: SlowFood Italia bilancio 2012
3.3 Le vendite di SlowFood Editore
!Come anticipato in precedenza si evidenzia come i dati del mercato italiano per il
settore dell’editoria rilevino un importante calo sia in termini di volumi (-7%), che in
termini di valore (-7,8%) e quindi, inevitabilmente, tale contrazione si manifesta anche 15
per quanto riguarda SlowFood Editore. Nella tabella successiva si confrontano i margini
Nielsen Bookscan, analisi 2012.15
portati dalla vendita di contenuti editoriali, divisi in due macro-categorie quali la
“vendita di servizi giornalistici” e “altri contenuti”.
!Tabella 4. Confronto tra vendite di SlowFood Editore per anno
Fonte: SlowFood Italia bilancio 2012
!!!!!!
III. I Presidi nel Veneto : i punti di forza
Come è stato esposto nel capitolo precedente, elemento importante e di rilievo per lo
sviluppo del pensiero di Slow Food è stato il progetto dell’Arca del Gusto, attraverso la
definizione e la scoperta di Presìdi nel territorio italiano. Negli ultimi anni il numero di
questi è aumentato notevolmente e sempre più prodotti degni di tutela vengono scoperti
e portati alla vista dei consumatori. Infatti, si evidenzia un trend di crescita positivo,
salvo per quanto riguarda il calo presentatosi tra il 2006 e il 2008, dovuto ad una
Tabella 5. Quantità di Presìdi per anno
Fonte: dati forniti da Slow Food Centro Studi, (2014)
revisione del progetto volta a introdurre il marchio e, quindi, un nuovo regolamento al
quale non tutti i presìdi hanno aderito, inoltre nella revisione degli stessi alcuni sono
stati chiusi.
In particolare nel Veneto i Presìdi attuali sono 12 e rappresentativi della cultura della
regione collocati in larga parte nella provincia di Vicenza e di Padova. Sono stati presi
in analisi tre di questi prodotti allo scopo di rilevare come questi siano effettivamente in
grado di valorizzare e rilanciare il nostro territorio.
!1. Vicenza
La provincia di Vicenza si estende per quasi tremila chilometri quadrati e la sua
popolazione è di oltre 860.000 residenti con una densità media di 317 abitanti . Il 16
comune di Grumolo sta seguendo un trend di crescita positivo negli ultimi anni tanto da
arrivare a 3770 abitanti, mentre l’area dei Sette Comuni ha visto il numero di residenti
diminuire leggermente, comunque ad oggi si contano oltre 21.000 abitanti.
Tra il 1991 e il 2011, la popolazione attiva della provincia è sempre stata in aumento e
nel 2006 il settore primario ha visto aumentare notevolmente il numero di impiegati , 17
tendenza che negli anni recenti è venuta a rallentare notevolmente; infatti, come
vedremo, così come nell’economia nazionale si sono manifestati grandi rallentamenti e
contrazioni che hanno inciso nelle economie del territorio.
La crescita degli addetti in agricoltura è spiegata dalla CCIAA di Vicenza come
conseguenza positiva alle scelte strategiche di politica di tutela ambientale, che nel 2006
hanno caratterizzato lo sviluppo della provincia; è altrettanto evidente che lo sviluppo
delle produzioni tipiche abbia beneficiato di queste spinte istituzionali che non
prevedono più un rapporto diretto tra quantità e premi, ma orientano la produzione
stessa all’ottenimento di un’agricoltura rivolta al mercato senza sovrapproduzioni e più
attenta alla tutela ambientale tanto che, negli anni recenti, a seguito della contrazione
dell’economia del territorio, una delle poche ad aver risentito di un incremento è stata
proprio quella del settore alimentare.
Sempre nella stessa pubblicazione, la CCIAA afferma che la sostenibilità dello sviluppo
ISTAT, http://demo.istat.it/ , 201316
CCIAA Vicenza, Relazione sullo stato dell’economia Vicentina nel 2006.17
è l’unica strada percorribile per la crescita vicentina, sottolineando come nel passato:
!Uno sviluppo industriale e insediativo privo di programmazione ha determinato una urbanizzazione diffusa e una dissipazione della risorsa “territorio”. Negli ultimi tempi si è assistito ad una netta inversione di rotta anche soprattutto da parte di quelle Amministrazioni Comunali che in fase di pianificazione urbanistica stanno introducendo azioni e progetti indirizzati a razionalizzare l’uso del territorio attivando sinergie e integrazioni reciproche. !
E in effetti l’adozione di queste politiche ha portato anche in periodi di contrazione un
continuo sviluppo del settore primario: è quindi essenziale poter godere in maniera
rispettosa di quello che il vicentino può fornire al fine di poter assicurare vantaggi di
lungo termine.
In secondo luogo per quanto riguarda il settore terziario Vicenza è rappresentata quasi
esclusivamente dall’altopiano di Asiago, ma la quasi totalità degli arrivi è legata a
motivi d’affari o fieristici più che di visita del territorio: Vicenza non è riuscita a
posizionarsi come meta turistica a livello rilevante, infatti se in Veneto il 58% delle
presenze sono straniere, a Vicenza se ne contano appena il 27% e, nello specifico, ad
Asiago solamente il 2,4%. È quindi importante promuovere il territorio per farlo
conoscere ai visitatori: per fare questo gli enti coinvolti nella gestione del territorio (sia
pubblici che privati) hanno investito molto negli eventi legati al cinquecentenario del
Palladio (CCIAA 2007) per far conoscere il territorio della provincia sotto un punto di
vista edonistico e non soltanto affaristico.
A tal proposito bisgona rilevare che, se la caratterizzazione del territorio con un
determinato prodotto ha come conseguenza anche la diffusione dell’immagine del
territorio stesso, il marchio DOP per il formaggio Asiago, simbolo di prestigio e di
identità, non è stato sfruttato al meglio dato che gli arrivi e le presenze sono
sostanzialmente stabili, attorno ai 40.000 arrivi rappresentati oltre il 60% da turisti
italiani.
Da questa prima analisi si noterà, quindi, come il settore primario e terziario con tutte le
loro potenzialità e sinergie debbano essere utilizzati quali driver per diffondere
l’interesse verso la regione e la cultura del territorio i quali sono in grado di contrastare
il periodo di rallentamento manifestatosi nell’economie nazionali così come in quelle
regionali.
1.1 Il riso di Grumolo delle Abbadesse
In Italia il mercato del riso sta seguendo un trend positivo dovuto a diversi fattori: da un
lato il mutare delle abitudini della popolazione residente e l’apertura a nuove culture
hanno portato ad adottare costumi alimentari che hanno alla loro base il riso, dall’altro
lato il valore di questo è in forte aumento.
Tale situazione non dovrebbe limitarsi al breve periodo, ma estendersi in un arco
temporale piuttosto ampio, legandosi a cambiamenti strutturali intervenuti all’interno
dell’Unione Europea a seguito della sua espansione.
Questa riflessione sottolinea come vi sia necessità di sfruttare il momento positivo che
si sta manifestando nel settore e prospetta degli interventi profondi e a lungo termine
nell’organizzazione italiana della filiera ponendo l’attenzione soprattutto sull’aspetto
varietale del riso e non solamente sulle quantità prodotte .18
Nonostante queste premesse più che positive, in Italia il radicamento delle altre varietà
di cereali è molto profondo e le difficoltà maggiori restano la possibilità di aumentare la
superficie coltivata a riso così come la necessità di ridurre il prezzo al produttore il
quale molto spesso risulta essere a favore di mais e frumento.
A tal proposito:
“L’area coltivata a riso rappresenta l’11% della superficie arabile mondiale ed è distribuita in 122 paesi di tutti i continenti. L’Italia è il principale paese produttore di riso in Europa, con un superficie coltivata di circa 236.000 ettari, pari alla metà di quella dell’Unione Europea. La produzione italiana alla raccolta corrisponde a circa 1,6 milioni di tonnellate, metà delle quali esportate. Gran parte del riso prodotto nel mondo è destinato al consumo del paese produttore; soltanto il 6-7% della produzione mondiale è oggetto di scambi internazionali, con qualche modesta variazione legata all’andamento dei prezzi internazionali e alle politiche restrittive messe in atto dai paesi esportatori. Il mercato internazionale è quasi totalmente gestito da un limitato numero di paesi esportatori, che vedono nelle prime posizioni la Thailandia, il Vietnam, gli USA e l’India. Anche l’Italia ha un ruolo significativo nella gestione degli scambi, in quanto il prodotto esportato rappresenta circa il 60% della produzione nazionale. Il consumo di riso varia ampiamente nel mondo ed è spesso in stretta relazione con l’importanza e la diffusione della coltura nei singoli paesi. I principali paesi produttori di riso sono anche quelli con il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Riso: congiuntura del settore e 18
prospettive di ampliamento delle superfici coltivate, 2008.
più elevato consumo pro-capite annuo.” 19
!Il consumo di riso in Italia ha quindi una forte penetrazione, ma una bassa frequenza:
questo significa che nelle sue varie forme di preparazione è conosciuto dalla totalità dei
consumatori, ma, a sua volta, è consumato saltuariamente . 20
Tabella 6. Quantità di riso prodotto e venduto in Italia per anno
Fonte: indagine integrata sul consumo di riso in Italia, commissionata dall’Ente
Nazionale Risi (2014)
!La diffusione del riso è concentrata soprattutto al nord, dove incide molto anche nel
consumo domestico. Un elemento critico risulta essere la qualità del riso stesso: infatti il
consumatore mediamente non è attento alla provenienza o alla qualità di questo,
compiendo acquisti soprattutto in base alla marca; per un territorio che fa di una
produzione tipica l’immagine del territorio stesso, questa è una criticità che deve essere
affrontata con un lavoro sinergico dei diversi attori coinvolti.
Aldo Ferrero, Riso, una risorsa economica, ambientale e culturale, 2014.19
Ente Nazionale Risi, indagine integrata sul consumo di riso in Italia, 2014, Tabella 6.20
Il comune di Grumolo delle Abbadesse, in provincia di Vicenza, si estende per quasi 15
km quadrati, ma le possibilità di sviluppo sono legate alla presenza di quasi 400 ettari di
territorio e dalla forte presenza di attività primaria che si estende per 1.200 ettari. Fino
alla metà degli anni ’90 la prospettiva di sviluppo si basava soprattutto sull’industria
della discarica consortile posta all’interno del territorio comunale e ciò stava divenendo
un problema importante: il rischio, infatti, era quello di concentrare le attività industriali
quasi esclusivamente sull’accumulo di rifiuti. L’amministrazione comunale, vista la
crescita costante della popolazione ha dovuto trovare una via di sviluppo
socioeconomica che riuscisse ad allontanare tale problema: la soluzione si manifestò
nella valorizzazione e promozione di una risaia storica (le prime attestazioni risalgono
attorno all’anno Mille), di sei ville signorili antiche e di un paesaggio naturalistico
molto esteso, i quali hanno spinto il paese ad adottare il progetto Slow Food, assieme
all’associazione dei risicoltori, facendo nascere il presidio del Riso di Grumolo delle
Abbadesse.
Uno dei primi effetti positivi per il territorio di Grumolo è stato il recupero delle zone
agricole che risultavano abbandonate da tempo, ciò ha portato ad accrescere l’interesse
anche per il territorio circostante in particolare con attenzione alle ville storiche: questo
si è reso possibile grazie al lavoro preliminare concentrato sulla produzione e sulla
commercializzazione del riso.
Attualmente gli ettari destinati alla produzione di Riso di Grumolo delle Abbadesse
sono un centinaio, e sono state aperte anche nuove aziende a dimostrazione di come il
progetto abbia rilevato un’attività in espansione, infatti la scelta di aderire al presidio ha
permesso di risollevare le sorti della produzione di riso, traducendosi in attività
produttiva ed è grazie alla commercializzazione del proprio prodotto che la coltivazione
di riso di Grumolo risulta oggi essere un’attività sostenibile dal punto di vista
economico.
Il comune di Grumolo, grazie al riso e alla sua commercializzazione è riuscito in questi
anni di partecipazione a creare una propria immagine che è stata in grado di rilanciare il
territorio portando a sua volta alla creazione di altri progetti.
Alla luce delle tendenze evidenziate dalla CCIAA di Vicenza, è da sottolineare la
valenza ambientale dei progetti del comune di Grumolo: lo sviluppo sostenibile, è stato
indicato, essere una delle poche vie percorribili nel prossimo futuro; Grumolo e il
presidio del Riso hanno interpretato questa esigenza autonomamente creando un
progetto di sviluppo ecosostenibile, ma che allo stesso tempo riesce a dare una
prospettiva di sviluppo socio-economico anche ai residenti. !1.2 L’Asiago Stravecchio Di Malga dell’altopiano dei Sette Comuni
Nel settore lattiero-caseario nell’ultimo triennio le performance di produzione di latte
hanno sempre seguito un trend positivo arrivando a un grado di auto
approvvigionamento che sfiora il 90%, l’indice di esportazione a tal proposito ha ancora
ampi margini di sviluppo ed è in continuo incremento; infatti il mercato estero risponde
positivamente quasi esclusivamente alle produzioni casearie, soprattutto se certificate da
marchi di qualità. La filiera lattiero-casearia incide per il 13% sul fatturato totale del
settore agroalimentare che negli ultimi anni ha visto un trend positivo in termini di
esportazione, tanto che si parla di un aumento del 6,06% delle esportazioni rispetto
all’anno precedente . 21
L'agroalimentare è forse oggi uno dei pochi settori in grado di assicurare una crescita
misurata ma costante, pertanto ripristinare e rafforzare l'attenzione sul tema del suo
sviluppo si profila, per le singole realtà territoriali, sempre più come una scelta
irrinunciabile.
Per quanto riguarda lo status delle aziende si rileva però un trend negativo: i produttori
di latte stanno vivendo un periodo di crisi di redditività dovuta in parte all’aumento dei
costi di produzione e in parte alla diminuzione del prezzo di vendita della materia
prima. Inoltre, il settore lattiero-caseario conta un elevata frammentazione (soprattutto
in allevamenti di piccole dimensioni) che porta a elevate perdite di efficienza sia
economica che tecnica.
In controtendenza sono, invece, gli allevamenti di montagna i quali se inserirti in piani
di gestione e valorizzazione, investendo su produzioni tipiche riconducibili a un
territorio sono in grado di essere sostenute e incentivate: si contano 37 produzioni
casearie DOP sul territorio nazionale che, sfruttando le loro caratteristiche intrinseche,
hanno ampi margini di sviluppo nel mercato estero.
Il formaggio Asiago possiede un marchio di certificazione fin dal 1978, e dal ’79 la
CLAL, Italia: Riepilogo Import/Export, 2014, http://www.clal.it/?section=riepilogo_istat21
gestione della produzione, della stagionatura e della tutela è affidata al Consorzio Tutela
Formaggio Asiago. La produzione si concentra su due tipologie di formaggio: l’Asiago
d’allevo, che sfrutta un sistema di 90 malghe (il più importante sistema di alpeggio
all’interno dell’arco alpino) e l’Asiago pressato; il grado di stagionatura identifica le
forme in fresche, mezzano (6 mesi), vecchio (1 anno) e stravecchio (almeno 19 mesi).
Leggendo i dati diffusi dal consorzio di tutela e dal CCIAA si vede come la produzione
di formaggio d’allevo risulti sostanzialmente stabile così come per l’Asiago pressato.
Tabella 7. Confronto tra forme prodotte per anno
Fonte: CCIAA Vicenza, Relazione sullo stato dell’economia Vicentina nel 2012 22
!Gli acquisti domestici di formaggio Asiago seguono un trend positivo così come i valori
di produzione: i consumi sono però concentrati per il 40% al Nord Est, sintomo di un
prodotto diffuso soprattutto nell’area di produzione, identificato con un territorio
preciso e rappresentativo di questo. Nonostante questa particolarità di consumo il
prodotto è molto apprezzato anche all’estero tanto che si può notare come l’esportazione
del prodotto verso l’estero presenti un importante tasso di incremento: tra il 2013 e il
2014 le quantità esportate sono aumentate del 24,39% (281 tonnellate) così come i
prezzi al kilo che hanno visto un incremento del 7,63% (6,94 €/kg).
CCIAA Vicenza, Relazione sullo stato dell’economia Vicentina nel 2012, http://www.vi.camcom.it/22
a_242_IT_72_1.html
Nell’area dei sette comuni dell’altipiano di Asiago (Asiago, Conco, Enego, Foza,
Gallio, Luisiana, Roana e Rotzo) il settore alberghiero e ristorativo ha però subito una
brusca flessione all’inizio degli anni 2000, e ora si sta riprendendo; un punto di
debolezza che è già stato individuato dalla CCIAA è la bassa presenza di turisti
stranieri, un segmento ad alta potenzialità che riuscirebbe a dare una forte spinta al
settore della ristorazione anche perché il prodotto, come già detto, è da questi molto
apprezzato. L’attività del presidio anima non soltanto la produzione del formaggio a
lunga stagionatura, ma si concentra anche sulla salvaguardia del territorio con il
recupero e la diffusione di tecniche a basso impatto ambientale, il recupero di malghe e
di percorsi naturalistici collegati a segmenti specifici di ristorazione, integrando così la
scoperta del territorio alla tutela dei prodotti tipici.
!2. PADOVA
La provincia di Padova conta più di 920.000 residenti, il 46% della popolazione vive
nell’area metropolitana .23
I principali punti di forza dell’economia padovana sono molteplici, tra questi si
distinguono le numerose attività industriali tecnologicamente avanzate , un centro ad 24
alti servizi finanziari commerciali e organizzativi e la forte sinergia con l’università.
Inoltre il turismo risulta essere molto diffuso tanto da risultare una delle principali
attività redditizie della provincia: la zona termale di Abano e Montegrotto conta 150
strutture ricettive, nel 2012 si sono registrati più di 600.000 arrivi. Il territorio offre
inoltre numerosi monumenti storici e artistici che attirano turisti italiani e stranieri: il
turismo scientifico e culturale incide in modo significativo nella città grazie
all’università di Padova. Si rileva, quindi, un quadro di continua attività in termini di
opportunità che possono trovare ampia diffusione grazie al fermento turistico rilevato.
L’agricoltura, con più di 18.000 imprese attive, rappresenta un settore ancora stabile
nonostante la crisi di redditività degli ultimi anni del settore, questo ha portato a una
integrazione della filiera agroalimentare con l’industria e a una selezione delle imprese
ISTAT, http://demo.istat.it/ , 201323 23
Le imprese iscritte al registro della CCIAA di Padova risultano essere più di 94.000 (CCIAA, 24
2014)
nel mercato che ha portato a migliorare gli standard produttivi e qualitatitivi all’interno
della filiera. Attualmente le attività zootecniche e cerealicole sono concentrate a nord,
mentre nell’area collinare è diffusa soprattutto la viticoltura e a sud/ovest le produzioni
ortofrutticole.
!2.1 La gallina padovana
Il settore avicolo in Italia è largamente diffuso tanto che conta più di 5.000 insediamenti
produttivi posizionandosi al quarto posto per quantità di carni avicole prodotte. Il 22%
di tali siti produttivi sono locati in Veneto: la provincia di Padova si posiziona tra le
prime dieci provincie per consistenza dell’attività avicola tanto che nel 2005 è stata in
grado di raggiungere una produzione di 15.500.000 unità.
Tabella 8. Confronto tra produzione e consumo di carni avicole per anno
Fonte: UNAITALIA, Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova,
Evoluzione della produzione e del consumo di carni avicole (2012)
Il Veneto inoltre risulta essere la seconda regione in Italia anche per la numerosità
dell’industria di lavorazione di carne avicunicola: esso rappresenta il 16% del totale
nazionale.
Dagli anni ’70 ad oggi, il consumo di carne di pollo è stato in costante aumento (se si
escludono le contrazioni dovute a situazioni straordinarie, come la paura dell’aviaria),
oggi, la produzione di carni avicole ha superato il milione e 200 mila tonnellate; nel
2012 ogni italiano ha mangiato, in media, 90 Kg. di carne dei quali 19,4 di pollame .25
Il Presidio Slow Food della Gallina Padovana nel 2002 contava sette allevatori,
distribuiti in tutto il territorio della provincia i quali si sono riuniti in un’associazione,
denominata “Pro Avibus Nostris" la quale si occupa soprattutto della gestione dei
rapporti con Slow Food e la diffusione del prodotto nel territorio. Il presidio apre nel
2000, e dopo due anni le aziende aderenti passano da 5 a 7, con un forte incremento
degli addetti sia nelle stesse che in associazione. Oggi si contano 8 soci i quali allevano
a vario titolo la Padovana, dal produttivo al didattico: l’associazione, infatti, ha saputo
integrare i passaggi dall’allevamento alla tavola creando una filiera sanitariamente
corretta avviando, inoltre, la collaborazione con le scuole e con le istituzioni locali,
Veneto Agricoltura, Provincia, Comune e Camera di Commercio, per proseguire nel
progetto di conservazione e miglioramento della razza.
In partenza si trattava di allevamenti amatoriali; il presidio, insieme alla Condotta
Padovana e alla CCIAA, ha fornito lo stimolo per far nascere un vero e proprio mercato,
il quale, oltre a spiegare l’incremento della produzione, al contempo conferma la
validità dell’iniziativa non solo nel tutelare prodotti tradizionali, ma anche nell’attivare
un’economia attorno ad essi, stimolandone quindi la conservazione e la diffusione.
Nel 2007 viene brevettato il Pollo Lattemiele: la CCIAA di Padova, l’associazione
Promopadova, le associazioni dei produttori e l’APPE, hanno lavorato per la creazione
di un nuovo prodotto in grado di identificare e di identificarsi con il territorio (concetto
tradizione dove c’è innovazione). Ora il presidio della Gallina Padovana sembra in forte
difficoltà, non riuscendo, contrariamente ai primi anni, a coinvolgere nuovi produttori e
nuovi canali distributivi sebbene siano comunque attive continue iniziative, quali, ad
esempio, sagre di paese volte alla diffusione del prodotto.
Un segnale più positivo si è ottenuto dal mondo della ristorazione a Padova, il quale ha
abbracciato positivamente il progetto di “Menu a km zero” lanciato dalla Coldiretti del
Veneto, dimostrando una vera e propria sensibilità agli stimoli di sviluppo sostenibile
UNAITALIA, Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova, Evoluzione della 25
produzione e del consumo di carni avicole, 2012, http://www.unaitalia.com/Filieraavicola.aspx
così come una grande coordinazione tra le varie imprese ristorative e la catena di
distribuzione.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IV. I numeri del turismo enogastronomico
I capitoli precedenti hanno rilevato come attraverso il Cibo, ossia la cultura
enogastronomica del territorio, si sia in grado di diffonderle e di incrementare
l’interesse sia dei cittadini che dei visitatori nei confronti delle varie regioni. Inoltre, si è
voluto evidenziare il potenziale del territorio veneto al fine di rilevare parte dei
numerosi prodotti di eccellenza in grado di promuovere efficacemente la regione e di
incentivare la ripresa economica della stessa.
A tal proposito, al fine di comprendere come il Cibo sia in grado di incidere
positivamente nelle economie, ci si pone ora lo scopo di evidenziare come il turismo
enogastronomico stia prendendo sempre più piede, evidenziando come la ristorazione
legata ai valori del territorio risulti essere una vera e propria opportunità da sfruttare per
l’Italia.
!1. Gastronomia come fattore di turismo
L’ enogastronomia rappresenta un elemento in grado di rilanciare i territori. Per fare
questo è necessaria la collaborazione degli attori presenti all’interno degli stessi al fine
di creare situazioni e ambienti che diano nuova attrattività e opportunità economiche,
sia per il territorio che per la sua popolazione. Tale obiettivo è perseguito dal
“Destination Marketing”, il quale si focalizza in primo luogo sul turismo cercando di
definire obiettivi di lungo termine per lo sviluppo e il rilancio analizzando l’ambiente
interno ed esterno di un territorio.
A tal proposito è emblematico rilevare come il turismo enogastronomico nell’economia
italiana sia sempre più diffuso ed apprezzato, infatti:
!Salgono al numero record di 4698 le specialità alimentari presenti sul territorio nazionale che sono state ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sul censimento dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni nel 2013, aggiornato con la pubblicazione della tredicesima revisione sulla Gazzetta Ufficiale. I prodotti censiti erano 4671 lo scorso anno, ma rispetto al 2000 quando è iniziato il lavoro di catalogazione a livello regionale sono piu' che raddoppiati quest'anno sotto la spinta - sottolinea la Coldiretti – della forte crescita del turismo enogastronomico in Italia.
!
Nella stessa analisi la Coldiretti afferma che proprio il Cibo rappresenta il principale
driver per la scelta della meta di vacanza tanto da superare in importanza le visite ai
musei e mostre e lo shopping.
Tabella 9. Confronto d’importanza dei fattori nelle decisioni di viaggio
Fonte: COLDIRETTI, analisi 2014
!Se da tale analisi risulta subito chiaro come l’enogastronomia rappresenti un elemento
indubbiamente rilevante, è importante evidenziare come, nel 2010, il 5% delle vacanze
in Italia sia stato motivato da interessi legati all’enogastronomia. Gli italiani hanno
rappresentato solo il 35,7% del totale della clientela, mentre nel 2013 i turisti hanno
speso nel territorio italiano ben 24 miliardi di euro tra pasti, ristoranti, pizzerie, trattorie
e agriturismi ; etc. Infatti, parte di questa spesa, pari al 33%, è stata destinata alla 26
Nell'estate 2012 le presenze negli agriturismi italiani sono arrivate a 4,1 milioni, con un 26
aumento rispetto all'estate 2011 (+2,5%)
tavola con l’acquisto di prodotti tipici per uso domestico.
Un trend positivo si riscontra soprattutto nel settore vinicolo dove i dati del Censis per
l’Osservatorio sul Turismo del Vino parlano del +12% del 2012 sul 2011, un risultato di
grande importanza.
Tabella 10. Confronto tra le attività svolte durante il turismo enogastronomico
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo su dati Unioncamere, analisi 2012
!A vantaggio di ciò si accostano tre importanti elementi: in primo luogo il mercato del
turismo enogastronomico è ancora di nicchia e lascia spazio ad ampi margini di crescita
dovuti alla bassa concorrenza. In secondo luogo è importante che il Cibo, c.d. “Italian
food” con tutte le sue culture, venga percepito dalle altre economie , sia in via di 27
sviluppo (come India, Brasile, Cina) che sviluppate (come la Russia), come un vero e
Secondo le statistiche elaborate da Contesti Turistici e dati dell’Osservatorio Mercati Esteri 27
2012 del TTG Italia
proprio status symbol e sia sempre più apprezzato in tutto il mondo. Il terzo elemento di
rilevante importanza è dato dal fatto che il turismo enogastronomico tratta un tema
ampiamente trasversale in grado di riversarsi su numerose altre economie dell’Italia e,
quindi, in grado di generare nuovo interesse e grande fermento nei mercati italiani.
Dai dati in Tabella 10 emerge come dall’enogastronomia l’interesse degli individui
spazi poi in numerosi altri settori che, grazie a questa, sono in grado di trovare nuove
opportunità di crescita e diffusione.
Tabella 11. Confronto tra la spesa delle famiglie nella ristorazione per anno
Fonte: elaborazioe C.S. FIPE su dati ISTAT, analisi 2013
!Se da un lato è importante evidenziare come i visitatori esteri vedano nell’Italia una
meta turistica di grande rilievo grazie ai punti evidenziati in precedenza, dall’altro è
importante evidenziare come gli italiani stessi, negli ultimi anni, abbiano cominciato ad
apprezzare il cibo di qualità e a sperimentarlo nei diversi centri di ristorazione. Infatti, i
dati rilevati dalla FIPE rilevano come, anche in un periodo di economia fortemente 28
La Federazione italiana dei pubblici esercizi (FIPE) è una associazione di imprese che 28
operano nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento. Aderisce a livello nazionale alla Confcommercio (Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi) organizzazione delle imprese del settore terziario e ne rappresenta insieme a Federalberghi, Fiavet, FAITA e Rescasa il settore turismo.
turbolento come quello che si è vissuto in questi anni, i consumi del c.d. “fuoricasa”
restano una voce di spesa significativa. La spesa delle famiglie italiane per la
ristorazione vale 73 miliardi di euro pari al 35% dell'intera spesa alimentare.
Dopo Spagna e Gran Bretagna, l'Italia è il paese europeo con la maggiore incidenza dei
consumi alimentari fuori casa sul totale della spesa alimentare (35% a fronte di una
media europea del 32%). In termini di spesa pro-capite, gli italiani spendono in
ristorazione circa 1.200 euro l'anno, il 32% in più dei francesi e il 53% più dei tedeschi.
Inoltre le abitudini degli italiani sono mutate sempre più negli anni: si registra un
cambiamento importante nella visione della cena. Se nel 1993 questa rappresentava il
pasto principale della giornata per il 17% della popolazione, oggi, invece, risulta esserlo
per il 24% e ciò si riflette nel settore della ristorazione tanto che a cenare fuori casa
almeno una volta a settimana è il 28,3% dei cittadini.
Tutto ciò dimostra che, a dispetto della crisi economica, gli italiani amano frequentare i
ristoranti, nonostante una situazione economica certo non favorevole.
!!!!!!!!!!!!
V. Conclusioni
Nell’ analisi effettuata ci si è domandati se attraverso le tipicità enogastronomiche dei
territori si fosse in grado di rilanciare l’economia italiana odierna.
Per fare questo si è analizzato il concetto di Cibo partendo dalla storia rilevando come
questo sia vera e propria cultura, ossia incontro tra tradizione e innovazione.
In seguito si sono esposti i grandi successi ottenuti da Slow Food per rilevare come
effettivamente la valorizzazione dell’enogastronomia possa avere successo nei mercati.
Da ciò si è passati ad esporre le eccellenze del territorio veneziano focalizzandosi su tre
tipicità presidiate da Slow Food al fine di evidenziare come la valorizzazione di queste
grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali abbia portato a differenti
vantaggi nelle economie stesse.
Dopo aver esposto le qualità del territorio Veneto ci si è concentrati ad osservare come
le economie reagiscano positivamente alle spinte portate dai mercati enogastronomici,
rilevando le statistiche recenti in tema di turismo e di ristorazione.
A conclusione dell’elaborato, è opinione di chi scrive che quanto esposto in precedenza
rappresenti una vera e propria opportunità per l’economia italiana e, in particolare, per il
Veneto, da non mancare. Infatti, i numerosi riscontri positivi portati dai dati hanno dato
conferma di come l’enogastronomia sia effettivamente una buona leva per il rilancio di
un territorio se questa viene supportata dalle amministrazioni locali. Inoltre la scarsa
competitività in tali mercati consentirebbe un rapido sviluppo e un successo che sarebbe
in grado di agevolare la ripresa economica del Paese grazie alle numerose tipicità di cui
questo dispone.
!!!!!!
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
- Bagnoli L., Manuale di geografia del turismo, Milano, Utet Università, 2006
- CCIAA Padova, Conoscere Padova, i numeri dell’economia provinciale
(internet)
http://www.pd.camcom.it/dev_cciaa/
- CCIAA Padova, Prezzi comparto avicolo (al 16.05.2014), (internet) http://
www.pd.camcom.it/elenco-uffici/prezzi/schede/prezzi-579/prezzi-comparto-
avicolo.html
- CCIAA Vicenza, Relazione sullo stato dell’economia Vicentina nel 2012,
(internet)
- Corigliano M., Viganò G. (a cura di), I presidi Slow Food: da iniziativa
culturale ad attività imprenditoriale, Il Sole24Ore, Slow Food, ottobre 2002,
(internet) http://www.fondazioneslowfood.it/inc_sito/eng/risultati.pdf
- Corigliano M. & Viganò G., 2004, Turisti per gusto. Enogastronomia,
territorio, sostenibilità, Novara : istituto geografico De Agostini
- Ente Nazionale Risi, Indagine integrata sul consumo di riso in Italia (2014),
(internet) http://www.enterisi.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=17505&idArea=17548&idCat=17552&ID=17552&TipoElemento=ca
tegoria
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Riso: congiuntura
del settore e prospettive di ampliamento delle superfici coltivate (2008),
(internet) http://www.enterisi.it/doc/Riso%20-%20Prospettive%20semine
%202008.pdf
- Montanari M., 2005, Il cibo come cultura, Laterza
- Paolini D., 2000, I luoghi del gusto : cibo e territorio come risorsa di
marketing, Milano, Baldini & Castoldi
- Petrini C., 2013, Cibo e libertà, Slow Food Editore
-UNAITALIA, Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova,
Evoluzione della produzione e del consumo di carni avicole, 2012, http://
www.unaitalia.com/Filieraavicola.aspx
- Auditel, http://www.auditel.it/
- CCIAA di Padova, http://www.pd.camcom.it/
- CCIAA di Vicenza, http://www.vi.camcom.it/
- CLAL società di consulenza nel settore lattiero-caseario, http://www.clal.it/
- Confcommercio, http://www.confcommercio.it/
- Confindustria Veneto, http://www.confindustria.veneto.it/
- Consorzio di Tutela Formaggio Asiago, http://www.asiagocheese.it/
- Direzione Sistema Statistico Regionale V eneto, http://
statistica.regione.veneto.it
- Ente Nazionale Risi, http://www.enterisi.it/
- Federazione Italiana Pubblici Esercenti, http://www.fipe.it
- Fondazione Slow Food per la biodiversità Onlus, http://
www.fondazioneslowfood.it
- Istituto Nazionale di Statistica, http://www.istat.it/
- Osservatorio Nazionale del Turismo su dati Unioncamere, http://
www.unioncamere.gov.it/P43K774O0/osservatorio-turismo.htm
- Provincia di Padova, http://www.provincia.pd.it/
- Provincia di Vicenza, http://www.provincia.vicenza.it/
- Slow Food, http://www.slowfood.it/
- Unioncamere, http://www.unioncamere.it/
- Unaitalia, http://www.unaitalia.com/
- Zanichelli, servizi e tecniche di enogastronomia http://
online.scuola.zanichelli.it/enogastronomiacucina/
!