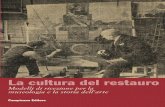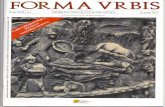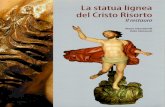Il restauro e la valorizzazione del tofet di Mozia
Transcript of Il restauro e la valorizzazione del tofet di Mozia
Sici
lia o
ccid
enta
le
Stu
di,
rass
egn
e, r
icer
che
29
Sicilia occidentaleStudi, rassegne, ricerche
a cura di Carmine Ampolo
EDIZIONI DELLA NORMALE
AGGIUNGERE CODICE A BARRE
e 40,00
Gli studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nell’antichità
sono per la Scuola Normale Superiore una tradizione ormai
consolidata. Questo volume, che si affianca a quello dedicato
al tema dell’agorà (Agora greca e agorai di Sicilia, 2012), offre
un quadro assai ricco delle più recenti ricerche archeologiche
e novità epigrafiche di un’area fortemente multiculturale e
multietnica.
Sono qui raccolti anche i risultati delle ricerche e delle attività
condotte dal Laboratorio di Scienze dell’Antichità della
Scuola Normale, integrati da un CD con i posters presentati in
occasione delle Settime Giornate Internazionali di Studi sull’area
elima e la Sicilia Occidentale.
Redazione a cura di Chiara Michelini, Maria Adelaide Vaggioli
Il volume contiene:Atti delle settime giornate internazionali di studi sull’area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo Erice, 12-15 ottobre 2009Workshop «G. Nenci» diretto da Carmine AmpoloVol. II
Altri studi sulla Sicilia occidentale non presentati in tale occasione
Indice
Abbreviazioni ix
Rassegne e comunicazioni archeologiche ed epigrafiche
Rassegna d’archeologia: scavi nel territorio di Palermo (2007-2009)Francesca Spatafora 13
Palermo. Uno scavo d’emergenza nell’area di Piazza MarinaFrancesca Spatafora, Carla Aleo Nero, Lucio Calcagnile, Gianluca Quarta, Marisa D’Elia, Giuseppe Montana, Luciana Randazzo, Francesca Terranova 23
Un nuovo documento epigrafico da SoluntoAlba Maria Gabriella Calascibetta, Laura Di Leonardo 37
Scavi nella necropoli occidentale di Himera, il paesaggio e le tipologie funerarieStefano Vassallo, Matteo Valentino 49AppendiceAnforoni corinzi di età arcaica rinvenuti nelle necropoli di HimeraMatteo Valentino 59
Primi dati antropologici dalla necropoli occidentale di HimeraPier Francesco Fabbri, Norma Lo Noce, Serena Viva 73
Un graffito punico su anfora tardo-arcaica dalla necropoli di HimeraRossana De Simone 85
L’insediamento di Monte Presepio nella Valle del Fiume Torto: un comprensorio della chora di HimeraRosa Maria Cucco 87
Monte Iato: scavi 2007-2008Hans Peter Isler 91
Il teatro alto-ellenistico di Montagna dei Cavalli/IppanaStefano Vassallo, Donata Zirone 105
vi Indice
Il sito fortificato medievale del Castellaccio di CampofioritoRoberto Graditi, Stefano Vassallo 113
Contessa Entellina: foto aeree 1955-2000. Persistenze e mutamenti nel paesaggio naturale ed antropicoAlessio Arnese, Alessandro Corretti, Antonino Facella, Chiara Michelini, Maria Adelaide Vaggioli 121
Materiali fenici, punici e di tradizione punica da Rocca d’Entella (PA). Un bollo e due graffitiMariela Quartararo 129
Contessa Entellina (Palermo). Indicatori di attività siderurgica secondaria nel Medioevo da Entella e dal territorioAlessandro Corretti, Laura Chiarantini 137
I bolli sulla Terra Sigillata Italica dalle ricognizioni nel territorio comunale di Contessa EntellinaAurora Maccari 151
Dinamiche commerciali e di approvvigionamento ceramico nel territorio di Contessa Entellina in età imperiale e tardoantica: riflessioni preliminari su quattro siti-campioneAntonino Facella, Marianna Perna, Paola Puppo, Maria Adelaide Vaggioli, Donata Zirone 155
Attività della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani: triennio 2007-2009Rossella Giglio Cerniglia 179
Scavi e restauri dell’Università di Roma ‘La Sapienza’ a Mozia, 2007-2009: il Tempio del Kothon, il Temenos Circolare, il Sacello di Astarte e il TofetLorenzo Nigro 207
Il restauro e la valorizzazione del tofet di MoziaRossella Giglio Cerniglia 219
Lilibeo (Marsala). Risultati della campagna 2008Rossella Giglio Cerniglia, Paola Palazzo, Pierfrancesco Vecchio, Emanuele Canzonieri 225
Nuove Ricerche a Castellazzo di Poggioreale. Campagne 2008-2009Rossella Giglio Cerniglia, Gioacchino Falsone, Paola Sconzo 239
vii Indice
Monte d’Oro di Montelepre. La necropoli di Manico di Quarara. Nuovi datiGianclaudio Ferreri 251
Per un riesame della documentazione materiale dello scarico di Grotta Vanella a SegestaMonica de Cesare, Alfonsa Serra 261
Segesta. Agora: la stratigrafia dell’ala Ovest della stoaAngela Clara Infarinato 275
Le attività dell’Institute of Fine Arts - NYU sull’Acropoli di Selinunte (2006-2010)Clemente Marconi 279
La Soprintendenza del Mare alla ricerca del luogo esatto della Battaglia delle Egadi (241 a.C.)Sebastiano Tusa, Jeff Royal, Cecilia Albana Buccellato 287
Altre ricerche della Scuola Normale Superiore
Tyndaris: per uno status quaestionis sulle ipotesi di ubicazione dell’agora/foroMaria Ida Patrizia Gulletta 297
Per un’analisi della figura di Eracle in Sicilia: dal VII sec. a.C. all’età romana Michela De Bernardin 305
Il santuario e la dea di Erice: una vocazione politica?Beatrice Lietz 313
Ei[rgesqai ajgora`~: l’allontanamento degli omicidi dallo spazio pubblicoIrene Salvo 319
La colonisation grecque de la Sicile dans les fragments de Diodore Aude Cohen-Skalli 325
Presentazione di strumenti informatici
SNS-Greek & Latin 6.1 per Mac OS X SNS-Greek & Latin 2.1 per WindowsAntonella Russo 333
viii Indice
Mnamon: Portale delle Antiche Scritture del MediterraneoAntonella Russo, Anna Santoni 335
MNHMHS cARIN
Commemorazione di Vincenzo TusaHans Peter Isler 343
Vincenzo Tusa: un ricordo sempre vivoFrancesca Spatafora 345
Vincenzo TusaSebastiano Tusa 349
Illustrazioni 353
Allegato CD con posters
Abbreviazioni
Autori antichi
Sono state adottate, di norma, le abbreviazioni dell’Oxford Classical Dictionary, Oxford-New York 19963 o del dizionario di H.G. Liddell, R. Scott, Oxford 19689, e del Thesaurus Linguae Latinae. Index, ed. Teubner, Lipsiae 1904, ad eccezione dei seguenti casi: Apoll. Rhod., Diod., Demosth., Mythogr., Plato.
Opere generali
BÉ = Bulletin Épigraphique, in «Revue des Études Grecques».BMC = Catalogue of the Greek Coins in the British Museum.BTCGI = Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle
Isole Tirreniche (fondata da G. Nenci e G. Vallet, diretta da C. Ampolo), Pisa-Roma 1977-1994, Pisa-Roma-Napoli 1996-2012.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863-CIS = Corpus Inscriptionum Semiticarum, Paris 1881-EAA = Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica ed Orientale, Roma 1958-FGrHist = Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1923-ICO = M.G. Guzzo Amadasi, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in
Occidente, Roma 1967 (Studi Semitici, 28).ICret = M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, I-IV, Roma 1935-1950.IG = Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae
Borussicae editae, Berolini 1873-IGDS = L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales de Sicile: contribution à
l’étude du vocabulaire grec colonial, Rome 1989.IGRRP = R. Cagnat (a cura di), Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes,
I-IV, Parigi 1906-1927.IGUR = L. Moretti (a cura di), Inscriptiones Graecae Urbis Romae, Roma
1968-1990.ILAlg = Inscriptiones Latinae de l’Algerie, Paris-Alger 1922-ILS = H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin 1892-1916.LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologie Classicae, Zürich-München 1981-LSCG = F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques, Paris 1969.LSS = F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques. Supplément, Paris 1962.RE = Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (neue
bearb.), Stuttgart-München 1893-1972.RIC = H. Mattingly, E.A. Sydenham and other, Roman Imperial Coinage,
1923-1967.SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden 1923-SNR = Sylloge Nummorum Romanorum.
x Abbreviazioni
Periodici
Sono state adottate, di norma, le abbreviazioni dell’Année Philologique, ad eccezione delle seguenti e dei titoli riportati per esteso:
AnnInst = Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica.ArchMed = Archeologia Medievale.BCA Sicilia = Beni Culturali e Ambientali. Sicilia.BCSFLS = Bollettino del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani.QuadAMessina = Quaderni dell’Istituto di Archeologia della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Messina.QuadMusSalinas = Quaderni del Museo Archeologico Regionale «A. Salinas».SicA = Sicilia Archeologica.
1. Premessa
Il tofet di Mozia sull’isola di San Pantaleo, nella laguna dello Stagnone di Marsala, costituisce quasi certamente il fulcro culturale e religioso più impor-tante per la comunità fenicia e punica che viveva sull’isola; il santuario, infatti, accompagna per secoli la storia della città ed è frequentato anche oltre la fine della sua configurazione urbana.
Esso è organizzato come uno spazio complesso, aperto al seppellimento dei sacrifici nel campo d’ur-ne, dove convergono elementi di cultura materiale fenicia, greca e indigena e dove sono presenti, in for-me e tipologie ancora non del tutto definite, edifici architettonicamente rilevanti, frutto di una elabora-zione di stili e tecniche di origini diverse.
Il tofet per la sua intrinseca peculiarità di area de-stinata a sacrifici e deposizioni connessi anche al mondo infantile, ha rappresentato nell’immaginario dell’opinione pubblica e nell’ambito della fruizione turistica un luogo di inquietante attrazione dovuta alla semplificazione e alla accentuazione del signifi-cato, ancora dibattuto, dell’incinerazione degli infan-ti e del loro seppellimento nel santuario.
Nel santuario del tofet1, unico finora nel suo gene-re in Sicilia, è documentata la stratigrafia del campo di urne e di cinerari che risale, attraverso otto stra-ti, dalla fine dell’VIII al IV sec. a.C.; sono presenti diverse installazioni di culto, tra le quali il sacello quadrato posto al centro del campo di urne e rivolto verso di esso, nel quale probabilmente erano collo-cati simulacri divini e immagini apotropaiche rinve-nuti in una stipe posta tra due blocchi davanti allo stesso sacello.
Nella configurazione più antica (Fase A) il tofet, delimitato a Sud da un muro di recinzione ripreso nelle indagini odierne, vedeva la presenza del sacello quadrato e, a Ovest, di un pozzo circolare posto di fronte ad un edificio a pianta allungata. Negli strati più antichi le urne sono semplici olle monoansate e vasi di impasto appartenenti sia alla tradizione indi-
gena sia – ovviamente – a quella fenicia con semplici segnacoli costituiti da ciottoli.
Nella configurazione più recente (Fase B) il San-tuario viene incluso e delimitato a Nord dalla cin-ta muraria, viene allargato verso Est, ampliando il campo di urne verso Est, e viene esteso anche verso Occidente con l’aggiunta del Sacello A, un tempietto in antis con una singola colonna dorica, nel quale è stato rinvenuto un tronetto fiancheggiato da sfingi. Questa struttura subì una spoliazione e nei cavi di fondazione vennero deposte numerose figurine al tornio di terracotta.
L’area era stata oggetto nel 1993 di una ultima campagna di scavi, volta a preparare il monumento alla musealizzazione, nella quale era prevista la rico-struzione di un momento di vita del santuario, rea-lizzando copie dei vasi e delle stele.
A tale scopo si era proceduto all’asportazione di uno strato archeologico, prelevando vasi e stele; la protezione dello strato sottostante, sul quale in se-guito si sarebbe dovuto stendere uno strato di mate-riale inerte, fu assicurata dalla costruzione di tettoie di legno, a loro volta protette da fogli di plastica e brecciolino. L’intera area di scavo venne recinta da una rete metallica al fine di evitare intrusioni.
Purtroppo le tettoie, per l’azione combinata degli agenti atmosferici e per l’opera instancabile dei co-nigli, sono crollate e hanno quindi cessato di eserci-tare la loro originaria funzione protettrice. Si erano anzi trasformate in un elemento dannoso, in quanto l’acqua piovana ristagnava all’interno, agevolando la crescita di vegetazione spontanea.
Si è reso quindi necessario dismettere queste tetto-ie, per assicurare la conservazione dei reperti ancora presenti in situ (fig. 324) e permettere, dopo sedici anni di precaria conservazione dei campi d’urne, una riapertura dell’area e, nello stesso tempo, consentire ai visitatori una lettura minima e non invasiva delle modalità d’uso e delle specificità del tofet.
Un finanziamento della Provincia Regionale di Trapani, finalizzato alla dismissione delle coperture
Il restauro e la valorizzazione del tofet di Mozia
220 Rossella Giglio Cerniglia
lignee poste a protezione temporanea dei tre cam-pi d’urne rinvenuti nel tofet di Mozia (fig. 325), ha permesso di intervenire sul santuario con tre diverse operazioni2:
1. Conservazione e salvaguardia di quanto era an-cora visibile delle deposizioni con rete di fibra pla-stica e pietrisco: si è così provveduto alla completa sigillatura delle deposizioni e delle urne che erano ancora a vista sul livello di calpestio antico dopo lo smantellamento della struttura lignea. Sono stati, poi, consolidati settori e brevi tratti murari che erano in fase di degrado o che avrebbero presentato in futu-ro situazioni critiche per il dilavamento dovuto agli agenti atmosferici.
2. Tre diversi settori sono stati destinati alla mu-sealizzazione nell’area aperta delle deposizioni e dei sacrifici con l’introduzione di copie delle urne – olla globulare e brocca con collo cilindrico – e il posi-zionamento delle stele e delle ciste originali. Questi settori sono stati realizzati dove lo scavo di Whitaker e le indagini della Ciasca avevano approfondito i li-velli delle deposizioni, al centro e ad Est del santua-rio, così da sfruttare adeguatamente la differenza di quota e permettere così una durevole conservazione dell’allestimento. Il posizionamento delle stele, del-le ciste e delle urne è stato concepito per offrire al visitatore la massima visibilità secondo una ampia tipologia e varietà delle deposizioni, tratte dalle se-quenze stratigrafiche individuate dalla Ciasca; sullo strato di pietrisco che protegge la superficie origina-ria del campo d’urne è stato steso un livello di malta-cemento misto a terra naturale la cui superficie, nel momento della stesa, è stata coperta ancora da terra naturale umica ad imitazione del livello di frequen-tazione del santuario così come appariva nella docu-mentazione all’atto dello scavo. Sono state utilizzate 41 copie di ceramica, 19 stele e 15 ciste originali di calcarenite.
3. è stata avviata una preliminare rilettura della planimetria finale, elaborata dall’arch. Ezio Mitchell al termine degli interventi di copertura nel 1993; tale verifica ha permesso di constatare la presenza sul ter-reno di altre strutture murarie o parti di edifici non notati in pianta, elementi che integrano in modo più articolato la storia degli eventi edilizi all’interno del santuario. è stato avviato lo scavo della superficie umica del settore meridionale del santuario, esterno a T1, per verificare l’effettivo limite del tofet ed even-tuali strutture ad esso annesse. Questa attività si è
configurata solo come indagine esplorativa, premes-sa per più consistenti interventi da effettuare nelle ricerche future.
In ultimo, in connessione con i lavori di restauro, l’équipe dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, coor-dinata da Lorenzo Nigro, ha ripreso studi sistemati-ci sulle urne e sul loro contenuto, incluse analisi del DNA e di microstratigrafia interna delle stesse con l’ausilio delle più moderne tecnologie.
2. Restauro delle opere murarie3
Alcune strutture mostravano segni di degrado avanzato, dovuto alla sfaldamento della malta di argilla originaria che legava il pezzame di calcare e di calcarenite. L’uso della malta-cemento, prevista per le opere di restauro, è stato in parte modificato e adattato al contesto delle strutture murarie, con terra naturale setacciata e depurata proveniente dallo scavo dell’humus all’interno del santuario stesso. In alcuni casi la terra è stata ‘spolverata’ sulla superficie ancora fresca della malta mentre, in altri casi, terra sciolta in acqua è stata spalmata sulla superficie del-le commessure riempite dalla malta e spazzolata con una scopa morbida.
Nel settore Ovest è stata ripristinata la cosiddetta piattaforma/altare M7 posta all’interno del sacello A, con integrazioni e riparazioni: i muretti di cemento realizzati durante le campagne di indagine degli anni Settanta del Novecento posti a sostegno della parete meridionale della piattaforma sono stati coperti con muretti a secco di pietre irregolari di calcare rinzep-pate con terra semplice.
Nel muro M6 (fig. 329) sono state integrate la parte inferiore, dilavata dall’acqua piovana, e la cresta con malta e terra.
Lungo il paramento Ovest di M4, all’interno del corridoio tra A e b, è stata realizzata una sottofon-dazione nel settore più a Nord del muro con legante a base di terra depurata: il muro M5 è stato conso-lidato con malta e terra su buona parte della cresta superiore.
Nel settore centrale del santuario presso il com-plesso di strutture murarie denominato in pianta come e, sono stati reintegrati nella loro posizione ori-ginaria i blocchi pertinenti all’allineamento D poiché il cordolo di cemento armato che li sosteneva aveva ceduto; i blocchi sono stati allettati su una sottofon-
221 Il restauro e la valorizzazione del tofet di Mozia
dazione realizzata con piccole pietre legate a secco con terra semplice.
Nel settore orientale le situazioni di degrado ri-guardavano la facciavista Nord del muro di limite Sud T1, il paramento Ovest di ME/MEA, tratto di fortificazione al confine del santuario ad Ovest e T3 che gli si lega.
Alcuni corsi di T1, presso l’angolo SudEst del san-tuario, nelle lacune sulla faccia Sud sono state esegui-te delle integrazioni con malta-cemento e pezzame di piccole dimensioni di calcare su brevi tratti.
T3 mostrava parte del paramento meridionale in crollo con il nucleo ormai a vista e la cresta residua con blocchi di grandi dimensioni pericolanti; è stata quindi integrata tutta la parete orientale con un al-tro paramento, in parte a sacco, in parte con malta-cemento, per sostenere i blocchi superstiti mentre la porzione del nucleo a vista nel settore orientale è stata rinzaffata con malta-cemento, integrata con pezzame di calcare ridotto in frammenti e, infine, spalmata terra sciolta in acqua sulle commessure e le integrazioni.
ME/MEA mostra sul paramento Ovest una tecni-ca a blocchi trasversali intervallati da spazi riempiti da pezzame irregolare misto a malta di fango; alcuni di questi intervalli erano collassati per dilavamento mentre altri avevano perduto completamente il pa-ramento visibile; sono state effettuate integrazioni e sottofondazioni per lo più con terra depurata e pez-zame all’esterno mentre nel nucleo è stata utilizzata malta-cemento.
3. Musealizzazione
La possibilità di una lettura agevole del ‘monu-mento tofet’ ha costituito l’intervento prioritario per una fruizione adeguata del luogo sacro. La selezione delle aree dove realizzare un allestimento museale che riproducesse le attività religiose e funerarie che si svolgevano all’interno del santuario (fig. 330) è sta-ta effettuata tentando di armonizzare le aree per la fruizione con quelle destinate alla sola conservazione delle urne originarie, protette sotto la rete frangiven-to e il pietrisco.
I tre diversi allestimenti sono stati posizionati nei settori centrale e orientale (fig. 331); la disposizione dei vari elementi – stele, urne, ciste – ha privilegiato una impostazione il più possibile didattica elaboran-
do in modo totalizzante tutte le caratteristiche in-dividuate nella lunga storia del tofet, concentrando, quindi, in una unica immagine sincronica la diacro-nia delle varie tipologie di deposizione che hanno caratterizzato i seppellimenti attraverso i secoli. Si è, quindi, preferito sottolineare l’ambientazione sce-nografica ricostruendo un contesto ‘perfetto’, ipo-tetico: gruppi di urne sparse, stele in relazione con gruppi di urne, cista con stele e urna davanti alla cista.
Anche la scelta delle stele (fig. 332), originali, ha un carattere esemplificativo delle possibili varianti, le più comuni, già elaborate nel corso delle indagini della Ciasca. Inoltre, si è cercato di sottolineare l’a-spetto realistico del campo d’urne con l’utilizzo di uno strato di terra che copre la coltre di cemento che fissa i vari elementi.
4. Analisi dei contesti architettonici
Nel corso dell’analisi e della verifica delle struttu-re sulla pianta generale (fig. 326) l’attenzione è stata focalizzata su tre diversi settori del santuario, quello occidentale e quello centrale.
Ad Ovest (fig. 327), tra il campo d’urne princi-pale e il sacello A, è presente uno stretto corridoio, perpendicolare alla linea di costa, che separa le due aree principali del santuario; la sua funzione, pro-blematica dal punto di vista dell’uso, si configura invece come una sorta di spazio di risulta connesso alle vicende edilizie dei due diversi settori del tofet; a Nord il corridoio non presenta alcuna chiusura ed è visibile, in situ, sulla superficie del terreno parte di un acciottolato che indurrebbe ad interpretare que-sta lacuna nel muro di terrazzamento settentrionale come un passaggio attraverso il muro di confine del-lo spazio sacro. Non sopravvivono, tuttavia, parti di muro o incavi che facciano ipotizzare la presenza di battenti per una postierla e resta, quindi, incerta la presenza di un passaggio protetto senza la verifica di qualche sistema di difesa o di chiusura.
La realizzazione di questo corridoio longitudinale tra i due settori principali del tofet, da una rinnova-ta analisi delle strutture murarie conservate, sem-bra essere il risultato di una trasformazione edilizia dell’area santuariale che produce come esito finale un ambitus tra due realtà architettoniche differenti; la presenza di una canaletta di smaltimento delle ac-
222 Rossella Giglio Cerniglia
que nel settore Sud di M6 sottolinea questo aspetto di spazio di servizio.
Un nuovo elemento si è aggiunto alla compren-sione del tempietto occidentale (fig. 328): è un si-stema di accesso, in M 6, che si configura come una soglia monumentale4 – L 26 – inquadrata da stipiti quadrangolari monolitici posti di testa, tamponata successivamente con una tecnica grossolana e poco accurata. Il sacello, la soglia e il muro M 14 sono rea-lizzati con blocchi isodomi di calcarenite compatta, apprestati, apparentemente, sulla scorta di un unico progetto costruttivo ed architettonico: avremmo, quindi, un recinto di cui conosciamo solo due lati, M 6 ed M 14, la soglia monumentale L 26 e, al centro, il sacello A con il podio/altare sul lato corto orientale. Quando la soglia era in funzione l’area antistante do-veva essere libera da edifici poiché è difficile credere che questo accesso ben costruito introducesse ad un angusto corridoio.
M 6 continua a Sud della soglia con una tecnica a telaio che utilizza lastroni irregolari come piedritti e pezzame minuto nei pannelli; non è chiaro se questo breve lacerto murario fosse originariamente in fase con la soglia o se costituisca, insieme alla tampona-tura che preclude l’accesso, una medesima attività costruttiva.
La struttura b (fig. 335), solo in parte scavata a Nord, è costituita da un vano allungato posto per-pendicolarmente alla linea di costa e con un possibile accesso a Sud, secondo Ciasca; i due muri M 4 ed M 13 sono realizzati con tecniche composite e materiali di reimpiego peculiari; in M 4, a Nord, sono, infatti, riconoscibili filari irregolari dove vengono allettate di testa stele provenienti dalle deposizioni mentre il filare superiore conserva blocchi più grandi rappre-sentati da frammenti di modanature architettoniche di coronamento pertinenti a gole egizie (fig. 333)5; il settore più a Sud, invece, con una chiara cesura, utilizza blocchi di grosse dimensioni, irregolari, con piccole zeppe incastrate nelle commessure o usate come letto di posa.
Il muro parallelo M 13 (figg. 334-336) è costrui-to, almeno nella sua parte più settentrionale, con blocchi6 intervallati a riempimenti sciolti di pietra-me informe; anche se la tecnica sembra attestarsi sui principi della modalità ‘a telaio’, i blocchi di ordito non sono del tipo ad ortostato, ma presentano una sezione quadrata che conferisce loro l’aspetto di cubi o dadi di fondazione e sono dotati, inoltre, di una ri-
sega sulla faccia Ovest; M5 costruito a brevissima di-stanza da M 13 è realizzato con una tecnica a piccoli scapoli irregolari di calcare.
Le due diverse tecniche adottate in M 4 testimonie-rebbero due funzioni differenti: la sua struttura parti-colarmente solida lo identifica come limite Ovest del santuario addossatosi al fianco del rilievo roccioso, secondo l’interpretazione della Ciasca; dopo la chiu-sura della soglia e forse la dismissione di parte (o tut-to?) del sacello A, lo spazio precedente viene allun-gato reimpiegando frammenti di materiale di risulta proveniente dalle ristrutturazione del santuario (o del tempietto?) per assumere, così, la configurazione finale; M 5, realizzato con una tecnica ancora diversa e posto ad una quota più alta, potrebbe essere una ri-strutturazione dell’ambiente b coincidente con la sua ultima fase di vita7.
L’edificio b (o alcune sue componenti) attraversa, quindi, tutta la vita del santuario (fig. 337), origina-riamente come limite dell’area sacra, poi come spa-zio chiuso che sfrutta il muro di confine M 4; tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C., il tempietto A rappresenta un nuovo elemento di architettura sacra in connessione con l’area delle deposizioni. La defunzionalizzazione definitiva del sacello e la de-predazione dei blocchi8 decretano la separazione tra le due aree, mentre b ora (ri)costruito con materiale di risulta e ingrandito, partecipa alla risistemazione che coinvolge il santuario durante i consueti innalza-menti degli strati con le nuove gettate di terreno per le deposizioni e, nello specifico, vicino alle modalità di riuso delle stele per il muro di limite orientale T29.
5. Settore centrale
Nell’area più elevata del tofet, un apprezzabile in-nalzamento della superficie rispetto alla quota di frequentazione relativa allo strato V del tofet carat-terizza questa breve balza a ridosso del limite centro-settentrionale del santuario10. A Sud della struttura identificata come G in pianta (fig. 338), sono presenti altre strutture murarie già messe in luce da Ciasca e orientate in direzione SudEst-NordOvest. In realtà si tratta di due allineamenti ben distinti di cui il più antico – M17 – è più a Nord mentre l’altro, M18, a quello parallelo, si configura come un rifascio e un probabile annesso di G secondo quanto si evince dal tipo di calcarenite e dalla tecnica a lastre.
223 Il restauro e la valorizzazione del tofet di Mozia
L’installazione quadrangolare posta ad Est – M16 – sembra anche appartenere al sistema più antico. L’orientamento di questi allineamenti è coerente e sembra fare riferimento ad una struttura (o ad un complesso di strutture) che si sviluppa secondo un asse privilegiato all’interno del santuario e che è sta-ta successivamente obliterata da G. L’edificio esibi-va, molto probabilmente, un aspetto monumentale come dimostra sul piano di fondazione l’imposta per i blocchi dell’elevato.
6. Lo scavo del settore meridionale
L’area posta a Sud del muro meridionale T1 era stata indagata dalla Ciasca con due trincee, ad Ovest e ad Est, dove erano stati individuati due tratti mu-rari che continuavano oltre la recinzione di prote-zione; si è deciso di verificare, quindi, la presenza di altre strutture parallele sulla fascia meridionale dal corridoio tra A e b all’angolo Ovest di A1. Sono state messe in evidenza solo le creste murarie di al-tri cinque muri, tutti perpendicolari a T1 e paralleli fra loro, senza approfondire tuttavia lo scavo oltre il livello umico e non è possibile, allo stato attuale, in-dividuare i percorsi all’interno degli ambienti, anche se è probabile che alcune lacune siano, in realtà, degli accessi tra gli spazi: la ricerca futura confermerà o amplierà tali ipotesi di lavoro.
Questa breve disamina su alcune problematiche strutturali del tofet dimostra che molte sono ancora le questioni aperte sul santuario e molteplici le dire-zioni di ricerca che potranno essere sviluppate per ampliare le nostre conoscenze sul monumento mo-ziese e sui suoi omologhi presenti negli insediamenti fenici del Mediterraneo.
Rossella Giglio Cerniglia
1 Situato nella parte nord-occidentale di Mozia, il tofet è stato scavato, per circa un decennio, tra il 1964 e il 1972, da Antonia Ciasca, dell’Università di Roma ‘La Sapienza’: Ciasca 1992, 113-155. Si veda anche Ead. 2002, Ribichini 2002, Bernardini 2005.
2 I lavori sono stati eseguiti sul campo dal dott. Pierfrancesco Vecchio a partire dal mese di aprile 2009 con lavori preparatori e, poi, con un intervento diretto (ottobre-dicembre 2009). Un concreto contributo di collaborazione è stato fornito, come con-sueto, dalla Fondazione Whitaker, attraverso il personale presen-te sull’isola, in particolare la dott.ssa Pamela Toti, che ringrazio.
3 Nella descrizione delle strutture e delle installazioni è stata utilizzata, a seguire, la numerazione adottata da Ciasca, a partire da M13.
4 Non rilevata da Ciasca 1992, 128.5 Ciasca 1992, 117, considera tutto M 4 come muro perti-
nente alla fase più antica.6 Se ne conservano solo due, allo stato attuale.7 Ibid., 118.8 Ibid., 145.9 Ibid., 132-133.10 Ibid., 116: «il nucleo iniziale occupa una sorta di collinetta/
pianoro roccioso di limitata estensione, aggettante sulla spiaggia settentrionale».
Bibliografia
Bernardini 2005 = P. Bernardini, Per una rilettura del santuario tofet-I: il caso di Mozia, in «Sardinia, Corsica et Baleares Antiquae», III, 2005 [2006], 55-70.
Ciasca 1992 = A. Ciasca, Mozia: sguardo d’insieme sul tofet, in «Vicino Oriente», VIII,2, 1992, 113-155.
Ciasca 2002 = A. Ciasca Archeologia del tofet, in C. González Wagner, L.A. Ruiz Cabrero (eds.), Otto Eissfeldt, Molk als Opfergriff im punischen und hebräischen und das Ende des Gottes Moloch, Madrid 2002, 121-140.
Ribichini 2002 = S. Ribichini, Il sacello nel “tofet”, in M.G. Amadasi Guzzo, M. Liverani, P. Matthiae (a cura di), Da Pyrgi a Mozia. Studi sull’archeologia del Mediterraneo in memoria di Antonia Ciasca, Roma 2002 (Vicino Oriente, Quaderno 3/2), 425-439.
Rossella Giglio Cerniglia
Mozia, tofet. 324. Veduta generale dell’area. 325. Mozia, tofet. Stato prima dell’intervento.326. Mozia, tofet. Pianta generale dell’area.327. Mozia, tofet. Lo spazio di risulta fra sacello A e campo d’urne.328. Mozia, tofet. Tempietto occidentale.
Rossella Giglio Cerniglia
Mozia, tofet. 329. Il muro M6.330. Nuovo allestimento, particolare da Est.331. Nuovo allestimento, veduta da Sud.332. l campo d’urne e le stele. 333. Particolare delle stele e gole egizie nel muro M4.334. Il muro M 13.
Rossella Giglio Cerniglia
Mozia, tofet. 335. Pianta. In evidenza il
sacello A e i due muri M 4 e M 13.
336. La struttura b.337. Ipotesi sulle fasi del
sacello e dell’edificio b.338. La struttura G e le due
fasi (in azzurro la più antica).