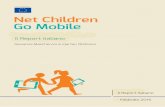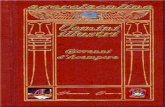Don Giovanni nel teatro letterario italiano
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Don Giovanni nel teatro letterario italiano
dello stesso Autore:
1965 – Introduzione alla lettura del XXIX canto del Purgatorio , Bolo-gna, “Quaderni di cultura del Liceo-ginnasio L. Galvani” n. 3
1989 - Lungo pranzo degli dei in Baviera, Poggibonsi, Lalli editore
1989 - Au château d’If, in Vaga la fantasia, La repubblica
1989 – Tabarin, “Temporali” n. 2, Bologna, Editoriale Mongolfiera
1991 – Il disagio scolastico: una esperienza di ricerca e progettazione , “Sensate esperienze” n. 13, Torino, Thema editore
1991 – Gioco di coppie 1: paesaggi di mare, “Tutto Ferrara” n. IV, 30
1995 – Disagio giovanile e relazione docente-studente, in AA.VV., Orientamento e Scuole superiori, Bologna, Synergon editore
2014 – Dentro/fuori - memorie di un sessantasettenne
1
INDICE
Prologo 3
Prefazione 9
Parte prima - Introduzione 13 Cap. 1 Don Giovanni: un fatto personale 13 Cap. 2 La nascita di Don Giovanni 25 Cap. 3 Storia delle versioni 33
Parte seconda - Don Giovanni nel teatro letterario italiano
45
Cap. 1 Repertori e periodizzazione 45 Cap. 2 Prime apparizioni e sviluppo nel teatro
di prosa (dalle origini al 1736) 59
Cap. 3 Il trionfo del tema nel teatro musicale (1777-1820)
95
Cap. 4 La grande crisi romantica e decadente (1832-1900)
117
Cap. 5 Un nuovo Don Giovanni? (1907-1967) 121 Cap. 6 Conclusione 143
Parte terza - Appendice 147
2
Epilogo 161
Parte quarta - Bibliografia 149 a. Testi italiani esaminati 150 b. Testi stranieri esaminati 154 c. Bibliografie specifiche 155 d. Saggi critici sul tema 155 e. Saggi critici su singoli Autori 156 f. Enciclopedie 158 g. Varie 159
3
PROLOGO
Ecco un testo che risale a cinquant'anni fa ma che, strano effetto, sento in continuità con il mio essere attualmente.
Ho raccontato nelle mie memorie1 che conclusi il lungo lavoro
di redazione della tesi di laurea con la presentazione al relato-re, il professor Petroni, di una bozza dattiloscritta; dopo qual-che giorno recuperai la mia opera: sulla prima pagina c'era annotato a mano il giudizio del prof che sostanzialmente dice-va che era molto deluso, che avevo fatto un lavoro pessimo e che si aspettava molto di più da me. Io ci rimasi molto male, naturalmente, anche se ero consapevole dei limiti della mia ricerca di cui peraltro lui portava una certa responsabilità per-ché io gli avevo proposto una tesi su tre grandi Don Giovanni (Tirso de Molina, Molière e Mozart/Da Ponte, testi sui cui c'era evidentemente molto da dire) ma lui mi aveva detto che era meglio il teatro letterario italiano, cacciandomi quindi in una serie di complicazioni e pasticci a cui non ero preparato (del resto, tutto quello che aveva fatto in precedenza per me era stato portarmi alla Biblioteca universitaria per farmi vede-re come si sfogliavano le schede di un catalogo! Ne dedussi che era meglio non chiedergli niente e feci tutto assolutamen-te da solo). Letto il suo giudizio andai dal suo assistente, che era un ragazzo simpatico (Pietropolli o qualcosa del genere) ma un po' evanescente e gli espressi la mia preoccupazione; lui mi rassicurò ed io quindi conclusi che la mia tesi andava bene lo stesso, e comunque non avevo tempo da perdere. Ecco, quel giudizio iniziale e la conseguente convinzione di aver scritto una boiata io l'ho creduto vero fino ad oggi: non ho quasi mai più degnato di uno sguardo il fascicolo, al più
1 Ottavio Malavasi, Dentro/fuori - memorie di un sessantasettenne,
2014
4
magari vi ho cercato una dato che mi serviva. Ma qualche tempo fa invece, come intervallo fra la lettura di due libri se-rissimi, ho preso in mano la mia tesi, l'ho saggiata qua e là e mi sono accorto che poi così schifosa non era e mi è venuta l'idea di proporla agli amici per una lettura senza pregiudizi o sem-plicemente come mio ricordo. Certo, se fosse vero che per quasi cinquant'anni ho creduto pessima una cosa invece non priva di qualche elemento di interesse, certo se fosse vero questo confermerei di essere uno strano personaggio, uno che non ha autostima sufficiente nemmeno per difendere quello che esce dalla sua testa
2.
Insomma, c'è da pensarci su, io naturalmente, non il lettore di questo libretto che si può limitare a verificare se ne ricava un qualche piacere o no. Eppure, almeno di alcune delle cose che ho fatto nella mia vita mi pare di essere stato fiero! Ma no, forse a posteriori, mentre le facevo ero pieno di dubbi e di sentimenti di inadeguatezza; ricordo che, nel periodo in cui ero in politica e facevo il manager dello spettacolo, partecipai ad un dibattito sulla cultura al Festival de l'unità e che prima di osar entrare nella sala mi aggirai a lungo nei dintorni disperato per aver affermato in un intervento sulla stampa di qualche giorno prima cose che mi parevano balordaggini (poi, ho capi-
2 A riprova: il mio amico Vanni (fine italianista) mi rivelò poco tempo
fa che la lectura Dantis che feci in terza liceo, che a me era sempre sembrata insostenibile e vana, lui invece l'aveva trovata coraggiosis-sima ("Ritengo che fra tutte le cose che hai scritto e che ho letto - ci sono parecchie lacune, però - quella più bella e significativa rimane l'analisi del XXIX del Purgatorio; quello fu veramente un atto di corag-gio intellettuale, una precisa scelta anticrociana e un'affermazione di piena indipendenza culturale. Credo che nessun liceale dell'epoca - non parliamo poi di quelli di adesso - invitato a parlare di un Canto della Commedia avrebbe fatto la tua scelta, ma si sarebbe diretto sicuramente su qualcuno degli eroi danteschi o su un canto politico. Bravo! Lo pensai allora e lo penso anche oggi").
5
to che erano idee abbastanza brillanti, invece, e così le ho descritte nelle mie memorie). Mah! Nel trascrivere la tesi non ho fatto molte correzioni anzi dav-vero pochissime (a parte una pagina sconclusionata che ho ricondotto alla ragione), intervenendo su errori di battitura e simili; soprattutto, non credo di avere falsato lo stile con cui è stata scritta originalmente anche se di tanto in tanto ho rime-diato ad alcune stranezze di cui non so spiegare la genesi e ho messo in nota (in corsivo) alcune osservazioni. Naturalmente ho migliorato l'aspetto grafico, che allora, quando si ricorreva alla battitura in copisteria, era infame.
9
PREFAZIONE Alcune parole sui criteri con cui è stato condotto il lavoro. Evidentemente, la difficoltà maggiore consisteva nel ritrovare quei testi che la ricerca bibliografica mi aveva indicato; a tutti è nota la situazione generale delle biblioteche italiane
3: assen-
za di cataloghi nazionali, interminabili stati di riordino, manca-to aggiornamento delle schede; a ciò si aggiungono, per la Nazionale di Firenze, i postumi dell'alluvione. Questi fattori nonostante la migliore buona volontà hanno impedito la con-sultazione di tutte le opere di cui avevo trovato una qualche indicazione; è certo però che le linee generali dell'evoluzione del tema sono ben rappresentate, nel senso che per ogni peri-odo ho potuto leggere qualche testo e che quindi l'incomple-tezza non ha portato gravi danni; ma questa mi è dispiaciuta. La conseguenza principale di questo stato di cose è che il lavo-ro che mi pareva potesse rientrare nello schema del "reperto-rio" si è dovuto trasformare in esame storico e critico, per quanto possibile data la mancanza spesso assoluta di studi su molte opere. Criterio quindi di massima è stato quello di forni-re il maggior numero possibile di notizie sul testo in esame, di darne un riassunto ragionato e di cercare di collocarlo nel contesto culturale generale e nella linea di sviluppo del tema, confrontandolo con opere coeve e cercando con ciò, quando fosse il caso, di definire dipendenze; ma il cambiamento di prospettiva che mi si è imposto durante lo svolgimento della ricerca ha portato ad una certa forzatura in qualche punto e forse a troppa uniformità nelle strutture di esposizione.
3 Di fatto, visitai solo quelle (statali, comunali, universitarie, ecc. ma
soprattutto dei Teatri storici) di Milano, Modena, Padova, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e naturalmente Bologna.
10
Occorre osservare ancora che, non esistendo un lavoro critico che esamini i Don Giovanni della storia teatrale italiana, vari sono stati gli studi che maggiormente ho usato: per la prima parte, dove riferisco di alcune personali im-
pressioni sul significato attribuibile al mito di Don Gio-vanni e con ciò giustifico la scelta del tema come oggetto di una tesi, dove faccio un rapido cenno ai principali pro-blemi inerenti la nascita di Don Giovanni e delineo una storia dello svolgimento europeo del tema, maggiori no-tizie mi hanno fornito i libri di Arturo Farinelli4 e di Gio-vanni Macchia
5.
Per quanto riguarda la seconda parte, su qualche Autore mi è stato possibile trovare una o più ricerche che di soli-to però toccano molto incidentalmente o non toccano af-fatto il mio tema o che risalendo a parecchi anni fa non rispondono allo stato attuale della ricerca su tale argo-mento; su altri Autori invece nulla ho trovato e quindi mi sono affidato al buon senso e alla mia sia pure ancora non vasta esperienza critica.
Dopo una breve appendice, nella terza parte riporto poi nella bibliografia soli i testi che ho consultato direttamen-te in quanto esiste già un'accurata ricerca su tale argo-mento, quella dovuta ad Armand E. Singer6, completa, per quanto ho potuto di persona constatare cioè riguardo ai testi italiani su Don Giovanni, nella misura circa del 90%.
4 Arturo Farinelli, Don Giovanni, "Letterature moderne" XXVI, Milano,
Bocca, 1946. 5 Giovanni Macchia, Vita, avventure e morte di Don Giovanni, "Univer-
sale Laterza" 48, Bari, Laterza, 1966. 6 Armand E. Singer, The Don Juan theme, versions and criticism: a
bibliography, "West Virginia University Bulletin" series 66, n.o 6-4, 1965, Morgantown, West Virginia University, 1965
11
In conclusione ben raramente ho potuto riferire giudizi di sin-goli studiosi su argomenti tanto particolari proprio nella misu-ra in cui erano assolutamente privi di sostanziali novità in rap-porto a quanto reso già noto dai lavori incentrati sui problemi generali inerenti al tema.
13
PARTE PRIMA - INTRODUZIONE
CAP. 1 - DON GIOVANNI: UN FATTO PERSONALE
Ascolterebbe e guarderebbe gli uomini. Era il loro te-stimone più attuale e più inattuale, il più presente e il più assente. Li guardava vivere con occhio acuto nei lo-ro più piccoli fremiti di passato e di futuro, e subito si faceva indietro e li percepiva solo come una massa uni-ca, come un grande essere solo nell'universo che attra-versava le stagioni, cresceva, invecchiava, moriva e ri-nasceva per vivere un po' meno giovane. Sentiva con angoscia, e con voluttà nell'angoscia, l'avventura uma-na come un'avventura mortale... a meno che essa ri-nunci a se stessa, si disincarni e, confessando il proprio sfinimento, si rimetta a Dio
7
Don Giovanni è uno di quei tanti echi
8 che vivono nella nostra
cultura e che, per il solo fatto di essere formati da tanti ele-menti che si è soliti analizzare separatamente, contengono implicitamente in sé un imperioso invito a considerarne solo il significato generale. Tanti sono i risvolti della leggenda di Don Giovanni, tanti i lati su cui fermare l'attenzione, tante le inter-pretazioni possibili che l'interesse, l'importanza culturale, in una parola la vitalità del tema si rivelano solo da un punto di vista lontano e sintetico.
7 Pierre Drieu La Rochelle, Gilles, Paris, Gallimard, 1938, p. 77.
8 Nel testo originale in verità stava scritto "una di quelle tante cose";
qualcuno, forse il succitato Pietropolli che comunque lesse solo le prime dieci righe, mi fece notare (ma io insistetti) che il termine era strano: concordo e quindi qui l'ho cambiato.
14
Don Giovanni confina infatti con la teologia, con la filosofia, con la morale, con la psicologia, al limite con la sociologia; trae umore dalla storia europea delle idee. Questo è il suo fascino, la possibilità di fare una sintesi di tutte quelle componenti. Accingersi quindi a esaminare l'aspetto diacronico del tema, il suo svolgimento in una letteratura teatrale, è cosa ben lonta-na dall'interesse per il personaggio: è un fatto particolare, che impone un atteggiamento lontanissimo da qualsiasi emotività. Ma il ragionare su un aspetto particolare della storia di Don Giovanni costa anche un secondo sforzo: su di lui molto si è detto e quindi compiere un lavoro di ricerca su singoli testi in quanto facenti parte di quel filone e solo per questo è servito unicamente a confermare, affinare, rimpolpare linee fonda-mentali di sviluppo ben conosciute e chiare. Ancora: la nostra idea di Don Giovanni è basata sui capolavori che ne hanno fatto la fama punteggiandone la storia; tutto il resto è servito a mantenere vivo l'interesse per il tema, è servito a grandi artisti per prendere spunto nelle loro realizzazioni: è questo "resto", quello che è servito al consumo, che io ho avuto di fronte: il risultato è stato uno studio in cui l'interesse per il personaggio non c'entrava più nulla e non aveva nemmeno ragione di esistere, continuamente frustrato da una serie inin-terrotta di testi perlomeno brutti e poco originali. Ciò non vuol dire che Don Giovanni ne esca malconcio: il mio concetto di lui è anteriore ad ognuno di questi testi, basato forse inconsciamente anche su di essi ma come in un'atmosfe-ra tutta diversa. Certo è che una simile situazione mi ha impo-sto una categorica distinzione fra piano di lavoro e piano d'in-teresse personale; questo per dire anche come possa essere stato disilluso dopo aver fatto un confronto fra il significato filosofico che ero solito attribuire a Don Giovanni e le idee che vagano nelle commedie e nei libretti della produzione italiana che di lui si è occupata.
15
Forse perché il mio interesse per Don Giovanni nacque nel momento in cui conobbi la conclusione di un discorso su que-sto personaggio, un'interpretazione del suo significato. Ho incontrato infatti Don Giovanni nelle pagine9 di due Autori francesi, Stendhal e Albert Camus, e il fascino della loro parole mi ha spinto a leggere alcuni testi, ricercando in essi ciò che aveva colpito quegli scrittori; ben conscio che essi non voleva-no interpretare le realizzazioni letterarie del personaggio ma solo valutarne il significato generale, credo che sia bene, per me soprattutto, ricordare le loro pagine proprio in quanto esse stanno alla base del mio concetto di Don Giovanni e co-me tali hanno costituito la prospettiva in cui mi sono mosso. Tutto questo, insieme ad una storia delle realizzazioni lettera-rie condotto per sommi capi esaminando la produzione euro-pea, ed insieme ad alcune considerazioni sull'origine storica della leggenda, ha costituito per me il punto di partenza per esaminare il materiale che avevo rintracciato; e come tale mi sembra doveroso rendere conto. Le pagine di Stendhal e di Camus c'inducono immediatamente a una prima considerazione, a un primo assioma: Don Giovan-ni ha avuto un'importanza sociale di primo piano sia quando è stato pubblicizzato da un'opera d'arte sia quando è rimasto come stimolo culturale nella mente di artisti e pubblico. Sten-dhal e Camus attraverso Don Giovanni parlano della loro so-cietà e delle sue origini storiche, dell'idea che essa aveva dell'uomo, dei rapporti fra gruppi e persone; e, poiché queste loro parole hanno come retroterra un dramma personale in-
9 In realtà, c'entra anche una sorta di "scena primaria": da ragazzo
amavo ascoltare la radio al buio, prima di addormentarmi; fu in uno di quegli stati di dormiveglia che ascoltai una scena (che anni dopo sco-prii essere del Don Juan di Molière) che si svolgeva di notte lungo il muro di cinta di un cimitero... ne rimasi molto colpito e inconsciamen-te, così pare, essa agì in me a lungo.
16
centrato sulla collocazione da assumere come uomo in un determinato contesto sociale e siccome ambedue gli scrittori hanno avuto il coraggio di "sporcarsi" nel mondo, i loro giudizi mi sembrano di grande importanza come se essi idealmente fossero uniti al dramma di Don Giovanni da un'affinità miste-riosa; almeno come tale io li ho sentiti. Cominciamo con Stendhal: un esame completo dei problemi connessi a Don Giovanni si trova nella novella Les Cenci10. Già Friedrich Leopold Novalis aveva detto negli Psychologische fragmente: "E' strano che l'associazione fra voluttà, religione e crudeltà non abbia da un pezzo richiamato l'attenzione degli uomini sulla loro intima parentela e la loro comune tenden-za"11; la scoperta della componente erotica (od autoerotica) in ogni atto religioso non era forse nemmeno allora una novità: importante era darne una formulazione cosciente. Questa considerazione di Novalis, che ha i suoi fondamenti in una filosofia naturalistica, apre a tutto un mondo. Stendhal accentua il significato della religione come normativa negativa, della virtù religiosa come atto di rinuncia e del pec-cato come violazione della legge. Il piacere di peccare (così come esiste un piacere di essere virtuosi anch'esso basato sulle stesse componenti psicologiche) è il passaggio successi-vo, la conclusione del ragionamento: "E' in Italia e nel Seicento che una principessa diceva mangiando un gelato con grande piacere una sera di un giorno molto caldo: - Peccato che non sia un peccato -"12. Ma siccome la norma religiosa ha una fun-zione sociale, tant'è vero che la sanzione è in primo luogo
10
Stendhal, Les Cenci in Choriques italiennes, texte établi et présenté par Michel Crouzet, Paris, Librairie Armand Colin, 1960. 11
citato in Mario Praz, La morte, la carne e il diavolo nella letteratura romantica, Firenze, Sansoni, 1966, p. 26. 12
Stendhal, Les Cenci s.c., p. 87.
17
esclusione dalla comunità, ecco che si esige da parte del pec-catore uno sforzo di dissimulazione, l'ipocrisia: "Perché Don Giovanni sia possibile occorre che ci sia ipocrisia nel mondo"13. In Don Giovanni coincidono così la ribellione (attuata con il solo mezzo disponibile a un uomo del Seicento, con l'opporsi alla morale); la concezione del peccato come piacere e con ciò la voluttà nel violare la norma; l'ipocrisia come mezzo di con-vivenza sociale il che vuol significare anche lotta all'ipocrisia in nome di un ipocrita senso dell'onore: "Don Giovanni prova una voluttà sopraffina nel prendersi gioco di opinioni che an-che a lui sembrano giuste e ragionevoli"
14. I tre semplici ele-
menti costituenti questo quadro, elementi che già da anni psicologi e psicoanalisi hanno messo in risalto come agenti a livello dell'inconscio in ogni individuo, hanno invece bisogno per il positivista (si può chiamare Stendhal positivista? Certo è che in simili occasioni ha veramente precorso i tempi col suo atteggiamento15) di una ben certa causa storica: ed ecco allora il discorso stendhaliano sulle religioni antiche e il cristianesi-mo: "Don Giovanni sarebbe stato un effetto senza causa nell'antichità; la religione era una festa ed esortava gli uomini al piacere; solo il governo parlava di astenersi e vietava le cose che potevano nuocere alla patria, cioè al beninteso interesse di tutti e non ciò che può nuocere all'individuo che agisce; nessun affermava che questa vita è una valle di lacrime e che è meritevole procurarsi sofferenze"16. Questo quadro della religione antica appare evidentemente troppo superficiale per poter dare logicamente origine alle affermazioni che scaturi-
13
ib, p. 83. 14
ib. p. 84. 15
Potremmo metterla così: realista, materialista e insieme storicista, romantico a modo suo, anticlericale naturalmente, ma positivista proprio no. 16
ib. p. 83.
18
scono dal confronto con la religione cristiana, ma certo è suffi-cientemente preciso nel cogliere il significato sociale della religione antica, affatto opposto a quello personalistico e più intimo tipico delle religioni semitiche: "Così è alla religione cristiana che io attribuisco la possibilità del ruolo satanico di Don Giovanni"17; e ancora: "Questo corpo di preti assoluta-mente separati dal resto dei cittadini ebbe come unica occu-pazione coltivare e fortificare il sentimento religioso; inventò seduzioni e abitudini per eccitare gli animi di tutte le classi, seppe legare il suo ricordo alle meravigliose impressioni della prima infanzia, non lasciò passare la più piccola peste o la più piccola grande sciagura senza approfittarne per raddoppiare la paura e il sentimento religioso. Così la religione ha prodotto cose singolari: fra queste io metto senza esitare il carattere tutto moderno di Don Giovanni "18. Certo è abbastanza esatto che di tutto il mondo classico il cristianesimo non abbia voluto assimilare un solo aspetto dell'uomo, il sesso, e che da questa costrizione innaturale sia derivata la teoria della repressione sessuale come merito, il cui culmine di elaborazione ideologica si può situare all'epoca della Controriforma: "E' a mio avviso un prodotto delle istitu-zioni ascetiche dei papi venuti dopo Lutero"
19. Legare le sorti
di Don Giovanni a quelle della Controriforma è cosa esattissi-ma ed è forse l'unico elemento di sostegno a tutta la costru-zione interpretativa su religione antica e cristianesimo. Proprio il legame fra Don Giovanni e spiriti controriformisti permette a Stendhal un'affermazione illuminante, più volte ripresa ma senza che mai se ne potesse ripetere la miracolosa assenza di astrattezza; la ragione del successo di Don Giovanni
17
ib. p. 85. 18
ib. p. 85. 19
ib. p. 85.
19
è così spiegata: "Il fatto è che c'è il diavolo e l'amore, la paura dell'Inferno e una passione esaltata per una donna, cioè quello che vi è di più terribile e di più dolce agli occhi di tutti gli uo-mini per poco che abbiano superato lo stato selvatico"20. Numerose altre frasi ci illuminano poi su aspetti particolari del personaggio: tutte ben si collocano nel quadro generale. "Poi-ché Don Giovanni per essere tale deve essere coraggioso e possedere quello spirito vivo e sicuro che fa vedere chiaro nelle motivazioni delle azioni degli uomini"21: la lotta contro l'ipocrisia qui si configura non come un'ipocrisia più raffinata bensì come un atto di coraggio che necessita di una particola-re disposizione d'animo e di carattere. E ancora: "Il Don Gio-vanni non ha affatto propensione per gli affetti, per le dolci illusioni, i sogni di un cuore tenero: gli ci vogliono prima di tutto piaceri che siano trionfi, che possano essere visti dagli altri e che non possano essere negati"22, frase questa in cui giocano i due elementi fondamentali della sua azione: la me-galomania e l'esibizionismo. E infine: "Il triste ruolo del Don Giovanni puro (quello che non cerca di conformarsi ad alcun modello ideale e che pensa all'opinione del mondo solo per oltraggiarla)"23, ove più che mai il ritratto di Don Giovanni si avvicina a quello del self made man della tradizione america-na, l'uomo di successo che, non impedito dagli ideali che co-stringono l'azione degli altri, dotato di fortuna e di sfacciatag-gine può conquistare, col manuale di comportamento in tasca, il mondo. Non saprei se un simile personaggio fosse o potesse essere per Stendhal un'ideale negativo o no: si tratterebbe di farne un problema morale e da ciò egli rifugge; ma è certo che per noi, sottoposti a un certo tipo di sollecitazioni riguardo alle
20
ib. p. 85. 21
ib. p. 88. 22
ib. p. 88. 23
ib. p. 90.
20
nostre capacità manageriali, il quadro è di una sconcertante verità e attualità. Tutto il discorso stendhaliano nel suo com-plesso mi soddisfa appieno proprio perché tutti gli elementi che caratterizzano Don Giovanni sono confluiti e ben si ordi-nano in una interpretazione; e l'importante è che essa non deve essere riferita ad una singola opera (anche se Stendhal ha sempre presenti soprattutto il Don Juan di Molière e quello di Mozart/Da Ponte) ma a tutto il complesso dei Don Giovanni sette-ottocenteschi che erano nella struttura culturale del nostro Autore. La compiutezza del ragionamento lascia anche in una certa misura stupiti perché credo che sia impossibile, lette queste pagine, pensare a Don Giovanni senza tenerne conto. Ad un altro tipo di interpretazione, che più che considerare i Don Giovanni realizzati si volge a ricercarne uno possibile, ancora da scrivere, mi ha introdotto Albert Camus, che com'è noto avrebbe voluto approfondire il discorso appena avviato in un'opera teatrale. Il motivo della differente inquadratura è semplice: non esiste un Don Giovanni che sia stato toccato dalla polemica filosofica del Novecento o che comunque si sia avvicinato alla problematica dell'uomo moderno; Camus ha capito che un simile Don Giovanni bisognava scriverlo. Con tutta l'attenzione filosofica che gli è propria egli costruisce pezzo per pezzo un nuovo personaggio, figlio diretto di quello che Kierkegaard aveva descritto nel Diario del seduttore24: Giovanni, un personaggio stranamente incompleto, non trae dalla realtà che lo circonda alcun stimolo proprio perché ogni azione si svolge nell'ambito della vita estetica25; ne risulta un
24
Søren Kierkegaard, Il diario del seduttore, trad. Luigi Randelli, Tori-no, Bocca, 1921. 25
oggi aggiungerei, almeno: "cioè intuitiva, parziale, soggettiva, pre-razionale".
21
uomo machiavellico nei suoi rapporti con gli altri e mai sincero nè spontaneo. Così il filosofo esistenzialista considerava do-vesse essere l'immondamento di un uomo: una situazione in cui dietro le proprie parole si deve scoprire il peso di dirle e in ogni momento sentire la precarietà del proprio esistere; il modo di vita di Giovanni è descritto con l'intenzione di farlo apparire un passaggio, un momento di un processo che si svolge: le cause di ogni situazione e quelle del crollo coincido-no, ciò che lo salva sul momento lo perderà un momento do-po, una tappa di un processo che porta a Dio. Camus trasferisce questa precarietà alla condizione vera e propria, del momento e del futuro, del personaggio, alla con-dizione reale dell'uomo. L'uomo assurdo di Camus è colui che "senza negarlo non fa nulla per l'eterno"26, è innocente e non ha nulla da giustificare e nulla per giustificarsi, e nessuno strumento per superare la propria situazione e per uscire dall'assurdo. Don Giovanni si riassume nella semplicità ele-mentare della sua rivolta: non è un illuminato che va alla ricer-ca dell'amore totale ma un essere che molto semplicemente ama tutte le donne con uguale trasporto e abbandono. Nè aspira al rinnovamento continuo delle sue sensazioni: ogni donna cerca di dargli qualcosa di più delle altre ma egli non può provare nulla di più che il desiderio della ripetizione; as-sume la propria condizione senza il minimo complesso. Molti credono che gli sia infelice ma "i tristi hanno due ragioni per esserlo: o ignorano o sperano. Don Giovanni sa e non spe-ra"27, non desidera andare oltre i confini della sua intelligenza e trova la sua felicità nel presente, che è piacere o avventura diretta al piacere. Camus esalta in lui la straordinaria lucidità che egli contrappo-ne alla fede cieca e di conseguenza lo vede come un perso-
26
Albert Camus, Le myte de Sisyphe, s.c. p. 97. 27
ib. p. 98.
22
naggio che ignora ogni comandamento che lo distolga dalla vita sessuale che per lui è la sola maniera positiva di essere; e così Don Giovanni ignora ogni metafisica, ogni religione, ogni discorso sull'esistere: cosa accade dopo la morte è futile e per chi sa di essere vivo la sequela dei giorni è tanto lunga; se si allontana da una bella donna non è perché non la desideri più ma perché ne desidera di più un'altra. Egli è felice dunque in un mondo in cui "la bontà è soppiantata dalla generosità, la coerenza dal silenzio virile, la comunione dal coraggio solitario"28. Alla collera divina egli oppone il suo onore umano; nè morale nè immorale egli è un comune, sano seduttore, con le qualità buone e cattive di un uomo qualun-que, ma è cosciente e per questo è assurdo, ha un'etica quan-titativa e vive legato al tempo. Egli non colleziona donne per-ché sarebbe un vivere nel passato, ma esaurisce la propria vita senza rimpianto; la passione non è rivolta a un solo essere ma invece è libera perché porta con sé tutti i volti del mondo e il suo fremito deriva dal fatto che sa di essere mortale. L'amore: molti libri hanno parlato dell'amore "ma dell'amore io conosco solo questa mescolanza di desiderio, di tenerezza e d'intelligenza che mi lega a quel tal essere. Questo composto non è lo stesso per un tal altro"
29. Tutta la vita sta in queste
parole: "amare e possedere, conquistare ed esaurire: ecco il suo modo di conoscere"
30.
Don Giovanni era indistruttibile: ecco perché Camus crede più logico che gli sia stato ucciso per mano di un gruppo di france-scani piuttosto che dalla giustizia celeste: "Vedi Larousse: i frati francescani lo uccisero e lo fecero passare per fulminato
28
ib. p. 99. 29
ib. p. 102. 30
ib. p. 103.
23
dal Commendatore"31; la statua rappresenta così i valori che Don Giovanni ha sempre negato, i poteri della ragione eterna, dell'ordine, della morale universale: solo questo è la statua. Oppure: il convitato di pietra non si presenta all'appuntamen-to e Don Giovanni deve provare la terribile amarezza di coloro che hanno avuto ragione. La coerenza dell'assurdità del suo eroe porta Camus a non accettare il finale del dramma tra-mandato usualmente: seguendo una tradizione più volte ope-rante dal Romanticismo in poi egli preferisce vedere Don Gio-vanni alla fine dei suoi giorni chiuso in un convento e lo imma-gina faccia a faccia con quel Dio che non adora e che pure serve, così come gli è servita la vita; inginocchiato con le brac-cia alzate verso il cielo, un cielo insignificante e vuoto, egli recita l'ultimo atto di una tragedia insostenibile: "Io vedo Don Giovanni nella cella di un monastero spagnolo su una collina e se guarda qualcosa non sono i fantasmi degli amori fuggiti ma forse, da una feritoia infuocata, qualche pianura silenziosa di Spagna, terra magnifica senz'anima in cui si riconosce. Sì, è con questa immagine melanconica e raggiante che bisogna fermarsi. La fine, attesa ma non desiderata, la fine ultima è spregevole"32. La storia di Don Giovanni coincide così con quella di Sisifo, di Prometeo, degli eroi dell'assurdo. Nonostante queste due interpretazioni siano rivolte a fini di-versi e facciano riferimento a intenzioni artistiche ben diffe-renti, nonostante appaiano diversamente integrabile al nostro discorso, tuttavia sorge spontanea la domanda se esse siano in contraddizione o se invece non si concilino sotto un solo se-gno. Bisogna riconoscere che metterle in rapporto non pare cosa facile: potremmo vederle nettamente separate dalle
31
Albert Camus, Carnets, mai 1935 février 1942, Paris Gallimard, 1962, p. 214. 32
Albert Camus, Le myte de Sisyphe s.c., p. 105.
24
intenzioni e dal clima culturale di cui sono proprie; potremmo considerarle in progressione, come se Stendhal avesse liberato il terreno dai più palesi falsi discorsi e posto le basi per un altro tipo di ricerca, quella affrontata in piena libertà da Ca-mus. Certo è che mi riesce più facile concepirle ben unite da un punto fondamentale: ambedue hanno colto che Don Gio-vanni non è un personaggio del passato ma una storia peren-nemente rinnovatesi in ogni uomo: la scoperta di questa sua attualità perenne è veramente il tenue legame fra Stendhal, Camus e la mia sensibilità personale. Il che non significa supporre un atteggiamento spirituale simi-le, ma uno sforzo comune di vivere Don Giovanni, di vederlo intorno a noi, di scoprire i suoi gesti, per ottenere alla fine di una lunga osservazione un convincimento, quello di poterlo considerare un'espressione della condizione umana33. Come tale è stato in ogni secolo oggetto di meditazione, di conversa-zione per tanti artisti e tanti pubblici, perché è nel quadro della condizione umana che occorreva e occorre parlarne, e allora diventa un parlare di sé. Quindi oltre ogni antitesi "opposizione/complementarità" le due analisi mi sono apparse prima di tutto un serio tentativo di descrivere un personaggio e poi due esami della condizione dell'uomo in epoche diverse, e come tali successivi in senso anche e soprattutto ideologico; ma proprio per questo essi sono ambedue presenti nella mia cultura e ambedue vi agi-scono cioè fanno parte della mia idea di Don Giovanni: così anche per me l'antico Burlador è diventato un fenomeno che si arricchisce via via, un eco nella nostra cultura che sento più che mai vicino.
33
strano non abbia mai usato la parola "archetipo".
25
CAP. 2 - LA NASCITA DI DON GIOVANNI Prima di esaminare i problemi storici e letterari connessi alla nascita della leggenda di Don Giovanni, mi pare occorra fare un'importantissima precisazione, cioè quali sono i limiti di variabilità entro cui essa è compresa. In altre parole, quali sono i confini entro cui possiamo muoverci nell'assegnare un'opera letteraria al filone dongiovannesco. A questo proposito Farinelli ci viene in soccorso: "Conviene distinguere nella leggenda del Don Giovanni due parti: la pri-ma comprende la vita gaudente e di conquista dell'eroe; la seconda narra la sua fine, l'invito della statua, il banchetto funebre; ed è una leggenda propria, quella del Convitato di pietra"34. Da momento in cui (1630 circa) i due nuclei sono stati accosta-ti possiamo distinguere due linee di svolgimento: oltre alle storie su seduttori e a quelle su fantasmi che ovviamente pro-seguono la loro strada, troviamo testi su Don Giovanni che trattano le sue avventure ma non la sua morte nel convito, ovvero descrivono un diverso tipo di morte, o una conversio-ne, o altro, e d'altro lato altre che comprendono avventure e morte dell'eroe nel convito. E possiamo subito dire che stori-camente il secondo nucleo domina incontrastato almeno fino all'Ottocento e che da allora in poi è il primo a prendere il sopravvento. Ma accanto a questa situazione semplice si colloca un elemen-to di disturbo: infatti, mano a mano che Don Giovanni si af-ferma e diventa famoso, sempre più il suo nome diventa un semplice sinonimo di libertino (con la collaborazione della parallela letteratura erotica del Settecento) e quindi viene sfruttato o usato in modo troppo estensivo, sino a produrre
34
Arturo Farinelli, op. cit. p. 39.
26
Don Giovanni che nulla hanno a che vedere con la leggenda originaria e che anzi non vi si richiamano affatto. Ovviamente, decidendo caso per caso, possiamo comprende-re nella storia dello svolgimento del tema anche opere che trattano una sola delle due parti, sempre che rispettino il limi-te storico rappresentato dalla prima realizzazione letteraria del personaggio, cioè dalla fusione dei due nuclei leggendari preesistenti (storie dei libertini da un lato; storie di convitti magici, di fantasmi eccetera dall'altro) sotto il nome di un solo eroe. È comunque da escludere da una trattazione sull'evoluzione letteraria del personaggio lo studio di quelle opere che chia-ramente usano il nome solo come sinonimo di seduttore im-penitente, ovvero come soprannome o come attributo di un personaggio. Tutto il resto naturalmente deve essere conside-rato come un'interpretazione della leggenda da parte di un Autore e confrontato con le linee di sviluppo accertate o da accertare. Chiarito questo, il primo problema che ci si presenta è identifi-care qualche dato sicuro sulla nascita di Don Giovanni. Già si è detto dei due nuclei narrativi preesistenti alla prima appari-zione letteraria della leggenda. Facendo ancora uso della cita-ta distinzione di Farinelli, se esaminiamo la prima parte appare evidente che la figura del seduttore non ha data di nascita: tra personaggi storici e personaggi letterari possiamo risalire di millenni, fino a Giasone o ad Alcibiade o a Teseo, ovvero, per restare a tempi più vicini alla nascita di Don Giovanni, alle gesta del Re Edgar nelle ballate del XIV secolo o a Roberto il diavolo o a Guilhom de Bergadan o a Gilles de Rais. Se ci vol-giamo alla seconda delle due parti rilevate da Farinelli, trovia-mo storie di fantasmi, di statue che parlano o altro fin da Apu-leio, nelle leggende su vari imperatori (Giuliano ad esempio) o papi (Silvestro II), e storie di conviti in moltissime fiabe di tutti i Paesi. Chi dunque ha inventato Don Giovanni aveva dietro di
27
sé una grande tradizione cui attingere, rinverdita fra l'altro nel suo stesso ambiente da parecchie commedie di Lope e altri Autori spagnoli; aveva presente quelle leggende e quelle me-morie storiche e suo grande merito sarebbe stato di aver fuso tutto quel materiale in una sola storia e un solo personaggio. Ma questo nuovo personaggio ha un nome illustre: Tenorio. In definitiva solo su questo si fonda tutta una teoria tendente a sostenere la storicità di Don Giovanni: ma dopo anni di ricer-che, più che stabilire che i Tenorio erano una grande casata spagnola originaria del Portogallo, la cui genealogia è ben documentata ma fra i cui componenti non vi è alcun Giovanni che sia detto libertino dalle cronache a lui relative, e che gli Ulloa o Ollao (a cui appartiene il personaggio del Commenda-tore) sono un'altra grande famiglia di origine galiziana, non si è potuto fare. E credo che di più non si possa, perché la sem-plice considerazione che era cosa comunissima, e di questo fa fede tutta una letteratura, usare nomi storici per personaggi di fantasia, e che tale uso non offendeva nessuno, dovrebbe togliere ogni slancio alla ricerca, senza contare che in fondo tutto si ridurrebbe ad accertare che esiste un Don Giovanni della famiglia Tenorio famoso seduttore, con quale interesse non so davvero. E anche il sorgere della leggenda di Don Gio-vanni de Mañara dovrebbe far vedere che non è certo possibi-le trovare un legame così stretto tra storia e fantasia lettera-ria, per quanti sforzi faccia l'Autore di dimostrare il contrario. Ovviamente con tutto questo non si vuole negare la possibilità che qualcuno si occupi del fondamento storico della leggenda di Don Giovanni, ma solo affermare comunque la poca rilevan-za che avrebbe una qualsiasi scoperta in questa direzione. Così pure mi sembra assolutamente priva di importanza la dibattuta questione sull'origine geografica della leggenda; i partiti sono pressappoco così delineati: i critici spagnoli pon-gono l'accento sulle caratteristiche meridionali di Don Giovan-
28
ni, altri, tra cui Farinelli35, sulla derivazione settentrionale di leggende di questo tipo. Anche qui dobbiamo intenderci: se ricerchiamo il luogo di origine di leggende sul seduttore o su conviti più o meno metafisici, non so davvero come si possa arrivare ad una conclusione se non ricorrendo a luoghi comuni razzisti sul sangue caldo dei mediterranei o sui terrori religiosi dei settentrionali abitanti di buie foreste. Se ricerchiamo inve-ce l'origine geografica dell'intera leggenda di Don Giovanni, non vedo come si possa prescindere dai documenti che ab-biamo in mano: e allora dobbiamo dire che egli nasce in Spa-gna ma che potrebbe essere nato altrove e questo lo si saprà non appena si troverà un testo su di lui scritto anteriormente a quello spagnolo. Abbiamo così definite alcune questioni che potevano disturba-re; resta solo da dare un volto allo scrittore che per primo ha dato vita e voce a Don Giovanni. E qui dobbiamo attenerci strettamente ai testi che abbiamo in mano: il primo in ordine cronologico è il Burlador de Sevilla. Di esso non conosciamo l'Autore e proprio per questo è stato attribuito ai più grandi fra i commediografi spagnoli: Goldoni lo credeva di Calderòn, noi con più fondamento di Gabriele Téllez, frate meglio noto con lo pseudonimo di Tirso de Molina. Questa attribuzione permette una migliore definizione della personalità dell'Auto-re del Burlador, e possiamo così figurarci che conoscesse le opere di Lope e di Cervantes che mettevano in scena perso-naggi simili, e soprattutto che avesse letto quell'Infamador di Juan de la Cueva del 1581 che pare (è infatti perduto) essere il più diretto antenato di Don Giovanni. Farinelli insiste nel sup-porre una fonte diretta che comprende addirittura tutti gli elementi che saranno distintivi di Don Giovanni e della sua
35
ib. p. 57: "Si può congetturare, dando più o meno nel segno, che l'immaginazione rigida e tetra del Settentrione le abbia [le leggende] prima concepite e trasmesse quindi ai popoli del Mezzodì".
29
storia; scrive infatti: "Tale come svolto nel Burlador, il tema del Don Giovanni suppone un fondo tradizionale simile alle leggende fin qui riferite, forse, sto per dire indubbiamente, una leggenda che univa già in sé delle due parti distinte. Que-sta leggenda, che sarebbe come l'anello di congiunzione fra le due antiche fiabe ricordate e la prima elaborazione drammati-ca spagnola del soggetto, ci sfugge, spiace dirlo, e si sottrae alla ricerca"36. Ma non ci sono prove di questa affermazione e quindi ritengo meglio attribuire al Burlador il merito di aver fissato tutte le scene tipo del racconto, i nomi, le situazioni, i concetti religiosi fondamentali, le finalità della rappresenta-zione; tutti questi caratteri rimarranno identici, salvo tagli ed ampliamenti, in tutti gli scenari della Commedia dell'arte e anche in opere più propriamente letterarie, fino a quando un nuovo Autore di forte temperamento non fissò altre situazio-ni, altri concetti, altre successioni di scene. Perché, occorre dirlo subito, la storia letteraria di Don Giovan-ni è fatta di tre o quattro capolavori tra cui stanno intermina-bili serie di mediocrità o addirittura atrocità (letterarie s'in-tende). Così succede che la ricerca delle influenze e delle fonti di singoli Autori si complica e si semplifica ad un tempo: certo fino a Molière Tirso è modello indiscusso, fino a Da Ponte-Mozart sono Molière e Tirso a tener banco, e poi Molière e Da Ponte insieme, e altri fino a Byron e i romantici, e da lì la storia si frammenta in infinite direzioni proprio perché la nuova Eu-ropa, quella nata dalle rivoluzioni liberali, quella nuova della prima guerra mondiale e quella nuovissima del secondo dopo-guerra, non ha un capolavoro da cui attingere, né un modello del passato che le possa parere ancora accettabile. Ma ed ecco dove si complica lo schema: Mozart fa scuola nel teatro lirico, Molière continua a regnare in di prosa, e in particolari momenti anche altri Autori di minor valore furono più adatti
36
ib. p. 56.
30
ad influenzare lo svolgimento della leggenda, per la grande diffusione raggiunta dalle loro opere o per l'apporto di ele-menti collaterali, come la musica o il ballo. Quindi il gioco delle influenze è enormemente semplice nelle linee generali (ab-biamo detto tre o quattro capolavori che sono tali proprio perché vasta e duratura è la loro influenza), ma molto com-plessa nei particolari, anche solo per l'enorme numero delle versioni. L'unica cosa che semmai non appare chiarissima nel Burlador, e che in un certo senso ha permesso un così gran numero di variazioni nelle varie epoche, è proprio il personaggio di Don Giovanni, non certo nelle sue azioni ma proprio nella sua psi-cologia. Forse non è chiaro perché è veramente complesso: ci appare sì il dissoluto e lo scapestrato che ci aspettavamo, ma anche il credente, che, dopo aver rifiutato molte volte il pen-timento, deriso gli ammonimenti del servo e della statua col suo "c'è tempo", arriva alla fine a chiedere pietà e a confessa-re di aver fallito nella seduzione di Donna Anna; e prima aveva salvato il servo dalle acque con indomito coraggio; ed è in sottile polemica con il concetto che si faceva strada in quei tempi della "considerazione" in luogo di quello dell' "onore". Per questa complessità, che è anche frutto di un severo anco-raggio ad un terreno storico visto con occhi di un contempo-raneo attento e impegnato, potrebbe anche derivare quella incertezza dei posteri nel caratterizzare Don Giovanni: diven-terà addirittura una marionetta, un maniaco sessuale, proprio perché fu sempre più difficile cogliere nel Burlador i più pro-fondi motivi della sua realtà filosofica. Ad esempio, certo agi-sce nella commedia un forte intento morale e, anche senza dire che la chiave di lettura è essenzialmente teologica, certo è posto ad esempio con molta chiarezza il problema della salvezza eterna in rapporto alle opere, risolto nella condanna nonostante le buone intenzioni di pentimento e la sincera volontà di Don Giovanni di confessarsi e di essere salvato.
31
Conclude Farinelli: "L'importanza capitale del Burlador sta nell'offrire riunite per la prima volta in un dramma le due parti distinte della leggenda, nell'avere delineato, oltre al carattere di Don Giovanni, titano, indomabile, rapido, fulmineo nell'agi-re, dissoluto senza essere scellerato, spergiuro benché cavalle-resco e prode, sprezzatore di ogni legge umana e divina eppu-re credente e in fin di vita smanioso di rappattumatosi in Dio; e quello di Catalinon, quello delle amate e burlate di Don Gio-vanni, caratteri tutti ripetuti, variati, fusi con altri nei drammi posteriori"37.
37
ib. pag. 72.
33
CAP. 3 - STORIA DELLE VERSIONI
Dopo il 1630, anno probabile di composizione del Burlador, appaiono in tutta Europa lavori incentrati sul personaggio di Don Giovanni: in alcune regioni la diffusione è immediata, in altre più lenta ed episodica. Prima traccia che ne abbiamo fuori dalla Spagna è in Olanda38 con il Don Juan di Fuyter del 1646, ma l'apparizione in quel Paese è isolata e solo dopo Molière i Paesi Bassi svolgeranno una funzione importante nella diffusione della leggenda. Più saldamente Don Giovanni si attesta in Italia, dove nel giro di pochi anni Cicognini, Gili-berto, Acciaiuoli, Perrucci e parecchi Anonimi fanno raggiun-gere al tema uno dei suoi momenti di massima diffusione. Probabilmente alcuni attori italiani si impadronirono del Bur-lador favoriti dalla moda che li costringeva a importare un gran numero di commedie spagnole per soddisfare il loro pubblico: infatti questi primi testi sono pressoché traduzioni della commedia di Tirso. Ma parallelamente a questa tenden-za conservatrice tipica della produzione letteraria, gli attori importatori ebbero anche la felice idea di fare del Burlador e del tema in generale una cosa propria, mutando e trasfor-mando il testo piacimento, forse favoriti dal fatto che non si hanno notizie di rappresentazioni dell'originale in questo peri-odo in Italia, nonostante parecchi compagnie spagnole vi ope-rassero abitualmente, specie a Napoli. Certo agli attori italiani doveva piacere un'idea teatrale il cui protagonista si travestiva varie volte, il servo aveva a disposizione avventure e pranzi, dove potevano entrare in scena pastori e pastorelle, Re, duchi, belle donne così via: in verità una vera manna, un vero campo di battaglia sterminato per dei buoni commedianti! Certo pia-ceva agli attori, ultimi figli del Rinascimento, quel personaggio
38
meglio: nelle Fiandre (ancora spagnole).
34
che aveva del titanico, gonfio di brama di sapere e di godere, anche se privo di quelle caratteristiche machiavelliche che eccitavano i furori dei Gesuiti tedeschi nella loro coeva rap-presentazione su Leonzio, personaggio che sembrava incarna-re due secoli di filosofia sulle leggi della morale e della società. In più, fin dall'origine Don Giovanni era presentato come un italiano, un principe italiano, tant'è vero che già la prima parte del Burlador si svolgeva a Napoli. Dopo averlo ben digerito, aver ben inserito in esso le lepidezze di Arlecchino e perfezio-nato con ciò i movimenti di scena, gli attori italiani esportaro-no Don Giovanni in Europa. In Francia, nonostante i palesi limiti che presentava, la trattazione della leggenda negli sce-nari dei Comédiens du Roi piacque infinitamente; e che Don Giovanni arrivasse in Francia per mezzo degli italiani è con-fermato dal fatto che De Villiers definisce il suo Don Juan tra-duzione da un testo italiano. È Biancolelli, famoso Arlecchino, a fare da re in questo campo: il suo scenario avrà anche l'ono-re di una traduzione. Ma gli Autori francesi non si fanno attendere. Dorimon col suo Festin de pierre del 1658 apre la serie; pare non conosca diret-tamente il Burlador e per fonte si indica di solito Gilberto at-traverso gli scenari. Qui Don Giovanni diventa un prode che combatte coraggiosamente contro il destino avverso, senza che mai abbia in mente la possibilità del pentimento. È questa la strada per incupire la vicenda e renderla truce; cosa che fa puntualmente De Villiers nel 1659 con un testo piuttosto sciat-to. È solo con Molière che Don Giovanni trova la sua seconda potente figurazione, nel 1655. Innanzitutto questa commedia opera alcune modificazioni che resteranno canoniche: elimina la prima parte della storia, quella che si svolge a Napoli; fissa la figura del padre di Don Giovanni, già apparso in Dorimon; amplia la scena del povero, già presente secondo l'ipotesi di
35
Macchia39 in uno scenario italiano; la successione delle scene viene resa più organica e più logica. Certo Molière conosce anche Tirso attraverso una traduzione, ammira le opere degli italiani e i precedenti dei suoi compatrioti; da tutte queste fonti trae una storia e crea finalmente un personaggio vivido e pesante. È il primo a rompere l'andazzo generale che tendeva a fare di Don Giovanni un cattivo: in quei tempi il cattivo della storia non è il violento seduttore, pare dica Molière, affermar-lo è una falsa coscienza della società: il cattivo della storia è l'ipocrita. Ecco così un Don Giovanni moderno, non più lancia-to alla ricerca del piacere come tale, ma che cerca il soddisfa-cimento dei sensi come affermazione, perché non crede a nulla, e della sua furbizia fa un mezzo per essere amato e delle sue parole una spada. Il padre e il povero: l'irreligiosità basata su una nuova filosofia e l'ipocrisia, due elementi non nuovi ma resi moderni e moralmente incisivi. Dice Macchia: "L'empietà diventa una dottrina e come se non bastasse la falsa devozio-ne serve addirittura il libertinaggio. Don Giovanni diventa Tartufo ed esalta l'ipocrisia, una delle migliori armi, un mezzo eccellente, infallibile, per raggiungere lo scopo. Quella polemi-ca sociale contro la morale, la virtù, l'onore che si pretende invincibile, polemica un po' larvata nel primo Burlador, qui si dichiara con irruenza, con compiacenza perversa, come se Don Giovanni fosse il denunciatore di una verità abilmente nasco-sta sotto lo schema della falsa devozione, ed egli si divertisse a fare scattare quella verità come una viva dimostrazione. Don Giovanni è l'eroe del calcolo, dello stratagemma, della pura politica (come egli dice una volta), della finzione, delle smorfie necessarie"40". Questo non piacque al pubblico di Molière: sia per non aver egli accondisceso a seguire una tradizione certo giovane ma
39
Giovanni Macchia, op. cit., p. XX-XXIII. 40
ib. p. 15.
36
ben consolidata (evita infatti ogni crudeltà nella rappresenta-zione), sia per avere in buona misura messo ogni spettatore, con tanti limiti ideologici ovviamente, di fronte a uno stile di vita che, in quanto costume e quindi abitudine, è sempre scomodo considerare in maniera critica, sia infine per aver fatto di Don Giovanni non un "mostro" in un certo tipo di so-cietà ma un figlio di quella società nient'affatto abnorme ma solo coerente fino al limite dell'intelligenza. Dopo 15 rappre-sentazione il Don Juan scomparve. Riapparve poco dopo in edizione riveduta e corretta a norma di galateo: educato e inoffensivo, moderatamente divertente, cammina il Don Juan di Thomas Corneille (del 1677, preceduto nel 1669 da quello di Rosimond) e parla in versi alessandrini. Mentre in Francia crolla il tentativo di dare un significato più profondo alla leggenda e il testo di Molière si riduce per i suoi imitatori a un ricchissimo repertorio di situazioni, versi, idee divertenti (vedi appunto il caso di Rosimond, vero centone incentrato sulle avventure di tre amici libertini che reiterando la scena della morte fra le fiamme convincono Don Giovanni a pentirsi), in Europa Don Giovanni continua la sua felicissima strada, adattandosi perfettamente alle esigenze delle compa-gnie di attori, cioè quasi sparendo di fronte ad Arlecchino ed entrando in scena solo per commettere scelleratezze, ridu-cendo gli altri personaggi a ridicoli inseguitori di un seduttore che fugge tra uno stupro e l'altro, ripetendo decine di volte le stesse situazioni di abbandoni, piante, promesse. È una grande crisi41. E non stupisca che si parli di crisi in un momento di larga diffusione: spesso i concetti di validità letteraria e di fortuna presso il pubblico sono in antinomia; proprio nel no-stro caso sovente il momento di massima produzione coincide con quello del peggior appiattimento e delle più grandi man-canze di originalità e di idee nuove. Grande crisi: e non valgo-
41
di sovrapproduzione o di sovraesposizione
37
no a rimpolpare le sorti del personaggio l'apporto di nuove culture: Gran Bretagna, Austria, Olanda; né il parallelo svol-gersi della letteratura settecentesca sui libertini, che anzi ag-giunge solo trasandatezza e ovvietà di soluzioni. In Gran Bretagna Don Giovanni arriva per il tramite combinato della Francia dell'Italia. Dopo che nel 1621-22 John Fletcher aveva messo in scena un libertino che mostra l'elenco delle sue conquiste, dimostrando che esisteva oltremanica un clima favorevole all'attecchimento della leggenda, è nel 1675 o 76 che Shadwell scrive il Libertine (che fra l'altro è il primo ad accogliere del 1692 arie musicate da Purcell). Ma basta sapere che è del 1714 la prima traduzione inglese di Molière per ren-dersi conto di quanto effimera fosse quell'apparizione. Così in Olanda, dove abbondano traduzione di Molière, ma solo questo. Così in Germania, dove pure la preesistente saga di Leonzio doveva favorire la diffusione del tema e dove Molière era stato tradotto sin dal 1690. A questo punto, considerato il grande numero di mediocrissi-me versioni della leggenda, non mette conto di riferire di tut-te; aggiungo solo che abbondano anche le rappresentazioni popolari, specie a Vienna, e che hanno grande successo le numerose farse per burattini con protagonista Don Giovanni. E così avanti fino a Mozart, terzo grande fatto nuovo. E stancamente la leggenda procede nel resto dell'Europa; in Spagna stranamente non ha attecchito; bisognerà aspettare Zamora nel 1744 per trovare un nuovo Don Giovanni in terra iberica dopo quello di Maldonado alla fine del Seicento. La figura del seduttore ha certo affascinato altri Autori, come Calderòn, ma la stanchezza è palese se Maldonado, nel tenta-tivo di fare un cambiamento pur nella fedeltà alla tradizione, fa di Don Giovanni un infelice sfortunato in amore fino al pun-to che non si capisce perché debba essere punito così severa-mente, proprio lui e non la donna che lo ha fatto tanto soffri-
38
re. E con Zamora ci troviamo in pieno clima di letteratura di cappa e spada, e allora abbondano carcere, duelli, riconosci-menti, travestimenti sino a rendere il lavoro una continua corsa per il palcoscenico, fra colpi di scena a non finire, senza sosta per nessuno. In Portogallo, ricordiamo il bieco Don Giovanni di Botelho (circa del 1700) e poi bisognerà attendere la fine del secolo per trovare qualcos'altro. Così si dica per i Paesi slavi dove la leggenda pare ignota. In Italia, dopo La pravità castigata del 1734, spetta a Goldoni il merito di rinverdire come meglio gli riesce la gloria di Don Giovanni: ma il tema non gli piace affatto e pare che lo affronti come per un dovere, come se fosse un banco di prova obbliga-torio per un aspirante Autore teatrale. Né fuori dal campo teatrale si può dire che poeti e romanzieri si interessino alla leggenda dei Don Giovanni. Credo bisogni aspettare Schiller per trovare un poema che se ne occupi, circa nel 1797. In questo panorama piuttosto desolante per le sorti del nostro eroe, c'è lo spazio per un fatto nuovo. Timidamente quasi, Acciaiuoli nel 1669 aveva scritto un libretto d'opera con pro-tagonista una specie di Don Giovanni. Nel 1713 il francese Le Tellier musicava un Festin de pierre; nel 1734 La pravità casti-gata forse di Mingotti. Poi balletti (di Gluck, Galeotti, Schröder e altri) e composizioni per musica, come quelle di Kurz e di Knecht. Don Giovanni trova così la strada della musica, in cui bene o male le sue avventure passano in secondo piano per l'ovvio prevalere della parte musicale nell'attenzione dello spettatore. È in effetti dice Farinelli: "Non v'è a mio giudizio nessun oggetto più acconcio del Don Giovanni ad essere mes-so in musica, ridotto ad opera. Le situazioni drammatiche nel Don Giovanni sono situazioni musicali per natura. Le azioni precipitate, il rapido mutare d'affetti, d'ogni affetto, scene idilliche, scene d'amore, che si intrecciano ad altre scene d'o-
39
dio, di imprecazione, di vendetta; per giunta il fantastico, il meraviglioso, l'inesplicabile che sgomentano, rinserrano nel cuore e che meglio assai si possono esprimere con note che con parole"42. Rileva poi lo stesso Farinelli43 come il tema potesse prestarsi all'estro di diverse nature di musicisti, quello tendente alla roboante vivacità o quello che aspira all'interiorità. Certo non è casuale il fatto che Don Giovanni diventasse uno dei re della scena europea; riferisce Macchia quello che scrisse del feno-meno Goethe nel 1815 riferendosi a una rappresentazione vista a Roma nel 1787 o 88: "Raccontava che la città ne era talmente eccitata che anche l'ultimo rigattiere, coi suoi mar-mocchi e tutta la famiglia, voleva assistervi dal loggione. Nes-suno poteva vivere senza aver visto, almeno una volta, arrosti-re Don Giovanni all'Inferno, ed il Commendatore volare quale spirito nel cielo"44. Ma questa diffusione veramente enorme nella seconda metà del secolo 18º non significa però un relati-vo affinarsi e migliorarsi del tema. Purtroppo la nostra storia delle versioni assomiglia sempre di più a un museo degli orrori poetici di malvagi librettisti! Ma è comunque importante che di Don Giovanni si parlasse sempre e che sempre apparisse sulle scene; e questo uno dei motivi fondamentali che spinse un vanesio come Da Ponte e un compositore tutto sommato nemmeno molto famoso come Mozart ad occuparsi di quella stessa leggenda che librettisti di molto successo e musicisti più affermati portavano sulle scene in quegli stessi anni, intorno al 1787, l' "anno di grazia dei convitati"45. E questa è anche la seconda grande giornata dei Don Giovanni italiano; dopo la Commedia dell'arte e le compagnie di attori che avevano dif-
42
Arturo Farinelli, op. cit. p. 136. 43
ib. p. 136. 44
Giovanni Macchia, op. cit., pag 76. 45
Arturo Farinelli, op. cit., p. 147.
40
fuso il tema per l'Europa, adesso l'opera italiana si afferma ancora una volta per la sua capacità di essere europea, di lar-go consumo e di buon livello medio. Si forma un connubio fra l'opera e Don Giovanni che dura ancora: la musica offre un appoggio e del chiasso per coprire le più grosse manchevolez-ze del personaggio; questi offre la possibilità di tenere avvinto un pubblico spesse volte occupato nel suo palco a mangiare, conversare, ridere, amoreggiare più che ad ascoltare. E in mezzo alle avventure, balli a profusione, tutti basati sulla velo-cità e repentinità dell'azione, quindi facili ad essere adattati alla vicenda. È dunque con la fine del secolo che comincia una frenetica produzione di Don Giovanni italiani: Calegari e Righini nel 1777; Albertini e Tritto nel 1783; Luzzi e Viganò dell'84; Berta-ti, Foppa e Da Ponte nel 1787; Fabrizi nel 1788 e via fin oltre il nuovo secolo. A questa larga produzione italiana non fa ri-scontro un analogo intensificarsi delle rappresentazione sul tema all'estero, sulla scia della nuova operistica italiana: evi-dentemente sino all'Ottocento il dominio italiano in questo campo dovete parere incontrastabile e nessuno tentò il ci-mento. Capolavoro di tutta questa fase è naturalmente il Don Giovan-ni di Da Ponte/Mozart. Anche per questa opera si potrebbe dire che non ebbe certo la fama che meritava, almeno fino al Novecento. Forse era seppellita sotto troppi consimili libretti, più adatti a far divertire il pubblico. Il Don Giovanni di Bertati ebbe una diffusione molto maggiore, fosse anche grazia al fatto che non si preoccupava affatto di quelle finezze psicolo-giche che abbondano in Da Ponte, specie in Donna Anna, in Merlina, in Leporello. Fatto sta che in Italia, dopo essere anda-ti in scena alla Pergola nel 1792, l'opera di Mozart sparisce; in Francia arriva solo nel 1805 in pessima traduzione; in Gran Bretagna fu rappresentato casualmente nel 1817, e addirittura in Spagna giunse dopo che nell'Impero russo. Diffusa così in
41
ritardo, quel capolavoro non ebbe grande influenza se non nelle cose migliori della successiva produzione italiana: influ-enza non larga, perché la concorrenza delle similari opere italiane le impediva il passo; non duratura, perché ormai il Romanticismo si apprestava a far subire una ben consistente metamorfosi a Don Giovanni. Quello dei Romantici infatti ha ben poco a che vedere con la sua leggenda; primo carattere appariscente è la sparizione della parte riguardante il convito della maggioranza dei testi prodotti in quegli anni; ormai Don Giovanni è solo un uomo e la sua è solo una storia d'amore e la morte sempre più spesso un pentimento o una sconfitta. Il Romanticismo aggiunge al personaggio stranezze e fantasie, chiari di luna e notti insonni, pessimismi e cinismi tratti da Werther e da Faust: "Faust finì quasi per assorbire il destino del suo rivale. La vita di Don Gio-vanni fu un po' regolata sulla sua. Don Giovanni si ammalò di faustismo"46. Don Giovanni diventa meditabondo, il piacere gli procura solo dolore, l'ipocondria lo avvelena; l'eroe gigan-tesco del peccato e della sfida alle leggi si rode nel dubbio e nell'indecisione circa le sue azioni, incerto dei suoi sentimenti. Aspetta la morte e la cerca come una liberazione, esamina il passato con la passione di uno studioso per cercare l'eterno del mortale. E come già Lessing aveva salvato il suo Faust pur destinato a perire sconfitto, così il problema di come salvare Don Giovanni arrovella gli scrittori: il più delle volte una donna gli offre sa-cramenti e tonaca che soddisfano appieno le ambizioni di ambedue. Veramente il mutamento è totale, ma non genera-lizzato, perché ancora qualcuno racconta la leggenda del con-vito, ma certo costui appare superato perfino a noi e la buona volontà non basta. I pilastri della nuova interpretazione sono Byron, che autorevolmente sancisce il divorzio di Don Giovan-
46
Giovanni Macchia, op. cit., pag 69.
42
ni dalla sua leggenda, e Grabbe che ne fissa i legami di paren-tela con Faust e in genere con i malati Romantici europei. Da allora in poi (fatte le debite eccezioni per cose certamente valide ed originali come Il convitato di pietra di Puskin del 1830), non esiste più nulla che influisca in modo rilevante sulla storia di Don Giovanni. E anche in senso assoluto manca al Romanticismo un capolavoro su Don Giovanni, manca il drammaturgo o il poeta che potentemente ne fissi nuovamen-te gesti e voci in maniera perlomeno coerente e intelligente. Don Giovanni, dice Macchia, "reclama addirittura il suo Shake-speare"
47.
Non valsero a nulla le fatiche ancora di tanti italiani né il tenta-tivo di rinverdire la leggenda innestandovi un supposto storico Don Giovanni di Mañara o Maraña, traendolo da Manuel Cano y Cueto, e introducendo motivi tipici della tendenza sacrilega del secondo Romanticismo; né le roboanti fantasie di Dumas che porta Don Giovanni in cielo fra angeli e spettri; nè Zorilla che col suo Don Juan Tenorio del 1845 insiste sulla truculenza emulando il suo conterraneo Espronceda, Autore del famoso Estudiante de Salamanca, che aveva sposato Don Giovanni allo scheletro di Elvira. Né, in quanto troppo isolate ed episo-diche, le fini interpretazioni di Baudelaire e di altri poeti di varia grandezza; anzi di anno in anno le cose peggioravano: Don Giovanni era sempre più una figura da romanzo d'ap-pendice, gonfio di sadismo, masochismo ed ogni altro piccolo difetto psicologico. Arriviamo così all'ultimo sviluppo, il più triste fosse. Don Gio-vanni nella società borghese della fine dell'Ottocento non può stare: o deve essere eliminato come simbolo di un vecchio modo di concepire i rapporti sociali, ed è dell'ipotesi di Shaw in Man and superman, o deve essere assimilato al tipo piran-delliano del contestatore educato e raffinato, che alla fine ha
47
ib. p. 66.
43
ragione sui fatti ma torto sui principi, ed ha ragione soprattut-to perché gli altri si rendono conto che il suo è un gioco di società. Don Giovanni desidera felicità borghesi e le ottiene con un po' di autocritica, quanto basta, e una scoperta di valo-ri superiori che la sua intelligenza gli ha fatto trascurare: sco-pre la patria, la famiglia, una semplice donna che non sia una mantide, scopre come sia bello amare le piccole gioie famiglia-ri e le oneste attività produttive. E ai nostri tempi manca un Don Giovanni: nessuno dei nuovi fatti culturali e filosofici del mondo contemporaneo ha in-fluenzato la produzione di opere sull'antico seduttore di Sivi-glia. Molti sono i nomi, anche negli ultimi anni, di Autori grandi o mediocri, Frisch e Montherlant per dire dei più importanti: ma nessuno ha sentito Don Giovanni come un personaggio da aggiornare continuamente e che quindi poteva avere qualcosa da dire all'uomo moderno. Un nuovo Don Giovanni poteva nascere, lo si è visto, dal genio di Camus, ma anche quel sogno è morto nel 1960. E così Don Giovanni aspetta ancora un ca-polavoro. Esposte alcune idee personali sul significato di Don Giovanni quali ho potuto ricavare dalle pagine di Stendhal e di Camus, delineate le linee generale dello svolgimento letterario della leggenda di Don Giovanni, ritengo che siano disponibili suffi-cienti elementi per poter intraprendere uno studio sui testi italiani incentrati sul tema. Non è possibile non ripetere qui quanto si è detto all'inizio di questa prima parte: la grande differenza riscontrabile fra il livello cui mi hanno abituato le meditazioni sul significato del personaggio neigrandi capolavori della storia europea del tema e la media qualitativa della produzione italiana, deve imporre un rapido cambiamento di atteggiamento, in ogni istante del discorso che si porta avanti. Fino ad adesso i vari temi presentati potevano indurre ad una riflessione, a sintesi
44
affrettate e provvisorie, stimolando comunque la mia atten-zione; d'ora in poi nulla di tutto questo. Quello che ho ricavato per la mia cultura personale dal lavoro che segue è stato solo un quadro particolareggiato di una situazione teatrale che mi era già nota. E accettare questo è costato un certo sforzo.
45
PARTE SECONDA - DON GIOVANNI NEL TEATRO LETTERARIO ITALIANO
CAP. 1 - REPERTORI E PERIODIZZAZIONE Ritengo opportuno far precedere ogni altro tipo di discorso da un elenco dei Don Giovanni italiani quale è risultato dalla ri-cerca bibliografica e dalla consultazione degli schedari di varie biblioteche italiane; proprio da quest'elencazione si potranno trarre alcune prime indicazioni sullo svolgimento storico del tema e sull'andamento della sua fortuna presso il pubblico. Inoltre sarà così possibile mettere subito in risalto alcuni "vuo-ti" di cui si cercherà poi di dare conto più ampiamente. Ripor-to in un solo elenco sia commedie, drammi ecc. che libretti per musica mantenendo però una doppia numerazione, di modo che il primo numero si riferisce all'ordine generale e il secondo a quello del proprio genere.
AUTORE TITOLO ANNO GENERE
1 1 Giacinto Andrea Cicognini (o Pseudo-Cicognini)
Il convitato di pietra dopo 1630
commedia
2 2 Onofrio Giliberto Il convitato di pietra 1652 commedia
3 3 Anonimo (casanatense) Il convitato di pietra 1652 scenario
4 4 Giuseppe Domenico Biancolelli
Il convitato di pietra 1658 scenario
5 1 Filippo Acciaiuoli L'empio punito 1669 libretto48
6 5 Giuseppe Domenico Biancolelli
Aggiunta al Convitato di pietra
1673 scenario
48
Per questo come per gli altri libretti do qui solo il nome del libretti-sta; dove invece abbia solo il nome del musicista appare la dizione "musica il"; nel caso invece in cui non mi è stato possibile sapere se il nome cui è attribuita l'opera è quello del librettista o del musicista appare la dizione "opera".
46
7 6 Andrea Perrucci Il convitato di pietra 1678 commedia
8 7 Andrea Perrucci Il convitato di pietra 1690 commedia
9 8 Anonimo Il atheista fulminato fine XVII
scenario
10 9 Anonimo (napoletano) Il convitato di pietra 1700 scenario
11 10 Anonimo Il convitato di pietra ossia Don Giovanni libertino
1726 commedia
12 2 Angelo Mingotti La pravità castigata 1734 libretto
13 11 Carlo Goldoni Don Giovanni Tenoria ossia il dissoluto
1736 commedia
14 3 Anonimo Il convitato di pietra ossia Don Giovanni Tenorio
1777 libretto
15 4 Filistri da Caramondani Don Giovanni ossia il convitato di pietra
1777 libretto
16 5 Giovambattista Lorenzi Il convitato di pietra 1783 libretto
17 6 Anonimo Il Don Giovanni 1784 libretto
18 7 Giuseppe Bertati Don Giovanni ossia il convitato di pietra
1787 libretto
19 8 Giuseppe Foppa Il (nuovo) convitato di pietra
1787 libretto
20 9 Lorenzo Da Ponte Il dissoluto punito ossia Don Giovanni
1787 libretto
21 10 Vincenzo Fabrizi (musica il)
Don Giovanni (Tenorio) ossia il convitato di pietra
1788 libretto
22 12 Francesco Cerlone Il nuovo convitato di pietra
1789 commedia
23 11 Anonimo Il convitato di pietra 1789 libretto
24 13 Anonimo Il convitato di pietra 1789 commedia
25 14 Anonimo Il convitato di pietra 1792 commedia
26 12 Marcello Bernardini o Giuseppe Bertati
Il Convitato di pietra 1792 libretto
27 13 Lorenzo Da Ponte Don Giovanni 1794 libretto
28 15 Anonimo Il convitato di pietra 1797 commedia
29 14 Giuseppe Foppa Il convitato di pietra 1802 libretto
30 15 Giulio Litta Don Giovanni in Porto-gallo
1800/1814
opera
31 16 Anonimo Il convitato di pietra 1803 libretto
47
32 17 Pietro Raimondi (musica il)
49
Il dissoluto punito circa 1818
opera
33 16 Ferdinando Augusto Bon50
Il convitato di pietra 1820 commedia
34 18 Giovanni Pacini (musica il) Il convitato di pietra di Bertati
1832 libretto
35 19 Dora Il Don Giovanni, Don Juan
1843 opera
36 17 Eugenio Rontini Don Giovanni ossia il gran convitato di pietra
1881 commedia
37 18 Domenico Bassi La cena di Don Giovanni
1884 commedia
38 20 Palmieri Il nuovo Don Giovanni 1887 opera
39 21 Danna Don Giovanni d'Alcazar fine XIX
opera
40 19 Antonio Saltiveri Un Don Juan Tenorio a Trossos
circa 1900
commedia
41 20 Anonimo Don Giovanni d'Alvara-dos
1907 commedia
42 21 Anonimo Il convitato di pietra 1909 commedia
43 22 Giuseppe Pagliara Don Giovanni 1911 commedia
44 22 Ettore Moschino L'ombra di Don Giovanni
1914 libretto
45 23 Anonimo Don Juan: sette amanti, sette peccati
1920 commedia
49
Questo titolo non appare nell'elenco delle opere musicate da Rai-mondi nell'Enciclopedia dello spettacolo, solitamente completissima. Non avendo rintracciato il testo non posso dire altro su tale attribu-zione fatta da Singer, op. cit, p. 152 alla voce 1491 e accompagnata dalle parole "I critici non sono certi circa i dettagli di questa opera né della data, sebbene sembri del tutto sicuro che sia stata realmente rappresentata". 50
Anche questo titolo non compare nell'elenco delle opere di Bon nell'Enciclopedia dello spettacolo nè ne ho trovato menzione in bio-grafie dell'Autore né nulla me ne hanno saputo dire dopo lunga ricer-ca alla Marciana. Citato da Singer, op. cit. p. 55 alla voce 499 come ripreso da Gendarme de Bevotte, n. 4187, II, 223, è accompagnato dalle parole "Una riduzione di parti delle commedie di Molière e di Corneille".
48
A questo primo elenco sono da aggiungere alcuni testi che le fonti bibliografiche non datano o che non recano data nella stampa.
55 1 Anonimo Il gran convitato di pietra Novara
56 2 Anonimo Il gran convitato di pietra Milano
57 3 Anonimo Il gran convitato di pietra Milano
58 4 Ippolito Nievo51
Don Giovanni
Elenco di seguito due testi che non so se siano opere teatrali non avendo potuto rintracciarli.
59 1 Ugo Fleres52
Don Giovanni
60 2 Franco Faccio53
La morte di Don Giovanni
1889 Vercelli
Nulla hanno invece che vedere col tema di Don Giovanni alcu-ne commedie e libretti che pure hanno nel titolo il suo nome o
51
E' menzionato in Singer, op. cit. p. 139 alla voce 1345 con le parole "Egli abbozzò o progettò un Don Giovanni in versi. Non posso trovare altra indicazione su di ciò". Si tratta dall'abbozzo di una commedia in versi. 52
Citato in Singer, op. cit. p. 98 alla voce 818 senza altra specificazio-ne. 53
Citato in Singer, op. cit. p. 85 alla voce 786 senza altra specificazio-ne. Franco Faccio era un musicista.
46 24 Raffaele Calzini Il debutto di Don Giovanni
1921 commedia
47 25 Alessandro Varallo Intermezzo: Don si pente
1922 commedia
48 26 Ugo Falena Don Giovanni 1923 commedia
49 23 Arturo Rossato Don Giovanni 1925 libretto
50 27 Raffaele Calzini Il crepuscolo di Don Giovanni
1927 commedia
51 24 Ettore Moschino Don Juan de Mañara 1941 libretto
52 28 Vincenzo Tieri Don Giovanni ultimo 1950 commedia
53 29 Gian Maria Cominetti Don Giovanni KO 1955 commedia
54 30 Alfredo Nalducci Don Giovanni al rogo 1967 commedia
49
la parola "convito". Forse alcuni testi del primo elenco an-drebbero inseriti qui in tanto in quanto potrebbero rivelarsi estranei alla leggenda dongiovannesca: sono quelli che non ho potuto vedere e quindi ovviamente non posso decidere nulla circa la loro appartenenza al ciclo.
61 1 Filippo Livigni54
Il convito 1781
62 2 Andrei (rielabora il)55
Il convito di Livigni 1782 libretto
63 3 Girolamo Rovetta56
La moglie di Don Giovanni
1876 commedia
64 4 Achille Torelli57
La duchessa Don Giovanni
1888 commedia
54
E' un dramma giocoso per musica di Domenico Cimarosa. Già Fari-nelli (op. cit. p. 170) chiarì che Cimarosa mai scrisse un Convitato di pietra ma solo musicò questo Convito in cui appaiono sì personaggi travestiti da statue ma senza che comunque possa essere riferito alla leggenda dongiovannesca. Vedi anche Macchia, op. cit. p. 89, nota sette. È in due atti. 55
E' un libretto musicato da Ferdinando Bertone che fu rappresentato a Londra nel 1782. 56
Questa come le altre commedie del gruppo usano il nome di Don Giovanni nel senso che si è chiarito, come sinonimo cioè di libertino o seduttore; giusto mi è parso quindi escluderle dalla trattazione vera e propria, ma ne do un breve resoconto in questa sede. La moglie di Don Giovanni (Girolamo Rovetta, La moglie di Don Giovanni, in Un volo dal nido. La moglie di Don Giovanni, Verona, H. F. Munster, C. Kayser successore, 1877, pp. 73-166) è una tipica commedia borghese "alla francese" che ci introduce in un ambientino di ricca villa nobiliare in cui Giacomo fa il dongiovanni in un affogato intreccio di amori ricambiati o no. La prima fu a Ferrara. 57
Come già mostra chiaramente il titolo, è Debora, ex attrice sposata a tale insignificante Luigi e che di tanto in tanto torna al corrotto mondo del palcoscenico, ad assumere la parte di dongiovanni della situazione, ma questa inversione non ottiene altro effetto che fare di lei una virago e dei suoi amanti dei burattini in cerca di un caldo luogo, la donna, in cui riposare a lungo. È in un atto.
50
65 5 Francesco Pastonchi58
Don Giovanni in provincia
1920 commedia
66 6 Carlo Terron59
La moglie di Don Giovanni
1844 commedia
67 7 Vitaliano Brancati60
Don Giovanni involontario
1954 commedia
58
E' una serie di 10 quadri con generico filo conduttore l'amore, il tutto in un tono educato, delicato, rarefatto, senza troppe passioni. Teatralmente inefficienti le brevi scenette ricordano le Operette leo-pardiane ma non certo per la profondità delle idee ma per il modo di concepire un dialogo. Operanti a fondo alcuni motivi patriottardi: nel primo quadro (L'uomo e la sua ombra) un uomo abbandona l'amante perché prima deve andare a vincere la guerra ed essendo il pezzo del 1911 si può intuire che si tratti quella di Libia. 59
Anche se è del 1944 fu rappresentata a Torino nel 1951. E' un com-plicato intreccio con alcune notazioni psicologiche estremamente generiche. L'amante di Giovanni, Dira, si rivolge alla di lui moglie Valentina per ottenere aiuto contro Giovanni che la tradisce. Valentina accetta di buona voglia e spiega poi ad un vecchio amico che ama Giovanni ma che lo considera virilmente debo-le e monotono nell'amore. Nel secondo atto Leo sulla spiaggia, fra cori di giova-nette al bagno, dichiara il suo amore a Valentina ma essa rifiuta di tradire il marito. Giovanni conferma poi allo stesso vecchio amico (ormai una scusa per far parlare i personaggi) di amare Valentina, ma nonostante le buone intenzioni la picchia quando sa che essa favorisce le sue avventure galanti, per amore. Nel terzo atto però, tra rinnovate dichiarazioni d'amore, lo strano ménage si rappez-za. Ne ho dato un parziale e succinto riassunto proprio per meglio esem-plificare che cosa ho inteso per "Don Giovanni che non c'entrano". Qui appunto Giovanni si chiama così per automatico riferimento a una tradizione di seduttori ma senza riprendere in nulla le caratteristiche del nostro personaggio; il nome non definisce un carattere accertato storicamente ma è semplicemente un soprannome. 60
Anche questa commedia come già il racconto dello stesso autore (Don Giovanni in Sicilia del 1943) chiama in causa un personaggio che si trova in situazioni eccitanti senza richiamarsi in nulla al tema don-giovannesco.
51
Non rientrano appieno nel tema del lavoro i balletti e le pan-tomime. Ne do però ugualmente un elenco accompagnato da qualche notizia storica.
68 1 Gaspare Angiolini61
Don Juan, oder das steinerne Gastnahl 1791
69 2 Vincenzo Galeotti62
Il convitato di pietra 1766
70 3 Eusebio Luzzi63
Il convitato 1784
71 4 Onorato Viganò64
Il convitato di pietra 1784
72 5 Domenico Rossi65
Don Juan Tenorio o por otro nombre el conbidado de piedra
1790
73 6 Eusebio Luzzi66
Il convitato di pietra 1793
74 7 Anonimo67
La mascherata di Don Giovanni
1834
75 8 Anonimo68
Don Giovanni di Maraña ossia l'ora del rimorso
1840
76 9 Giovanni Casati69
Don Giovanni di Maraña 1843
61
Musica di Christoph Willibald von Gluck. E' un balletto in quattro atti rappresentato per la prima volta a Palermo nel 1758. 62
Musica di Giuseppe Antonio Le Messier; fu rappresentato per la prima volta nel 1766 in aggiunta, con altri due balletti, al Tancredi di Balbis musicato da Bertoni. 63
Incerta l'attribuzione della musica, per solito riferita ancora a Chri-stoph Willibald von Gluck. Fu uno dei tre balletti aggiunti all'Ezio di Metastasio nella rappresentazione fattane a Pavia nel 1784. 64
Musica di Luigi Marescalchi, fu rappresentato a Roma. 65
Citato senza altra specificazione da Singer, op. cit. p. 160 alla voce 1569: "Mitjana scoprì questo lavoro e lo discusse; scrivendo in spa-gnolo chiama l'autore Domingo. Il cognome potrebbe indicare che era italiano". 66
Musica attribuita a Gluck; fu uno dei balletti scritti per Il matrimonio per industria di Rutini. 67
Rappresentato a Napoli. 68
Rappresentato a Parma. Singer, op. cit. p. 33 alla voce 272 dice "apparentemente da Dumas". 69
E' uno dei pochi testi di balletto che sono riuscito a rintracciare (Giovanni Casati, Don Giovanni di Maraña, ballo fantastico in cinque parti, di Giovanni Casati da rappresentarsi nell'Imperial Teatro alla
52
Scala la primavera 1843, Milano, Pier Gaspare Truffi); ne riporto un breve riassunto per dare un esempio di quello che poteva esser Don Giovanni in un ballo. Nel castello del duca di Algazor, Don Pedro di Maraña sta per sposarne la figlia, Isabella; un individuo mascherato (è Don Giovanni) tenta di pugnalare Don Pedro e riesce poi a dileguarsi. poi ricompare senza maschera e motteggia il fratello di Pedro. Si iniziano le ricerche dell'assalitore; nel trambusto Don Gio-vanni rapisce Isabella mentre il suo amico Don Alfonso rapisce Elvira; tutti si lanciano all'inseguimento. Nel castello di Don Giovanni Isabella rinviene e chiede di restare sola con Elvira per meditare sulla proposta di matrimonio; le due donne si preparano alla fuga attraverso una botola da cui si arriva ai sotterranei dove poco prima i servi del padrone di casa hanno sistemato le statue delle due amanti. Mentre Isabella è già nascosta nella botola, entra Don Giovanni, che corteggia Elvira e quindi Isabella tenta di pugnalarlo. Ma arrivano i salvatori, il duca, Don Pedro e tutti gli altri. Mentre Don Giovanni si batte Isabella fugge indossandone il cappello e il mantello. E' raggiunta poi da Alfonso in un villaggio di contadini in cui si festeggiano le nozze di due giovani; questi tenta di convin-cerla che il duca e Don Pedro sono morti nell'assalto, che Don Giovanni la vuole sposare e tenta infine di portarla via ma i contadini liberano la donna e lo scac-ciano; anche Don Giovanni, giunto alla ricerca di Isabella, è scacciato dagli imbestialiti contadini per avere tentato di sedurre la giovane sposa. Isabella infine si rifugia in un eremitaggio di suore; lì riesce ad avvicinarla un vecchio frate, che subito si rivela essere Don Giovanni e tenta di rapirla. Giunge Don Pedro, che ingaggia un duello con Don Giovanni e cade ucciso, così crede il vincitore. Giungono infine tutti gli altri inseguitori: Don Giovanni dopo una inutile resistenza nel convento dà fuoco a tutto e fugge trascinando Isabella. Dopo tanto correre Don Giovanni nel suo castello banchetta allegramente e racconta le sue avventure agli amici, ma le statue nei sotterranei cominciano ad agitarsi, le luci si spengono, le mura crollano; giunge Don Pedro creduto morto e Don Giovanni muore per l'emozione. Isabella può così sposare l'amato.
Se si trattasse di un testo per il teatro di prosa avremmo potuto nota-re compiaciuti gli interessanti mutamenti avvenuti nella leggenda, cioè la nuova collocazione dei soliti episodi canonici. Ma dato il tipo di genere conviene notare come tutto sia trasferito nell'azione, con largo spazio per elementi di sicuro effetto, ma almeno (e sia detto in rap-porto alle contemporanee commedie che si esamineranno) qui c'è la scusa delle necessità imposte dal fatto che non erano disponibili a quella data tecniche di ballo tali da poter rendere complesse situazioni psicologiche. Il balletto fu rappresentato alla Scala nella primavera del 1843; nulla so dell'Autore delle musiche.
53
77 10 Carlo Veneziani70
L'alba di Don Giovanni 1932
Infine l'elenco delle rappresentazioni per burattini e marionet-te. Anche questi testi possono qualche volta vantare illustri fonti. Difficile datarli: in linea di massima sono della seconda metà dell'Ottocento.
78 1 Francesco Cerlone71
1825
70
Per completare un sia pur marginale discorso sul balletto, ecco un testo che, contando appunto sulle nuove tecniche di ballo che si pos-sono riassumere nelle regole della c.d. danza classica, può far riferi-mento ad un altro clima e ad un altro stile. Don Giovanni alle prese con donne simbolo: è beffeggiato dalla Fanciulla del sentimento per la sua timidezza di adolescente, dalla Donna della passione, dalla Donna eroica e dalla Donna ignota; tutte costoro allontanandosi lasciano cadere un velo. All'alba ritorna la Fanciulla a cui Don Giovanni restituisce il velo e con cui si intrattiene a parlare e a suonare la mandola. A mezzogiorno arriva la Donna della passione con cui Don Giovanni scherza inebriato dal nettare. Nel pomeriggio arriva la Donna eroica con cui Don Giovanni fa lo spaccone per ottenere un abbraccio. Al tramonto le tre Donne cercano Don Giovanni che è sparito. In piena notte Don Giovanni incontra la Donna ignota: essa rifiuta il velo nero che aveva lasciato cadere, non cede al nettare né alle spacconate e se ne va. Quasi all'alba Don Giovanni strappa il velo nero ed esce tra il pianto delle tre donne per la sua prima disillusione d'amore. E' qui evidente un clima di esasperato estetismo simbolista che per nulla costituisce una interpretazione di Don Giovanni: tutto si riduce al luogo comune novecentista della sua sconfitta (Carlo Veneziani, L'alba di Don Giovanni, pantomima di Carlo Veneziani, musica di Franco Casavola, Milano, Ricordi, 1932). 71
E' citato con parecchi dubbi come rappresentazione per burattini da Singer, op. cit. p. 68 alla voce 608; avendo però rintracciato un Nuovo convitato di pietra del Cerlone stampato a Bologna nel 1789, potrebbe essere valida l'ipotesi che la menzione si riferisca ad una versione di questo testo.
54
79 2 Anonimo72
Il ravanello spaventato da un morto parlante
fine XIX
80 3 Compagnia Fiando-Colla73
Don Giovanni il dissoluto ovvero il castigo impensato con Famiola disgraziato in amore
81 4 Compagnia Carlo Conti73
Don Giovanni
82 5 Compagnia dei lupi73
Il convitato di pietra
83 6 Compagnia dei Colla73
Don Giovanni
Gli elenchi proposti possono subito indurre ad alcune conside-razioni di tipo statistico. Suddividendo la produzione (esclusi balletti, pantomime e rappresentazione per burattini) in pe-riodi cinquantennali ci si presenta questo quadro:
72
E' detto tratto da Zorilla. Roberto Leydi e Renata Mezzanotte Leydi in Marionette e burattini, Milano, Collana del gallo grande, 1958, ricordano che ne parla Gregorovius nei Wanderjahre in Italien (II, p. 246). 73
Tutti questi sono citati nel suddetto libro dei Leydi; il primo vi è riportato per intero ed è da avvicinare in primis alla commedia di Andrea Perrucci Il convitato di pietra del 1690 se non addirittura alla prima stesura del 1678; ha inoltre strettissimi punti di contatto con il Don Giovanni ossia il gran convitato di pietra di Eugenio Rontini del 1881 e con altre due commedie milanesi edite senza data e anonime (n.i 56,32 e 57,33 del nostro elenco). Incerte sono le datazioni, di cui per la verità gli Autori non parlano nemmeno. Le differenze fra questi testi si riducono al diverso dialetto parlato dal servo di Don Giovanni e all'estensione delle varie parti: di tutto ciò si dirà parlando di Andrea Perrucci. Quanto all'ordine cronologico, non ho trovato elementi di giudizio né credo d'altronde, come risulta dalla lettura del libro dei Leydi, che se ne possano trovare.
55
Si nota facilmente74 che il momento di maggiore produzione va localizzato nel cinquantennio 1750-1800 (di fatto, 1777- 1800, 15 testi in 33 anni!). Nella trattazione potranno assumere rilevanza anche i periodi di maggiore assenza del tema:
74
Forse allora non usava, ma un grafico sarebbe stato molto più chia-ro:
DAL AL TOTALE COMMEDIE LIBRETTI
1650 1700 10 9 1 1701 1750 3 2 1
1751 1800 15 4 11
1801 1850 7 1 6
1851 1900 4 3 2
1901 1950 12 9 3
1951 1967 3 2 0
TOTALE 54 30 24
56
per le commedie drammi ecc. gli anni 1736-1789, 1797-188175 e 1927-1950;
per i libretti i periodi dal 1734 al 1777, dal 1843 al 1887 e dal 1925 al 1941;
in assoluto i momenti di maggiore crisi sono collocati negli anni 1736-1777 e 1843-1881.
Altra cosa che può subito essere discussa tenendo presente gli elenchi che si sono dati è quella dei titoli di questi testi: fino alla commedia anonima del 1726 (n. 11-10) non compare mai alcun accenno al nome "Don Giovanni"; da quella data in poi i due titoli, Convitato di pietra e Don Giovanni, procedono ap-paiati o addirittura sono ambedue presenti nello stesso testo. Dal 1900 la titolatura "Convitato di pietra" scompare presso-ché uniformemente. Da notare la preferenza accordata dai testi anonimi alla dizione "Convitato di pietra", che potrebbe anche confermare l'ipotesi che questi citati nelle bibliografie non siano altro che ristampe anonime di varie epoche di opere già note. Specie nella seconda metà dell'Ottocento, e con particolare frequenza ancora negli Anonimi, accanto al "Convi-tato di pietra" compaiono aggettivi quale "gran, grande, nuo-vo, nuovissimo", segno che anche per quegli scrittori era ben chiara la coscienza di avere dietro una lunga tradizione. Nel 900 poi tipiche le apposizioni indicanti la sconfitta di Don Gio-vanni: "ultimo", "KO", "il crepuscolo di", "al rogo" e simili. Un esame poi che si volgesse a cercare la definizione di periodi distinti da tendenze di sviluppo omogenee per proporre una divisione razionale della materia sarebbe pienamente soddi-
75
Non considero per la verità quel Convitato di pietra di Bon che, come ho già detto, è piuttosto dubbio e comunque probabilmente di nessuna importanza.
57
sfatto dall'evidenza con cui gli elenchi sopra riportati defini-scono quattro momenti principali:
il periodo 1650-1736, che conosce solo realizzazioni per il teatro di prosa, salvo un'eccezione, e in cui testi si posso-no ricondurre a fonti ben definite
il periodo 1777-1820 in cui la prevalenza dei libretti per musica impone al tema dongiovannesco quei particolari mutamenti ed adattamenti di cui si dirà
il periodo 1832-1900 che vede una paurosa crisi del Don Giovanni sulle scene italiane, che si esprime anche attra-verso il rapido declino della produzione librettistica fino al suo pareggiamento con quella per la prosa
il periodo 1907-1967, infine, che vede rifiorire sulla scena teatrale, in scarsissima misura su quell'operistica, il tema di Don Giovanni, con accenti e formulazioni nuove.
In quanto evidente, adotto per il mio lavoro una simile perio-dizzazione.
59
CAP. 2 - PRIME APPARIZIONI E SVILUPPO NEL TEATRO DI PROSA (DALLE ORIGINI FINO AL 1736)
Negli anni 1636-1637 operava a Napoli la compagnia di attori spagnoli Roque de Figueroa, quella stessa che per prima aveva rappresentato in patria il Burlador. Pare quindi lecito supporre che l'opera di Molina e con essa il tema di Don Giovanni sia stato introdotto in Italia in questo modo e in quegli anni, an-che se non si hanno notizie di rappresentazioni in Italia del Burlador in quel periodo. Comincia così una vasta produzione italiana su Don Giovanni, scenari e commedie che hanno per fonte sicura e certa proprio il testo di Tirso; solitamente si indica in Cicognini
76 il primo Autore di una commedia sul tema
collocando il suo Convitato di pietra nell'anno 1650 circa. Questo il parere di tutti critici compreso lo stesso Farinelli
77.
Ma più attente ricerche su Cicognini e il definitivo articolo di Benedetto Croce78 hanno sostanzialmente modificato il qua-dro della situazione: il testo non gli può essere attribuito e deve essere riferito ad altro Autore Anonimo, convenzional-mente chiamato Pseudo-Cicognini.
76
Giacinto Andrea Cicognini nacque a Firenze nel 1600 da Jacopo, valente commediografo, e morì a Venezia prima del 1651 lasciando gran numero di commedie e drammi per musica. 77
Per un discorso completo su questa attribuzione vedi Le festin de pierre avant Molière, textes publiés avec introduction, lexique et notes par Georges Gendarme de Bevottes, Paris, Hachette, 1907 pp. 350-367. 78
Benedetto Croce, Intorno a Giacinto Andrea Cicognini e al convitato di pietra, in Aneddoti di varia letteratura, vol. II, Napoli, Ricciardi, 1942, pp. 1-15.
60
I motivi di questa negata attribuzione sono molteplici ma quel-lo che pare più valido a Croce è il fatto che in quel Convitato alcuni personaggi usano parlate dialettali, cosa che il letterato fiorentino non avrebbe mai concepito come possibile e che invece era comunissima nei canovacci della Commedia dell'ar-te. Infine i documenti portati da Anna Maria Crinò79 paiono escludere per via storica l'attribuzione ritenuta una volta ca-nonica. Anche la data quindi comunemente accettata per il Convitato di pietra va modificata: 1650 era infatti una datazio-ne ipotetica basata sull'attribuzione a Cicognini morto per l'appunto prima del 1651; essa quindi potrebbe salire o scen-dere; al Convitato dello Pseudo-Cicognini potrebbe perciò togliere anche il primato di essere stato il primo test italiano su Don Giovanni. Ricorda ancora Croce80 che Bartolomeo Bocchini nel suo Le pazzie de' savi ovvero il Lambertaccio cita un Convitato e que-sto nel 1640. Dal che si potrebbe dedurre che prima di quella data esistevano scenari italiani sul tema e che la commedia dello Pseudo-Cicognini si rifaceva a tali testi, fatto confermato anche, come già detto, dall'uso del dialetto. Il nuovo quadro cronologico potrebbe quindi essere questo: 1636-1637 intro-duzione del tema in Italia da parte di compagnia di attori spa-gnoli; 1637-.... scenari italiani sul tema di cui uno potrebbe essere il Convitato del manoscritto casanatense (3-3 del no-stro elenco) affiancato da commedie di cui un esempio po-trebbe essere appunto quella dello Pseudo-Cicognini; poi dal 1652, con la commedia di Onofrio Giliberto, le date si fanno più sicure. Non posso dire quanto questo quadro possa consi-derarsi documentato. Certo che Macchia, l'unico critico che si
79
Anna Maria Crinò, Documenti inediti sulla vita e l'opera di Jacopo e di Giacinto Andrea Cicognini, in "Studi secenteschi", II, 1961. pp. 255- 286. 80
Benedetto Croce, op. cit. p. 8.
61
è occupato della questione in tempi recenti, dopo aver nega-to la paternità del testo in questione a Cicognini, non dà affat-to un quadro cronologico nemmeno ipotetico e anzi sorvola su molti interrogativi. Evidentemente è impossibile datare con sicurezza gli scenari, quindi per questa via è impossibile defini-re sicure precedenze. Inoltre ancora Giovanni Macchia lancia una validissimi ipotesi, cioè che la scena dell'incontro fra Don Giovanni e il povero, che è così significativa in Molière, fosse già ne Il atheista fulminato, altro scenario del manoscritto casanatenze 4186; infatti si notano in un punto alcune vigoro-se cancellature ad inchiostro fatte da mano diversa da quella dell'amanuense: appunto sotto questi sgorbi si possono legge-re le parole "Aurelio lo burla" e "infine gli dà licenza che", che farebbero pensare alla possibilità che Aurelio (che nell'Athei-sta tiene il posto di Don Giovanni) inviti il mendico a bestem-miare in cambio di una ricompensa81. Ma dopo aver proposto quest'ipotesi Macchia non discute una nuova collocazione cronologica da dare al testo tradizional-mente detto della fine del secolo XVII. Occorre allora spostare la data fino a prima del 1665, circa gli anni in cui Biancolelli esportava in Francia il suo Convitato. Su tutti questi problemi non esistono documenti nè ipotesi alternative alle vecchie sistemazioni; Molière dice di aver tradotto il suo Don Juan da un testo italiano che potrebbe essere stato quello dello Pseu-do-Cicognini o di Giliberto o di Biancolelli o forse dell'anonimo autore dell'Atheista o un altro ancora. Insomma, a tutt'oggi, scartata la vecchia collocazione cronologica o per lo meno fatte in essa parecchie crepe, non appare nulla che possa so-stituirvisi altrettanto organicamente. Quindi, o non fare alcun tentativo di ordinazione o cercare un'ipotesi.
81
Una completa discussione su quest'ipotesi si trova nel citato libro di Macchia, pp. XX-XXIII e 20-24.
62
Per trovare una sia pur minima traccia per definire l'intera questione, ho cercato di vedere se le variazioni nel nome dei personaggi, prendendo come base il Burlador, seguissero un certo ordine, ma nulla ne ho concluso: i nomi variano a caso, specie per quanto riguarda quelli del servo di Don Giovanni e delle varie pastorelle e pescatrici. Ho tentato allora di fare alcune ipotesi e di immaginare una possibile linea di evoluzione dal Burlador in avanti e di con-frontarla con i testi che avevo a disposizione; i risultati ovvia-mente non hanno alcuna pretesa di essere veri ma solo in maggiore o minore misura probabili. Gli assiomi su cui si basa l'ipotesi sono due: il primo che, non potendosi la ricerca ba-sarsi sull'esame interno del testo in quanto si tratta prevalen-temente di scenari, occorre cercare linee di svolgimento solo considerando il contenuto narrativo; il secondo, che la linea di sviluppo sia stata questa: apparizione del Burlador in Italia, che provoca l'interesse di Autori italiani che tendono a sempli-ficare il testo di Tirso eliminando le situazioni più complesse e aggiungendo nuovi intrecci; la successione quindi dovrebbe essere: Burlador, il testo ad esso più legato in quanto sua semplificazione e che introduce meno novità, e via di tutti gli altri scenari e commedie più autonomi. Esamino prima quattro testi dandone i riassunti comparati: il primo è il Burlador
82, gli altri sono Il convitato di pietra, venti-
quattresimo scenario del manoscritto 4186 della Biblioteca casanatense intitolato Ciro monarca: delle opere regie che contiene 48 scenari della metà del Seicento83; Il convitato di pietra dello Pseudo-Cicognini84; e infine Il convitato di pietra
82
Delle molte edizioni del Burlador ho usato quella tradotta da Anto-nio Gasparetti, Milano, Rizzoli, 1956. 83
E' in appendice al citato libro di Giovanni Macchia, pp. 149-168. 84
E' in appendice al citato libro di Giovanni Macchia, pp. 181-226.
63
del manoscritto XI, AA, 40 della Nazionale di Napoli datato 170085. Cominciamo con le parti dei quattro testi che si riferisco-
no alle scene napoletane.
85
E' in Enzo Petraccone, La commedia dell'arte, storia, tecnica, scena-ri, Napoli, Ricciardi 1927, pp. 428 437
Burlador - Don Giovanni sta per lasciare Isabella che lo crede il duca Ottavio, ma rifiuta di accendere il lume; lei allora sospetta e lancia grida di aiuto. Entra il Re di Napoli reggen-do un candeliere: Isabella e Don Giovanni fuggono. Il Re incarica Don Pietro Tenorio, sopraggiunto, di ricercare il colpevole; questi allonta-na i soldati accorsi e a lui Don Gio-vanni si arrende: lo zio consiglia al nipote di fuggire a Milano o in Sicilia ma Don Giovanni sceglie la Spagna. Don Pietro riferisce poi al Re come il colpevole gli sia scappato ma aggiun-ge che Isabella accusa Don Ottavio; il Re comanda che la donna sia impri-gionata e che si ricerchi Don Ottavio. Questi nel frattempo si è appena alzato e vestendosi conversa con il servo Ripio; giunge Don Pietro e gli comunica, dopo aver naturalmente raccontato l'accaduto, che il Re lo ha mandato per arrestarlo e costringerlo poi al matrimonio riparatore; Don Ottavio casca dalle nuvole e spinto da Don Pietro decide di partire per la Castiglia.
Scenario casanatense - Don Giovanni lascia Isabella che invoca aiuto; arriva il Re di Napoli reggendo un candelie-re che Don Giovanni fuggendo spe-gne. Il Re riferisce a Don Pietro, ambasciatore di Spagna, l'accaduto e lo incarica delle indagini. Per strada intanto Zaccagnino assonnato incon-tra il padrone Don Giovanni e i due duellano, ma poi si riconoscono e Don Giovanni racconta di Isabella e della decisione di fuggire in Spagna. Don Pietro riferisce al Re che il viola-tore è fuggito ma che si è trovato il rodellino di Don Ottavio; Isabella accusa perciò Ottavio e il Re ordina di ricercar il presunto colpevole e di imprigionare la donna. Don Ottavio poi riceve in casa Don Pietro che gli dà notizie dell'accusa e decide di fuggire in Castiglia.
Pseudo-Cicognini - Isabella cerca di trattenere Don Giovanni incognito;
Scenario napoletano - Don Giovanni fugge da Isabella che vuole sapere chi
64
all'arrivo del Re ella fugge mentre Don Giovanni corre via buttando a terra il lume del Re. Questi incarica Don Pietro di ricercare il colpevole; Don Giovanni poi si arrende allo zio e ne riceve aiuto, dopo aver confessato il delitto, per fuggire in Castiglia. Isabella interrogata da Don Pietro afferma di non avere riconosciuto il colpevole e di amare Ottavio; Don Pietro le rivela che l'aggressore è proprio Ottavio; Isabella è poco convinta ma accusa l'amato davanti al Re. Don Giovanni e il servo Passa-rino si incontrano per strada, non si riconoscono e vengono a duello; una volta superato l'errore Don Giovanni comunica che gli è necessario fuggire in Castiglia.
sia, spegne il lume al Re sopraggiunto e dilegua. Il Re dà incarico a Don Pietro delle ricerche; al buio Don Giovanni si arrende allo zio, gli rac-conta l'accaduto e Don Pietro lo consiglia di fuggire dalla finestra. Don Pietro poi interroga Isabella ed essa rivela che aveva un appuntamento con Don Ottavio; Don Pietro ne deduce che l'aggressore sia lui e consiglia la ragazza di dirlo al Re in modo da affrettare le nozze. Pulcinel-la intanto si mette a dormire per strada ma Don Giovanni cadendo dal balcone lo sveglia; i due duellano ma riconosciutisi partono per la Castiglia. Don Pietro riferisce al Re dei sospetti e del cattivo esito delle ricerche; Isabella conferma la colpa di Ottavio e il Re ne ordina l'arresto. Don Otta-vio frattanto è in camera sua e si sta vestendo aiutato dal servo Coviello cui racconta che il gioco gli ha impe-dito di andare all'appuntamento con Isabella; sopraggiunge Don Pietro a riferire dell'accusa e consigliare la fuga. Il Dottore, visto che le cause a Napoli sono poche, decide di partire con il parente Tartaglia accompagna-to dalla figlia Rosetta.
Alcune osservazioni: identica in tutto quattro i testi la scena di Don Giovanni con Isabella e il Re; diverso invece il comporta-mento di Don Pietro: in Molina, nello Pseudo-Cicognini e nello Scenario napoletano costui inganna apertamente Ottavio e il Re per salvare il nipote, mentre nel manoscritto casanatense Pietro è ambiguo e in definitiva tutti il brano è incongruente (perché Pietro nulla sapendo di Don Giovanni avverte Don Ottavio del pericolo? Forse perché è ambasciatore di Spagna e vuole proteggere un compatriota? Ma allora perché il Re gli
65
ha affidato le indagini?). Isabella apertamente in tutti testi mira a farsi sposare e accetta di accusare Don Ottavio proprio per affrettare la realizzazione del suo desiderio. Rispetto al Burlador i tre testi italiani hanno la novità del duel-lo fra Don Giovanni e il suo servo; lo scenario napoletano infi-ne introduce il motivo dell'appuntamento dato da Isabella a Ottavio e della mancata realizzazione di esso a causa del gio-co. Già da questa prima parte possiamo trarre alcune indica-zioni: lo Scenario casanatense appare sensibilmente semplifi-cato rispetto al Burlador fino a cadere in incongruenze; i due altri testi italiani introducono varianti e novità. Il secondo nucleo narrativo è quello rappresentato dalle
scene sulla spiaggia o nella campagna. Burlador - Su una spiaggia delle coste spagnole Tisbea pesca. Urla dal mare: Caterinone, servo di Don Giovanni, porta a riva il padrone e Tisbea subito li soccorre. Mentre Caterinone va via a cercare gente subito Don Giovanni si dichiara innamorato della ragazza; all'arrivo degli altri pescatori Tisbea racconta del salvataggio e accoglie Don Giovanni e il servo in casa. Intanto nella reggia di Castiglia Don Gonzalo d'Ulloa riferisce al Re della situazione politica portoghese e fa l'elogio di Lisbona; il Re soddisfatto dell'esito dell'ambasceria promette la figlia di Don Gonzalo a Don Giovanni Tenorio. Sulla spiaggia Don Giovanni si prepara alla fuga mentre i pescatori stanno per dare inizio a una festa in suo onore; seduce Tisbea con ripetu-te promesse e giuramenti e poi sparisce; il fidanzato di Tisbea, Anfri-so, insieme alla ragazza promette vendetta.
Scenario casanatense - Mentre le pescatrici sono intente al loro lavoro arrivano Don Giovanni e Zaccagnino naufraghi; subito Don Giovanni si apparta con una delle ragazze mentre il suo servo è bastonato da Cappelli-no cui ha tentato di rubare Spinetta: Zaccagnino spiega poi alla pescatrice chi sia Don Giovanni e che abitudini abbia: infatti questi puntualmente fugge fra le disperate proteste della ragazza sedotta. Nella reggia di Castiglia Don Gonzalo Ulloa parla al Re dell'ambasceria in Portogallo e il Re riconoscente ne promette la figlia Donna Anna a Don Ottavio.
66
Pseudo-Cicognini - Rosalba sul mare canta il suo amore per Manolo; urla dal mare: Rosalba accoglie Don Giovanni e Passarino che a poco a poco si riprendono. Rosalba si pre-senta come una pastorella e Don Giovanni subito le dice che per un voto fatto nel momento del pericolo la deve sposare; è Bassolino ad esprimere il suo disappunto per il nuovo inganno, ma Don Giovanni giura: se mente possa essere ucciso da un uomo di pietra. Il Dottore concede a Pantalone la mano della figlia Rosetta e tutti insieme giocano poi agli indovinelli. Don Giovanni saluta Rosalba che gli ricorda i giura-menti; nell'andar via Passarino getta alla ragazza la lista delle amanti del padrone e Rosalba disperata si getta in mare.
Scenario napoletano - Tisbea pesca sul mare; le si avvicina Rosetta che aspetta di imbarcarsi per la corte di Castiglia. Naufragio: Don Giovanni e Pulcinella giungono a terra e subito Don Giovanni seduce Tisbea mentre Pulcinella prova con Rosetta facen-dosi passare per Don Giovannino. Don Giovanni poi fugge e Pulcinella lancia la lista a Tisbea.
Fatti nuovi: anche nello Pseudo-Cicognini appare il Dottore con i suoi compagni che serviranno a preparare un nuovo rapimento di Don Giovanni: nello Pseudo-Cicognini e nello Scenario napoletano compare la lista delle amanti di Don Gio-vanni. Il testo di Tirso comincia a mostrare una situazione piuttosto complicata, quella del matrimonio di Donna Anna prima promessa a Don Giovanni e poi a Don Ottavio: tutti i testi italiani invece semplificano la vicenda facendo che il Re la prometta subito a Don Ottavio (lo Pseudo-Cicognini e lo Sce-nario napoletano hanno la scena fra il Re e il Commendatore spostata più avanti).
Terzo nucleo: Don Giovanni a Siviglia. Burlador - Il vecchio Don Diego Teno-rio, padre di Don Giovanni, riferisce al Re di Castiglia delle malefatte del figlio e quegli gli commina l'esilio da
Scenario casanatense - Don Giovanni e Don Ottavio s'incontrano in Siviglia e questi racconta all'amico il perché della fuga da Napoli, rivelando inoltre
67
Siviglia e il matrimonio riparatore con Isabella; Donna Anna sposerà un altro nobile. Giunge a corte Don Ottavio: vorrebbe vendetta ma il Re lo calma offrendogli in sposa Donna Anna e Ottavio accetta. Don Giovanni e Don Ottavio s'incontrano per strada ma il Marchese della Motta inter-rompe il loro colloquio; questi rivela a Don Giovanni, dopo aver rievocato le sue avventure galanti, di amare Donna Anna che però è promessa a un altro; Motta infine va via e una donna consegna per errore a Don Giovanni un biglietto di Anna che fissa un appuntamento notturno al Marchese; Don Giovanni legge il biglietto e medita nefandezze. Cate-rinone invano tenta di rimproverarlo; ritorna Motta e Don Giovanni gli dice che una donna gli ha riferito che Anna attende l'amato alla mezzanot-te (in realtà l'appuntamento è per le 11) e che per segno di riconoscimen-to deve indossare un mantello rosso. Giunge poi Don Diego che rimprovera Don Giovanni per le sue malefatte e gli comunica la notizia dell'esilio; questi non è affatto turbato. Incontra poi ancora il Marchese che aspetta con i musici l'ora fissata per fare la serenata: lo intrattiene un po' poi, adducendo un tiro da giocare, si fa dare il mantello e va via. Dalla casa di Don Gonzalo giungono urla di aiuto: Don Giovanni e il Commendatore si battono e questi rimane ucciso; nella fuga Don Giovanni incontra Motta, gli rende il mantello e fugge; l'ignaro Marchese giunge sul luogo del mi-sfatto, viene arrestato e il Re lo condanna a morte.
di amare Donna Anna. Si scambiano i mantelli; Don Ottavio poi a notte fonda va a fare la serenata, ma Anna non si affaccia e Ottavio desolato se ne va. Urla dalla casa; Don Giovanni uccide il Commendatore. Don Gio-vanni e Don Ottavio poi si incontrano e riscambiano i mantelli. Anna piange il padre davanti al Re e a Don Ottavio; il Re fissa una taglia. Zaccagnino avverte il padrone del pericolo.
68
Pseudo-Cicognini - Don Giovanni e Don Ottavio s'incontrano in Siviglia e questi confida il suo amore per Anna; si scambiano poi mantello e ferraiolo, ma Ottavio sospetta qualcosa. Otta-vio va dal Re e loda la bellezza della città; giunge il Commendatore che riferisce dell'ambasciata e parla di Lisbona. Il Re preannuncia il matri-monio di Donna Anna ma non dice con chi. Dongiovanni si reca alla casa di Anna mentre l'ignaro Ottavio fa la serenata e siccome nessuno si affac-cia se ne va deluso; Don Giovanni compie il misfatto, poi grida, duello e morte del Commentatore; Anna maledice l'assassino e con Ottavio accusa Don Giovanni davanti al Re, che fissa una taglia dando incarico a Fichetto di pubblicare il bando. Passarino, alla vista dell'avviso reale, medita ad alta voce sulla sorte, Don Giovanni lo sente e lo costringe a fingere come si comporterebbe se fosse interrogato circa le gesta del padrone: Passarino confessa tutto. Si scambiano poi gli abiti e così fuggono dalle guardie, Don Giovanni facendo-si passare per il suo servo e Passarino per il Re che va ad un'impresa galan-te.
Scenario napoletano - Don Ottavio racconta della sua fuga da Napoli al Re di Castiglia che gli promette pro-tezione. Coviello annuncia l'arrivo del Commendatore che riferisce dell'am-basciata a Lisbona e il Re promette Donna Anna a Ottavio. Il Dottore e Tartaglia giungono a corte, ricono-scono Coviello e gli danno appunta-mento alla villa dove è rimasta Roset-ta. Don Ottavio incontra Don Giovan-ni e gli parla del suo matrimonio. Dongiovanni confida a Pulcinella l'intenzione di sedurre Donna Anna; un servo per sbaglio consegna un biglietto di questa che fissa un ap-puntamento ad Ottavio. Don Giovan-ni e Ottavio si scambiano il mantello. Il Dottore riferisce a Rosetta dell'in-contro con Coviello ed essa parla insistentemente del suo desiderio di marito. Don Giovanni va a fare la serenata a Donna Anna ed è accolto in casa; Don Ottavio poco dopo fa la serenata ma se ne va deluso. Urla, duello e morte del Commendatore. Ottavio si vorrebbe scusare con Anna per il ritardo della sera prima e si avvia verso la casa di lei, ma incontra Don Giovanni che gli restituisce il mantello. Don Ottavio dal Re loda la città; arriva Anna e riferisce del delitto: il Re decreta un tempio per il Commendatore e una taglia su Don Giovanni. Pulcinella corre a riferire al padrone.
In tutto questo nucleo i rapporti fra i testi si complicano: mol-tissimi sono infatti i mutamenti. In linea di massima lo Scena-rio napoletano appare legato alla Pseudo-Cicognini dalla pre-sente in ambedue della taglia su Don Giovanni e della lode di Ottavio a Siviglia: lo Pseudo-Cicognini aggiunge poi scene no-
69
tevoli come quella della fuga di Don Giovanni con un secondo scambio di abiti; tutti i testi semplificano poi il Burlador nell'e-liminare la figura del marchese della Motta e fonderla in quel-la di Don Ottavio, non senza peraltro appesantirla. Per tal via ovviamente i motivi che spingono Anna a dare un appunta-mento all'amante sono invertiti: Anna intriga contro un fidan-zato che non vuole, nei testi italiani invece a favore del pro-messo sposo. Lo Scenario napoletano riscopre poi lo scambio di persona nella consegna del biglietto di Anna e dà maggiore autonomia e spazio di azione a Coviello.
Quarto nucleo: ultime avventure di Don Giovanni in cam-pagna.
Burlador - Batrizio e Aminta stanno per sposarsi; Caterinone annuncia loro l'arrivo di Don Giovanni che nel corso della festa lentamente si sosti-tuisce al fidanzato nel cuore di Amin-ta; Batrizio ha poi da Don Giovanni la conferma del suo sospetto: egli ha goduto della ragazza e il povero contadino decide di rifiutare lo sposa-lizio e di lasciarla a Don Giovanni; questi ha poi un'ultima scena con Aminta piena di promesse e giura-menti ma è già pronto alla fuga.
Scenario casanatense - Cappellino e Spinetta stanno per sposarsi ma Don Giovanni rapisce la ragazza. Pseudo-Cicognini - Mentre il Dottore e Pantalone pescano Don Giovanni rapisce Brunetta. Scenario napoletano - Rosetta sta per sposare Pozzolano ma Don Giovanni la rapisce; il Dottore e Tartaglia picchiano Pulcinella credendolo il rapitore.
Tutta questa scena nel Burlador ha una certa rilevanza anche se in fondo è un doppione della seduzione di Tisbea; tutti i testi italiani la tagliano a fondo o facendo ritornare Don Gio-vanni sui luoghi del primo inganno o collegandone infine le avventure quelle del Dottore tramite appunto il rapimento.
Quinto nucleo: la cena con il Commendatore e la morte di Don Giovanni.
70
Burlador - Sulla spiaggia di Tarragona giunge Isabella (chiamata da Napoli per sposare Don Giovanni) e il servo Fabio; i due incontrano Tisbea dispe-rata: breve racconto e la donna si accoda. Don Giovanni si sta avviando al suo rifugio; con Caterinone si ferma alla tomba del Commendatore, ne sbeffeggia la statua e l'invita a cena. Mentre Don Giovanni è a tavola bussano alla porta; Caterinone va ad aprire e torna pieno di paura inciam-pando; lo stesso Don Giovanni va allora alla porta e fa accomodare la statua. Mentre la cena si svolge i musici cantano; alla fine, appartati, la statua ricambia l'invito a Don Gio-vanni che accetta. Alla reggia si presenta Don Ottavio: vuole chiedere il permesso di sfidare Don Giovanni che adesso sa autore dell'inganno di Napoli, ma il Re impone la pace; Ottavio incontra poi Aminta che cerca Don Giovanni e le promette aiuto intendendo in realtà servirsi della sua testimonianza. Don Giovan-ni riferisce a Caterinone dell'incontro col Re che lo ha accolto molto bene e con Isabella che è pronto a sposare; ma prima deve andare al tempio e va via col servo. La statua accoglie gli ospiti e Don Giovanni si accomoda a una mensa parata a lutto su cui sono piatti a base di scorpioni e di vipere; alla fine del pranzo la statua afferra la mano di Don Giovanni e lo trascina sottoterra. Al palazzo reale frattanto Batrizio, Tisbea, Aminta e Motta accusano Don Giovanni ma giunge Caterinone a riferire della morte del padrone: tutti lodano la giustizia di Dio; si decide che Anna sposi Ottavio contento di sapere che Don Giovanni
Scenario casanatense - Don Giovanni e Zaccarino sono al tempio; invito alla statua. Spinetta rivela a Cappellino di essere stata violata da Don Giovanni e infine si recano in città per chiedere giustizia. Ottavio ormai sospetta di Don Giovanni e lo dice a Zaccarino che subito ne riferisce al padrone. Mentre Don Giovanni è a tavola, con grande paura del suo servo arriva la statua che dopo la cena ricambia l'invito. Cappellino, Spinetta e i pe-scatori accusano Don Giovanni da-vanti al Re; anche Ottavio si unisce al coro. Don Giovanni va a cena con la statua; mentre Ombra e Morte sparecchiano, il Commendatore afferra la mano di Don Giovanni e lo precipita nell'Inferno. Zaccarino riferisce al Re: Don Giovanni all'Infer-no si lamenta.
71
ha confessato in punto di morte che essa è ancora pura. Pseudo-Cicognini - Passarino rimpro-vera Don Giovanni ma inutilmente; i due giungono alla tomba: Don Gio-vanni sfida la statua con un guanto e poi dice a Passarino di invitarla a cena; la statua accetta accennando con la testa per due volte. Ottavio comincia a sospettare di Don Giovan-ni e ne parla al Re. Don Giovanni a tavola: con vari trucchi Passarino ottiene un piatto; bussano: la statua viene fatta accomodare e ricambia l'invito. Passarino vorrebbe licenziarsi ed esige la sua paga, ma poi rinuncia. Il Dottor intanto chiede giustizia al Re. Don Giovanni va a cena dalla statua; la tavola è parata a lutto; una canzone preannuncia la fine: la statua prende la mano di Don Gio-vanni e lo precipita all'Inferno. Passa-rino rimpiange la sua paga poi va alla reggia a raccontare; Don Giovanni dall'Inferno si lamenta.
Scenario napoletano - Don Giovanni nel tempio invita la statua. Il Dottore, Tartaglia e Pozzolano interrogano Rosetta sul rapitore, poi vanno dal Re a chiedere giustizia. Coviello rivela a Don Ottavio che l'uccisore è Don Giovanni ma questi non può crederlo; Pulcinella però, colto al volo, confes-sa tutto e Ottavio lo manda a sfidare Don Giovanni. Mentre Don Giovanni cena, Passarino gli porta la notizia della sfida; bussano: la statua è introdotta e si svolge il banchetto, con un brindisi alla donna più bella. Pozzolano intanto accetta di sposare Rosetta. Nel tempio Don Giovanni è a cena sulla tavola ornata a lutto; la statua lo invita a pentirsi ma questi rifiuta; la statua vola in cielo e Don Giovanni sprofonda all'Inferno. Pulcinella riferisce al Re; Don Giovan-ni dall'Inferno si lamenta.
Prima cosa da osservare in quest'ultima parte è che manca in tutti testi italiani la ricomparsa di Isabella, sicuro segno che tutta la parte napoletana comincia ad essere sentita come inutile e che presto sarà eliminata dalla leggenda. La morte di Don Giovanni è un'altra delle scene chiave ed è quindi logico che la differenza sostanziale non sia poi molto e domini una maggiore uniformità. Nello Pseudo-Cicognini nuovo il fatto che è Passarino a fare l'invito alla statua e che lo stesso rim-pianga la sua paga alla morte di Don Giovanni; nello Scenario napoletano nuova la sfida da parte di Ottavio. Come si vede le differenze fra i testi italiani e il Burlador è veramente poca, segno che la commedia di Tirso ha veramente impresso confi-
72
ni precisissimi e insuperabili allo svolgersi della leggenda e che questi limiti in un primo periodo sono ben presenti e attivi. A questo punto bisogna cercare di stabilire un rapporto fra questi testi; i dati in fondo sono solo questi: lo Scenario 24º del manoscritto casanatense è una semplificazione rozza del Burlador rispetto al quale non introduce elementi nuovi se non quelli del duello fra Don Giovanni e il servo e il lamento finale; il Convitato dello Pseudo-Cicognini aggiunge molte cose rispettando poco la successione delle scene di Tirso; infine lo Scenario napoletano introduce novità come il Dottore (perso-naggio tipico della Commedia dell'arte), la lista, la lode a Sivi-glia, la taglia. Il centro del discorso è quindi lo Pseudo-Cocognini; e allora per via ipotetica: lo Scenario casanatense precede lo Pseudo-Cicognini in quanto rispetta molto di più l'ordine delle scene del Burlador, non ha nessuna delle varianti degli altri due testi (salvo naturalmente il duello e il lamento finale). Il Convitato del manoscritto casanatense quindi deriva piuttosto da Tirso attraverso un numero imprecisato di altri scenari di varie epoche
86.
Più difficile trovare un rapporto fra lo Pseudo-Cicognini e lo Scenario di Napoli; propendo per considerare precedente il primo testo in quanto lo Scenario mantiene l'innovazione della commedia aggiungendone altre (appuntamento mancato fra Ottavio e Isabella a Napoli; lo sbaglio del biglietto; il finale più agile) che sarebbero, almeno in parte, passate nello Pseudo-Cicognini se questo lo avesse avuto come fonte. Ma è pur vero che nello Scenario napoletano non c'erano la novità dell'invito fatto da Passarino nè l'interrogatorio del medesimo; si po-trebbe supporre una lettura del Burlador, che non ha queste
86
Che questi scenari esistessero è dimostrato per esempio da due passi di questo testo: atto I - "Don Giovanni, Zaccagnino fanno la solita scena con la pescatrice; atto II - "Don Giovanni, Zaccarino, vedendo il tempio con la statua e l'epitaffio solito".
73
scene, o di un altro scenario. Inoltre (principio di autorità!) Croce87 lo dice posteriore allo Pseudo-Cicognini e avrà le sue buone ragioni anche se non le specifica. Quindi concludendo: Il convitato di pietra della raccolta casa-natense sarebbe uno dei tanti scenari che si possono supporre esistiti intorno al 1640 fra l'introduzione del Burlador in Italia e l'inizio della produzione letteraria italiana sul tema; esso rap-presenterebbe uno degli ultimi momenti del processo di sem-plificazione del testo di Tirso, tanto è vero che cade in incon-gruenza. Il convitato di pietra dello Pseudo-Cicognini sarebbe l'opera di uno scrittore che conosce il Burlador e con esso confronta gli scenari eliminando le incongruenze, sistemando le situazioni, organizzando diversamente l'ordine delle scene, ma d'altra parte inserendosi nella linea di evoluzione italiana cioè accettando l'apporto della tradizione della Commedia dell'arte (ad esempio il duello fra Don Giovanni e il servo, il dialetto, ecc.); è ovvio che è lecito supporre che tutte le inno-vazione di questo testo fossero in uno scenario perduto. Il convitato di pietra infine della biblioteca nazionale di Napoli rappresenta un ulteriore momento: accetta la tradizione dello Pseudo-Cicognini, recupera alcune cose da Tirso, dà un diverso spazio a Pulcinella e propone varianti al finale. Le obiezioni a tutta quest'ipotesi possono essere molte. Più ci penso e più me ne vengono in mente; fondamentale sarebbe per esempio questa: nulla indica che lo Pseudo-Cicognini abbia per fonte lo Scenario casanatense né che lo scenario napole-tano si rifaccia allo Pseudo-Cicognini; in mezzo potrebbero esserci stati altri testi perduti o anche tradizioni parallele con diversi archetipi. Tengo ancora precisare che base di tutta quest'ipotesi è la supposizione di una linea di sviluppo che generalmente è la più probabile quando un certo numero di artisti si trova di fronte un modello di grande autorità: sempli-
87
Benedetto Croce, op. cit. p. 12
74
ficazione prima, poi arricchimento, rimaneggiamento eccetera con sempre maggiore autonomia. Tutto ciò vale naturalmente a proporre una datazione relativa dei tre testi; per una assoluta, considerando l'evoluzione eu-ropea del tema e constatando che queste opere non ne sono influenzate né incidono su di essa, collocherei tutti i testi al periodo precedente Molière e precisamente: al decennio 1640-1650 lo Scenario casanatense; lo Pseudo-Cicognini e lo Scenario napoletano agli anni successivi, certo prima del 1658 anno in cui Biancolelli scrisse il suo Convitato. Ciò nonostante, ho preferito nel mio elenco ordinare queste opere così come viene indicato da una bibliografia aggiornata, anche critica-mente, quale quella di Singer, che risale al 1965 nella sua ul-tima revisione. Molti nuovi elementi, o molte delusioni forse, senza dubbio potrebbe portare la lettura del Convitato di pietra di Onofrio Giliberto ma tale opera è perduta ed è quindi inutile arzigogo-larci sopra come ha fatto a suo tempo Gendarme de Bévotte (al proposito Macchia ricorda come questi affermasse che in Giliberto poteva esistere la scena del povero senza avere mai evidentemente letto l'opera in questione)
88
Croce89 ricorda che il Quadro ne dette la scheda: Il convitato di pietra, rappresentazione tragica di Onofrio Giliberto di Bolo-gna, in Napoli per Francesco Savio, 1652 in 12º; aggiunge che fu ristampata a Bologna; cita l'Allacci che dice trattarsi di commedia in prosa e conclude ricordando che Goldoni affer-mava essere quel testo più o meno uguale a quello che lui riteneva il Convitato di Cicognini; Croce aggiunge che si può
88
Giovanni Macchia, op. cit. p. XX. 89
Benedetto Croce, op. cit. p. 13.
75
supporre che vi fosse accentuato l'elemento morale e religio-so90. Ho tenuto da parte la trattazione del Convitato di pietra di Giuseppe Domenico Biancolelli, dell'Aggiunta al Convitato di pietra del medesimo autore, rispettivamente del 1658 e del 1673, e dell'anonimo Atheista fulminato, e questo perché con le due citate opere (due, giacché appunto l'aggiunta costitui-sce parte integrante del Convitato e non ha una sua autono-mia) ci si trasferisce su un altro piano: da un lato perché Bian-colelli è il primo ad eliminare le scene napoletane e con ciò comincia a sentirsi molto indipendente dal modello del Burla-dor, dall'altro perché l'Atheista è il primo travestimento di Don Giovanni; insieme perché, unitamente al fatto che le ipotesi di Macchia sulla scena del povero spingono ad abbassare la da-tazione dell'Atheista fino a farlo fonte di Molière quindi coevo a Biancolelli, i due scenari hanno una prima scena molto simi-le; in riassunto infatti suonano così:
90
Benedetto Croce, op. cit. p. 15.
Biancolelli - Arlecchino invita il Re ad avere pazienza per le malefatte di Don Giovanni; per consolarlo raccon-ta poi le avventure della regina Giovanna.
Atheista - Il Re di Sardegna si lamenta con la corte di non poter avere figli dalla moglie malata; i cortigiani lo consolano.
In ambedue i casi c'è un Re triste che ha bisogno di consola-zione; basta ciò per poter considerare le due scene apparenta-te? Forse in assoluto no, ma considerando che è la prima volta che un simile Re appare nella leggenda di Don Giovanni mi pare probabile una comunanza, certo più che non una così singolare coincidenza. Del resto, i nostri due testi hanno in comune il fatto di essere essenzialmente diversi dalle altre produzioni italiane: Biancolelli nel senso, forse deteriore, dell'asservimento del tema all'esigenza di dare risalto ad Ar-
76
lecchino, l'Atheista nel senso di travestire Don Giovanni con nomi diversi in diverse avventure; in ambedue però la mede-sima coscienza: le scene fondamentali non si toccano se non in particolari di contorno, il che vuol dire che per questi Autori i due nuclei della leggenda (avventure da una parte, convito dall'altra) sono chiaramente una sola cosa e che è inconcepibi-le un Don Giovanni che non muoia fulminato dall'intervento di una qualche statua. Il convitato di pietra di Biancolelli91 non c'è giunto direttamen-te ma in una traduzione di Thomas Simon Gueullette che reca la data del 30 novembre 1669, giorno in cui il testo fu replica-to, in un in un manoscritto della Biblioteca dell'Opéra di Pari-gi92. Citerò solo in riassunto le più interessanti novità: come si è detto, manca del tutto la parte che si svolge a Napoli; dopo la scena ricordata
Arlecchino di notte si lamenta del padrone, ma giunge anche Don Giovanni che finge di lamentarsi anche lui delle proprie malefatte: Arlecchino pentito sfida lo sconosciuto per dare prova della sua fedeltà e dopo una comica battaglia si finge ferito; i due poi si riconoscono.
E' la scena vecchissima del duello arricchita di occasioni e spunti comici.
91
Figlio di comici, Giuseppe Domenico Biancolelli nacque a Bologna nel 1636 o 37; avviato fin da piccolo all'Arte, fu a Parma, Parigi e Roma protetto dal principi e cardinali. Dopo un soggiorno a Vienna ritornò a Parigi nel 1661 fra i Comédiens du Roi come secondo Zanni e poi come primo, nel ruolo di Arlecchino. Amico di Luigi XIV, morì di polmonite dopo una danza il 2 agosto 1668. Di lui restano 73 scenari tradotti da Gueulette. 92
E' in appendice al citato libro di Macchia, pp. 165-176.
77
Dongiovanni è a tavola; Arlecchino ottiene un piatto affermando che un medico gli ha rivelato che è molto indigesto.
La stessa scena era nello Pseudo-Cicognini ma qui è ancora arricchita e resa certo più comica. Identica la scena del nau-fragio, ma
Arlecchino ha modo di biasimare il padrone dicendo che Don Giovanni all'Infer-no sarebbe capace di sedurre persino Proserpina e gettando la lista alla pesca-trice invita il pubblico a guardare se nell'elenco non sia compresa una qualche parente. Nuovi lazzi fra Arlecchino e Pantalone mentre i loro padroni, Don Giovanni e Don Ottavio, si scambiano i mantelli.
Interessante il fatto che il commendatore si chiami Don Pierre, col che è evidente che si vuole giocare sul doppio senso di Festin de Pierre.
Dopo il delitto Arlecchino medita sulla taglia; giunge Don Giovanni che lo co-stringe a dimostrare che se interrogato non parlerebbe, ma Arlecchino confessa tutto.
Scena già vista anche questa.
Alla fuga di Don Giovanni Arlecchino ha modo di farsi beffe dei contadini. Nel tempio è Arlecchino a invitare la statua per ordine del padrone. Gustosissima scena è quella in cui Pantalone vuole costringer Arlecchino a dire chi sia stato l'aggressore di Donna Anna e Arlecchino conclude il suo ragionamento con il nome di... Pantalone.
Richiama decisamente Molière la scena in cui Don Giovanni dietro le insistenze del servo finge di pentirsi. Nella Suitte du festin de pierre93 Biancolelli aggiunge alcune scene al testo precedente:
Dopo la serenata di Don Giovanni ad Anna, Arlecchino corre a prendere una scala per andare da Diamantina. Arlecchino fa lazzi con contadini e con un cieco. Arlecchino parla di Diogene.
Ed altre; tutte queste nuove scene hanno per comune deno-minatore il nome di Guillaume al cui suono Arlecchino è preso
93
ib.. pp. 177-179.
78
da grande paura. Lo scenario reca la data del 4 febbraio 1673 e non si ha notizia che sia stato rappresentato prima di quel giorno. Le fonti di questi due scenari sono evidenti e tra di esse metteremo in prima fila lo Pseudo-Cicognini; il fine è quello di incentrare la rappresentazione su Arlecchino. Lo stile è quello di appunti sparsi non ordinati, quelli che oggi chiame-remo "appunti per una regia". Il atheista fulminato94 è uno scenario anonimo, quarto del citato manoscritto della Casanatense. Macchia95 ricorda che Thomas Shadwell cita nella prefazione del suo Libertine del 1676 un Atheista di Autore italiano rappresentato frequente-mente in Italia, addirittura di domenica nelle chiese. Certa-mente il testo fu esportato in Francia e probabilmente servì come fonte a Molière. Come dice il titolo Don Giovanni è qui un ateo ed è la prima volta che una simile interpretazione del personaggio compare nello svolgimento del tema. Si è detto che è un travestimento di Don Giovanni e non è certo casuale che in questo periodo vadano di moda simili prove (vedi L'empio punito di Acciaiuo-li). Presenta un'azione molto più rapida e violenta del solito con forti tinte "romantiche" tanto da far pensare a volte a certe situazioni di Ernani o della Forza del destino (natural-mente mi riferisco ai libretti musicati da Verdi).
Dopo la citata scena il duca Mario riferisce che il conte Aurelio gli ha rapito la sorella Leonora e il Re lo incarica delle ricerche; Bertolino, servo di Aurelio, e altri si lamentano delle malefatte del rapitore. Mentre Aurelio e Leonora alla macchia si giurano eterna fedeltà, i banditi portano Cassandro e la figlia Angela assaliti durante il loro viaggio a Cagliari. Aurelio libera Cassandro ma vuole un riscatto per la ragazza. Leonora comincia ad essere gelosa. Bartolino riferisce al padrone dell'accusa mossagli ma Aurelio non è punto scosso. Aurelio, Bartolino e Leonora si trovano poi davanti al tempio con le statue dei genitori di Mario:
94
ib.. pp. 131-147. 95
ib. p.132.
79
Aurelio le beffeggia, Leonora lo prega di smetterla, Bartolino trema; le due statue parlano invitando Aurelio a desistere dagli insulti e a ricordarsi che "chi di coltel ferisce di coltel perisce". Intanto a Cagliari Mario e il servo Buffetto si apprestano a partire per le ricerche; mentre Mario va alla reggia con Magnifico, Buffetto prega l'amante Olivetta di seguirlo contro i banditi. Nella campagna Aurelio ed Angela hanno un incontro e Leonora vi assiste nascosta; Aurelio manda via Angela con Bartolino e subito deve subire le rampogne di Leonora; ribatte con le maniere forti e getta la donna a terra; un romito accoglie nella sua grotta la disperata Leonora.
Finisce così il primo atto: Mario fa un po' le parti di Don Pietro e di Don Ottavio, Cassandro e Angela quella del Dottore e della ragazza. Le statue sono diventate due e più elementare sistema di amplificazione non si poteva inventare. Nuova la scena d'amore di Aurelio con Angela cui Leonora assiste na-scosta, di sicuro effetto. Nuovissimo il romito anche se serve solo a risolvere momentaneamente una complessa situazione di scena.
Aurelio ordina a Bartolino di spiare le mosse di Mario ma il servo esorta il pa-drone a pentirsi; così Aurelio decide di andare lui stesso dopo aver rubato la veste al romito per travestirsi. Mario intanto con Buffetto e Olivella vestiti comicamente si appresta a partire e promette a Magnifico che avrà ragione del bandito in un sol giorno. Leonora ha una crisi di disperazione e il romito la consola. Nella campagna intorno giungono Mario e i suoi soldati; Aurelio si fa avanti offrendosi di aiutare a catturare il bandito. Giunge al palazzo reale Berto-lino proprio mentre il Re è pentito della decisione presa di perseguire Aurelio che avrebbe potuto essere il suo erede, ma ancora una volta il servo accusa il padrone. Nella campagna Aurelio intanto sparpaglia i soldati e ha così facile via a catturare a tradimento Mario e i suoi; vorrebbe farli fucilare ma ancora una volta il tempio si apre e le statue invitano Aurelio a pentirsi in tempo, prima del tramonto.
Buffetto mostra in questo atto una certa indipendenza che fa pensare alla libertà di cui godeva Coviello nello scenario napo-letano. La ripetizione dell'intervento delle statue è un palese tentativo di accentuare l'aspetto miracolistico della vicenda, nonchè un ampliamento teso a creare un clima. Nel terzo atto Ancora una volta Aurelio fa la sua professione di ateismo rimproverato da Berto-lino. Giunge Olivetta a raccontare la fuga di Mario dal campo e poi per ordine di
80
Aurelio, ma non controvoglia, va a intrattenere la truppa; mentre è così occupa-ta un soldato le comunica la notizia dell'esecuzione di Buffetto e la ragazza ha modo di vedere il suo fidanzato impalato. Arriva Angela vestita da bandito e Aurelio invita tutti a mangiare; arriva anche il romito e qui forse si svolge la famosa scena. Giunge infine Leonora, che muore per le troppe astinenze ed è trasportata nel tempio dei genitori. All'apertura del tempio appaiono le statue con la spada in mano: Aurelio fa chiedere loro da Bertolino se vogliono duellare con lui e le statue fissano l'incontro per il tramonto. Intanto il romito e Cassan-dra riferiscono al Re di Leonora e di Angela, Olivetta di Mario e di Buffetto. Mentre parlano arriva lo stesso Mario trafelato. Aurelio dunque va al tempio per il duello: una delle statue gli prende la mano e lo invita a pentirsi; Aurelio rifiuta: s'apre il cielo e un fulmine lo fa sprofondare. Bertolino e gli altri riferiscono al Re. In cielo le statue e Leonora lodano Dio, all'inferno Aurelio, Plutone e i demo-ni fanno lamenti.
Nel terzo atto si confermano le tendenze già rilevate: la ripeti-zione della scena del rimprovero da parte di Bertolino e l'inuti-le crudeltà di Buffetto impalato; la cena è sostituita da un duello; nuovo il fulmine, già preannunciato dal titolo, che giunge a punire Don Giovanni. In linea di massima, nonostante le novità derivanti dalle situazioni che l'Autore ha preferito a quelle classiche, i luoghi tipici sono gli stessi anche se manca ogni scena paragonabile alla violazione di Anna e all'uccisione del Commendatore. Il testo pare dipendere soprattutto dallo Pseudo-Cicognini e dallo Scenario napoletano cui si riallaccia in particolare per la grande autonomia data al servo del conte (che qui tiene le veci di Don Ottavio). Tre casi particolari un po' fuori dal tipo di evoluzione che si è cercato di delineare (dal Burlador all'autonomia): Il empio punito di Acciaiuoli, barocchismo travestimento di Don Gio-vanni e primo libretto per musica, del 1669; Il convitato di pietra di Perrucci, interessante ma superfluo tentativo di dare forma nobile e letterariamente curatissima alla vecchia leg-genda di Tirso al di fuori della linea di evoluzione; Don Giovan-ni Tenorio ossia il dissoluto di Goldoni, compimento del pro-cesso verso l'autonomia e autentica interpretazione della sto-ria in base a nuovi canoni estetici e di comportamento.
81
Il empio punito96 di Filippo Acciauoli97 è come si è detto è il primo libretto per musica in senso assoluto; il compositore potrebbe essere stato o lo stesso Acciauoli o Alessandro Me-lani98; fu rappresentato per la prima volta a Roma in palazzo Colonna nel 1669. Contempera in un certo senso l'esigenza di adattare la leggenda di Don Giovanni al teatro d'opera con-temporaneo che propendeva per temi tipicamente arcadici ricchi di pastorelle e di ambienti rustici; la stesura è ovviamen-te in versi, di una mollezza veramente notevole.
Mentre gli stallieri lavorano alla reggia di Pella, giunge Ipomene a chiedere dell'amato Cloridoro, che sopraggiunge poco dopo, ha una scena d'amore con la ragazza e parte poi per la caccia. Sulla spiaggia intanto Atamira, figliola del re di Corinto, cerca il marito Acrimante, cugino del re medesimo; una nave affonda e Atamira accoglie a terra lo sposo e il servo Bibi; cerca di riconquistare il marito ma è respinta. Sopraggiungono intanto pastori e pastorelle, e Acrimante ottiene ospitalità da Auretta; Altamira cerca invano di trattenerlo rimproverandolo e spiega poi a Bibi che fu ingannata e costretta al matrimonio da un travestimento di Acrimante. Arrivano sul posto il Re di Macedonia Atrace e il cugino Cloridoro per la caccia e incontrano Atamante che dice di essere una ragazza tracia lì naufragata e rimasta orfana; il Re ordina che sia portata alla reggia e rifocillata. Nel palazzo reale Ipomene, sorella di Atrace, invoca l'amato in compagnia della nutrice Delfa. L'aio di Ipomene, Tidemo, riferisce al Re che è arrivato Acrimante e tutti ne sono contenti; giungono anche Ipomene, che abbraccia subito Clorido-ro, e dietro di lei Acrimante e BiBi; Acrimante confida al servo l'intenzione di possedere Ipomene. Poco dopo Bibi ha un incontro con Delfa e le dichiara il suo amore apprendendo dalla donna che Ipomene ama Cloridoro: le dà allora incari-co di dire alla padroncina che Cloridoro l'attenderà a notte nelle stanze di Acri-
96
E' in appendice a Giovanni Macchia, op. cit. pp. 227-332. 97
Filippo Acciaiuoli nacque a Roma nel 1637; dopo lungo peregrinare vi ritornò nel 1668 diventando Arcade e cortigiano di Cristina di Sve-zia. Fu impresario, Direttore del teatro Tron ma anche macchinista. Morì nel 1700 lasciando numerosi testi fra cui anche rappresentazioni per burattini. 98
Alessandro Melani nacque a Pistoia il 4 febbraio 1639; fu in Francia dal Cardinal Mazzarino, poi Maestro di cappella a Pistoia, a Bologna e infine a Roma dove morì nel 1703.
82
mante; anche Bibi ottiene un appuntamento da Delfa. A sera con l'aiuto di Niceste Bibi dà la scalata al tetto per calarsi sul balcone di Delfa. Intanto si svolge un ulteriore incontro fra Acrimante e Atamira: ancora una volta la donna è respinta. A notte poi nel giardino, mentre i mori ballano, il Re Atrace geme d'amore per Atamira.
Un vero travestimento insomma! Ovvi quali personaggi rap-presentino i ruoli tradizionali: Acrimante è Don Giovanni, Ipo-mene Donna Anna, Tidemo il Commendatore, Atamira è un po' Isabella e un po' la pescatrice, Cloridoro è Ottavio; il Re ha uno spazio maggiore che in precedenza: è qualcosa di più che un semplice giustiziere o ascoltatore di racconti altrui. Nel secondo atto,
Bibi legato ad una corda raggiunge dal tetto il balcone di Delfa; sta per darle un bacio ma un malinteso fa sì che Niceste lo sollevi di botto e lo faccia volare per il giardino e, siccome Bibi ha indossato il mantello del padrone, Atrace crede che si tratti di Acrimante che vuole andare da Ipomene o da Atamira, e dà incarico a Cloridoro di iniziare le ricerche. Ipomene intanto, secondo i patti, si reca nelle stanze di Acrimante fiduciosa di trovarvi Cloridoro, ma c'è invece Acrimante ad attenderla ansioso; purtroppo Bibi arriva in furia a chiamarlo a rapporto dal Re e Ipomene resta lì ad aspettare. Mentre Acrimante sta per arrivare dal Re questi accusa Atamira di tradire il suo amore con Acrimante ma la donna smentisce accusando piuttosto il marito di puntare a Ipomene; giunge infine Acrimante ed è condannato alla prigione; Cloridoro cerca di consolarlo e Atamira medita di liberarlo. Cloridoro trova Ipomene nelle stanze di Acrimante e naturalmente maledice la fidanzata. Atrace sempre più irritato decide di giustiziare Acrimante ma Atamira sostiene di aver diritto alla vendetta e il Re le concede questo privi-legio; infatti questa porta al marito imprigionato del veleno: dopo che ha fatto la sua professione di orgoglio e di superbia, alla presenza di Bibi e della donna Acrimante, chiede perdono e beve il veleno; Atamira ordina a Bibi di portare il corpo nelle sue stanze. Cloridoro intanto è disperato e solo dietro le insistenze di Delfa e Bibi fa pace con Ipomene che da parte sua lo invita a un convegno notturno. Atamira riferisce poi il Re che Acrimante è morto e questi approfitta dell'occasione per proporre il matrimonio, ma la donna rifiuta. Infine, decisiva scena d'amore fra Delfa e Bibi: la donna vuole portarsi a letto a tutti i costi il servo che accetta ma propone di trasferirsi in un'altra stanza visto che in quella c'è il cadavere di Acrimante; intanto un sogno viaggia in testa al morto: nella reggia dell'Inferno Proserpina balla con Acrimante e con lui si intrattiene mentre demoni e mostri danzano.
Un secondo atto tragico e intricato, in cui risalta la strana sfor-tuna di Acrimante che viene processato e condannato vera-
83
mente solo per le sue cattive intenzioni. Si riconoscono facil-mente le solite scene: gli amori del servo, gli appuntamenti ecc.; interessante la scena finale che amplifica un'idea già di Biancolelli; estremamente spettacolare doveva poi risultare il volo di Bibi attraverso il giardino, ottima scusa per utilizzare trucchi scenici.
Bibi dunque è restato senza padrone e quindi senza soldi e di questo si lamenta, ma Atamira giunge a consolarlo: infatti poco dopo Acrimante si risveglia con grande stupore del suo servo ma non è affatto riconoscente a colei che lo ha salvato, anzi la scaccia e subito fa confessare a Bibi l'esistenza dell'appuntamen-to fra Ipomene e Cloridoro. Poco dopo infatti Ipomene lancia grida di aiuto: accorre Tidemo e Acrimante lo uccide; il Re sopraggiungendo crede di aver ucciso lui il vecchio in quanto ha sparato un colpo di pistola contro l'aggressore. Giunge anche Cloridoro all'appuntamento e subito dà inizio alle ricerche ma non trova nulla; arriva poco dopo Telefo, ambasciatore di Corinto, a imporre di sposare Atamira perché troppo a lungo ha trattenuto la ragazza in casa sua. Atamira è così costretta a rivelare la sua condizione di sposa di Acrimante. Bibi dice addio a Delfa e poi sollecita alla fuga il padrone, che piuttosto insulta la statua di Tidemo e la invita a cena; la statua risponde di accettare; Acrimante allora invoca Plutone perché lo aiuti e subito sei statue portano una tavola apparecchiata; la statua non vuole cibi terreni e, poiché Acrimante si è votato a Plutone ed è tempo che segue il suo destino, vola in cielo mentre l'empio spro-fonda; all'Inferno Acrimante è alle prese con Caronte cui domanda notizie su come si possa tornare indietro. Come al solito Bibi riferisce al Re: Bibi e Delfa si sposano, Atamira e Atrace si sposano e tutti lodano la giustizia celeste.
La storia fa acqua da tutte le parti e vi sono parecchie illogici-tà; tipica poi l'amplificazione del motivo della statua, visto che sei sono qui quelle che intervengono al banchetto, o meglio sette considerando quella di Tidemo. In conclusione si può dire che l'Autore conosce bene soprattutto Biancolelli da cui trae parecchie situazioni e anche lo Pseudo-Cicognini e lo Sce-nario napoletano, mentre non appare necessario il riferimento al Burlador in quanto le scene del testo comuni con Tirso compaiono anche nei citati testi italiani. Inutile poi insistere sul totale fallimento che significa, nei riguardi della leggenda, questo libretto: non è su questa strada che il tema può trovare la sua fortuna; Inutile anche rimarcare la modestia del testo e
84
gli infiniti limiti artistici che presenta la resa dei personaggi. Questa insomma non è un'interpretazione ma un mero trave-stimento e quel che è peggio con la piena coscienza di farlo. Nell'Empio punito le scene napoletane della leggenda sono un lontano ricordo: Atamira fa solo cenno a Bibi di un precedente inganno di Acrimante. Già in Biancolelli e nell'Atheista esse non apparivano: vuol dire che la linea di sviluppo più sicura conduceva all'eliminazione di tutta quella parte anche a poca distanza dalla prima apparizione del tema, e questo perché viene spontaneo considerarla inutile essendo il carattere di Don Giovanni già sufficientemente precisato da tutto il resto. Di ciò è ben cosciente Molière che pure certo conobbe e usò il Burlador. Un passo indietro rispetto a questa evoluzione è anche Il con-vitato di pietra di Andrea Perrucci99 nelle sue due stesure, quella del 1678 (che non ho visto) e quella del 1690 edita sot-to lo pseudonimo di Enrico Prendarca100. Suppongo che la situazione presentata dal secondo testo si possa riferire con sufficiente sicurezza anche al primo in quanto è detto una rielaborazione di esso. Riappaiono qui i nomi di Tisbea e di Coviello e tutta la vicenda è una vera e propria riscrittura dello Pseudo-Cicognini: diverse sono le parole, ora più ora meno, ma sempre identica la situazione e soprattutto identico lo spirito; evidente anche la conoscenza del Burlador; inutile quindi riferirne un riassunto. Giova invece notare che chiara-
99
Andrea Perrucci nacque a Palermo il 1 giugno del 1651 e studiò lettere e diritto a Napoli: fu segretario di molte accademie di Napoli, Palermo, Roma e poeta del teatro San Bartolomeo a Napoli. Ivi morì il 6 giugno 1704. 100
Il convitato di pietra, opera tragica ridotta in miglior forma e abbel-lita dal dottor Enrico Prendarca, in Napoli, a spese di Tommaso Aicar-do, 1706.
85
mente Perrucci ha intenti poetici e li palesa come può soprat-tutto nel far parlare molto a lungo i suoi personaggi: e così ecco Tisbea che disquisisce sul vantaggio di essere contadina (come già faceva in Tirso) e fa un lungo lamento quand'è ab-bandonata, e c'è il lungo lamento di Anna e la lunga lode di Don Giovanni alle donne di Castiglia e il lungo lamento dalle fiamme... ma questi supremi interessi poetici male si coordi-nano con la narrazione che spesso ha bisogno solo di velocità e di passaggi concisi. E troppo dà noia una così pedissequa imitazione e un così costante richiamo ai testi canonici; pur tuttavia il Convitato di Perrucci ha avuto un'importanza fon-damentale negli anni in cui venne a mancare agli Autori la consultazione degli scenari e forse dello stesso Pseudo-Cicognini; così è possibile citare alcuni testi che sono riduzione e adattamenti di Perrucci: il primo è Il nuovo convitato di pie-tra101 di Francesco Cerlone102 del 1789, poi Il Don Giovanni Tenorio ossia il gran convitato di pietra103 di Eugenio Rontini del 1881 infine i due testi che non hanno data nella stampa104
101
in Commedie di Francesco Cerlone napolitano, Bologna, tomo VI, 1789, pp. 167-244. 102
Francesco Cerlone nacque a Napoli del 1730; ivi esercitò la profes-sione di tintore per tutta la vita tanto da essere soprannominato "l'ar-tigiano poeta"; morì nel 1818. 103
Eugenio Rontini, Don Giovanni Tenorio ossia il gran convitato di pietra con Stenterello procaccino amoroso, naufrago sfortunato, spaventato dalle fiamme infernali, commedia in quattro atti, Firenze, Salani, 1881. 104
Il gran convitato di pietra, dramma tragico in tre atti ad uso dei piccoli teatrini, Milano, tipografia Giovanni Gussoni editore. Il fatto che il dramma sia detto "ad uso dei piccoli teatrini" potrebbe far pen-sare che si tratti di una rappresentazione per burattini. Il gran convitato di pietra, commedia in tre atti ad uso di almanacco per l'anno corrente, Milano, dalla stamperia Tamburini. Anche qui "uso di almanacco" potrebbe far pensare che il testo si rivolgesse un pubblico infantile o comunque poco colto.
86
(n.i 56,32 e 57,33 dell'elenco) e la rappresentazione per burat-tini Don Giovanni ovvero il castigo impensato con Famiola disgraziato in amore (n. 80,3)105. Tutti i testi citati sono riduzione da Perrucci nel senso che ne copiano parti intere variando solamente i nomi (ad esempio in Cerlone Coviello si chiama Ficcanaso, nei due Anonimi milane-si Arlecchino, in Rontini Stenterello, nella rappresentazione per burattini Famiola) e ne tagliano parti considerevoli rabber-ciandole alla meno peggio; la loro copiature è così cieca che hanno tutti la parte napoletana, cosa che nel loro secolo è veramente straordinaria. Nessuno, questo è certo, di quei testi ha una sua autonomia né una sua personalità; dimostrano solo l'importanza avuta da Perrucci nel propagandare il tema dongiovannesco in periodi in cui altri modelli o non erano più graditi per vari motivi o non erano più reperibili, ad esempio gli scenari. Il libretto di Acciauoli e la commedia di Andrea Perrucci non costituiscono affatto una novità nella storia di Don Giovanni né una tappa che avrà un seguito: il primo adatta la leggenda a certe esigenze in maniera automatica e senza creare affatto dei personaggi, il secondo fa un'accurata riscrittura di testi noti escludendosi dalle linee di sviluppo e rinunciando a tenta-re di inventare un Don Giovanni adatto ai suoi tempi. Questa conclusione però potrebbe parere falsata da un pre-giudizio: sembra quasi che si voglia dire che quello che non hanno fatto Acciauoli e Perrucci ha fatto Goldoni. Non na-scondo che l'impressione che si ricava dalla lettura del Don Giovanni Tenorio ossia il dissoluto106 di Goldoni è proprio que-
105
È pubblicato Roberto Leydi, op. cit. Gli Autori sarebbero compo-nenti della Compagnia Fiando-Colla. 106
E' in Collezione completa delle commedie dell'avvocato Carlo Gol-doni, Piacenza, dai torchj del Majno, 1833, vol. 39, p. 177.
87
sta: finalmente un Autore che, anche se a volte con poca accu-ratezza, pur senza fare un capolavoro, con onestà sente il personaggio e con onestà lo colloca in una prospettiva teatrale contemporanea; e siccome credo che la cosa più importante sia sentire Don Giovanni come un fenomeno culturale che si arricchisce anno dopo anno, questo mi pare un gran merito. Per capire però bene gli intenti di Goldoni bisogna prima met-tersi in una nuova condizione psicologica, pensare intensa-mente al modo di fare teatro che Goldoni descrive nel Teatro comico e al tipo di società che fu oggetto della sua rappresen-tazione; raggiunta una certa immedesimazione in quell'am-biente, occorre di cercare di collocare Don Giovanni in quell'ambito: stona! Ebbene la soluzione di Goldoni è la più semplice, la più naturale, la più logica, la più realistica: Don Giovanni per Goldoni non è un tabù, intoccabile, Goldoni sa che è una brutta storia priva di senso, balorda, e tale la consi-dera anche se opera di un Calderòn, che tutti allora credevano Autore del Burlador; dovendo scriverne uno (immaginiamo che, essendo alla sua quinta prova teatrale e non avendo ot-tenuto alcun successo definitivo, essendo legato da un ferreo contratto con il teatro San Samuele dell'impresario Imer, non avesse poi tanta libertà nella scelta dei suoi temi), Goldoni affronta la sua fatica con tutta la sicurezza di un artigiano; e in definitiva tutto il sapore della sua nuova arte è proprio questo: fondamentale onestà, fondamentale buon senso, fondamen-tale buon gusto, mestiere ma sempre schiena dritta e profes-sionalità. Ed è infatti il buon gusto a condurre questo nuovo dramma: i personaggi per questa via acquistano dimensioni e significati tutti diversi; come può la statua sussistere in un simile mon-do?
Don Alfonso, primo ministro del re di Castiglia, spiega ad Anna la differenza fra amore filiale e amore di sposa e le preannuncia un matrimonio d'alto livello. Giunge in quel momento il Commendatore di Lojola reduce da una spedizione contro i ribelli siciliani e carico di tanta gloria che il Re, visto che il generale
88
disprezza una ricompensa in denaro, gli ha decretato l'onore di una statua. Subito Alfonso gli riferisce dei progetti matrimoniali del Re circa Donna Anna e il Commendatore è felicissimo di poter ubbidire. Uscito Alfonso, Anna confida al padre di non amare affatto il promesso sposo Don Ottavio, di cui Alfonso ha preannunciato l'arrivo, ma il padre le impone l'obbedienza; Anna da sola con-ferma il suo proposito di rifiutare il marito impostole.
Veramente tutta un'aria nuova! Un umanissimo e spiritoso brano di "educazione sessuale" apre l'atto, un accorato e deci-so monologo lo conclude; il Commendatore e Alfonso diven-tano i personaggi con una dimensione storica, ambedue difen-sore di un vecchio modo di concepire i rapporti umani e so-stenitori della ragion di Stato o comunque della convenienza o del buon diritto dell'autorità a decidere anche un matrimonio; Anna, forte carattere di damina, nega questo diritto e questo costume e si propone di usare tutte le sue arti di donna per ottenere lo scopo. Questo clima non indica affatto che una tragedia sia possibile, il che significa che i personaggi si sono resi indipendenti dal loro passato letterario, cioè non è affatto difficile per il lettore dimenticare chi sia il Commendatore e che cosa abbia sempre significato, e chi sia Anna e quale de-stino le sia riservato.
Nella campagna di Castiglia, Elisa e Carino si preparano alle nozze; Carino va a sistemare l'ovile e Elisa sola parla del suo amore per il fidanzato dopo tante inutili piccole avventure. Grida: arriva Don Giovanni appena assalito dai banditi e derubato; Elisa lo accoglie, Don Giovanni fa subito delle proposte, la ragazza vorrebbe non cedere ma la fatale promessa la convince. Intanto sulla strada anche Isabella incappata nei banditi, si difende ed è salvata da Ottavio a cui racconta perché è venuta da Napoli: il tradimento di Don Giovanni; Don Ottavio, colpito dalla storia, le promette aiuto. Carino solo si lamenta del disprezzo dei cittadini per i contadini e cerca poi Elisa ma naturalmente non la trova; vede poi ritornare la ragazza con Don Giovanni e si nasconde per osservarli: i due fanno una scena d'amore poi Don Giovanni si allontana con la scusa che deve prepara-re le nozze; Carino allora interroga Elisa e la ragazzi inventa che in effetti ha parlato con un contadino (Don Giovanni si era così travestito) ma del matrimo-nio di certe cerve, e che ora questi è andato in città a venderle... ma poi in lacrime confessa tutto e prega Carino di riprenderla; questi rifiuta ed Elisa sviene dopo aver finto di uccidersi; Carino corre a cercare dell'acqua per farla rinvenire e infine si riconcilia con la fidanzata, che rimasta sola ride della sua credulità.
89
Elisa non è la solita pastorella o pescatrice: Don Giovanni le insegna a mentire ed ella si serve di tutte le arti per riconqui-stare il fidanzato niente affatto pentita; il male viene dalla città, pare dire Carino ed è un tema di tanta letteratura sette-centesca, ma qui, in queste scene, si sente molto chiaramente la falsità del mondo contadino descritto, si sente che in realtà sotto i panni rustici stanno carattere di dame e signorini: quando Carino corre a cercare l'acqua verrebbe da dire "non acqua, i sali!"... acqua in campagna invece, niente sali, ma la situazione è la stessa. Ricompare Isabella scomparsa da tempo ma ormai ha la spada in pugno.
Giunge Ottavio a visitare la fidanzata e sotto l'occhio severo di Alfonso i due si scambiano di malavoglia la promessa; Ottavio poi presenta Isabella che ha portato con sé; ecco l'occasione: Anna accusa Ottavio d'amar Isabella e non lei, e se ne va sdegnata; anche Don Ottavio prega Don Alfonso di non costringerlo a quel matrimonio ma il ministro conferma che non è possibile disubbidire al Re. Mentre Isabella è restata sola nella stanza sopraggiunge Don Giovanni che, udito dalla donna nascosta, rivela il suo grande desiderio di avventura; Isabella cerca ancora di trattenerlo ma invano; i due si accalorano fino a mettere mano alla spada. Ma arriva il Commendatore che riconosce l'amico e impone la calma; Isabella sdegnata se ne va. Il Commendatore e Don Giovanni si apprestano ad andare a rendere omaggio al Re ma siccome sono lì giunti Alfonso e Ottavio Don Giovanni decide di restare e il Commendatore si avvia da solo; Alfonso chiede a Don Giovanni se sia vera la storia del tradimento perpetrato ai danni di Isabella, e Don Giovanni afferma di amar Isabella ma che quella donna o non è Isabella o è lei ma impazzita e che lui è fuggito da Napoli per aver ucciso un Ministro che l'aveva offeso. Torna Isabella: Don Giovanni appunto nega che sia lei e Ottavio ed Alfonso paiono credergli; Isabella chiede vendetta al cielo e se ne va. Don Giovanni resta solo a meditare ma sopraggiunge Elisa a disturbarlo e deve inventare che c'è un piccolo ritardo per le nozze; giunge anche Carino che accu-sa Elisa di tradimento: è l'occasione che Don Giovanni aspettava, cede Elisa a Carino e li lascia lì a litigare dimentichi di chi sia il vero colpevole; Carino alla fine abbandona Elisa che per parte sua pregusta già nuovi amori.
Veramente non è successo ancora nulla di tragico: Don Gio-vanni vince su Isabella solo perché domina meglio gli strumen-ti di comunicazione, mente, inventa; Isabella invece, forte della sua ragione, sa solo entrare a chiedere giustizia o alla spada o al cielo. Don Giovanni sembra avviato a dover subire
90
il triste destino di essere smascherato di fronte a tutti, un po' come il protagonista de Il bugiardo. Deliziosa la fine dell'atto: Don Giovanni esce da un'avventura come facendo il vuoto dietro di sé riconducendo quasi la situazione a prima del suo intervento; Elisa ha altri progetti: sembra un'altra storia, la ragazza sedotta dal signorotto che male si adatta al letto dei servi ma da cui saprà trarre profitto.
Don Giovanni, il Commendatore e Donna Anna sono a tavola; un paggio viene a chiamare il Commendatore da parte di Don Alfonso e Don Giovanni resta solo con Anna, le dichiara subito il suo amore ad Anna niente affatto turbata dice che prima vuole l'approvazione del padre; Don Giovanni minaccia, giunge fino ad estrarre il pugnale ma ritorna il Commendatore ed Anna gli riferisce la scena: mano alle spade! Don Giovanni ferisce l'ospite e fugge: il Commendatore muore poco dopo fra le braccia di Anna che giura vendetta e si rimprovera di non aver subito impedito a Don Giovanni di proseguire la sua dichiarazione. Giungono Ottavio e Don Alfonso: il primo parte alla ricerca di Don Giovanni, il secondo dietro le insistenze di Anna scioglie la promessa di matrimonio. Ritorna Ottavio e comunica che Don Giovanni si è rifugiato nell'atrio dov'è la statua del commen-datore, atrio che gode del diritto di asilo; Anna sola piange sul destino delle donne di essere sottoposte alla volubilità degli uomini.
Goldoni deve pur cominciare a fare i conti con la leggenda! Qualcosa di tragico deve accadere: Don Giovanni minaccia Anna con un pugnale; ma non è nel suo stile, perché allora? Il tema di Don Giovanni è veramente fuori dal mondo di Goldoni e, per quanti sforzi faccia di mettersi nei panni dello scrittore di teatro che guarda al suo mestiere e nulla più, non riesce a cavarsela senza una forzatura. Conclusione: un simile Don Giovanni tragico non può stare in quel secolo, occorre ridicolizzarlo (e a ciò penseranno schiere di mediocri):
Don Giovanni è chiuso nell'atrio; arriva Elisa a prospettargli la fuga con l'aiuto di due guardiani suoi parenti e Don Giovanni le promette il matrimonio; ma arriva anche Isabella e si riprende il duello: è Alfonso a interromperli questa volta; Don Giovanni solo con Alfonso adduce scuse: il vino, la passione, chiede insomma pietà, e Alfonso promette che chiederà grazia al Re.
91
In fondo le scuse addotte da Don Giovanni sono perfettamen-te comprensibili.
Giunge Anna e Don Giovanni ai suoi piedi chiede perdono e promette il matri-monio; Anna comincia già a impietosirsi.
Ma la tragedia non può sfumare!
Una lettera del re di Napoli che svela la storia di Isabella convince Anna a rad-doppiare la guardia per far morire Don Giovanni di fame; anche Alfonso lo abbandona. Arriva Carino e Don Giovanni lo prega di ucciderlo, ma questi lo invita piuttosto a pentirsi; Don Giovanni però non può pregare rivolgendosi a quel Dio che da tempo non adora.
Sorge spontanea la domanda: perché il Bugiardo può salvarsi e Don Giovanni deve morire? Perchè in queste scene egli porta il peso di una tradizione, gliela vediamo sulle spalle: il miracolo dei primi atti, un Don Giovanni nuovo, nuove facce intorno alla sua storia, si frantuma di fronte all'impossibilità di Goldoni di rendere un simile tono tragico.
Don Giovanni perciò sfida il cielo e un fulmine lo fa sprofondare. Tutti arrivano per ascoltare il racconto di Carino; Elisa prova ancora col fidanzato ma al rifiuto definitivo decide di tornare in campagna visto che con i contadini ci sa fare ma con i cittadini non ha fortuna.
L'intera commedia fallisce nel suo finale, cioè al momento di fare i conti con la leggenda e in fin dei conti con il miracoloso, il magico, il soprannaturale, l'astratto, il simbolo. Questo falli-mento fonda il Don Giovanni settecentesco che è ridicolo an-che se nessuno se ne accorge, ridicolo perché è costretto a risolvere i suoi problemi non con la calma e l'educazione del galateo ma con modi estranei al comportamento della buona società contemporanea; Goldoni fonda questa dicotomia fra il Don Giovanni moderno e la sua leggenda, sostituita, fin dove possibile, dalle pacate osservazioni sui matrimoni imposti, su città e campagna, e così via (ma non è forse questo il lato più
92
importanza dell'opera, che resta un modesto lavoro di un ottimo artigiano)107. Il Don Giovanni di Goldoni fu preceduto cronologicamente da altri due testi che non ho visto: uno è un Anonimo dal titolo Il convitato di pietra ossia Don Giovanni libertino, datato Londra 1726 di cui, fuorché la citazione della bibliografia, null'altro so;
107
Allora non avevo letto i Memoires, ma come si vede nei miei giudizi intuii quella che poteva essere l'opinione dell'Autore: "Tutti conoscono quella cattiva rappresentazione spagnuola, dagli Italiani chiamata Il Convitato di Pietra e dai Francesi Le Festin de Pierre. Io l’ho sempre riguardata con orrore, né ho mai potuto intendere come questa farsa si sia sostenuta per sì lungo tempo, abbia richiamato in folla gli spetta-tori e fatto la delizia di un paese colto. N’erano maravigliati i comici italiani stessi; e, o per burla o per ignoranza, alcuni dicevano che l’autore del Convitato di Pietra aveva fatto il patto col diavolo perché lo sostenesse. Non mi sarebbe mai caduto in pensiero di fare il mini-mo lavoro su questa composizione; ma imparata la lingua francese quanto bastava per darle una lettura, vedendo che Molière e Corneille se n’erano occupati, mi accinsi anch’io a fare alla mia patria il bel regalo di questo tema, a oggetto di mantenere la parola al diavolo con un po’ più di decenza. Vero è che, non potendo darle lo stesso titolo perché nella mia rappresentazione la statua del commendatore non parla, non cammina, né va a cena in città, la intitolai Don Giovanni, a somiglianza di Molière, aggiungendovi: o il Dissoluto. Credetti di non dover sopprimere il fulmine che lo incenerisce, perché l’uomo malva-gio deve esser punito; maneggiai bensì questo avvenimento in modo che comparir potesse un immediato frutto dello sdegno di Dio, e potesse pur provenire da una combinazione di cause seconde, diretta sempre dalle leggi della Provvidenza. Nella prima rappresentazione [...] tutti trovarono da divertirsi, e notarono che la commedia ragiona-ta è sempre preferibile alla triviale e insulsa" (Carlo Goldoni, Memorie scritte dal medesimo per l'istoria della sua vita e del suo teatro - rive-dute e corrette, trad. Franceso Costero, E-text, 2002, p. 65)
93
l'altro è La pravità castigata che fu rappresentato la prima volta a Brno nel 1734; il testo è attribuito ad Angelo Mingot-ti108 e la musica allo stesso o a Eustachio Bambini109. Si chiude così il primo periodo. Gli elementi principali della linea evolutiva sono in definitiva riconducibili a un progressivo allontanamento dal testo del Burlador verso un'autonomia sempre più accentuata con lo sviluppo di temi collaterali; all'apparizione del primo libretto per musica sul tema; alla prima formulazione del Don Giovanni settecentesco in Goldo-ni dopo alcuni sterili tentativi di invertire la rotta con un vuoto esercizio accademico (privo di lustro fra l'altro).
108
Pochissimo si sa di Angelo Mingotti: nacque a Venezia e col fratello Pietro fu impresario in ogni parte d'Europa, a Brno, a Graz, ad Ambur-go, a Bonn. 109
Eustachio Bambini nacque a Pesaro circa nel 1687. Fu maestro di cappella a Cortona e poi a Pesaro; impresario dal 1745 del Ducale di Milano, nel 1750 gestiva un teatro a Strasburgo; curò gli spettacoli dell'Opera italiana a Parigi dal 1752 al 1754 favorendone la rapida affermazione.
95
Cap. 3 - IL TRIONFO NEL TEATRO MUSICALE (1777-1820)
Parallelamente alla prima grande crisi europea di Don Giovan-ni anche in Italia il ritmo della produzione rallenta intorno ai primi decenni del secolo per riprendere in direzione e in campi diversi negli ultimi. Ciò che verso la fine del '700 toglie Don Giovanni dal dimenticatoio e nel contempo riesce a distinguer-lo dai personaggi della letteratura sui libertini fu la scoperta della leggenda del convitato come fatto musicale; già si è det-to del perché di questa fortuna: rileviamo qui che l'Italia in questi anni è il centro diffusore del nuovo Don Giovanni così come lo è della nuova musica. Ovviamente rare volte un libretto ha pretese letterarie: di tutti i testi per musica di questo periodo pochissimi possono vanta-re una qualche autonomia da quelli che li hanno preceduti e distinguersi per particolari intuizioni dell'Autore; proprio per questo il libretto di Da Ponte appare quasi un miracolo. Ovvio poi anche che la produzione italiana abbia come modelli pres-soché esclusivi lo Pseudo-Cicognini e Perrucci: non esistono ancora fuori d'Europa modelli sufficientemente validi (del Don Juan di Molière pare sia proibito anche solo parlare) né è più possibile in Italia consultare gli scenari o magari le commedie minori, mentre certo Perrucci e lo Pseudo-Cicognini erano a disposizione di tutti. Un esempio di questa situazione è l'ano-nimo Il convitato Di Pietro ossia Don Giovanni Tenorio110 musi-cato da Giuseppe Callegari111 rappresentato a San Cassiano di
110
Il convitato di pietra, dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel nobile teatro Trono di S. Cassian nel carnevale dell'anno 1777, in Venezia, presso Gio. Battista Casali. 111
Giuseppe Callegari o Calegari nacque a Padova circa nel 1750; esercitò soprattutto la professione di impresario, prima a Padova con soci, poi col fratello Antonio lui pure compositore.
96
Venezia per il carnevale del 1777; è preciso preciso Perrucci, con qualche adattamento al nuovo gusto limitatamente al rispetto delle regole del galateo: così Don Giovanni e Don Ottavio si incontrano sulla spiaggia dopo il naufragio e Ottavio, dopo aver raccontato di amare Anna, invita l'amico al concer-to e siccome questi è bagnato e vestito da viaggio gli offre mantello e cappello. Inoltre le esigenze del genere costringono l'Autore a mantenere in scena parecchi personaggi alla volta: Don Giovanni sarebbe solo per tutto il secondo atto se gli altri non decidessero di assistere alla cena e di commentarla in musica; e ancora, Don Giovanni prima di cena canta alla spi-netta; frequentemente qualche personaggio rimane solo per cantare una meditazione sui propri casi (e finalmente Ottavio ha la possibilità di accorgersi che Don Giovanni sta esageran-do: prima Isabella e adesso Anna!). Ormai sappiamo che segno sicuro di arcaismo e di derivazione da Perrucci è la sussistenza delle scene napoletane; quindi questo è un libretto che, rinun-ciando a cercare una propria autonomia dai modelli, si acco-moda a minuti cambiamenti in definitiva solo per rendere più accettabili certe situazioni ad un pubblico nuovo. Nello stesso anno 1777 Vincenzo Righini112 musicò un Don Giovanni ossia il convitato di pietra attribuito ad Antonio Fili-stri da Caramondani113 che fu rappresentato la prima volta a Praga o a Vienna.
112
Vincenzo Righini nacque a Bologna il 22 gennaio 1756. Tentò la carriera di cantante ma visto il poco successo cominciò a comporre a Praga e a Vienna ma senza ottenere troppi consensi; dal 1787 fu Mae-stro di cappella dell'Elettore di Magonza e riuscì a mettere insieme una grande tournée nel 1804. Ritornato a Bologna vi morì il 19 agosto 1812. 113
Nato nel 1750 a Venezia, fu alla corte di Prussia come Intendente agli spettacoli; risiedette poi in Italia e a Berlino, collaborando con alcuni dei migliori musicisti del tempo.
97
Seguirono poi nel 1783 Il convitato di pietra di Giovanni Batti-sta Lorenzi114 musicato da Giacomo Tritto115, rappresentato per la prima volta Napoli, che è una farsa in un atto, e Il Don Giovanni musicato da Giovacchino Albertini116 rappresentato a Varsavia nel 1784 nella traduzione di Wojciech Bogusławski, grande attore a drammaturgo. Non ho trovato nessuno di questi tre testi e quindi passò ad altro. Giungiamo così all'anno fatidico 1787, che vide tre Convitati, di cui due sicuramente di valore e soprattutto dotati della capacità di influenzare larga-mente la produzione successiva. Il nuovo convitato di pietra117 di Giuseppe Foppa118, musica di Francesco Gardi119, fu rappresentata a Venezia appunto nel 1787.
114
Giovanni Battista Lorenzi, nato a Napoli nel 1721, fu Direttore del teatro di corte dei Borboni esercitando una censura severissima; morì in patria nel 1807. 115
Giacomo Tritto, nato ad Altamura il 2 aprile 1733, fu Maestro di cappella dal 1799, Direttore del San Carlo dal 1787, Direttore di tutti i Reali Conservatori dal 1806 dal 1816 e Maestro della Real Casa; morì a Napoli il 16 settembre 1824. 116
Giovacchino Albertini nacque a Pesaro nel 1751; Maestro di cappel-la del re Stanislao Augusto di Polonia fu poi al servizio del principe Poniatowski, ambasciatore a Roma. Morì nel 1811. 117
Il nuovo convitato di pietra, dramma tragico comico da rappresen-tare nel nobile teatro di San Samuele in carnovale dell'anno 1787, Venezia, appresso Modesto Fenzo. 118
Giuseppe Maria Foppa (Venezia, 1760 – 1845) è stato Autore di oltre 80 libretti; fu attivo essenzialmente nella sua città natale, ma compose opere anche per i teatri di Milano, Genova, Padova, Reggio Emilia, Pistoia, Bologna e Firenze; è ricordato soprattutto per testi che furono musicati da Gioacchino Rossini (L'inganno felice, La scala di seta, Il signor Bruschino e il dramma Sigismondo); diverse furono le sue riduzioni di lavori di Carlo Goldoni.
98
Credo che (in coppia con l'altro suo libretto, riduzione da que-sto, del 1802) con quest'opera si tocchi il fondo: è un testo illogico, superficiale, trascurato, banale, sciocco e chi più ne ha più ne metta.
Don Giovanni, alle prese con Anna e con Tisbea, ordina al servo Zuccasecca di dare fiori alle donne ma esse sono talmente arrabbiate che si vede costretto ad andarsene. Anche Anna decide di allontanarsi per andare a raccontare a tutta Siviglia come Don Giovanni le ha ucciso il padre. Zuccasecca decide di mettersi a consolare Tisbea mentre Don Masone, segretario di Don Giovanni, decide di fare altrettanto con Anna. Alla locanda in cui si è svolta tutta questa scena è arrivata intanto Isabella che rivela il suo nome all'ostessa Betta e si ritira nella sua stan-za; Don Giovanni arriva subito dopo per poter vedere la forestiera ma Betta gli impedisce l'ingresso e il servo di Isabella, Comino, rifiuta di dire che sia la padro-na. Ma i due poi si incontrano: Don Giovanni si giustifica della fuga da Napoli adducendo la moda che costringe a fare viaggi, ma conferma d'altro canto il suo amore; in quella arrivano Zuccasecca e Masone a chiamare Don Giovanni perché vada consolare Anna e Tisbea che delirano d'amore; Isabella alla notizia se ne va irata. Anna e Tisbea comunicano a Betta la loro intenzione di rimanere alla locanda ancora qualche giorno, per gelosia di Isabella: reciprocamente poi si invitano a cedere il cuore di Don Giovanni ma nessuna delle due vuole perdere un simile marito, e Tisbea poi è sicura che sarà sposata in quanto l'amore supera ogni differenza di sangue. Arrivano al recinto del sepolcro Don Giovanni, Maso-ne e Zuccasecca: Don Giovanni sfida la statua ma poi la perdona e la invita a cena; la statua accetta e accenna di sì. Alla locanda intanto cresce la temperatu-ra: quattro donne (anche Betta si è unita) aspettano Don Giovanni beccandosi a vicenda: Anna decide di sposare Don Giovanni per poterlo avvelenare e vendica-re così il padre. Arriva Masone a invitare a cena Isabella; Anna propone a Maso-ne e Zuccasecca di cambiare padrone e di entrare al suo servizio: il segretario accetta subito ma il servo vorrebbe rimandare a dopo la cena. Comunque i tre adesso hanno un problema: sono senza soldi; Zuccasecca propone di abbraccia-re la professione di banditi e prova a fare la scena di una rapina; prova anche Masone ma ambedue sono poco convincenti; tenta Anna, risulta bravissima e
119
Le località e le date di nascita e di morte sono sconosciute; si sa che nel 1786 debuttò a Modena come operista e che dal 1787 al 1791 fu Direttore del coro femminile e compositore presso l'Ospedale dei Derelitti, a Venezia; poi dal 1797 circa prestò servizio come Maestro di cappella presso l'Ospedale dei Mendicanti. Scrisse numerosi lavori, soprattutto di stampo comico ma anche, nel 1809, una cantata in onore di Gioacchino Murat.
99
perciò si mette a capo della banda. Tutti i personaggi riuniti si pongono poi una terribile domanda: chi sposerà Don Giovanni? Questi, così preso d'assalto, chiede un giorno di tregua ma in quel momento bussano: è la statua; Anna si butta ai piedi del padre chiedendo perdono ma questi la maledice; siccome la statua non vuole cibi terreni Don Giovanni e i suoi servi le fanno un bel brindisi; la statua poi ricambia l'invito e Don Giovanni accetta.
Finisce così un primo atto sconclusionato e balordo; certo l'autonomia dai modelli è stata sempre considerata di per sé un processo irreversibile se non a costo di gravi rischi, ma ovviamente bisogna poi essere capace di sostituire a ciò che si toglie scene valide (anche se non si esige che siano belle); qui invece donne che corrono dietro a Don Giovanni bramando di essere sposate e nemmeno la scena che offriva più possibilità di buona riuscita (quella del confronto fra tutte le sue fidanza-te) è resa con un minimo di umanità: Don Giovanni è un burat-tino e quelle donne fantasmi assatanati. Occorre osservare che qui le entrate e le uscite dei personaggi sono regolate da leggi misteriose: entrano, dicono qualcosa, escono senza un motivo, ritornano, ridicono qualcos'altro e riescono... una vera corsa! È evidente del resto che in una simile situazione anche le sce-ne tipiche della leggenda diventano ridicole (vedi il brindisi) e altre scene sono ancora grosse gaffes. La tendenza quindi è quella di ridicolizzare il personaggio ma purtroppo senza la coscienza di farlo e su questa strada certo è sempre più diffici-le un recupero. Ancora peggio il secondo atto:
Tisbea, ancora impaurita dalla cena, invita Don Giovanni a ritornare con lei alla capanna che fu teatro del loro primo incontro; uscita lei, Don Giovanni convince Betta a fuggire con lui a notte; uscita Betta, Isabella comunica a Don Giovanni che ha deciso di abbandonarlo e se ne va. Uscita Isabella, Masone raccoglie la confessione di Don Giovanni: non sposerà nessuna di quelle donne. Esce Don Giovanni ed entra Zuccasecca che ha la triste delusione di apprendere dal com-pagno che Anna non lo voleva come amante ma come servitore; lui non vuole credere a questa versione ma la stessa conferma accettando subito dopo le proposte amorose di Don Masone. Anna poi incontra Don Giovanni, crede alle sue parole e decide di non partire più; Don Giovanni però, uscita Anna, si fa
100
sorprendere da Isabella con la valigia in mano e devi inventare che i bagagli sono di un amico ma Isabella, decisa più che mai, senza sentir altro gli comunica l'intenzione di abbandonarlo (e due!). Don Giovanni fugge, ma Anna decide di seguire il promesso e si fa accompagnare da Betta e Tisbea. Don Giovanni, in fuga con Masone, Zuccasecca e i facchini, incontra Anna e Isabella e le fa legare a un albero lasciando il servo a fare la guardia; Anna cerca di farsi liberare da Zuccasecca promettendogli il suo amore ma il servo le fa vedere la lista (per-ché?) e se ne va. Giunge Comino e libera le donne: Anna gli ruba il pugnale e parte all'inseguimento, Isabella resta sola (il suo servo sta inseguendo Anna) e trema per la vita di Don Giovanni che intanto è giunto coi suoi compagni al recinto. Lì fa posare i bagagli; arriva Anna con tanto di pugnale ma uno sguardo di Don Giovanni la calma e la convince al matrimonio. Masone resta solo al sepolcro ed è costretto a dire a Tisbea e a Betta dove sia andato Don Giovanni; le due donne partono di gran carriera. Infine tutti si ritrovano al sepolcro, assi-stono alla morte di Don Giovanni e hanno modo di gettare uno sguardo nell'Ere-bo aperto.
La situazione è evidentemente troppo complicata perché qualcuno pensi di concludere in qualche modo la vicenda (fra l'altro, non si possono combinare matrimoni perchè mancano personaggi maschili). Non ho parole! Indeciso se riconoscere in questo testo lo schema di uno dei peggiori film western che ricordi della mia fanciullezza o se invece serenamente consi-derare tutto ciò come una testimonianza sulla vita teatrale del Settecento, rinuncio a pensare ulteriormente a un simile ob-brobrio, che se potesse far ridere qualcuno sarebbe solo per disperazione. Ancora a Venezia, nel 1787 Giuseppe Bertati120 rappresentò il suo Convitato di pietra121 mentre a Praga Lorenzo Da Ponte122
120
Giuseppe Bertati nacque a Martellago in provincia di Treviso il 10 luglio 1735 figlio di un povero agente di campagna. Il nobile Antonio Grimani lo fece studiare al seminario di Treviso, ma la passione per il teatro lo prese fin dal 1763; dal 1770 fu a Vienna condottovi da Gal-luppi e dal 1790 alla 1794 fu Poeta cesareo presso quella Corte. Ritor-nato per motivi di salute a Venezia si impiegò all'Arsenale; morì nel 1815 lasciando una settantina di libretti di cui 45 per il teatro Giusti-nian in S. Moisè.
101
assisteva alla prima del suo Il dissoluto punito ossia Don Gio-vanni123, musicati il primo da Giovanni Gazzaniga124 e il secon-do da Wolfgang Amadeus Mozart. I rapporti fra queste due libretti sono chiarissimi: Da Ponte amplia il testo in un atto di Bertati saccheggiando a piene
121
Don Giovanni ossia il convitato di pietra, Milano, Gio. Battista Bian-chi regio stampatore, 1789. 122
Non pretendo qui di riferire in maniera organica la vita di Lorenzo Da Ponte (Ceneda 1749 - New York 1838), troppo complessa ma an-che abbastanza nota. Ricordo solo che, arrivato nel 1782 a Vienna e presentato a corte da Salieri, già nel 1783 ebbe il titolo di Poeta dei Teatri imperiali e iniziò un periodo di grande lavoro allietato dall'ami-cizia dell'imperatore Giuseppe II: per Salieri scrisse un primo libretto (che fu un vero fiasco), poi uno per Martini che ottenne un caloroso successo; sulla scia dell'affermazione ottenuta iniziò una produzione di circa 15 libretti, non capolavori ma di buon livello. L'incontro con Mozart, che da tempo cercava un soggetto per un'opera e un libretti-sta di valore, gli diede l'occasione di produrre testi di alta qualità lette-raria (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte): non è certo un caso che tre dei cinque capolavori operistici di Mozart siano proprio stati scritti dal Nostro. 123
In ogni biblioteca italiana si trovano almeno decine di edizioni di questo libretto, perché ordinariamente ogni rappresentazione signifi-cava una ristampa; a prima vista ognuno testi ha una sua particolarità (qualche cambiamento di nomi, qualche aria in più o altro); quindi, anche perché non ho indagato su queste differenze, ho preferito rifarmi a un testo critico moderno: Lorenzo Da Ponte, Tre libretti per Mozart, a cura di Paolo Lecaldano, Milano, Rizzoli, 1956. 124
Giovanni Gazzaniga nacque a Verona nel 1643 e studiò a Venezia con Porpora che poi lo portò con sé a Napoli facendolo entrare gratui-tamente al Conservatorio Sant'Onofrio a Capuana; dal 1770 fu scolaro di Piccinni che lo fece esordire al Teatro Nuovo. Tornò poi a Venezia diventando in breve famoso in tutta Europa; dal 1791 fu Maestro di cappella a Crema, dove morì nel 1818. Lasciò un grande numero di opere, cantate e composizioni sacre.
102
mani l'apparato dei versi e non vergognandosi di ricopiare parte intere: con ciò non faceva che seguire un uso normalis-simo a quei tempi ma questo fatto gli dovete parere poco bello al tempo in cui redasse le sue Memorie in cui ripetuta-mente cita come fonti testi ben più importanti, l'Inferno di Dante addirittura; aggiunge alcune scene nuove e rivede tutto facendo uso della sua indubbia capacità poetica o forse della sua superiore abilità artigianale. Notiamo subito che Bertati è il primo in Italia a risentire in maniera diretta e certa dell'influenza del Don Juan di Molière e si vede con quale ritardo ciò avviene; in definitiva Bertati e Da Ponte correggono la tradizione italiana sulla base di quella molièriana ma senza cogliere alcune delle particolarità più significative del modello, conservando ad esempio la scena dell'uccisione del Commendatore. I riassunti dei due testi confrontati dà esattamente la dimen-sione di quello che Da Ponte deve a Bertati.
Bertati - Pasquariello attende Don Giovanni in strada; grida; Anna inse-gue Don Giovanni, arriva il Commen-datore, Don Giovanni lo invita a non battersi considerata l'età ma il duello avviene ugualmente e Don Giovanni lo uccide, fuggendo poi insieme a Pasquariello. Anna si dispera sul cadavere; giunge Ottavio che le promette vendetta e le offre il ma-trimonio; Ottavio poi solo si lamenta della sorte che lo ha fermato sulla soglia della felicità.
Da Ponte - Leporello attende Don Giovanni in giardino proponendosi di smettere di fare servitore; urla; Anna cerca di trattenere Don Giovanni; duello col Commendatore, Don Giovanni e Leporello fuggono mentre giunge Ottavio a consolare Anna col suo amore.
Nessuno dei testi introduce alcuna novità; più evidente che mai la loro comune derivazione da Perrucci; Da Ponte vera-mente si limita a riscrivere, pur dando una maggiore gamma di accenti a Leporello.
Bertati - In campagna Don Giovanni e Pasquariello vedono arrivare una
Da Ponte - In una strada Leporello rimprovera il padrone che si spazien-
103
carrozza e si nascondono in un casino per vedere chi trasporti; Elvira ne scende e Don Giovanni si fa avanti; i due presto si riconoscono ed Elvira rimprovera Don Giovanni della fuga da Burgos chiedendo spiegazioni; Don Giovanni invita il servo a darle e se ne va; il poveretto balbettando dice che Don Giovanni vuole sempre nuove conquiste, che ama tutte le donne del mondo fuorché le vecchie e che è un vero marito universale; Elvira piange e vuole riparazione.
tisce essendo lì per una conquista; il servo conclude amaramente che aggiungerà anche quel nome alla lista. Arriva Elvira alla ricerca di Don Giovanni che, non avendola ricono-sciuta, le si avvicina ma subito la donna lo accusa di averla abbandona-ta a Burgos. Leporello è incaricato di dare spiegazioni: farfuglia un po' e poi mostra la lista; Elvira giura ven-detta.
Fortissimi si fanno qui legami con Molière: l'intera scena del servo che si arrabatta a dare spiegazioni sul comportamento del padrone era già nel Don Juan. Bertati - Don Giovanni seduce nel casino Donna Ximena con la promes-sa di sposarla, poi va via a segnarla sulla lista. Biagio vuole sposare Matu-rina ma è irritato da un colloquio fra la ragazza e Pierotto; dopo qualche schermaglia i due si promettono amore. Pasquariello si mescola a loro ma Biagio si arrabbia; arriva Don Giovanni, smaschera il servo che si era presentato come Don Giovanni-no, fa la corte alla ragazza, schiaffeg-gia Biagio e lo caccia via; quindi seduce Maturina mentre Ximena apprende da Pasquariello chi sia Don Giovanni e sconsolata decide di non cercarlo più. Arriva ancora Elvira ad accusare Don Giovanni ma si intro-mette Maturina e Don Giovanni lascia così le due donne ad accapigliarsi.
Da Ponte - Zerlina e Masetto invitano i compagni all'amore e all'allegria; arrivano Don Giovanni e Leporello, e subito prendono parte alla gioia per il prossimo matrimonio; Don Giovanni manda il servo al palazzo per prepa-rare la festa di nozze e comanda a Masetto di andare con lui: questi non vuole abbandonare Zerlina, ma vi è costretto dalla spada minacciosa di Don Giovanni. Allontanatesi i due, Don Giovanni parte all'attacco e prospetta a Zerlina l'ipotesi di farla diventare una signora; convintala porta la ragazza al casino per celebra-re le nozze ma li blocca Elvira che accusa ancora Don Giovanni e trasci-na via Zerlina. Arrivano Anna e Otta-vio per chiedere aiuto nelle ricerche dell'aggressore, ma Elvira mette in guardia Don Giovanni che per parte sua sostiene essere Elvira pazza, tal-
104
chè, quando ella si allontana, la segue per evitare che commetta follie. Anna ha però ha riconosciuto da certe parole Don Giovanni come l'aggressore; Ottavio solo giura ven-detta. Leporello riferisce al padrone come al palazzo cerchi di trattenere gli ospiti per dargli il tempo di termi-nare l'impresa e come abbia chiuso fuori Elvira inviperita; Don Giovanni decide di andare anch'egli alla festa. Nel giardino Zerlina cerca di convin-cere Masetto della propria purezza; arriva Don Giovanni e Masetto si nasconde per vedere se la ragazza gli è fedele; anche questa cerca di nascondersi ma invano, Don Giovanni la scopre e si accorge anche della presenza di Masetto: lo fa allora uscire dal nascondiglio e gli consegna Zerlina. Giungono in maschera Anna, Elvira e Ottavio: Leporello li invita alla festa a nome del padrone; nel corso del trattenimento Don Giovanni riesce a neutralizzare Masetto e a ballare con Zerlina portandola lenta-mente in un'altra stanza, mentre il servo trattiene il giovane contadino. A questo punto Anna, Elvira e Ottavio decidono di intervenire: buttano giù la porta e Zerlina esce da un'altra parte rifugiandosi fra le due donne; Don Giovanni corre ai ripari e finge di cercare Leporello per punirlo dell'af-fronto fatto a Zerlina ma nessuno crede alle sue menzogne e tutti minacciano la vendetta del cielo.
Con queste scene Da Ponte inizia una parte maggiormente autonoma dal suo modello e pone le premesse per nuovi svi-luppi. In verità, abituato a ben altro tipo di imitazioni, dovrei dire che poco importa se vi sono somiglianze con Bertati (il quale poi fa l'altro copia da Molière tutto il diverbio fra Elvira e
105
Maturina - nel Don Juan la disputa si svolge fra due contadi-ne). Da Ponte ha il buon senso di eliminare la figura di Donna Ximena personaggio del tutto inutile, ma soprattutto la scena del ballo è completamente nuova e in definitiva è la prima autentica modifica in Italia dello schema classico della leggen-da. Lo svolgimento è accuratissimo, la caratterizzazione dei personaggi efficace senza le forzature tipiche degli altri testi (solo Elvira è un po' caricata). Magari tutte le imitazione di cui abbiamo parlato e di cui parleremo fossero così! Secondo atto (di Da Ponte, beninteso):
Da Ponte - Leporello ha deciso di lasciare il servizio di Don Giovanni ma padrone con quattro doppie lo trat-tiene; Leporello vorrebbe in compen-so che Don Giovanni rinunciasse alle donne, ma anzi, questi vuole adesso sedurre la cameriera di Elvira. Come fare? I due si scambiano d'abito e Don Giovanni fa una serenata; Elvira dopo molte indecisioni decide di scendere in giardino: lì trova Leporel-lo e scambiandolo per l'amato lo abbraccia; Don Giovanni intanto finge il rumore di un duello costringendo i due ad allontanarsi. Campo libero per la serenata alla cameriera, ma arriva-no Masetto e i compagni contadini per cercare Don Giovanni che aiutato dal travestimento si fa passare per Leporello e si mette alla testa delle ricerche: ordina agli uomini di divi-dersi in due gruppi e di dare bastona-te alla cieca al primo sospetto; con questo stratagemma riesce a battere Masetto e a buttarlo a terra, poi scappa alla lesta; Zerlina consola il fidanzato. Leporello ed Elvira intanto si sono rifugiati nell'atrio della casa; il servo vorrebbe tagliare la corda ma sbaglia porta; proprio in quel mo-mento arrivano Anna e Ottavio, e
106
Leporello invano cerca una via di scampo visto che sono giunti anche Masetto e Zerlina: tutti si riconosco-no, Ottavio è fermato in tempo prima che infilzi Leporello, che chiede pietà e fugge. Ottavio va via a sporgere denuncia; Elvira restata sola chiede vendetta al cielo ma ha tuttavia una punta di pietà per Don Giovanni.
Tutta questa parte, nuova rispetto a Bertati, dimostra la cono-scenza di altri testi, ad esempio Leporello che vuol abbando-nare il servizio ricorda varie altre situazioni già viste (il servo che cambia padrone ecc.); lo scambio di abito fra Don Giovan-ni e Leporello ricorda lo Pseudo-Cicognini; ancora, abbiamo già visto Leporello picchiato perché scambiato per il proprio padrone. A questo punto Da Ponte ricomincia seguire il testo di Bertati:
Bertati - Nella piazza ove è la statua del commendatore giungono Don Giovanni e Pasquariello; la statua sembra fissarlo e Don Giovanni la invita a cena mentre il servo trema di paura; la statua accetta.
Da Ponte - Don Giovanni, scavalcato il muro, entra nel cimitero, seguito poco dopo da Leporello; questi racconta del pericolo che ha corso e Don Giovanni riferisce di aver avvici-nato la cameriera ma che costei l'ha riconosciuto ed è fuggita. Una voce minaccia la punizione dal cielo prima dell'alba; Leporello trema, Don Gio-vanni si dà a cercare l'origine di quella voce ma essa ancora lo avver-te di lasciare in pace i morti; infine legge l'iscrizione e comanda a Lepo-rello di invitare a cena la statua, che accetta. I due ritornano a casa per prepararsi. In casa di Anna frattanto Ottavio cerca di consolare la donna.
Anche in questa parte Bertati si tiene agli elementi essenziali della leggenda mentre Da Ponte li varia e li amplifica fino a dare nuove caratterizzazioni a fatti e personaggi.
107
Bertati - Nella casa di Don Giovanni Lucerna sta apparecchiando la tavola quando arriva Elvira; giungono poi anche Don Giovanni e Pasquariello, ed Elvira prega Don Giovanni di pentirsi ma invece questi la invita a passare lì la notte; Elvira naturalmen-te se ne va arrabbiatissima. Pasqua-riello prova a convincere il padrone ma Don Giovanni dice che ancora trent'anni di quell'attività è poi si pentirà! Va poi a tavola; il servo riesce a rubare una polpetta che però gli gonfia la faccia ed è scoperto. Battono alla porta: la statua è intro-dotta; quando il Commendatore ricambia l'invito, Don Giovanni accetta; la statua vuole la mano come pegno e afferratala invita Don Giovanni a pentirsi; al rifiuto Don Giovanni è trascinato via dal demo-nio e dalle Furie. Pasquariello raccon-ta tutto l'accaduto.
Da Ponte - Don Giovanni controlla che tutto sia pronto per la cena, i piatti, i musici ecc.; mentre mangia Leporello riesce a rubare un boccone ma è scoperto: costretto a parlare a bocca piena si scusa dicendo di aver voluto assaggiare i piatti dell'ottimo cuoco del padrone. Arriva Elvira che in ginocchio prega Don Giovanni di pentirsi; poi esce ma rientra urlando e fugge da un'altra porta: è la statua che arriva. La fine di Don Giovanni si svolge nel solito modo; Leporello a stento racconta agli altri dell'accadu-to; Ottavio e Anna decidono di spo-sarsi mentre Leporello malinconica-mente si avvia alla taverna per cer-carsi un nuovo padrone.
Anche in questo nucleo ambedue i testi dimostrano chiara-mente la loro dipendenza da Molière (tipica scena del servo che parla a bocca piena). Da Ponte giustamente elimina Lan-terna, figura inutile, ma nel complesso è molto fedele a Berta-ti, non però fino al punto di risultare incongruente con le parti aggiunte; ovviamente, cioè, la sicurezza che guida Da Ponte nelle parti nuove è presente anche dove rifà Bertati: un gran-de mestiere lo regge e una certa dose di intuito lo aiuta a co-gliere in Bertati le dissonanze più gravi. Il verso è sempre cura-tissimo, adatto perciò ben figurare anche nei recitativi. Se è evidente una derivazione del testo di Da Ponte da Bertati, non capisco perché si supponga così spesso una qualche pa-rentela con Goldoni, anche se magari limitata al luogo comune "conosce Goldoni"; se ci dovessimo basare sui testi dovrei dire che molto poco li accomuna, se non un nuovo concetto di Don Giovanni che Da Ponte non aveva certo bisogno di andare a
108
cercare in un suo predecessore. Può essere interessante os-servare gli effetti che ha l'eliminazione di Donna Ximena, che in Bertati è un tipico esempio di donna sedotta da Don Gio-vanni e cassarla quindi significa anche rifiuto di un simile tipo di personaggio; e in effetti Elvira, Anna e Zerlina hanno sì una dimensione corale nel senso che sono accomunate dalla loro condizione di sedotte, ma anche loro ben chiare individualità, cioè non sono uno stereotipo nè un doppione una dall'altra: Anna é portata alla vendetta, Elvira al perdono, Zerlina è sbal-lottata fra amori più grandi di lei; sono forse le donne intorno di Don Giovanni a farne la storia? Potrebbe essere un'ipotesi sufficientemente provata, credo, e sarà uno dei luoghi comuni del Don Giovanni novecentesco125.
125
A tutto ciò ho ripensato molti anni dopo, per uso scolastico, e rias-sunsi così le differenze di Da Ponte rispetto a Bertati:
sviluppa la vicenda in due atti, anzichè uno solo, rendendola meno concitata;
aggiunge nuove scene, in particolare tutto il finale del primo atto (il ballo) e l'inizio del secondo (Leporello che vuole abbandonare il padrone, Leporello costretto a scambiare gli abiti con il padrone e perciò picchiato);
riduce da dieci ad otto i personaggi, sopprimendo un'altra amante di Don Giovanni ed un altro suo servo, inutili doppioni;
cambia alcuni nomi: Pasquariello diventa Leporello, Biagio diventa Masetto, Maturina diventa Zerlina;
invece del linguaggio ovvio e quotidiano tipico dell'opera buffa, ne adotta uno essenziale ma accurato;
trasforma Don Giovanni, da rozzo e frenetico inseguitore e viola-tore di femmine, in un cavaliere "ideale" del '700, raffinato, astu-to ed acuto, galante e seducente, impavido e buon schermitore, capriccioso, scettico o quasi cinico; potremmo quasi dire che ne fa un personaggio autobiografico, nel senso che probabilmente a-vrebbe voluto essere come lui;
amplia il ruolo del servo Leporello, che diventa così la grottesca deformazione del padrone: furbo, sfacciato, pauroso, pigro; po-
109
A questo punto il discorso sui due libretti potrebbe allargarsi: basterebbe il nome di Mozart a renderlo immenso (e tanto più interessante) ma i limiti di questo lavoro e una notevole in-competenza in fatto di musica mi spingono a tentare solo alcune conclusioni. Bertati e Da Ponte rappresentano i due poli opposti di un'interpretazione di Don Giovanni e ciò è inte-ressante in rapporto alla loro comune derivazione e ai legami che li uniscono: quella ridicolizzante, fondata certo con le migliori intenzioni dalla Commedia dell'arte e portata avanti adesso da molti mediocri Autori, e quella rinnovata del Don Giovanni settecentesco fondata da Goldoni e saldamente inse-rita nel contesto della leggenda da Da Ponte. Già si è detto che cosa significhi " di Don Giovanni settecentesco": in Goldoni era solo e semplicemente un cavaliere di buon gusto, e quanto
tremmo quasi dire, i difetti che Da Ponte teme gli si possano rim-proverare;
conferisce alla coppia delle dame che inseguono Don Giovanni (Donna Elvira e Donna Anna) precise e diverse caratteristiche psi-cologiche: nobile la prima (cerca di redimere il seduttore e dopo la sua morte decide di ritirarsi in convento), più ambigua la se-conda (di cui non si capisce fino in fondo se ha ceduto o no a Don Giovanni) in coppia con il fidanzato Don Ottavio, scialba e noiosa figura di sospiroso innamorato quasi incapace di azione;
attribuisce a Zerlina caratteri di "civiltà" niente affatto contadine-sca, e la rende accorta civetta, ben disponibile a giocare su due fronti (se Don Giovanni volesse...). Corrispettivamente, il fidanza-to Masetto non sta in scena solo per incassare botte ed indossare corna: tenta di reagire, non ci riesce ma almeno ci ha provato;
dà al Commendatore una dignità più alta e distaccata dalle cose del mondo, facendone un personaggio inquietante e misterioso; d'altra parte, ormai la sensibilità del "secolo dei Lumi" sta virando al meraviglioso, allo sconosciuto, al miracoloso che saranno i pun-ti forti del Romanticismo.
110
più Don Giovanni si comportava come tale tanto più diventava impossibile il suo rapporto con il "miracoloso"; Da Ponte eli-mina questa contraddizione: il cavaliere di buon gusto diventa anche un uomo soggetto a forze divine di cui non sa tener conto; è il passaggio dall'Illuminismo al Romanticismo, è lo stesso meraviglioso equilibrio nella musica di Mozart fra la vecchia scuola settecentesca e quella nuova e nascente. In un certo senso quindi Da Ponte chiude un ciclo, completa un'idea e ne apre un altro, quello in cui Don Giovanni riacquisterà in pieno la coscienza dei suoi gesti nel miracoloso, nel fantastico, nella libertà espressiva e quindi anche la consapevolezza dei limiti dello sconosciuto che lo circonda. Mentre questa soluzione comincerà a serpeggiare fra non molti anni in Europa sulle orme di Faust, in Italia per lunga pezza ancora di Don Giovanni sarà il solito burattino inseguito-re di donne e inseguito da fidanzate; l'apertura cioè data da Goldoni e confermata da Da Ponte non trova eco nel resto della produzione nemmeno come incitamento a cercare nuovi sviluppi significativi alla leggenda. Quindi tristemente la diffu-sione del tema proseguì in Italia su vecchi canali, molti dei quali addirittura anteriori a Da Ponte e Goldoni, naturalmente fino a quando questo fu sopportabile al pubblico; quando evidentemente il sorgere di nuove esperienze teatrali non rese più accettabile una simile impostazione, Don Giovanni, che camminava su una vuota struttura, entrò in crisi. Nessuna meraviglia quindi che gli ultimi testi di questo secolo non risentano affatto della nuova aria portato Da Ponte al soffocato mondo di Don Giovanni e si rifacciano invece ad altri modelli favoriti, già lo si è detto, dalla scarsa diffusione dell'o-pera di Mozart in Italia. Così Il dongiovanni (Tenorio) ossia il
111
convitato di pietra musicato da Vincenzo Fabrizi126 su testo di Giovanni Battista Lorenzi127 o di Giuseppe Diodati128 rappre-sentato a Fano nel 1788, e la citata commedia di Francesco Cerlone. Seguono alcuni testi che non ho visto: un anonimo Convitato di pietra129 del 1789, un altro Convitato di pietra dato a Roma
126
Poco si conosce della vita di Fabrizi, forse a causa dei suoi moltepli-ci viaggi. Studiò sotto la guida di Giacomo Tritto e nel 1783 a Napoli, all'età di 19 anni, mise in scena il suo primo lavoro. Nel 1786 fu nomi-nato Maestro di cappella dell'Università di Roma e successivamente diventò Direttore del Teatro Capranica. Dopo circa tre anni iniziò a spostarsi verso vari centri europei per rappresentare le sue opere: fu a Dresda, a Lisbona, a Londra e a Madrid. Di lui si conoscono una quindicina di opere buffe, scritte per lo più negli anni tra il 1783 e il 1788. Del suo Convitato si cita una rappresentazione a Roma nel 1787. 127
Giovanni Battista Lorenzi (Napoli, 1721 –1807) iniziò l'attività di librettista scrivendo canovacci e riduzioni per recite che venivano rappresentate nel palazzo del duca di Maddaloni o di altri signori napoletani. Nel 1763 entrò nella compagnia del Teatro di Corte e nel 1769 ne divenne Direttore. In seguito fu nominato "Regio revisionato-re delle opere teatrali". Amico di Giovanni Paisiello, fu un uomo di ampia saggezza letteraria e conoscitore attento delle tecniche teatrali più aggiornate. Egli ammirava immensamente sia la poesia metasta-siana che la letteratura francese. È considerato il più importante li-brettista dell'opera buffa napoletana del suo tempo. 128
Nacque a Napoli e scrisse molti libretti di cui ne sono rimasti 12 (quattro per Cimarosa, sei per Tritto, uno per Fabrizi); famoso il suo Impresario delle Smirne. 129
Nelle biografie è citato L'impresario in angustie e il convitato di pietra, farsa per musica, Milano, 1789 ma io trovato parecchie copie di questo testo con solo il primo libretto, del Convitato nessuna trac-cia. Musicò la prima farsa Domenico Cimarosa e il testo era forse di Diodati; della seconda non so né compositore nè librettista.
112
nel 1789 e un terzo anonimo Convitato di pietra datato 1792; di questi ultimi testi oltre la menzione delle bibliografie null'al-tro so. Come si vede la frequente è più o meno costante (ogni anno o poco più un nuovo Convitato) ma in realtà sono tutti testi che tradiscono la loro derivazione al primo sguardo. Così pure il Convitato di pietra130 attribuito a Marcello Bernar-dini
131 da Capua o ancora a Bertati, musicato da vari maestri;
la vicenda è un po' quella di Bertati: si reintroduce lo scambio di persona nella consegna del biglietto che fissa l'appunta-mento fra Ottavio e Anna; prima del duello col padrone il ser-vo Ficcanaso si finge spagnolo; Don Giovanni impedisce ad Ottavio di andare all'appuntamento facendolo trattenere al gioco; riappare Isabella; si ripete la situazione di Foppa con Isabella che chiede a Ficcanaso di entrare al suo servizio. C'è poi un altro Convitato132 rappresentato a Cagliari nel 1803: è semplicemente un rifacimento di Bertati con l'aggiunta di qualche parte del Convitato del 1792; manca invece l'ultima scena con Ficcanaso che racconta agli altri personaggi la morte di Don Giovanni. Interessante il fatto che Don Giovanni vi fac-cia una lunga lode alle donne di Cagliari: evidentemente ogni
130
Il convitato di pietra, farsa in un atto solo in appendice a L'ultima che si perde è la speranza, farsa di un atto solo da recitarsi per musica nel nobilissimo Teatro della nobildonna Tron Veronese in San Cassiano il carnevale dell'anno 1792, in Venezia appresto Modesto Fenzo; la musica di quest'ultima farsa era del Bernardini. 131
Marcello Bernardini è detto "Maestro di cappella romano" ma tradizionalmente è nato a Capua. Nel 1767 è certamente a Roma e nel 1795 in Polonia Maestro di cappella della principessa marescialla Lobomirska; compose anche musica sacra e una cantata. 132
Il convitato di pietra, dramma giocoso per musica in due atti da rappresentarsi nel Regio Teatro di Cagliari nel carnevale dell'anno 1803, dalla Reale Stamperia.
113
testo era soggetto a modificazioni di questo tipo ogni volta che veniva rappresentato in una città diversa. Del 1794 è il Don Giovanni di Lorenzo Da Ponte133, opera tragi-comica in un atto con musiche di Gazzaniga, Sarti134, Federi-ci135, Guglielmi136 e naturalmente Mozart, rappresentato al King's Theatre di Londra. Già durante il soggiorno a Vienna Da Ponte aveva riunito alcune delle sue più famose arie in un polpettone, L'ape musicale, che ebbe un ottimo successo; giunto a Londra, volendo evitare che si rappresentasse un Don Giovanni che non fosse il suo accettò di trasformare il suo libretto adattandolo ai gusti del pubblico britannico: maggiore
133
La rappresentazione del febbraio del 1790 di Così fan tutte segnò l'apice della carriera di Da Ponte. Nel marzo morì Giuseppe II e il suc-cessore Leopoldo II instaurò un regime di severa economia; lasciò quindi Vienna nel giugno del 1791, nel 1792 si sposò e poi fu a Londra dove tentò variamente la fortuna ma presto fallì. Nell'aprile del 1805 si imbarcò sul Columbia diretti in America dove si diede a sballate imprese commerciali poi già vecchio si ridusse a professore introdu-cendo così la conoscenza della lingua italiana nel continente. 134
Giuseppe Sarti nacque a Faenza nel 1629; dopo gli studi a Padova e a Bologna fu a Copenhagen con Mingotti, prima organista e poi Mae-stro di cappella di Federico V. Coinvolto in intrighi e oppresso dai debiti fu espulso e riparò Venezia; dopo un soggiorno a Milano dal 1779 come Maestro di cappella del Duomo, a San Pietroburgo divenne Maestro di cappella di Caterina ma venne poi esiliato in Ukraina; ripartì allora per l'Italia ma morì per strada a Berlino il 28 luglio 1802. 135
Vincenzo Federici (Pesaro 1764 - Milano 1826), allievo del bologne-se Gadani, visse fra l'Italia e l'Inghilterra, componendo una quindicina di opere teatrali e balletti: particolare successo ebbe l'opera Castore e Polluce, 1803. Fu professore al Conservatorio di Milano. 136
Pietro Carlo Guglielmi nacque circa nel 1763-1770; studiò al Con-servatorio di Napoli, fu poi a Madrid, in Portogallo e a Parigi; fu Mae-stro di cappella dell'arciduchessa Beatrice di Massa Carrara e morì a Napoli il 28 febbraio 1817.
114
sarebbe stato qui l'uso del libretto di Bertati ma non avendo visto il testo non sono in grado di precisare in che misura. Ho poi notizie di un Convitato di pietra di Anonimo da Bastia, ma null'altro so. Nel 1802 ritorna alla ribalta Giuseppe Foppa col suo Convitato di pietra137 per la musica di Francesco Gardi. Se il suo primo di libretto era un abisso. questo è certo un insulto: Alba (che fa la parte di Anna), Tisbea e Isabella sono qui sempre all'insegui-mento ed essendo il tutto ridotto a un atto si può immaginare quale sia il ritmo di ingressi, uscite, promesse: finisce nel solito bosco con Isabella che giura o di amare o di non amare, poi Don Giovanni sprofonda e buona notte. Nello stesso anno questo libretto fu rappresentato alla Scala con un finale più serio (?!). Ho poi il titolo di un Don Giovanni in Portogallo di Giulio Lit-ta138, opera del 1800-1814. Concludono il periodo l'opera di Piero Raimondi139 Il dissoluto punito140 e Il convitato di pietra141 di Fernando Augusto Bon del 1820.
137
Il convitato di pietra ridotto in farsa per musica dal signor Giuseppe Foppa, da rappresentarsi nel nobilissimo teatro Venier in San Bene-detto il carnevale dell'anno 1802, in Venezia, per il Casali. 138
Giulio Litta (1822-1891) si è formato presso il Conservatorio di Mi-lano e ha debuttato nel 1843. Ha composto diverse opere, la maggior parte dei quali per i teatri milanesi. La sua ultima, Il violino di Cremo-na, è stata rappresentata alla Scala nel 1882. 139
Pietro Raimondi nacque a Roma il 20 dicembre 1786; fu allievo di Tritto e poi maestro di musica a Genova. Organizzò poi giri di rappre-sentazioni delle proprie opere; dal 1824 Direttore dei Regi Teatri di Napoli, dal 1833 professore a Palermo e poi Maestro di cappella di San Pietro a Roma, dove morì il 30 ottobre 1853. 140
Come ho già detto nell'elenco generale, tale opera non compare nell'Enciclopedia dello spettacolo.
115
Si chiude così una fase ricca di fatti nuovi e rilevanti nella sto-ria del tema, ma purtroppo più spesso abbiamo visto agire motivi che spingono Don Giovanni a fini sempre meno onore-voli; il livello della produzione tutto sommato è piuttosto scar-so e salvo poche eccezioni i testi sono sempre poco originali se non addirittura pedisseque copiature: la crisi in Italia è chia-ramente annunciata e a ben pensarci è del tutto logica.
141
Riportando tale titolo nell'elenco generale ho già riferito dei dubbi circa quest'opera.
117
Cap. 4 - LA GRANDE CRISI ROMANTICA E DECADENTE (1832-1900)
Purtroppo questo capitolo è terribilmente incompleto: non mi è stato possibile rintracciare nessuno dei testi citati nell'elen-co, ma le linee generali del discorso però possono essere an-cora salvate. Se Giovanni Pacini142 rappresenta a Viareggio nel 1832 un Convitato di pietra, opera buffa in un atto su libretto di Berta-ti, significa che niente di quello che succedeva in Europa a Don Giovanni era passato in Italia; se il signor Dora mette in scena a Londra un suo Don Giovanni, opera in tre atti in versi, nel 1843 revisionando Da Ponte significa che non c'erano molte alternative: o un testo vecchio o niente. Parallelamente a que-sta italiana esiste una crisi europea, ma essa venne presto risolta in ambiente poetico e fra categorie di lettori dal gusto molto raffinato: è il tempo di Byron, di Grabbe, di Puskin, dell'affermazione, con Prosper Merimée e Alexandre Dumas, della nuova leggenda di Don Giovanni de Mañara; almeno si può dire il tema ha una sua vita, non più fra pubblici esaltati ma presso ristrette categoria di artisti. In Italia niente di tutto questo: dal 1832 al 1881 (non considerando la revisione di Dora) il vuoto assoluto. E' del 1881 appunto il Don Giovanni Tenorio di Eugenio Ronti-ni, che, lo si è visto, ha per modello addirittura Perrucci. Ho poi una serie di titoli anch'essi significativi in quanto non per-mettono affatto un aggancio degli autori italiani all'evoluzione
142
Giovanni Pacini nacque a Catania il 17 febbraio 1796; figlio d'arte fu maestro di musica e morì a Pescia il 6 dicembre 1867,
118
europea: Domenico Bassi143 riduce da un ignoto il suo La cena di Don Giovanni a Milano nel 1884; Palmieri compone un'ope-ra buffa nel 1887, Il nuovo Don Giovanni e si è già notato che l'aggettivo "nuovo" significa in realtà "vecchio", riverniciato; tale Danna compone un'operetta dal titolo Don Giovanni d'Al-calzar alla fine del secolo e all'alba del Novecento Antonio Saltiveri scrive un suo Don Giovanni Tenorio a Trossos. Questi ultimi due titoli più che indicare novità mi sembrano evocare atmosfere esotiche e manierate. Purtroppo più di questo non mi posso permettere, se non una conclusione: pare che nel teatro italiano non esiste un Don Giovanni romantico; varie possono essere le cause di questo fenomeno: la forte tradizione settecentesca sul tema che to-glie l'aiuto del successo a ogni tentativo di innovazione e non sprona a una rinnovata produzione; l'arretratezza del pensiero filosofico italiano e soprattutto la sua chiusura in paragone all'elaborazione europea, tedesca in particolare; il poco inte-resse dei romantici italiani per il teatro; il ritardo con cui in Italia è nato il teatro borghese, figlio diretto di quella rivolu-zione industriale che da noi fu limitata dalla lentezza con cui si compì il processo unitario nazionale e dalle generali condizioni economiche. Questi fattori hanno reso marginale la cultura italiana per molti anni, talchè certo pochissimi scrittori italiani hanno una dimensione europea e certo con sicurezza non esistette un teatro romantico (se non nelle astratte intenzioni di Manzoni) né un teatro borghese se non nelle pallide imita-zioni delle commedie francesi fatte dalle Compagnie di giro. Queste però sono cause troppo generali, alle volte, perché bene si adattino alla storia del tema; resterebbe da spiegare in particolare perché tutto l'Ottocento non si interessi granché a
143
Domenico Bassi nacque nel 1832; figlio d'arte, fece compagnia con molti grandi attori del tempo; dal 1885 Direttore del Teatro Carigna-no, morì a Torino nel 1903.
119
Don Giovanni mentre si appassiona ancora per l'opera comica e poi per il melodramma romantico; la spiegazione è in un certo senso proprio nella linea evolutiva: a Don Giovanni oc-corre essere moderno per significare qualcosa, in Italia non gli riesce alcun adattamento e quindi, come per una legge della giungla, è escluso dal successo. I temi che i pochi Autori pro-pongono sono presumibilmente sempre quelli e adesso non sono più sopportabili da parte del pubblico; Don Giovanni aspetta un capolavoro meno compromesso col passato, più aperto alle nuove idee e se esso non venne, facciamo la mora-le, doveva morire
144.
144
Alcune attinenze col tema, almeno limitatamente alla presenza di certe scene non certo per la caratterizzazione psicologica dei perso-naggi, presenta La forza del destino, libretto di Francesco Maria Piave per la musica di Giuseppe Verdi del 1861, tratto dal dramma di Ángel de Saavedra (che certo doveva conoscere la letteratura teatrale su Don Giovanni e comunque si ispirava a Byron): ad esempio, il padre di Leonora si chiama marchese di Calatrava (che è l'ordine di cui è il padre di Anna è Commendatore); la scena iniziale del primo atto ri-corda le gesta di Don Giovanni nell'uccisione di Don Gonzalo; il fratello di Leonora svolge la parte di Don Ottavio; si ritrovano poi i motivi del convento e della grotta dell'eremita che sono già nell'Atheista. Come si è detto le somiglianze sono del tutto esteriori ma non escludono la conoscenza di alcuni testi su Don Giovanni (Francesco Maria Piave, La forza del destino, musica di Giuseppe Verdi, Milano, Ricordi, 1955).
121
CAP. 5 - UN NUOVO DON GIOVANNI? (1907-1967)
Arriviamo così a parlare di una "rinascita" di Don Giovanni: diciamolo subito, con molti grossi equivoci. I pilastri del nostro ragionamento sono stati due: Don Giovanni non è concepibile al di fuori della sua leggenda, nel senso che privarlo della sua storia porta gravi rischi che è molto difficile aggirare (vedi l'esperienza di Goldoni); Don Giovanni non è concepibile al di fuori del della sua perenne contemporaneità nel senso che perché il personaggio viva occorre che se ne trasformi il signi-ficato e che lo si esprima in una qualche forma artistica. Con-tinuando a utilizzare questi due fondamentali prospettive, riguardo alla prima mi pare che le strade battute dalla produ-zione novecentesca sono due: Don Giovanni diventa un so-prannome, è un sinonimo di libertino, e queste commedie le abbiamo escluse dalla trattazione; Don Giovanni diventa il fantasma di se stesso cioè un individuo che ogni tanto s'imbat-te nell'ombra delle scene tipiche della sua leggenda. Per quan-to invece riguarda la seconda, formalmente almeno siamo a posto: il Don Giovanni novecentesco bene riflette le tendenze letterarie decadentiste e dannunziane, la retorica fascista, il disorientamento del dopoguerra ma in realtà si trova ad agire in questi contesto senza essere per nulla cambiato, essendo ancora il vecchio Burlador del '600. In altre parole, se Don Giovanni ha un significato, è su questo significato che un nuovo Autore deve misurarsi, nel cambiarlo, nell'adattarlo, nel modernizzarlo. Don Giovanni nel Novecento è sempre sconfitto ed è evidente che nel nostro secolo debba esserlo; non altrettanto evidente che lo debba essere un nuo-vo Don Giovanni. Gli Autori di cui diremo si limitano in defini-tiva a prendere il vecchio personaggio, a sfrondarne un po' la leggenda fino a ridurla una serie di simboli, a metterlo a con-
122
fronto con personaggi nuovi e scoprire che Don Giovanni o si pente o si imborghesisce, si sposa o si fa monaco. Un esempio estremamente significativo: Don Giovanni nella tradizione sempre stato un nobile, ed anche quello del '900 lo è; a questa appartenenza di classe noi siamo abituati a dare un ben preci-so significato: ebbene, certo la nobiltà nei secoli passati non aveva la stesse funzioni di quell'attuale né essere nobili in secoli diversi significa la stessa cosa; logico quindi che un Don Giovanni, preso di peso dai secoli passati e messo a confronto con una società che alla nobiltà del sangue dà solo un peso limitato ai salotti, si trovi a disagio e risulti alla fine battuto. Quindi, succintamente: Don Giovanni agisce in un ambiente nuovo ma non è per nulla cambiato e in queste condizioni non può essere che un sopravvissuto; la sua leggenda è ridotta ad una serie limitata di luoghi tipici (una statua là, un Commenta-tore qui) che evocano, soprattutto nella sua psicologia, un passato che non gli consente di pensare nè di agire. Un Don Giovanni novecentesco in definitiva, almeno in Italia, non esiste se non in quanto sconfitto, esiliato ed alienato: trasferito dalla "macchina del tempo", ha una doppia vita, vive sì nella contemporaneità ma ha come un inconscio ritardato di qualche secolo, che ogni tanto affiora; oppure, è il semplice e spensierato seduttore che ad un certo punto scopre di essere mosso dal complesso di Edipo; oppure, vive in vere e proprie scenografie, con Spagne cartolinesche, luoghi comuni, chitarre e gaggia; oppure, Don Giovanni fanciullino è alle prese con donne-mantidi, ingombranti simboli della mamma, che li cal-pestano. In queste condizioni il vecchio Don Giovanni non può soprav-vivere, perchè il Burlador non è compatibile con Edipo nè può sopportare di incontrarsi con una super-donna; per queste nuove cose occorreva un Don Giovanni radicalmente nuovo... La sconfitta di Don Giovanni prende per lo più le sembianze di una sconfitta sessuale, che evoca quella del maschio moder-
123
no: Don Giovanni vecchio che cerca affetto sincero in una fanciullina è un chiarissimo simbolo di impotenza e altrettanto quello che si esilia, si rinchiude, ecc. Questi Autori dimostrano in fondo solo che per loro Don Giovanni è morto e stupisce che ancora nel 1967 qualcuno (ma dove vive costui?) insista a ripetere il ritornello. E così, a chi è appena un po' partecipe delle sorti del teatro in Italia riesce difficile leggere questi testi con serenità di giudizio145. Dopo due testi anonimi che si richiamano al clima del secolo precedente (Don Giovanni d'Alvarados del 1907 e Il convitato di pietra del 1909, che non ho visto ma che dal titolo non promettono nulla di nuovo) è Giuseppe Pagliara146 a iniziare la serie novecentesca con il Don Giovanni147, dramma in quattro atti in versi rappresentato o solo pubblicato nel 1911. Si tratta di una storia basata sul pentimento di Don Giovanni, sulla sua vecchiaia, sul ricorso ad elementi magici al di fuori di ogni realtà che possa giustificarli; ovviamente l'ambientazione al XVI secolo non ha altra scusa che l'aderenza alla leggenda: le situazioni sono tipicamente moderne.
A Siviglia Don Pedro e Don Pablo aspettano Don Giovanni che si è annunciato con un biglietto al convegno dove sono stati invitati anche Diego, Eloisa, Isabel-la, Elvira e Ines, che Pedro ama non ricambiato; finalmente giunge Don Giovan-ni: teatralmente consegna il mantello a Leporello, si scusa del ritardo, saluta
145
Sono stato costretto a rimaneggiare tutta la parte del capitolo che precede, perchè non sono riuscito nemmeno a capire quello che volessi sostenere; forse in copisteria fecero un po' di confusione, o davvero avevo scritto cose illogiche; l'unica cosa evidente era quanto odiassi il teatro di consumo farcito di pirandellismo e condito da un po' di psico-analisi! - che allora imperversava anche in televisione e alla radio - quello che con il mio amico Enzo riconoscevamo dall'uso del "capisci?" ripetuto a ogni piè pari a conclusione di un qualunque ragionamento. 146
Commediografo, poeta e giornalista napoletano nato nel 1868. 147
Giuseppe Pagliara, Don Giovanni, Napoli, Ricciardi, 1911.
124
tutti e ricorda che manca Don Luigi da lui ucciso in duello a Venezia perché lo sbeffeggiava. Gli invitati si trasferiscono a tavola dove resta un posto vuoto per Don Luigi; i musici cominciano a suonare e si apre una conversazione sull'amore: l'amore è avventura dice Ines, l'amore trasforma dice l'Elvira, l'amore domina il tempo e dà eterna giovinezza all'amante dice Don Giovanni, mentre Diego molto più praticamente sostiene che più che ricercare una supposta giovinezza le donne vogliono uomini validi. Ma Don Giovanni da quell'orecchio non ci sente anzi riferisce della sua ultima avventura: una dama gli ha gettato una rosa dal balcone; poiché Diego è incredulo, egli scommette una borsa di denari che entro l'alba porterà lì la donna. Chiama perciò Leporello e gli spiega dove devono andare: da ciò Diego capisce che si tratta della sorella; Don Giovanni decide di andare ugualmente mentre Pedro e Paolo trattengono Diego.
Subito ci appare chiarissimo il "nuovo" Don Giovanni: osses-sionato dalla vecchiaia, dalla teatralità dei suoi gesti, dal fatto che qualcuno possa non credere alle sue avventure. Comun-que, giunti alla fine del primo atto, ci si comincia a domandare perché questi personaggi sono stati riuniti; dai nomi e degli accenni a Don Luigi parrebbe doversi concludere che le donne sono ex amanti e gli uomini ex rivali o ex compagni di avventu-ra: sembra quindi che la cerchia configuri una società segreta che assegna a ognuno una parte nel mondo di Don Giovanni di cui sono un po' le marionette. Certo è che qui c'è un Don Giovanni che (lo dirà molto meglio Camus) vive nel passato, si è costruito un pubblico per l'ennesima avventura e per farlo è andato a cercare le persone del suo ricordo.
In caso di Diego Anna e la fida Costanza parlano del cavaliere visto la mattina; le due donne sono sole perchè hanno dato il permesso al servo Michele di andare in libera uscita. Da buona mezzana Costanza invita Anna alla vita e all'amore, poi questa si ritira nelle sue stanze per andare a dormire; bussano: Costanza apre a Don Giovanni che dice di dover riferire un'ambasciata di Don Diego alla sorella; Costanza ha riconosciuto il cavaliere della mattina ma sta al gioco e avverte Anna che giunge trepidante per il fratello; Don Giovanni calma la ragazza, si rivela e dichiara il suo amore vinto dalla purezza e dall'ingenuità della fanciulla; Anna vorrebbe non cedere ma poi lo abbraccia. Rumori dalla strada interrom-pono il colloquio: Don Giovanni corre fuori mentre Anna cerca invano di tratte-nerlo ben sapendo che potrebbe incontrare il fratello. Nel terzo atto la scena è una piazzetta davanti all'abitazione di Anna e Diego; Leporello cerca di trattenere Michele che vorrebbe rientrare in casa raccontan-dogli della stretta comunanza che ha con Don Giovanni, come se fossero una
125
sola anima, e infiorando le avventure del padrone, le fughe ecc. Si apprende che la causa del rumore è stata l'arresto da parte della ronda di finti ciechi. Don Giovanni esce dalla casa e si imbatte immediatamente in Diego, gli sbarra il passo, gli ricorda le avventure ed i bagordi fatti insieme ma poi si giunge al duello: nel corso della lotta Don Giovanni comincia capire che cosa significa per lui Don Diego, non gli sembra più di combattere con il suo nemico ma con se stesso, non ha più voglia di vincere ma di essere ucciso; infine, complice Leporel-lo, trafigge Diego ma quando si china sul morto si riconosce in lui. Ultime gesta di un avventuriero: dice ad Anna che Don Giovanni è morto, poi trascinato da Leporello si rifugia in chiesa mentre sopravviene la ronda.
Ci si è avvicinati in questo atto al tipo del Don Giovanni ro-mantico e decadente ma con tanta superficialità che il raffron-to in fin dei conti è inutile; tipica la scena del duello: ricono-scersi nel nemico è un luogo comune dal William Wilson di Poe in poi. A questo punto non si capisce assolutamente che cosa ci stia a fare un quarto atto: dopo il gran numero di per-sone portate in scena in un inutile convegno la vicenda si è ridimensionata in una dignitosa riedizione di una tipica avven-tura di Don Giovanni, l'uccisione di un parente di Anna, in questo caso il fratello.
Il quarto atto si svolge in un castello sui Pirenei dove Don Giovanni insieme alla giovinetta Teresa passa le sue ultime giornate; ha portato lì la ragazza per far vivere la tetra dimora della luce della sua innocenza. Giunge Leporello con i Cavalieri della miseria; Pedro e Diego irriconoscibili sono insieme al gruppo. I Cavalieri spiegano a Don Giovanni che vivono di rapina e Don Giovanni ordina a Leporello di distribuire monete; poi congeda i Cavalieri e trattiene i due miste-riosi visitatori: Pedro si è rovinato al gioco e Don Giovanni racconta che un giorno ha combattuto in duello contro se stesso e che da allora ha perduto ogni ricordo; Diego si rivela e racconta di Anna, morta fra le sue braccia invocando il nome dell'amato. Don Giovanni, vinto dal ricordo di Anna, della sua purezza e del duello, muore invocandola e pregandola di accoglierlo in cielo. Pedro toglie dal dito di Don Giovanni l'anello talismano e con Diego si allontana prospettan-do l'ipotesi che, chissà... risorgerà?
E così siamo giunti oltre i limiti del comprensibile e del soppor-tabile: che significato abbiano i finti ciechi o i Cavalieri della miseria, che cosa diavolo voglia un Diego redivivo, che cosa prometta un anello talismano, mi sembra sia pazzia sondare e ricercare.
126
A distanza di pochi anni seguì L'ombra di Don Giovanni 148 di Ettore Moschino149, tre atti e quattro quadri per la musica di Franco Alfano150 del 1914; l'Autore stesso ne fece una rielabo-razione nel 1941 aggiungendovi un prologo151. La cosa di maggior effetto di questa nuova storia doveva stare nel fatto di mettere in scena un Don Giovanni, quello di Maña-ra, che viveva le sue avventure mentre in tutta Europa si rap-presentava sulle scene la leggenda di Don Giovanni Tenorio: si aveva così un personaggio reale che viveva in parallelo ad uno letterario; ma anche qui la maniera prevale su ogni altro inte-resse. Nel prologo dell'edizione del 1941
Le amanti di Don Giovanni Tenorio apprendono del suo ritorno sulla terra sotto il nome di Don Giovanni di Mañara, per espiare fin quando non si pentirà e sarà redento da un'anima sublime che si immolerà per lui.
Nelle due edizioni poi la vicenda proseguì identica:
Il primo atto ci porta nel castello dei conti Cinarca in Corsica; il custode e il servo Lionello vedono dalle torri il corteo funebre di Orlanduccio seguito dalla di lui sorella Vannina che invoca vendetta. Giunge a bussare al castello Don Giovanni, figlio del vecchio conte, che giunge dalla Spagna per espiare gravi colpe sulla tomba della madre; mentre questi si è ritirato a pregare, irrompono nel castello Vannina e i suoi compagni che hanno identificato in Don Giovanni l'uccisore di Orlanduccio: il custode però mostra loro il padrone che prega e tutti si acquieta-no, ma Vannina ha ancora dei dubbi. Nel secondo atto, dopo un colloquio fra
148
L'ombra di Don Giovanni, dramma lirico in tre atti e quattro quadri di Ettore Moschino, musica di Franco Alfano, Milano, Ricordi, 1914. 149
Ettore Moschino ((L'Aquila 20 ottobre 1867 - Roma 5 aprile 1941) fu poeta dannunziano, librettista e drammaturgo. 150
Nato a Napoli l'8 marzo 1876, Franco Alfano studiò al Conservato-rio di Napoli e si perfezionò a Lipsia; fu poi Direttore del Liceo musica-le di Bologna, di quello di Torino e Sovrintendente del Massimo di Palermo; morì a Sanremo il 17 ottobre 1954. 151 Ne ho trovato un riassunto in Teatro Reale dell'opera, Don Giovan-ni di Mañara di Franco Alfano, 15ª stagione lirica 1941-1942.
127
Lionello che legge la Bibbia e Don Giovanni che dubita della salvazione, Vannina, giunta con un gruppo di poveri cui Don Giovanni ha dato molte offerte, ha modo di interrogarlo ma l'accusa di aver ucciso Orlanduccio si trasforma ben presto nell'occasione per una seduta di magia: Don Giovanni nega di essere il seduttore di Siviglia, Vannina tenta di pugnalarlo ma il bagliore della lama lo fa apparire come il libertino tanto noto al mondo intero e Don Giovanni la seduce. Una terrificante e quanto mai improbabile Sardegna introduce il terzo atto in cui le donne intorno al rogo del morto decidono, incitate dalla madre di Vannina Doriola, di bruciare il castello; là intanto si è giunti alla trasfigurazione: Don Giovanni davanti all'altare chiede perdono dell'ultima malefatta e sente nascere in sé un nuovo sentimento, che presto si precisa in amore per Vannina, la quale giunge ad abbracciarlo davanti al crocefisso: gli amanti non odono le grida nè vedono le fiamme.
Ovviamente una sete di esasperato estetismo domina tutta la vicenda; non colgo davvero quale figura di Don Giovanni possa uscirne delineata: solo la vecchia storia dell'uomo vissuto e della giovinetta che lo redime col suo amore. Ho poi un titolo, Don Juan: sette amanti, sette peccati, di Ano-nimo, presentato a Vienna nel 1920 ma non so null'altro. Ormai credo sia evidente l'impossibilità di cercare un filo con-duttore tra questi testi se non ricorrendo a temi estremamen-te generici come la sconfitta di Don Giovanni appunto; il fatto potrebbe essere imputato proprio alla mancanza per questi Autori di un modello sicuro su cui fondare almeno la coerenza interna delle loro opere. Un nuovo tema introduce Il debutto di Don Giovanni152 di Raf-faele Calzini153, in un atto.
152
Raffaele Calzini, Il debutto. La fedeltà. La diva, Firenze, Bemporad, 1921. 153
Nato a Milano il 29 dicembre 1885, Raffaele Calzini fu narratore e critico; morì a Cortina d'Ampezzo il 2 settembre 1953.
128
E' infatti un classico esempio di una delle interpretazioni no-vecentesche del personaggio; in questo caso la malattia che affligge Don Giovanni non è la vecchiaia ma la super-donna, cioè la femmina esperta che istruisce il giovane per tenerezza: Don Giovanni è malato di adolescenza. La donna così tenta di inglobarlo in se stessa contando sul fatto che il giovane sia disposto a subire la violenza. Qui però il finale vuole farsi beffa della situazione psicologica creata, tanto da parere una forza-tura; è un procedimento molto vecchio del linguaggio teatrale che è sempre comodo usare in un prodotto di consumo: il pubblico ama essere introdotto in una situazione in cui un personaggio di continuo afferma una interpretazione del fatto che lo spettatore non può condividere perché troppo difficile, ma poi la nega alla luce di un sentimento "superiore" (l'amore, l'umanità, la religione, la patria, la mamma, ecc.) e il pubblico può tirare un sospiro di approvazione; è una forma tutta mo-derna di "imprevisto", un colpo di scena estremamente (e in maniera mistificata) culturalizzato.
In una posada disperatamente tesa a rappresentare una Spagna cartolinesca, tra Siviglia e Madrid, la Dama e il Fante, dopo la serenata e l'interruzione di lugubri voci di viandanti dalla strada, ricordano come è nato il loro amore: incontratisi a cena, il Fante ha seguito la Dama nelle sue stanze e l'ha amata. Il Fante è nuovo e cerca la sua strada, e la Dama è lì apposta. Questa è la descrizione della situa-zione ed ecco la negazione: il Fante se ne vuole andare ma è trattenuto dalla presenza di gente fuori dalla stanza; deve subire così l'assalto della Dama ad un livello per forza di cose superiore: essa è il mistero, il suo destino, colei che ha trasformato il giovane in un'altra cosa. Il Fante sul momento non è in grado di replicare e la Dama prosegue la descrizione di se stessa in chiave mistica e sottolizza sul proprio uso puramente sensuale. Seconda negazione: il Fante rivela di aver ucciso un uomo che faceva una sere-nata e di essersi per questo rifugiato da lei; adesso ha il coltello per il manico, è lui il detentore di mistero, lui che uccise e non sa perché: la super-donna cede e crede al Fante; ma questi, sempre più misterioso, cerca la pietà: prima giovane complessato, adesso perseguitato. Ecco, la posada si anima, si cerca l'ucciso, si urla il nome di Don Giovanni. Terza negazione: il Fante si affaccia al balcone e urla ai compagni "vengo ragaz-zi" e, crudelmente indifferente, "...dormivo..."; e cala il sipario.
129
Già, perché è evidente che debba calare il sipario: il pubblico ha avuto la sua dose di soddisfazione/frustrazione, il suo "ho capito/non ho capito": non esisteva alla situazione di mistero altra negazione che un duro ritorno alla realtà, al solito tipo di Don Giovanni che le pensa tutte e che sa fingere così bene. Un testo come questo può essere considerato importante per alcune notazioni di costume: dimostra come spesso il pubblico possa essere spinto al masochismo e ad accettare qualsiasi travestimento cultural-scientifico della realtà; una cosa del genere nel 1921 dimostra a mio parere chiaramente quanto questo costume abbia nuociuto: l'avere diffuso l'abitudine alla pseudo-filosofia (e alla pseudo-scienza) ha facilitato in grande misura la formazione di quei miti di cui il fascismo fu grande produttore. Il gioco sulle parole, l'uomo intelligente che ha capito in mezzo agli stolti che non ci sono ancora arrivati e altra situazioni ancora, fanno parte di quel tipo di "profondità" teatrale che, risolta alla fine nel trionfo di un valore "superio-re", ha facilitato nel pubblico troppo semplicistiche equazioni; il disprezzo fascista per tutto ciò che non si risolve in mito (razza, forza, guerra, genio ecc.) nasce anche da questo. L'anno successivo, il 1922, vide Intermezzo: Don Giovanni si pente154 di Alessandro Varaldo155. Ecco una commedia in un atto in versi che ci mostra un Don Giovanni sconfitto dall'artrite e predisposto alle visioni che si aggira in ambienti bui e si butta in avventurette da cui non sa come uscire; diventa così la maschera più patetica e il testi-
154
In Alessandro Varaldo, Donne, profumi e fiori, p. 97, Milano, Son-zogno, 1922. 155
Alessandro Varaldo nacque a Ventimiglia il 25 gennaio 1876; fu critico, romanziere e Direttore della Siae; morì a Roma il 17 febbraio 1953.
130
mone più completo del fallimento sessuale dell'uomo dannun-ziano156.
Una Spagna tanto di maniera da sembrare il libretto della Carmen: in una piaz-zetta di Cadice arrivano cantando ariette studenti, beoni e la ronda che prose-gue il suo giro. Leporello e Don Giovanni entrano in scena parlando di una pos-sibile conquista, una bellissima dama di un patio vicino afflitta da un innocuo fidanzato; il servo va ad attendere il padrone alla locanda mentre nella notte Don Giovanni rimpiange la sua giovinezza, si lamenta della vecchiaia incalzante e ricorda soprattutto le notti di felicità con la pura Fiorina, quando era giovane; sotto il peso di queste memorie assiste alla serenata di Lionello, notaio, alla fidanzata, che guarda caso si chiama anch'essa Fiorina: questi propone alla ragazza la fuga per andare a sposarsi da un eremita nella sierra. Dongiovanni inviperito, mentre i due parlottano, fa rumore ottenendo così che Fiorina si ritiri; egli deve dimostrare, a se stesso principalmente, di valere ancora qualcosa: affronta Lionello, tenta di bussare alla porta della ragazza, chiama Leporello e gli ordina di legare il notaio e di buttarlo in un angolo. Dall'atroce maschera di reumatico ancora capace di menare le mani a quella di raffinato seduttore: Don Giovanni prende la chitarra e canta; Fiorina si affaccia, lo crede Lionello e decide di aderire alla richiesta di fuggire; Don Giovanni vuole un bacio ma la ragazza, sempre più simile alla fanciulla del ricordo, vuole prima essere sposata e allora Don Giovanni si lancia in un discorso profondo che tocca l'essenza del bacio, gli angeli, il Natale ecc. Fiorina abbastanza intontita starebbe per cedere ma prima, ultima risorsa, si fa un segno di croce: Don Giovanni crede adesso di avere di fronte la Fiorina della sua giovinezza ed è sconvolto, ma, ripresosi, da buon peccatore pentito rimettere tutto a posto: Leporello slega il notaio, Don Giovan-ni lo porta da Fiorina che vorrebbe vendetta ma si acquieta quando Don Gio-vanni offre la sua carrozza per la fuga. Dopo questo pasticcio ha ancora un dubbio: sarà servito a qualcosa il suo pentimento? Leporello gli dice che certo è stato perdonato e se lo porta alla taverna dove un oste poco in regola vende falso vino del Reno.
Come si vede, continua la serie dei Don Giovanni che si pento-no, che si sposano o che cercano e trovano perdono e pietà. Importante è sempre il ruolo della donna: vince sempre, do-mina sicura e, ora parlando della mamma ora dei santi, amma-lia un povero Don Giovanni che si aggira per i castelli d'Europa o per le viuzze spagnole disperato e stanco sotto il peso dei ricordi di tre secoli.
156
quello che copre la sua laidezza con l'estetismo e il culto del suo Io.
131
Il Don Giovanni157 di Ugo Falena158 è un esempio di una delle correnti del Don Giovanni novecentesco, il recupero dell'anti-ca leggenda; questo testo si leva un po' sugli altri per l'accor-tezza dell'operazione e per la cura con cui introduce alcuni elementi nuovi.
La vicenda inizia con il rogo in effigie di Don Giovanni fuggito in Sicilia dopo numerosi inganni; una grande folla giubilante vi assiste e da un patio il Com-mendatore, la figlia Anna, Ottavio e altri invitati di rango. Un misterioso cavalie-re si avvicina ad Anna e le chiede un appuntamento minacciando in caso di rifiuto di rivelare il proprio nome a tutti: Anna ha riconosciuto Don Giovanni, sviene e questi fugge mentre la folla si contende le ceneri del rogo; Anna rinvie-ne e tutti poi si allontanano. Leporello e Don Giovanni arrivano sulla piazza deserta: come al solito il servo ha paura ma Don Giovanni lo consola affermando che in fondo l'importante è separarsi bene dalla vita. Una ragazza che torna dal rogo con la sua reliquia di cenere offre a Don Giovanni l'occasione per intenerirsi al pensiero che la fanciulla prova pietà per lui; arriva Anna che implora Don Giovanni di fuggire ma egli è deciso: o insieme o niente; Anna è il vero amore di tutta la sua vita, che è stata come una scala che aveva lei al culmine e per que-sto egli ha compiuto tutti i suoi delitti così risolutamente, per raggiungerla. Di fronte alla minaccia di costituirsi Anna cede e decide di fuggire ma giunge il Commendatore: Don Giovanni uccide il padre Adriana ed anche Ottavio; ai soldati sopravvenuti la donna dichiara che l'aggressore ero uno sconosciuto.
Col secondo atto comincia la "stanchezza" di Don Giovanni: tutti gli eventi ricadono sulla sua testa ed egli pare poter solo subire.
In un palazzotto presso Siviglia Don Giovanni organizza, nonostante il rischio, una cena di addio per gli amici; Leporello commenta sfavorevolmente quest'idea del padrone mentre questi si intrattiene con Don Luigi (cui tempo addietro aveva rapito l'amante per scommessa) che lo ha nascosto fino a quel momento. Don Giovanni vive sotto il peso dell'amore per Anna, ma le sue lettere sono respinte e Leporello non riesce a consolarlo. Un brusco richiamo: dal muro di
157
Ugo Falena, Don Giovanni, dramma in tre atti,"Commedia", V, XXI, 1.11.1923, p.13. 158
Ugo Falena (Roma, 25 aprile 1875 – 20 settembre 1931) è stato un commediografo, impresario teatrale e regista cinematografico italia-no.
132
cinta appare la statua, Leporello lancia grida di terrore ma la visione presto scompare. Arrivano gli amici con le loro donne per il banchetto; durante la festa arriva una dama mascherata che Don Giovanni accoglie bene e fa danzare; la donna si rivela per Anna e proclama il suo amore: anche Don Giovanni le dichia-ra amore eterno e annuncia il suo pentimento per il delitto. Ma Anna è venuta solo per portargli l'ultimo respiro e muore uccisa dal veleno ingerito da una fialetta; Don Giovanni alla disperazione vorrebbe essere ucciso da uno degli amici che pure ha offeso con qualche inganno, ma la statua riappare e, udita solo da lui, invita l'assassino all'appuntamento di mezzanotte.
Col terzo atto Don Giovanni perde ancora di più il carattere di protagonista delle proprie azioni: la sua stanchezza lo costrin-ge a subire un destino tradizionale.
In un cimitero disseminato di monaci in preghiera Don Giovanni chiede a un frate il perdono passeggiando fra le tombe e insiste sul fatto che è stato Dio a farlo così, e che l'amore, come lo ha condotto per tutta la vita, così ora lo spinge verso Dio. Un altro frate si avvicina e comunica al confratello che la lampada sulla tomba del Commendatore non vuole accendersi; Don Giovanni sente che la sua esistenza è agli sgoccioli e le stelle, i rumori, gli odori lo colpiscono in manie-ra nuova: le sue ultime parole sono un inno alla vita e una confessione di dolore, come se dietro ad ogni sua risata ci fosse sempre stata una lacrima. Il frate commosso alla mezzanotte concede il perdono; passi pesanti si sentono dal fondo e Don Giovanni fugge; lo stesso frate poi scopre macchie di sangue sulla tomba del Commendatore.
Molti sono i motivi vecchi e nuovi contenuti in questo testo, rappresentato per la prima volta alla Pergola di Firenze: la fanciulla che torna dal rogo ricorda tutte le giovinette che accompagnano gli ultimi giorni di Don Giovanni; il discorso sull'amore è tipico di tutto questo periodo e tante altre scene ancora ricordano versioni contemporanee e no. Ma nuova è la resa della vicenda che risulta molto efficace: tutto il terzo atto vive dei pochi elementi che preannunciano a Don Giovanni la sua fine; e così è nuovo (almeno in Italia) un Don Giovanni che coscientemente si avvia alla morte dopo avere scoperto la ragione della sua vita e con ciò essersi giustificato.
133
Nello stesso filone di riscoperta della leggenda si inserisce il Don Giovanni159 di Arturo Rossato160, musica di Felice Lattua-da161, rappresentato a Napoli nel 1929. Qui però il rapporto con la leggenda è un po' artefatto da esigenze propriamente sceniche e anzi tutta la vicenda ha una pesantezza che manca-va agli originali.
In una piazzetta di Siviglia, alla "Taverna del lauro" siedono a un tavolo Don Luigi Menghia, Avellia, Sentellia e, in disparte, un uomo mascherato che scrive una lettera con vicino Sciutti; l'oste Cristoforo serve i tavoli e chiede a Luigi del matrimonio con donna Maria fissato per l'indomani. Il cavaliere mascherato manda Sciutti a portare una lettera a Ines, al convento; arrivano le maschere che dicono di aspettare Don Giovanni per le nove in punto; a quell'ora Cristoforo continua a dire che Don Giovanni arriverà, Luigi promette che lo ucciderà, il coro impaziente attende. Appare Don Giovanni, il cavaliere di prima senza la masche-ra: tutti gli fanno festa meno Luigi che siede in disparte; fra i brindisi Don Gio-vanni ricorda Isabella di Napoli; Luigi si arrabbia: mettono mano alle spade, ma Don Giovanni promette che prima dell'alba avrà Maria, beffeggia Luigi e poi se ne va in compagnia cantando diabolicamente. Luigi è restato solo sulla piazza; bussa alla porta di Maria, le espone i suoi timori e le chiede di poter restare accanto a lei per quella notte (Don Giovanni ascolta non visto); Maria consegna a Luigi la chiave e gli dà appuntamento alla mezzanotte. Andatosene Luigi, Don Giovanni chiama Sciutti e i suonatori perchè vuole fare una serenata a Ines nel convento. Luigi è assalito dai servi di Don Giovanni e derubato della chiave; Don Giovanni va al convento, corrompe con una borsa di denaro la portinaia e rapi-sce Ines, fuggendo poi a cavallo.
159
Felice Lattuada, Don Giovanni, tragedia in quattro atti di Arturo Rossato, Milano Sonzogno, 1929. 160
Nato a Vicenza il 17 giugno 1882 fu autodidatta, tranviere e giorna-lista all'Avanti e al Popolo d'Italia; amico di Mussolini, cercò poi una posizione autonoma facendo fronda al regime. Morì a Milano l'11 marzo 1943. 161
Felice Lattuada nacque a Caselle di Morimondo in provincia di Milano il 5 febbraio 1382; diplomatosi nel 1911, dal 1937 fu Direttore della Civica Scuola di musica di Milano.
134
Inutile dire che tutta la taverna è una scusa per un scena di massa e infatti è tutto un incrociarsi di voci, cori, monologhi; il resto della vicenda si dipana secondo i ritmi tradizionali né niente di nuovo è il Don Giovanni che ne risulta.
Nel casino di campagna di Don Giovanni Ines dorme ancora, mentre i servi aspettano il ritorno del padrone, sparito dopo il ratto; Ines si sveglia ed è terro-rizzata, vorrebbe andar via ma la trattengono i passi di Don Giovanni che ritorna; questi le dice che fra poco arriverà lì il padre della ragazza per il matrimonio, poi usando tutte le sue arti inebria Ines quasi ipnotizzandola; entra Sciutti agitatis-simo: Don Giovanni manda via Ines e riceve Luigi mascherato, che lo accusa, ma Don Giovanni risponde che tutto era stabilito nel patto. Ugualmente, i due duellano fino a che Sciutti non annuncia l'arrivo di Don Gonzalo, padre di Ines; Don Giovanni chiede una pausa, Luigi si ritira in un'altra stanza. Di fronte a Gonzalo Don Giovanni prega che gli sia concessa Ines per ottenere la quale è disposto a qualsiasi punizione; ma Gonzalo rifiuta: Don Giovanni in ginocchio lo prega ancora me in quel momento entra Luigi affermando che Don Giovanni sta ancora scherzando; inviperito Don Giovanni spara a Gonzalo poi si batte con Luigi e, ridendo satanicamente, lo uccide. All'arrivo della gente di Gonzalo Don Giovanni si butta dalla finestra nel Guadalquivir.
E' questo evidentemente un Don Giovanni vecchissimo, preci-samente quello che cerca di ispirare pietà nel pubblico cer-cando di passare da perseguitato: la lunga scena con Gonzalo lo ha in fondo solo questa giustificazione.
Di notte, al cimitero, fra candide colonne, fra il busto di Gonzalo e un'urna che reca il nome di Ines, si aggira un custode che appende una lanterna davanti al Commendatore; arriva Don Giovanni: il custode è impaurito ma Don Giovanni gli domanda se sia quello il Pantheon di Tenorio e ammira l'architettura; il custode vorrebbe chiudere ma Don Giovanni vede l'urna, ne chiede e l'uomo risponde che Ines è morta d'amore per Don Giovanni, che a questo punto si rivela facen-do fuggire il guardiano. Don Giovanni piange sulla tomba e appare, fra canti celesti che invocano la pace, l'ombra di Ines; lui è incredulo e scaccia il fantasma ma poi è convinto dalla donna che lo invita a pentirsi e a seguirla, e poi scompa-re. Don Giovanni ha ancora dei dubbi: ama troppo la vita! Risate e rumori infer-nali: Don Giovanni snuda la spada ma barcolla e cade; lo rialzano Avellia e Sen-tellia e con loro si mette a scherzare, invita i due a cena ma vorrebbe come ospite anche qualcuno dei morti; sceglie Gonzalo e lo invita a casa sua; i due trascinano via Don Giovanni che ride pazzamente.
135
Si confermano qui le solite abitudini di chi riscrive un Don Giovanni, dare maggiore rilevanza al miracolistico e al magico, il tutto in gran parte per fare spettacolo.
Don Giovanni banchetta coi compagni; ha lasciato un posto vuoto a tavola per Gonzalo. Mentre una donna danza voluttuosamente inneggiando a Siviglia Don Giovanni ordina a Sciutti di versare da bere al silenzioso ospite, ma bussano: Sentellia grida che è il morto, Sciutti che è un fantasma. Passi pesantissimi rimbombano: arriva Gonzalo mentre le luci si spengono; il fantasma avverte Don Giovanni che ha ancora un'ora prima dell'alba ma Don Giovanni snuda la spada per difendersi; Gonzalo però scompare repentinamente ridendo. Giunge l'alba: Don Giovanni sveglia Sentellia e Sciutti e dice che la beffa è finita: infatti crede che sia stato tutto uno scherzo dei due; li rimprovera, si giunge al duello: Don Giovanni resta ferito mentre i compagni si danno alla fuga. Don Giovanni si sente morire: chiede al cielo un'altra notte ma gli alberi si trasformano in fanta-smi e sfilano per il funerale: prima le donne tradite, poi altre figure mentre Don Giovanni delira; all'alba muore invocando la bellezza della vita; il giardino sullo sfondo si anima di uccelli e di vivacità.
La morte di Don Giovanni chiarisce bene gli intenti dell'Autore: l'intervento della statua ha sempre avuto un significato reli-gioso nel senso che essa rappresentava la giustizia divina (vedi ad esempio i commenti al racconto del servo di Don Giovanni in tanti testi già esaminati), ma qui l'intervento miracoloso è una visione, un'apertura su un mondo misterioso e Don Gio-vanni muore per soddisfare una predizione, per colpa del suo fato: non è invocata nessuna giustizia che debba colpire il suo comportamento demoniaco, la sua risata pazza lo ha già defi-nito come colui che morirà per le sue colpe ma certo non in nome di un valore superiore. Ho poi indicazione di un Il crepuscolo di Don Giovanni di Raffa-ele Calzini del 1927, che evidentemente doveva concludere il ciclo iniziato con Il debutto. Dal 1927 al 1941 un altro grande vuoto, fino al già citato Don Juan de Mañara di Moschino, elaborazione del suo preceden-te libretto.
136
Quindi dobbiamo andare 1950 per trovare un nuovo Don Gio-vanni, più di vent'anni di assenza; almeno si potrebbe suppor-re che in questo tempo Don Giovanni si sia aggiornato perché chiaramente tutte le prove novecentesche finora viste non ne avevano mai messo in scena uno moderno in senso stretto ma anzi coscientemente avevano rappresentato un recupero ar-cheologico, il più delle volte. Invece, salta fuori un Don Gio-vanni niente affatto cambiato se non nei suoi tratti esteriori, nel senso che, anche se si muove in ambiente moderno, è pur sempre un tipo abnorme nella sua società, un "mostro" che deve essere integrato se non può più essere punito da una giustizia divina. Il Don Giovanni ultimo162 di Vincenzo Tieri163 rappresenta un tentativo di modernizzare il personaggio utilizzando gran parte degli elementi della leggenda ma rendendoli plausibili ed a-datti ad apparire in un contesto sociale contemporaneo: ci sono quindi la seduzione, il rapimento, la morte del Commen-datore, la statua.
Nel castello di Pietrafitta, ricco di telefoni e di aggeggi moderni, Don Giovanni riceve tale Maria, vecchia fiamma e amante in carica insieme a tante altre; dopo che questa ha parlato con la segretaria di Don Giovanni del caso Calatrava (il Commendatore morto di attacco cardiaco che tanto ha fatto scalpore nella buona società), Don Giovanni assicura alla donna il suo amore. Il cameriere avverte che è arrivata Teresa; Don Giovanni con una scusa manda via Maria, disdice per telefono l'appuntamento con un'altra donna e riceve la ragazza con cui finge di avere scrupoli; è annunciato l'arrivo di Elvira: Don Giovanni manda via Teresa e ascolta la donna che, accordatasi con la segretaria Isabella, gli dice che Anna, la figlia del Commendatore, e il fidanzato Dario lo stanno cercando
162
Vincenzo Tieri, Don Giovanni ultimo, commedia in tre atti, "Teatro" II, 23, p. 21. 163
Nato a Conegliano calabro in provincia di Cosenza il 28 novembre 1895, ha aggiunto nel dopoguerra al giornalismo e alla produzione teatrale anche la regia.
137
con cattive intenzioni; anche Isabella cerca di far presente il pericolo ma Don Giovanni ama l'avventura e vuole fare di testa sua.
Col secondo atto cominciano i dubbi e le giustificazioni di Don Giovanni: per forza, è un po' il simbolo della bella società! Se i problemi sono pochi, ci si passa in mezzo senza parere, fra un bicchiere e l'altro, fra telefoni bianchi e personale in frac, ma se si addensano nubi ci si deve mettere in guardia, in quel mondo il duello è cosa normale e doverosa per i gentiluomini (del 1950!).
Teresa confida a Don Giovanni che teme di essere abbandonata e che ha paura che il padre muoia di dispiacere come il Commendatore; Don Giovanni la con-vince a tornare a casa. Continua il walzer: dopo che Don Giovanni ha fissato appuntamenti per telefono con Laura e con Maria, Isabella gli comunica l'arrivo di Elvira ed Anna; Don Giovanni diventa meno sicuro e racconta sprezzante che ha fatto testamento poiché aspetta la visita di Ottavio e che nello studio del notaio c'era il busto del Commendatore. Elvira ed Anna entrano: Anna non vuole vendetta nel senso stretto del termine e quindi Elvira propone il matrimonio riparatore, ma l'amica alza il prezzo, la sua sarà una vendetta lunga e raffinata. Uscite le donne arriva Ottavio, uomo d'onore e fidanzato offeso, che chiede un duello; Don Giovanni comincia già a cedere quanto a nervi: sprezzante, non ritiene Ottavio degno di battersi con lui, poi modera la cosa dicendo che gli vuole far evitare l'errore da lui commesso al primo tradimento di una donna, errore che l'ha costretto a vendicarsi di quella su tutte le altre. Ultimi sussulti: Don Giovanni rivendica la sua libertà, che lo lascino fare come vuole; quando tutti se ne sono andati, si alzano le nebbie di una possibile tragedia: la telefona-ta di Teresa dall'albergo è interrotta improvvisamente e Don Giovanni teme il suicidio della ragazza.
Terzo atto, la liberazione.
Isabella, colei che in silenzio ha vegliato sulla tranquillità di Don Giovanni in mezzo a lettere di altre donne che legge e butta via su ordine del padrone, colpisce il cuore del suo nobile signore ormai incline a una soluzione; e Don Giovanni sputa tutta la sua storia: la figura del padre che lo allontanava dalla madre, e la madre che si sposa tradendo l'amore del figlio, e l'odio per il patri-gno... ma con chiare parole Isabella rifiuta una interpretazione psicoanalitica, niente complesso di Edipo, prescrive a Giovanni una buona cura di affetto e di calma; Don Giovanni convinto trova la sua pace nel matrimonio con Isabella.
Un Don Giovanni che si pente, prova pietà per una ragazza e la rimanda casa, che comincia a guardare la segretaria e la
138
sposa, e che inoltre trova una spiegazione moderna della pro-pria situazione nel complesso di Edipo, nella scena di violenza vista da piccolo, nel tradimento del primo amore, nella clau-strofobia e così via. Da questa interpretazione lo spettatore si sente lusingato, perché bene o male anche lui ha sentito par-lare di quelle stranezze della psicologia moderna, ma grazie ad un meccanismo già visto questa situazione deve essere negata in nome di un sentimento "superiore": Isabella riduce tutto a bisogno di tenerezza e si presenta quindi come sostituto della figura materna, la protettrice, colei che tiene in ordine la casa, e ovviamente una simile affermazione non può essere ulte-riormente negata senza che crolli tutto un mondo. Ecco quindi che Don Giovanni si riduce ad un infelice che, attraverso la rivelazione psicoanalitica delle proprie frustrazioni e la pro-messa da parte di una figura femminile di un buon grado di protezione e di tenero affetto, trova la sua sistemazione ed esce dalla propria condizione (e qui si sente l'eco del "gioco delle parti" pirandelliano) per trovare la pace. Ma il tragico è che è una commedia del 1950, che si permette il lusso di pro-porre temi e soluzioni teatrali che, già usate nel primo dopo-guerra, avevano lasciato il posto a ben altro sulla scena euro-pea; per questo il tentativo di modernizzare Don Giovanni resta sterile e non aggiunge niente di nuovo o di interessante al mito se non nella misura in cui possono considerarsi rilevan-ti gli sforzati adattamenti al moderno delle classiche situazioni della leggenda. E' opportuno insistere poi ancora su quanto si disse a proposi-to del testo del 1921 di Calzini (e già il fatto che il confronto si faccia con un testo di trent'anni prima è significativo): il siste-ma di ricorrere al trucco della affermazione/negazione da risolvere nella scoperta del "sentimentale" che vince lo "scien-tifico" è una classica formula del teatro commerciale come quella che sollecita meglio la vanità dello spettatore borghese; ma in più qui si rivela anche il cedere a una moda culturale
139
nascente allora in Italia, la psicoanalisi, capita e interpretata in modo quanto mai superficiale: ricorda tanto il "discorsino" dell'esperto televisivo di psicologia, altra figura simbolo di un certo modo di intendere la cultura. Non ho visto purtroppo il Don Giovanni KO di Gian Maria Co-minetti
164, tre atti del 1955; concludiamo quindi con i due
tempi di Don Giovanni al rogo165 di Alfredo Balducci166 del 1987. Mancava davvero che Don Giovanni fosse paragonato a un moderno aspirante capitalista e industriale che scala la Borsa! Abbinata alla vicenda dell'industriale mister Johann (scenica-mente per mezzo di paleolitici cerchi di luce entro cui entrano di volta in volta i personaggi delle due storie) scorre la vicenda di Don Giovanni e il rapporto fra le due storie non è sempre chiaro. Con innegabile abilità e una certa qual polemica politi-ca l'Autore trasporta la vicenda dello scalatore sociale su un piano moralistico scoprendo complessi di autodistruzione.
La figura di Re Alfonso XI è ridicolizzata col farne un ragazzetto di 14 anni in balia dei suoi consiglieri il cui interesse precipuo è quello di fargli fare quello che vogliono lasciandogli l'impressione di comandare realmente. Il consigliere Con-salvo riferisce al Re dei mostri nati e dei fatti terrificanti verificatesi in Spagna in relazione, o perlomeno è politicamente utile far credere sia così, alle malefatte di Don Giovanni che ha ucciso il Commendatore e violato Anna; ma la parola "violato" risulta nuova al Sovrano che vuole particolari e tutta la Corte arrossisce per spiegare che cosa è successo ad Anna senza usare parole azzardate: Consal-vo disquisisce sul sacramento del matrimonio ma il Re è ancora insoddisfatto; si adatta poi a firmare la condanna a morte di Don Giovanni quando gli si prospet-
164
Gian Maria Cominetti (Salasco, 14 dicembre 1884 – Roma, 2 set-tembre 1961) è stato un regista e sceneggiatore italiano, attivo in teatro e nel cinema. 165
Alfredo Balducci, Don Giovanni al rogo, due tempi, "il dramma" XLIII, 374-37 5, nov.- dic. 1967, p. 111. 166
Alfredo Balducci (Livorno, 21 agosto 1920 – Milano, 23 febbra-io 2011) è stato un drammaturgo italiano vincitore di numerosi premi.
140
ta la possibilità di andare a vedere un bellissimo cavallo: come attirato da un invisibile zuccherino il Re dimentica i desideri insoddisfatti di conoscenze sul sesso. Incontriamo Don Giovanni e Catalinon, dopo un congruo incrociarsi di battute fra i personaggi della storia industriale; il servo vorrebbe che il padrone fuggisse dopo la condanna, ma questi ha un appuntamento cui non vuole rinun-ciare, con Stella che Catalinon ha avvicinato fingendo di essere il cugino Pedro. Il primo atto si chiude con la scena migliore di tutto il dramma: il nostro mister Johann è riuscito a sposare una ricca vedova e la prima notte di nozze consiste in uno spogliarello della sposa intercalato dal disbrigo di pratiche e di corrispon-denza, un indumento e una cambiale, e infine la grande prova d'amore: il dono di una società. Nel secondo atto Don Giovanni fa considerazioni sulla reale portata delle sue turpi azioni: esclude che le donne da lui sedotte fossero vergini ma è ben consa-pevole che erano solo ipocrite; egli ha il fuoco dentro e almeno non lo nasconde. L'incontro con la statua del Commendatore induce Don Giovanni a considerare che in fondo è merito suo se esiste quel monumento, proprio per il fatto che ha tolto di mezzo il padre di Anna all'apice della sua gloria.
Tutte queste considerazioni vogliono passare per profonde, non sono ragionamenti per assurdo o comunque tesi a rap-presentare il cinismo di Don Giovanni!
Don Giovanni manda Catalinon in cerca di un frate per fingere il matrimonio con Stella, ma invece di costei arriva di gran carriera Anna che, essendone amica, la vuole salvare; Don Giovanni comincia a fare delle scene invitando Anna ad ucciderlo e proclamando il suo amore: alla fine fatalmente Anna gli crede ancora e lo abbraccia; Don Giovanni beffeggia la statua per la nuova conquista e fugge mentre Anna lo maledice. Dopo che Mr. Johann è stato, pare, ucciso dai suoi avversari, la scena è di nuovo nella reggia dove i consiglieri commentano fra di loro la morte di Don Giovanni che si è gettato con indomito coraggio contro i soldati mandati ad arrestarlo. Arrivano il Re e Consalvo, che non è soddisfatto di quella fine in quanto voleva un'esecuzione esemplare; ancora una volta il Re non è d'accordo ma promettendogli altri divertimenti Consalvo lo induce a firmare una nuova sentenza: Don Giovanni sarà bruciato sul rogo; un consigliere si domanda se questo non lo renderà ancora più famoso, così come accade per Prometeo.
Come si vede i motivi che giocano in questo testo sono quanto mai vecchi: ragion di Stato e giustizia, ipocrisia e coerenza; paradossale la parte moderna che scopre che l'economia è dominata dai complessi di autodistruzione dei capitalisti. Ad essere benevoli questo testo non rappresenta nulla di nuovo, è una commedia fuori dal tempo che ha trovato però modo di
141
vincere il premio dell'Istituto del dramma; considerazioni sul teatro italiano e sui premi letterari sono fatti di cronaca, ma scoprire questa situazione fa sempre un certo effetto. In conclusione possiamo affermare che non esiste nel Nove-cento italiano un modo unico per interpretare il tema: si bat-tono piuttosto varie strade, mettendo in rapporto un Don Giovanni giovane con una donna matura, un Don Giovanni vecchio con la giovinetta, col matrimonio, con una fanciulla che lo ammalia, e infine recuperando l'intera leggenda adatta-ta per quando possibile alle nuove forme espressive, il più delle volte solo per esigenze spettacolari. E così come non esiste uno sviluppo di ognuna di queste linee, così non esiste nemmeno una linea evolutiva del tema né un approfondimen-to organico di nessuno dei temi affrontati; solo un concetto estremamente generico accomuna questi testi, il Don Giovan-ni sconfitto, nel senso che è privato della potenza e della forza titanica che possedeva nelle realizzazioni letterarie dei secoli passati. Insomma, non esiste un Don Giovanni novecentesco in senso stretto ma tanti tentativi poco riusciti in molte direzioni e ciò perché manca un modello e ovviamente perché manca un capolavoro.
143
CAP. 6 - CONCLUSIONE
L'attività spirituale, l'istruzione, la civilizzazione, la cul-tura, l'idea sono tutti concetti poco chiari, poco definiti, tali che sotto la loro bandiera è molto agevole far uso di parole che hanno un senso ancora meno chiaro e che facilmente sono applicabili a sostegno di qualsiasi teo-ria!
Lev Tolstoi, Guerra e pace167
Un certo numero di imbecilli e di furbi si mettono d'ac-cordo fra loro di sapere, ad esempio, il messicano; si impongono in tal modo alla società che li rispetta e ai governi che li pagano. Li si riempie di favori proprio perché non hanno alcuna intelligenza e il potere non ha da temere che sollevano il popolo e che fomentino di-sordini invocando sentimenti generosi.
Stendhal, La certosa di Parma168
Come si è già detto all'inizio, questo lavoro non ha portato nulla di nuovo, in senso stretto, alla conoscenza dello svolgi-mento del tema dongiovannesco; ha precisato però alcuni concetti generali applicati ad un argomento specifico (modelli ed imitatori ad esempio) e rilevati almeno tre punti abbastan-za importanti:
167
Lev Tolstoi, Guerra e pace, traduzione di Agostino Villa, "I capolavo-ri Sansoni" 21-23, Firenze, Sansoni, 1966, vol. III, p. 1821. 168
Stendhal, La chartreuse de Parme, texte établi, avec introduction, bibliographie, choronologie, notes et relevé par Henry Martineau, Paris, Editions Garnier Frères, 1961, p. 148.
144
In primo luogo è sufficientemente provata la scarsa influ-enza esercitata dal Don Juan di Molière sulla produzione italiana; i primi testi che chiaramente vi si rifanno sono infatti quelli di Bertati e di Da Ponte.
In secondo, pare certa la mancanza di interesse dei Ro-mantici italiani per Don Giovanni, come conferma anche l'elenco più oltre riportato in Appendice.
In terzo luogo si è potuto stabilire che non esiste un Don Giovanni "all'italiana" con caratteristiche proprie, se non nel senso in cui da un certo momento in poi la produzio-ne nostrana, essendo più conservativa di quella coeva eu-ropea, insiste su motivi decrepiti, ripetendoli in maniera molto simile per lunghi anni e caratterizzando così in un certo senso un tipo di personaggio. La storia italiana di Don Giovanni è cioè parallela a quell'europea fino a quando i testi scritti per il teatro in Italia, forti del loro successo, si attardano in operazioni archeologiche; da quel momento Don Giovanni divenne da noi un fenome-no fatiscente, che appare e che scompare, tenta di evol-vere in molte direzioni ma non ne approfondisce vera-mente nessuna.
Al termine di un lavoro così pesante e stante lo scarso numero di conclusioni rilevanti che possono esserne tratte, mi sono sorte spontanee alcune considerazioni che più che riguardare i temi che ho trattato si riferiscono al modo in cui li ho affronta-ti. In definitiva, e ciò valga come una confessione, la mia ricer-ca mi pare possa essere agevolmente definita un fallimento e ciò per tre motivi: prima di tutto, a causa della forzata incom-pletezza derivante dal fatto di non aver potuto trovare tutti testi di cui avevo notizia; poi in ragione del brusco cambia-mento di rotta che mi si è imposto appena mi sono reso conto della situazione che si era determinata: buona parte degli
145
appunti e delle note ai testi che avevo redatto è stata difficil-mente adattata alla nuova linea espositiva che mi era parso necessario adottare; infine a causa di un personalissimo at-teggiamento, di un complesso di mie opinioni, certo poco documentate, sulla validità scientifica della cosiddetta critica letteraria. Il difetto più rilevante che ho riscontrato nei metodi correnti di conduzione della ricerca su un'opera letteraria è il suo esse-re assolutamente avulsa dallo studio della coeva situazione storica e sociale, come se cioè fosse dato per scontato che la letteratura ha un suo sviluppo totalmente autonomo dalla realtà; troppe volte si parla di arte come di un fatto in cui si riscontrano solo verifiche di concetti idealistici come "eterni-tà" o "bello" senza mai considerare il rapporto dialettico che essa ha di continuo con bene identificabili condizioni sociali e in generale con lo sviluppo storico. Questa constatazione, seppure debba riconoscere che è limitata alla mia modesta conoscenza di storia della critica letteraria, mi ha spinto a indirizzare i miei studi proprio alla ricerca di una possibile al-ternativa a tale situazione, ricerca che per forza di cose posso considerare solo agli inizi, non avendo cioè assolutamente le idee chiare su tutti gli immensi problemi che una simile pro-spettiva reca con sé. Proprio per questo affermo essere il mio lavoro un fallimento, nel senso cioè che avrei voluto essere capace di fare una cosa diversa da quella che ho fatto, nella convinzione che sia possi-bile contrapporre a un metodo di critica a mio parere poco scientifico una via nuova (ma forse già attuata da qualche studioso che la mia ignoranza non mi ha ancora fatto conosce-re) per esaminare, capire e giudicare la letteratura. Insisto sul fatto che tutto quanto ho detto è semplicemente una confes-sione, ovvero è un salvarmi la coscienza dicendo che non avrei voluto fare quello che ho fatto; ovvero, con tanta benignità da
146
parte mia, potrebbe essere un programma di lavoro che spero di poter seguire negli anni a venire.
147
PARTE TERZA - APPENDICE
Un interessante allargamento del discorso potrebbe costituire l'esame dei romanzi, racconti, opere di poesia e film italiani incentrati sulla figura di Don Giovanni. Ne do perciò un elenco, quale occasionalmente è risultato dalla ricerca bibliografica e che quindi ha il semplice valore di un suggerimento per even-tuali ricerche.
1 Felicita Casella Haydée XIX
2 Enrico Panzacchi Don Giovanni 1877 sonetto
3 Giovanni A. Cesareo Don Giovanni: gli amori 1883 poema
4 Enrico Panzacchi Accanto al fuoco 1888
5 Ferdinando Di Giorgi La fine di Don Giovanni 1895 novella
6 Olindo Guerrini Scrive Donna Elvira poema
7 Arturo Graf La dannazione di Don Giovanni 1905 poema
8 Giovanni Cena Don Giovanni all'inferno 1907 sonetto
9 Carola Prosperi La conquista di Don Giovanni 1913 novella
10 R. Pantini La morte di Don Giovanni 1916 poema
11 Mario Pensuti La seconda vita di Don Giovanni 1924 novella
12 Mirto Jehnsch Don Giovanni 1932 romanzo
13 Lorenzo Giusso Don Giovanni ammalato 1932 poema
14 Alberto De Angelis Don Giovanni ovvero l'elogio della volubilità
1936 racconto
15 Filippo Nissolino Don Giovanni 1937 novella
16 Vitaliano Brancati Don Giovanni in Sicilia 1943 novella
17 Mario Soldati Don Juan's night of love sceneggiatura di Soldati, Novarese, Bassani, Frassineti
1952 film
18 Mauro Bolognini Il bell'Antonio sceneggiatura di Pasolini e Vissentini
1962 film
Quest'elenco può confermare quanto poco il tema abbia inte-ressato i Romantici italiani; potrebbe poi fornire indicazioni utili a definire meglio i caratteri del Don Giovanni novecente-sco.
149
PARTE QUARTA - BIBLIOGRAFIA
La situazione denunciata da Farinelli169 nel 1946 ("sono fiocca-te e fioccano tuttodì dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghil-terra e da altrove i lavori di erudizione intorno all'origine e allo sviluppo della leggenda del dottor Fausto; sul Don Giovanni invece, fratello di sangue del Fausto, la critica ha quasi sempre taciuto") oggi credo si possa considerare del tutto cambiata anche perché i lavori bibliografici sul tema hanno messo a disposizione un gran numero di titoli. In particolare il più volte citato libro di Armand E. Singer, The Don Juan theme, versions and criticism: a bibliography, scritto nel 1954 e aggiornato varie volte fino all'edizione che ho consultato risalente al 1965, presenta un panorama quasi completo dei testi e degli studi critici su Don Giovanni. Inutile sarebbe perciò stato ricopiare qui quanto agevolmente si può trovare nella citata bibliografia: per una bibliografia delle bibliografie si vedano perciò le pagine 15-20; per un re-pertorio delle opere italiane e straniere su Don Giovanni le pagine 29-191; per un elenco dei saggi critici sul tema le pagi-ne 312-351 e per saggi su singoli Autori le pagine 192- 311. Nella bibliografia quindi di questo lavoro indico solamente i libri che ho direttamente consultato.
169
Arturo Farinelli, op. cit. p. 15.
150
a. TESTI ITALIANI ESAMINATI
Giacinto Andrea Cicognini, Il convitato di pietra, in Giovanni Macchia, Vita, avventure e morte di Don Giovanni, "U-niversale Laterza" 48, Bari, Laterza, 1966, pp. 181-226
Anonimo, Il convitato di pietra, ib. pp. 149-163
Giuseppe Domenico Biancolelli, Il convitato di pietra (Le festin de Pierre), ib. pp. 165-176
Filippo Acciaiuoli, Il empio punito, ib. pp. 227-332
Giuseppe Domenico Biancolelli, Aggiunta al convitato di pietra (La suite du festin de Pierre), ib. pp. 177-179
Enrico Prendarca (Andrea Perrucci), Il convitato di pietra, ope-ra tragica ridotta in migliore forma e abbellita dal dot-tor Enrico Prendarca, in Napoli, a spese di Tomaso Aic-cardo, 1706
Anonimo, Il atheista fulminato, in Giovanni Macchia, op. cit., pp. 130,147
Anonimo, Il convitato di pietra, in Enzo Petraccone, La com-media dell'arte, storia, tecnica, scenari, Napoli, Ric-ciardi, 1927, pp. 428-437
Carlo Goldoni, Don Giovanni Tenorio, ossia il dissoluto, in Col-lezione completa delle commedie dell'avvocato Carlo Goldoni, Piacenza, dai torchj del Majno, vol. XXXIX, p. 177
Anonimo, Il convitato di pietra, dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel nobile teatro Tron di S. Cassiano nel carnovale dell'anno 1777, in Venezia, presso Gio. Bat-tista Casali
151
Filippo Livigni, Il convito, dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel teatro di Monza la fiera di S. Giovanni dell'anno 1782, in Milano, appresso Gio. Battista Bian-chi Regio stampatore
Lorenzo Da Ponte, Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni, in Tre libretti per Mozart, a cura di Paolo Lecaldano, "BUR" 963-967, Milano, Rizzoli, 1956, pp. 193-300
Giuseppe Bertati, Don Giovanni ossia il convitato di pietra, Milano, Gio. Battista Bianchi Regio stampatore, 1789
Giuseppe Foppa, Il nuovo convitato di pietra, dramma tragi-comico da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Sa-muele il carnovale dell'anno 1787, Venezia, appresso Modesto Fenzo
Francesco Cerlone, Il nuovo convitato di pietra, in Commedie di Francesco Cerlone napoletano, Bologna, 1789, vol. VI, pp. 167-244
Anonimo, Il convitato di pietra, farsa in un atto solo, in appen-dice a L'ultima che si perde è la speranza, farsa in un atto solo da recitarsi per musica nel nobilissimo teatro della nobildonna Tron veronese in S. Cassiano il carno-vale dell'anno 1792, in Venezia, appresso Modesto Fenzo
Giuseppe Foppa, Il convitato di pietra, ridotto in farsa, per musica del sig. Giuseppe Foppa da rappresentarsi nel nobilissimo teatro Venier in S. Benedetto il carnovale dell'anno 1802, in Venezia, per il Casali
Anonimo, Il convitato di pietra, dramma giocoso per musica in due atti da rappresentarsi nel Regio teatro di Cagliari nel carnovale dell'anno 1803, dalla Reale stamperia
Giovanni Casati, Don Giovanni di Maraña, ballo fantastico in cinque parti, di Giovanni Casati da rappresentarsi
152
nell'Imperial Regio Teatro alla Scala la primavera 1843, Milano, Pier Gaspare Truffi
Francesco Maria Piave, La forza del destino, musica di Giusep-pe Verdi, Milano, Ricordi, 1955
Girolamo Rovetta, La moglie di Don Giovanni, in Un volo dal nido. La moglie di Don Giovanni, Verona, H. F. Munster C. Kayser successore, 1877, pp. 73-166
Eugenio Rontini, Don Giovanni Tenorio ossia il gran convitato di pietra, con Stenterello procaccino amoroso, naufra-go sfortunato spaventato dalle fiamme infernali, commedia in quattro atti, Firenze, Salani, 1881
Anonimo, Il gran convitato di pietra, commedia in tre atti ad uso di almanacco per l'anno corrente, Milano, dalla stamperia Tamburini
Anonimo, il gran convitato di pietra, dramma tragico in tre atti ad uso de' piccoli teatrini, Milano, Tip. Giovanni Gus-soni editore
Compagnia Fiando-Colla, Don Giovanni il dissoluto ovvero il castigato impensato, con Famiola disgraziato in amo-re, in Roberto Leydi e Renata Mezzanotte, Marionette e burattini, Milano, "Collana del gallo grande", 1958, pp. 289-319
Achille Torelli, La duchessa Don Giovanni, in Teatro, Milano, Barbini, 1888, p. 54
Giuseppe Pagliara, Don Giovanni, Napoli, Ricciardi, 1911
Ettore Moschino, L'ombra di Don Giovanni, dramma lirico in tre atti e quattro quadri, Milano, Ricordi, 1914
Francesco Pastonchi, Don Giovanni in provincia, Milano, Fac-chi, 1920
153
Raffaele Calzini, Il debutto di Don Giovanni, in Il debutto. La fedeltà. La diva, Firenze, Bemporad, 1921, pp. 7-51
Alessandro Varaldo, Intermezzo: Don Giovanni si pente, in Donne, profumi e fiori, Milano, Sonzogno, 192, p. 97
Ugo Falena, Don Giovanni, dramma in tre atti, "Commedia" V, 21, 1/11/1923, p. 13-29
Felice Lattuada, Don Giovanni, tragedia in quattro atti di Artu-ro Rossato, Milano, Sonzogno, 1929
Carlo Veneziani, L'alba di Don Giovanni, pantomima di Carlo Veneziani, musica di Franco Casavola, Milano, Ricordi, 1932
Ettore Moschino, Don Juan de Mañara, riassunto in Teatro Reale dell'Opera, Don Juan de Mañara di Franco Alfa-no, XV stagione lirica, 1941-1942
Carlo Terron, La moglie di Don Giovanni, in Teatro, Bologna, Cappelli, 1961, pp. 77-129
Vincenzo Tieri, Don Giovanni ultimo, commedia in tre atti, "Teatro" II, 23, pp. 21-36
Vitaliano Brancati, Don Giovanni involontario, commedia in tre atti, "Sipario" IX, 103, novembre 1954, pp. 38-55
Alfredo Balducci, Don Giovanni al rogo, due tempi, "Il dram-ma" XLIII, 374-375, nov-dic 1967, pp. 11-131
154
b. TESTI STRANIERI ESAMINATI
Tirso de Molina, L'ingannatore di Siviglia e il convitato di pie-tra, traduzione di Antonio Gasparetti, Milano, Rizzoli, 1956
Molière, Don Juan, in Théâtre complet de Molière, texte établi avec préface, chronologie de la vie de Molière, biblio-graphie, notices, notes, relevé de variantes et lexique par Robert Jouanny, Paris, Editions Garnier Frères, 1960, vol. I, pp. 707-776
George Gordon Byron, Don Juan, in The poetical works of Lord Byron, London, Oxford University press, Humprey Mil-ford, 1928, pp. 625-840
Aleksàndr Puskin, Il convitato di pietra, in Opere, a cura di Ettore Lo Gatto, Milano, Mursia, 1977, pp. 1055-1084
Christian Dietrich Grabbe, Don Juan und Faust, in Scherz, Sa-tire, Ironie und Tiefere bedeutung, "Deutsche national Litteratur" 161, Berlin, 1884-1899, p. 139
José Zorilla y Moral, Don Juan Tenorio y El puñal del godo, Buenos Aires, Espansa-Campe, 1951
Charles Baudelaire, Don Juan aux enfers, in I fiori del male. I relitti. Supplementi ai fiori del male, a cura di Luigi De Nardis, con testo a fronte, "UE" 466, Milano, Feltrinel-li, 1965
George Bernard Shaw, Uomo e superuomo, in Le opere, tradu-zione di Paolo Ojetti, "I nobel", Torino, UTET, 1966, pp. 369-673
Jacinto Benavente, Don Juan, in Obras completas, Madrid, Aguilar, 1956, vol. I, p. 207
155
Henry de Montherlant, Don Juan, pièce en trois actes, Paris, Gallimard, 1958
Max Frisch, Don Giovanni o l'amore per la geometria, in Tea-tro, traduzione di Enrico Filippini, "I narratori" 12, Mi-lano, Feltrinelli, 1962
c. BIBLIOGRAFIE SPECIFICHE
Max Armand E. Singer, The Don Juan theme, versions and criti-cism: a bibliography, "West Virginia University bulletin, series 66, n. 6, 4 december 1965, Morgantown, West Virginia University, 1965
d. SAGGI CRITICI SUL TEMA
Stendhal, Les Cenci, in Chroniques italiennes, texte établi et présenté par Michel Crouzet, Paris, Librairie Armand Colin, 1960
Søren Kierkegaard, Il diario di un seduttore, traduzione di Luigi Redaelli, Torino, Bocca, 1921
Søren Kierkegaard, Don Giovanni, traduzione di K. M. Gul-dbrandeens e R. Cantono, Milano, M. A. Denti, 1944
Federico de Simone-Brouwer, Don Giovanni nella poesia e nell'arte, Napoli, Tipografia universitaria, 1894
156
Georges Gendarme de Bevotte, La légende de Don Juan. Son évolution dans la littérature des origines au roman-tisme, Paris, Hachette, 1906
Albert Camus, Carnets. Mai 1935 - Février 1942, Paris, Galli-mard, 1962, pp. 214-215
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, pp. 98-105
Arturo Farinelli, Don Giovanni, "Letterature moderne" 26, Milano, Bocca, 1946
Giovanni Macchia, Vita, avventure e morte di Don Giovanni, con tre scenari della commedia dell'arte, un'Opera re-gia e un dramma per musica, "Universale Laterza" 48, Bari, Laterza, 1966
e. SAGGI CRITICI SU SINGOLI AUTORI
1. Giacinto Andrea Cicognini
Georges Gendarme de Bevotte, Le festin de pierre avant Mo-lière, textes publiés avec introductions, lexique et notes par Georges Gendarme de Bevotte, Paris, Ha-chette, 1907, pp. 369-424
Arturo Farinelli, Un rimaneggiatore di drammi ispanici, "Italia e Spagna" II, 1929, pp. 410-416
Benedetto Croce, Intorno a Giacinto Andrea Cicognini e al convitato di pietra, in Aneddoti di varia letteratura, Napoli, Ricciardi, 1942, col. II, pp. 1-13
157
Anna Maria Crinò, Documenti inediti sulla vita e l'opera di Jacopo e Giacinto Andrea Cicognini, "Studi secente-schi" II, 1961, pp. 255-286
2. Onofrio Giliberto
Richard Mahrenholtz, Der verlorene Giliberto, "Zeitschrift für Französiche Sprache und Literatur" IV, parte II, 1882, pp. 275-277
Benedetto Croce, Intorno a Giacinto Andrea Cicognini e al convitato di pietra, in Aneddoti di varia letteratura, Napoli, Ricciardi, 1942, col. II, pp. 13-15
3. Domenico Biancolelli
Georges Gendarme de Bevotte, Le festin de pierre avant Mo-lière, textes publiés avec introductions, lexique et notes par Georges Gendarme de Bevotte, Paris, Ha-chette, 1907
Giannina Spellanzon, Lo scenario italiano "Il convitato di pie-tra", "Revista de filologìa española" XII, 1925, pp. 376-384
4. Giuseppe Calegari
Giovanni Salvioli, Il primo "Convitato di pietra" e il vero autore del libretto "Il flauto magico", "Gazzetta musicale di Milano" XLII, 1887, pp. 379-380
158
5. Lorenzo Da Ponte
Søren Kierkegaard, Don Giovanni, traduzione di K. M. Gul-dbrandeens e R. Cantoni, Milano, M. A. Denti, 1944
Maria Friedländer, Honored adventurer, "Opera news" VI, nov, 1942, pp. 20-25
Luigi Dalla Piccola, Appunti sulla scena della statua del Don Giovanni, "La rassegna musicale" XX, apr. 1959, pp. 107-115
Paolo Lecaldano, Introduzione e note a Lorenzo Da Ponte, Tre libretti per Mozart. Le nozze di Figaro. Don Giovanni. Così fan tutte, "BUR" 963-967, Milano, Rizzoli, 1956, pp. 5-35, 38-44, 472-500
6. Vincenzo Tieri
Achille Geremica, Don Giovanni ultimo, "Il dramma" XXVI, nov. 1950, p, 44
f. ENCICLOPEDIE
AA.VV., Enciclopedia dello spettacolo, Roma, Casa editrice Le maschere, 1954
AA.VV., Dizionario letterario Bompiani di tutti i tempi e di tutte le letterature, Milano, Bompiani, 1956
159
g. VARIE
Stendhal, La chartreuse de Parme, texte établi, avec introduc-tion, bibliographie, choronologie, notes et relevé par Henry Martineau, Paris, Editions Garnier Frères, 1961
Lev Tolstoi, Guerra e pace, traduzione di Agostino Villa, "I ca-polavori Sansoni" 21-23, Firenze, Sansoni, 1966
Pierre Drieu La Rochelle, Gilles, Paris, Gallimard, 1939
Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, "Biblioteca Sansoni" 14, Firenze, Sansoni, 1966
161
EPILOGO
Ma poi, nella mia vita, quanto è stato importante questa pri-ma prova di ricerca e quanto il personaggio che ho studiato? Ad ambedue le domanda la risposta è: per nulla. Quanto alla letteratura, non me ne sono più occupato, se non di quella teatrale e musicale, su cui ho molto letto e scritto qualcosa ad uso accademico (la tesina di abilitazione su Gram-sci critico teatrale), dei colleghi (corso di aggiornamento su Il teatro e l'Islam) e degli studenti (dispensine su Tre caravelle e un cacciaballe di Dario Fo, Il barbiere di Siviglia di Rossini, La scrittura teatrale, oltre che naturalmente sul Don Giovanni di Mozart); ho preferito occuparmi di storia, scienza ecc. Per il resto, non credo proprio che alcun aspetto della mia biografia possa essere spiegato da un condizionamento don-giovannesco: non sono stato un seduttore (nè di donne nè di qualunque altro pubblico), anzi ho sempre adottato un basso profilo a volte eccessivo. Debbo invece riconoscere di aver più volte, ancor più di recen-te, riflettuto sulla violenta intrusione nella scena sociale e politica contemporanea di personaggi di seduttori vanitosi e pronti a tutto: dai "tronisti" ed altri protagonisti delle crona-che, fino a Berlusconi (ma forse anche Renzi): quelli che vo-gliono piacere a tutti i costi, che pretendono di essere amati, che non sanno vergognarsi dell'essere superficiali e ignoranti perchè si vedono disinvolti e spontanei, che credono che tutti gli altri siano imbecilli da incantare con promesse mirabolanti, che ostentano denaro e potere... Adesso come allora simili tipi, comunque volgari, possono godere di grande successo,
162
salvo che poi, inevitabilmente, come racconta Leporello "tra fumo e fuoco / giusto là il diavolo / se 'l trangugiò"170. La punizione allora era divina e quindi prestabilita e inevitabile in aeterno; quella di oggi è mediatica ma anch'essa non può essere sfuggita perchè la popolarità ha una data di scadenza come gli altri prodotti di consumo. La pena era l'Inferno, oggi l'oblio, che per loro deve essere anche peggio. Quello che è andato perso è quindi solo la ribellione all'ordine; provo fastidio nei confronti di gran parte di quelli che manife-stano la loro protesta, non per il fatto in sè naturalmente, ma perchè mi pare cerchino un pubblico utilizzando parole fru-stre, usurate dalla storia, banali e prive di senso, quando non cucite su misura dei loro interessi: non sono capaci di comin-ciare da se stessi, dal non piegarsi a quello che non gli va at-traverso comportamenti personali coerenti e rischiosi, senza cercare approvazione e un seguito? Almeno il mio Don Gio-vanni lo faceva, da vero snob, e quindi mi sta molto più simpa-tico. Ma ancor di più sono fioriti negli ultimi vent'anni i servi di commedia, peraltro privi della consapevolezza di Leporello che fin dall'inizio dichiarava "Voglio fare il gentiluomo / e non voglio più servir"171: quelli dell'era berlusconiana erano per lo più ridicoli, sciocchi e quindi al fondo quasi simpatici, quelli di oggi hanno perso in facezia e ostentano serietà, ma sono pap-pagalli che ripetono i versetti del mantra del giorno; in tutto ciò si rivela l'innata abilità italiana (ma è poi anche universale) al servaggio. Se questi tipi mi appaiono privi del bene dell'in-telletto, sono indulgente, se sospetto che siano dei furbi che consapevolmente tutelano le loro paghe
172 mi ripugnano.
170
Lorenzo Da Ponte, Don Giovanni, II, 18. 171
ib., I, 1. 172
"Ah, mes gages!" dice Sganarelle in Molière, Don Juan, V, 5.
163
Non spendo una parola sui costumi sessuali: da 50 anni tutto è cambiato radicalmente (ed è stata l'unica vera rivoluzione), quei tipi di donna sono scomparsi e con loro quindi parole come sedotta, matrimonio riparatore ecc.; è rimasta la violen-za, ma Don Giovanni (quello "classico") non vi fece mai ricor-so: degno di rispetto anche per questo. Bene, adesso posso rimettere la mia tesi là dove giaceva da 50 anni: e buonanotte.