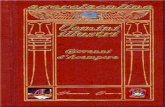Tra reliquia e teorema: l'oggetto prospettico all'epoca di Giovanni Bellini
IL CAPITOLO 20 DEL VANGELO DI GIOVANNI
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of IL CAPITOLO 20 DEL VANGELO DI GIOVANNI
Seminario Vescovile Diocesano Maria Immacolata – Brescia
SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI
Tesi di Diploma
IL CAPITOLO 20 DEL VANGELO DI GIOVANNI
Candidato: Arturo TONINELLI
Relatore: Prof. Don Flavio DALLA VECCHIA
Anno Accademico 2010 - 2011
Indice generale
INTRODUZIONE...........................................................................................................................2
IL CAPITOLO 20 DEL VANGELO DI GIOVANNI......................................................................4
Critica testuale........................................................................................................................4
Il testo............................................................................................................................4
Giovanni, capitolo 20 ...................................................................................................4
Struttura letteraria...................................................................................................................7
Analisi esegetica: interpretazione, passi paralleli, tradizione e contemporaneità................12
GESÙ DI NAZARET VISTO DAI DISCEPOLI..........................................................................28
Yehoshua ben Yosef..............................................................................................................28
Gesù, il Cristo, Figlio di Dio................................................................................................30
BIBLIOGRAFIA...........................................................................................................................34
2
INTRODUZIONE
“La cristologia moderna va interpretata come il tentativo di invertire l'inversione, tornando agli
inizi: rifare «il cammino degli apostoli›› (E. Schillebeeckx). E' necessario fare cristologia “dal
basso", in senso radicale: recuperare l'umanità e da qui raggiungere il significato della divinità.
Impresa difficile, come ha mostrato A. Schweitzer; e rischiosa, come mostrano sino ad oggi sia gli
errori che le condanne. Però necessaria, possibile e feconda, come mostrano le magnifiche
cristologie attuali aperte e incomplete, ma indubbiamente le migliori della storia cristiana.” (A.T.
Queiruga, pag.45, Concilium 3/2008).
Il capitolo 20 del vangelo di Giovanni contiene un versetto che è difficile dire cosa significhi (G.
Segalla, pag. 463, 2008):
17 Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei
fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro››.
“Non mi trattenere” è il modo con cui noi oggi traduciamo l'espressione greca mē mou aptou (La
Sacra Bibbia, CEI-UELCI, 2008). Il verbo haptō, che alla forma media significa “legare a sé,
attaccarsi, aderire, toccare, afferrare, attaccare” ricorre solo qui nel quarto vangelo (Santi Grasso
2008, pag. 765). Dipendendo dalla traduzione, l'ordine di Gesù può essere reso in vari modi: “non
mi toccare”, “non mi trattenere”, “non continuare a toccarmi”, con significati che possono avere una
diversa espressione.
Nel nostro tempo molte donne e uomini hanno creduto e credono nell'uomo Gesù di Nazaret. Lo
considerano un maestro di virtù, che ha portato un messaggio etico agli uomini del suo tempo.
Semplicemente un uomo. Maria di Magdala ha riconosciuto in questo modo il suo “Rabbunì”, il
maestro che ha seguito lungo le strade della Palestina, che ha assistito nella sua sofferenza e morte
in croce. Grande è la sua gioia di vederlo di nuovo accanto a lei. Ma Lui le dice di non
toccarlo/trattenerlo ... lì c'è più di un uomo.
Scopo del presente lavoro è quello di fare un'indagine storica delle traduzioni e dei commenti di
questo passo, prendendo in esame il versetto, il contesto nel quale si svolge l'azione e i passi
paralleli dei vangeli sinottici, con l'obiettivo di capire come la prima comunità dei discepoli sia
passata da Gesù di Nazaret a Cristo, Figlio di Dio. Sia passata dal peregrinare con un “uomo” che
3
parlava con autorità, che poteva essere toccato, alla speranza nel ritorno del Figlio del Dio vivente
che, quando è asceso, ha lasciato per noi e con noi il Suo Spirito.
Come è stato possibile che un gruppo di donne e uomini discepoli di un uomo abbiano visto in lui la
divinità?
4
IL CAPITOLO 20 DEL VANGELO DI GIOVANNI
Critica testuale
Il testo
Il testo greco del Vangelo di Giovanni risulta dal confronto con i manoscritti del IV – V secolo. I
principali testimoni del testo sono il Codex Vaticanus (B), il Codex Sinaiticus (01) e il Codex Bezae
(D). Il Vaticanus presenta una tradizione testuale “orientale”, popolare in Egitto, specialmente ad
Alessandria, mentre il Bezae rappresenta una tradizione “occidentale” che si trova anche nelle
prime traduzioni in latino (Vetus latina) e siriache. Il Sinaiticus ha caratteristiche simili al Vaticanus,
mentre per i primi sette capitoli è simile al Bezae.
Il testo di questi manoscritti va anche valutato confrontando le prime traduzioni latine, siriache,
copte ed etiopiche. Le citazioni di Giovanni fatte dai Padri della chiesa sono un utile confronto.
Soprattutto Boismard ha sviluppato, nell'analisi testuale di Giovanni, un confronto con le citazioni
dei Padri per ricavarne lezioni più primitive.
A metà dello scorso secolo sono stati ritrovati in Egitto una serie di papiri (Collezione Bodmer),
alcuni di questi contengono frammenti del Primo e il Nuovo Testamento. In particolare i manoscritti
nominati P66 (Bodmer II) e il P75 (Bodmer XV) contengono il Vangelo di Giovanni e sono databili
all'anno 200 circa.
Giovanni, capitolo 20
1τη δε μια των σαββατων μαρια η μαγδαληνη
ερχεται πρωι σκοτιας ετι ουσης εις το μνημειον
και βλεπει τον λιθον ηρμενον εκ του μνημειου.
1Il primo giorno della settimana, Maria
Maddalena viene di buon mattino al sepolcro,
mentre era ancora buio e vede la pietra rimossa
dal sepolcro.2τρεχει ουν και ερχεται προς σιμωνα πετρον και
προς τον αλλον μαθητην ον εφιλει ο ιησους και
λεγει αυτοις ηραν τον κυριον εκ του μνημειου
και ουκ οιδαμεν που εθηκαν αυτον
2Corre allora e va da Simone Pietro e dall'altro
discepolo che Gesù amava e gli dice: «Hanno
portato via il Signore e non sappiamo dove
l'abbiano posto».3εξηλθεν ουν ο πετρος και ο αλλος μαθητης και
ηρχοντο εις το μνημειον
3Partì dunque Pietro e anche l'altro discepolo, e
si avviarono verso il sepolcro.4ετρεχον δε οι δυο ομου και ο αλλος μαθητης
προεδραμεν ταχιον του πετρου και ηλθεν
πρωτος εις το μνημειον
4Correvano ambedue insieme; ma l'altro
discepolo precedette Pietro nella corsa e arrivò
primo al sepolcro.
5
5και παρακυψας βλεπει κειμενα τα οθονια ου
μεντοι εισηλθεν
5Chinatosi, vide le bende che giacevano distese;
tuttavia non entrò.6ερχεται ουν και σιμων πετρος ακολουθων αυτω
και εισηλθεν εις το μνημειον και θεωρει τα
οθονια κειμενα
6Arriva poi anche Simon Pietro che lo seguiva,
ed entrò nel sepolcro; e vide le bende che
giacevano distese7και το σουδαριον ο ην επι της κεφαλης αυτου
ου μετα των οθονιων κειμενον αλλα χωρις
εντετυλιγμενον εις ενα τοπον
7e il sudario che era sopra il capo; esso non
stava assieme alle bende, ma a parte ripiegato
in un angolo.8τοτε ουν εισηλθεν και ο αλλος μαθητης ο ελθων
πρωτος εις το μνημειον και ειδεν και επιστευσεν
8Allora entrò anche l'altro discepolo, che era
arrivato per primo al sepolcro, e vide e credette.9ουδεπω γαρ ηδεισαν την γραφην οτι δει αυτον
εκ νεκρων αναστηναι
9Non avevano infatti ancora capito la scrittura:
che egli doveva resuscitare dai morti.10απηλθον ουν παλιν προς αυτους οι μαθηται 10I discepoli poi ritornarono a casa.11μαρια δε ειστηκει προς τω μνημειω εξω
κλαιουσα ως ουν εκλαιεν παρεκυψεν εις το
μνημειον
11Maria invece era rimasta presso il sepolcro,
fuori, in pianto. E, mentre piangeva, si chinò
verso il sepolcro,12και θεωρει δυο αγγελους εν λευκοις
καθεζομενους ενα προς τη κεφαλη και ενα προς
τοις ποσιν οπου εκειτο το σωμα του ιησου
12e vide due angeli biancovestiti, seduti, uno in
corrispondenza del capo e l'altro dei piedi, dove
era stato posto il corpo di Gesù.13και λεγουσιν αυτη εκεινοι γυναι τι κλαιεις
λεγει αυτοις οτι ηραν τον κυριον μου και ουκ
οιδα που εθηκαν αυτον
13Essi le dicono:«Donna, perché piangi?».
Risponde loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'abbiano posto».14ταυτα ειπουσα εστραφη εις τα οπισω και
θεωρει τον ιησουν εστωτα και ουκ ηδει οτι
ιησους εστιν
14Detto ciò, si voltò indietro e vide Gesù che
stava lì, ma non sapeva che era Gesù.
15λεγει αυτη ιησους γυναι τι κλαιεις τινα ζητεις
εκεινη δοκουσα οτι ο κηπουρος εστιν λεγει
αυτω κυριε ει συ εβαστασας αυτον ειπε μοι που
εθηκας αυτον καγω αυτον αρω
15Le dice:«Donna, perché piangi? Chi cerchi?».
Quella, pensando che fosse l'ortolano, gli dice:
«Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo
hai posto, e io lo andrò a prendere».16λεγει αυτη ιησους μαριαμ στραφεισα εκεινη
λεγει αυτω εβραιστι ραββουνι ο λεγεται
διδασκαλε
16Le dice Gesù: «Maria!». Quella, voltatasi, gli
dice in ebraico: «Rabbunì!» (che significa
maestro)17λεγει αυτη ιησους μη μου απτου ουπω γαρ
αναβεβηκα προς τον πατερα πορευου δε προς
τους αδελφους μου και ειπε αυτοις αναβαινω
προς τον πατερα μου και πατερα υμων και θεον
17Le dice Gesù: «Non mi trattenere, perché non
sono ancora salito al Padre. Va' piuttosto dai
fratelli e di' loro: – Salgo al Padre mio e Padre
vostro e al Dio mio e Dio vostro – ».
6
μου και θεον υμων18ερχεται μαριαμ η μαγδαληνη αγγελλουσα τοις
μαθηταις οτι εωρακα τον κυριον και ταυτα ειπεν
αυτη
18Maria Maddalena va ad annunciare ai
discepoli: «Ho visto il Signore», e quanto le
aveva detto.19ουσης ουν οψιας τη ημερα εκεινη τη μια
σαββατων και των θυρων κεκλεισμενων οπου
ησαν οι μαθηται δια τον φοβον των ιουδαιων
ηλθεν ο ιησους και εστη εις το μεσον και λεγει
αυτοις ειρηνη υμιν
19La sera di quello stesso giorno, il primo della
settimana, mentre le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per paura dei giudei erano
chiuse, venne Gesù e stette in mezzo a loro e
dice loro: «Pace a voi!».20και τουτο ειπων εδειξεν τας χειρας και την
πλευραν αυτοις εχαρησαν ουν οι μαθηται
ιδοντες τον κυριον
20E, detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
Si rallegrarono i discepoli, vedendo il Signore.
21ειπεν ουν αυτοις [ο ιησους] παλιν ειρηνη υμιν
καθως απεσταλκεν με ο πατηρ καγω πεμπω
υμας
21Poi disse di nuovo: «Pace a voi! Come il
Padre ha mandato me io mando voi».
22και τουτο ειπων ενεφυσησεν και λεγει αυτοις
λαβετε πνευμα αγιον
22E detto ciò, soffiò su di loro e dice loro:
«Ricevete lo Spirito Santo: 23αν τινων αφητε τας αμαρτιας αφεωνται αυτοις
αν τινων κρατητε κεκρατηνται
23a chi rimettete i peccati, sono loro rimessi; a
chi li ritenete, sono ritenuti».24θωμας δε εις εκ των δωδεκα ο λεγομενος
διδυμος ουκ ην μετ αυτων οτε ηλθεν ιησους
24Tommaso, uno dei dodici (quello chiamato
«Didimo» = «Gemello») non era con loro
quando venne Gesù.25ελεγον ουν αυτω οι αλλοι μαθηται εωρακαμεν
τον κυριον ο δε ειπεν αυτοις εαν μη ιδω εν ταις
χερσιν αυτου τον τυπον των ηλων και βαλω τον
δακτυλον μου εις τον τυπον των ηλων και βαλω
μου την χειρα εις την πλευραν αυτου ου μη
πιστευσω
25Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli rispose loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non
metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non
metto la mia mano nel suo fianco, non crederò
affatto».26και μεθ ημερας οκτω παλιν ησαν εσω οι
μαθηται αυτου και θωμας μετ αυτων ερχεται ο
ιησους των θυρων κεκλεισμενων και εστη εις το
μεσον και ειπεν ειρηνη υμιν
26E, otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di
nuovo in casa e Tommaso stava con loro. Viene
Gesù a porte chiuse e stette in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!» 27ειτα λεγει τω θωμα φερε τον δακτυλον σου
ωδε και ιδε τας χειρας μου και φερε την χειρα
σου και βαλε εις την πλευραν μου και μη γινου
27Poi dice a Tommaso: «Metti il tuo dito qui e
guarda le mie mani, e porgi la tua mano e
mettila nel mio fianco, e non essere più
7
απιστος αλλα πιστος incredulo, ma credente».28απεκριθη θωμας και ειπεν αυτω ο κυριος μου
και ο θεος μου
28Rispose Tommaso e gli disse: «Signore mio e
Dio mio!».29λεγει αυτω ο ιησους οτι εωρακας με
πεπιστευκας μακαριοι οι μη ιδοντες και
πιστευσαντες
29Gli dice Gesù: «Perché mi hai visto hai
creduto? Beati coloro che hanno creduto senza
vedere!».30πολλα μεν ουν και αλλα σημεια εποιησεν ο
ιησους ενωπιον των μαθητων [αυτου] α ουκ
εστιν γεγραμμενα εν τω βιβλιω τουτω
30Gesù in presenza dei [suoi] discepoli fece
naturalmente molti altri segni che non sono
scritti in questo libro.31ταυτα δε γεγραπται ινα πιστευ[ς]ητε οτι ιησους
εστιν ο χριστος ο υιος του θεου και ινα
πιστευοντες ζωην εχητε εν τω ονοματι αυτου
31Questi sono stati scritti affinché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e, credendo,
abbiate la vita nel suo nome.
Struttura letteraria
Il capitolo 20 tratta del periodo successivo alla «risurrezione», di come Maria Maddalena scopre la
tomba vuota, corre a chiamare i discepoli, del sopralluogo di Pietro e del discepolo prediletto,
dell'incontro di Maria con Gesù e dell'apparizione di Gesù ai discepoli riuniti nel cenacolo. Questo
racconto è preceduto da quello della Passione, molto più lungo e continuo nella successione
fattuale, ed è seguito da Gesù risorto che appare ai discepoli presso il mare di Tiberiade.
Sebbene la maggior parte degli studiosi ritenga di dover mantenere distinti questi due ultimi
capitoli, considerando il capitolo 21 un'aggiunta del redattore finale, è stato proposto1 di leggere
Giovanni 20-21 sincronicamente, con un occhio verso l'unità e la coerenza di questa parte del
Vangelo.
Il capitolo 20 può essere suddiviso in due unità maggiori, a loro volta suddivise in due sotto sezioni
e da un epilogo. La prima sezione si svolge nell'orto di proprietà di Giuseppe d'Arimatea, presso il
sepolcro (Gv 20, 1-18), mentre la seconda all'interno del luogo dove erano radunati i discepoli (Gv
20, 19-29); l'epilogo finale è un commento dell'Autore, che fa da conclusione al capitolo (Gv 20,
30-31). Entrambe le sezioni iniziano con un indicazione temporale (v. 1 e 19): «Il primo giorno
della settimana» e ognuna può essere suddivisa in due episodi con un intermezzo (v. 9 e 24).
Il primo episodio di ciascuna scena riguarda i discepoli e come raggiungono la fede. Il secondo
1 GEORGE L.D., Reading the Tapestry, in cui vuole leggere l'arazzo finemente tessuto sul "fronte" piuttosto che mettere a fuoco il groviglio della storia sul suo lato posteriore. George distingue il suo lavoro da quelli destinati alla storia della composizione (ad esempio, Bultman, Marrone, Barrett, e Schnackenburg). Il suo metodo è un approccio letterario-retorico che si concentra sul ruolo del lettore implicito. Oltre a dimostrare l'unità dei capitoli 20-21, George è interessato ad analizzare la strategia retorica della narrazione, in particolare come il capitolo 21 apra ulteriori possibilità interpretative per il lettore implicito. Vedi anche WAETJEN H.C., The Gospel of the Beloved Disciple: a work in two editions, p.8-9
8
episodio ha come fatto principale l'apparizione di Gesù ad una persona, prima a Maria Maddalena,
poi a Tommaso. In questi episodi fondamentale è il modo con cui viene descritto il riconoscimento
di Gesù da parte dell'interessato. Successivamente questo riconoscimento è riportato ad un uditorio
più ampio: Maria corre a riferirlo a Pietro e al Discepolo prediletto da una parte, e poi, Gesù si
rivolge prima a Tommaso e in seguito alla massa di coloro che crederanno senza aver visto.
L'unità complessiva, se ad un primo sguardo può sembrare scorrevole, mostra alcune tensioni e
fratture nel tessuto narrativo che sollevano problemi nell'unità narrativa del testo. In particolare la
prima sezione (20,1-18) mostra un numero eccezionale di incongruenze, che rivelano la mano di un
redattore che ha ottenuto l'organizzazione combinando tra loro materiali eterogenei. Seguiamo
Brown2 nel sottolineare le seguenti difficoltà:
• La Maddalena si reca al sepolcro da sola al v. 1, ma dice «noi» al v.2.
• Ella conclude che il corpo è stato trafugato al v. 2, ma sembra che non guardi dentro il
sepolcro fino al v. 11.
• Vi è un duplicato della della descrizione di Pietro e del Discepolo prediletto:
− due frasi di moto a luogo nel v. 2
− letteralmente: «Pietro uscì ... ed essi stavano andando» al v. 3.
− la ripetizione di ciò che fu visto ai vv. 5 e 6 ma con due verbi diversi per
“vede”.
− la contraddizione fra «egli vide e credette» al v. 8 ed «essi non avevano
compreso» al v. 9.
• La fede del Discepolo prediletto non ha alcun effetto sulla Maddalena né sui
discepoli in genere (v. 19).
• Non è chiaro quando e come la Maddalena sia tornata al sepolcro (v. 11).
• Perché, al v. 12, ella vede nel sepolcro degli angeli, mentre Pietro e il Discepolo
prediletto videro gli abiti funebri?
• Il suo dialogo con gli angeli, al v. 13, non fa progredire affatto l'azione.
• Ella si volge verso Gesù due volte (vv. 14 e 16).
La seconda sezione racconta di due apparizioni ai discepoli riuniti in un luogo a porte chiuse.
L'intervallo temporale tra le due apparizioni di Gesù è di una settimana. Le due sequenze mostrano,
a prima vista, una narrazione più coerente, rispetto a quelle presso il sepolcro. Ma anche in queste si
può scorgere una disunione:
2 BROWN R. E., Giovanni, pp. 1250-1251.
9
• La scena di Tommaso sembra introdotta troppo bruscamente, nel primo incontro non
era stato detto della sua assenza.
• Forse Tommaso non ha ricevuto i doni dello Spirito e l'autorizzazione a rimettere e
trattenere i peccati (vv. 22-23)?
• Tommaso non crede a quanto dicono i discepoli, ma formula la dichiarazione di
credere riprendendo i particolari della scena precedente. Gesù mostra le mani e il
fianco ai discepoli per farsi riconoscere (v. 20).
• Nell'incontro successivo, Gesù ripete le parole dette da Tommaso la settimana
precedente.
• Gesù invita Tommaso a: «... non essere più incredulo, ma credente.», che pare essere
un rimprovero a chi vuole constatare per credere. Ma Gesù non aveva mostrato le
mani e il fianco anche nella prima apparizione? Perché allora rimprovera solo
Tommaso?
• La beatitudine (v. 29) rivolta a «coloro che hanno creduto senza vedere!» privilegia
un gruppo particolare di discepoli?
• Come intendere allora il rapporto tra «i molti altri segni» del v. 30 e la beatitudine
della fede senza vedere?
I due racconti delle apparizioni non erano originariamente uniti alla narrazione delle visite al
sepolcro, perciò non meraviglia che i versetti da 19 a 23 fossero indipendenti da 20,1-18.
Nonostante il tentativo fatto al v. 19 «La sera di quello stesso giorno», per cucire insieme le due
narrazioni, il racconto dell'apparizione ai discepoli potrebbe seguire direttamente il racconto della
passione. Se il discepolo prediletto credette sulla base di quanto aveva visto nel sepolcro vuoto (v.
8), di questa sua fede non si scorge traccia quando i discepoli si rintanano dietro le porte sbarrate (v.
19). Né la fede della Maddalena ha minimamente toccato il gruppo, malgrado il messaggio da lei
portato (v. 18).
L'unità letteraria del testo è stata messa in discussione da diversi autori. Alcuni spiegano le
incoerenze ricorrendo all'ipotesi della redazione in più fasi o redazioni multiple3, altri sostengono
che il quarto Vangelo sia la combinazione di diverse fonti indipendenti.
3 BROWN R. E., Giovanni, pp. XLIII-L: l'Autore ipotizza 5 stadi nella composizione del vangelo. Un primo stadio in cui esisteva un corpo di materiale tradizionale con le parole e le opere di Gesù, materiale simile a quello dei vangeli sinottici. Nel secondo stadio vediamo lo sviluppo di questo materiale negli schemi giovannei, stadio caratterizzato da selezione, ripresa, modellamento, durato forse alcuni decenni. Nello stadio 3, l’organizzazione di questo materiale proveniente dallo stadio 2 viene redatta nella prima edizione del Vangelo, sembrerebbe logico ad opera dell'evangelista. Lo stadio 4 sarebbe la seconda edizione, sempre ad opera dell'evangelista. Infine, lo stadio 5, l’edizione finale o redazione da parte di qualcuno che non è l'evangelista, ma che Brown chiama il redattore.
10
Fabris4 ci propone una pista per la comprensione dei problemi, fa un'analisi del testo a partire dalla
sua collocazione lessicale e semantica. Fin dalle prime righe del racconto la narrazione è
caratterizzata dal movimento, che conferisce una certa dinamicità alla scena. Maria “viene” al
sepolcro, “corre” e “va” dai discepoli. Pietro “partì” e anche l'altro discepolo si “avviarono”, poi
“correvano”, ma l'altro lo precedette e “arrivò” prima di lui. Constatata la mancanza del corpo di
Gesù la scena rallenta, i discepoli se ne “ritornarono” a casa e la dinamicità si spegne (vv. 1-10).
La concentrazione del verbo èrchesthai e dei suoi composti è impressionante in questi primi versetti
del capitolo 20: èrchesthai, sei volte; eisèrchesthai, tre volte; exèrchesthai e apèrchesthai,
rispettivamente una volta. Questo dinamismo è accentuato dalla presenza del verbo trèchein,
“correre” (vv. 20,2.4) e dal composto protrèchein “correre più velocemente” (v. 20,4b),
accompagnato dall'avverbio dello stesso campo semantico: tàchion, “più veloce” (v. 20,4). Il
movimento è diretto verso il sepolcro, che è sempre al centro della scena: il vocabolo mnēmèion
“sepolcro” si ripete sette volte nei vv. 20,1-10 e compare anche nel successivo per ben due volte (v.
20,11). In questa area semantica ritroviamo altri vocaboli, pietra (v. 20,1), bende e sudario (vv.
20,5.6.7).
Altro campo semantico che emerge è quello visivo, con l'uso di diversi vocaboli per esprimere il
verbo vedere, ma tutti con un diverso significato. Il primo verbo che incontriamo è blèpein: la
Maddalena vede la pietra rimossa dal sepolcro (v. 20,1) e il Discepolo prediletto vede le bende nel
sepolcro (v. 20,5). Segue theōrèin, Simon Pietro entrò nel sepolcro e vide le bende (v. 20,6), al v. 12
Maria Maddalena vide due angeli e al v. 14, Gesù. Giovanni usa anche horàn (v. 20,8) e altre cinque
volte nei vv. 18.20.25.27.29. Quattro volte ritroviamo il verbo “vedere” associato a “credere”, come
nel v. 8: «allora entrò anche l'altro discepolo ... vide e credette.» Quest'ultimo verbo “credette”
ricorre altre due volte nel capitolo. Se si tiene conto anche dei due vocaboli hapaxlegòmena
giovannei pistos e àpistos (20,29c), questo campo semantico del “credere”, si estende quanto quello
del “vedere”.
Si può pensare che l'evangelista abbia voluto dare un preciso significato per ognuno di questi verbi,
oppure si può trattare di un uso poetico dei sinonimi del verbo vedere con un solo significato.
Phillips5 pensa che ciascun verbo abbia un suo particolare significato, iniziando dalla forma più
materiale del vedere e procedendo verso la più elevata forma del vedere come intuizione. Egli
ordinerebbe i verbi nel seguente modo crescente: blèpein, theōrèin, horàn, quest'ultimo
accompagnato dal verbo “credere”, il verbo che esprime il pieno apprezzamento della verità reale
celeste.
4 FABRIS R., Giovanni, pp. 1010-1012.5 PHILLIPS G. L., Faith and Vision in the Fourth Gospel, in Study in the four Gospel, p. 83.
11
L'autore inizia la sua analisi con blèpein, che è il modo di vedere ordinario, mera visione oculare.
La Maddalena vede la pietra rimossa dal sepolcro, il Discepolo prediletto le bende distese. Giovanni
non utilizza più questo verbo nel resto del capitolo. È il modo più appropriato per vedere quello che
c'è da vedere, senza nessun bisogno di andare oltre. Blèpein è perfettamente adeguato alla visione
della realtà quotidiana della vita, è il modo di vedere un normale sepolcro dopo che il cadavere è
stato trafugato.
Secondo Brown6 in Gv 9,39 assume una dimensione spirituale: «...perché coloro che non vedono ci
vedano», forse il verbo potrebbe essere stato scelto per il contrasto con il suo uso in tutto il resto del
capitolo per indicare la vista fisica. Altra eccezione in 5,19 dove blèpein acquista un significato
molto più elevato di visione, la visione del Figlio di ciò che fa il Padre.
Al secondo grado di visione, pone theōrèin, con il significato di osservare, guardare attentamente. È
un vedere che richiede più tempo e concentrazione, ma non è ancora un vedere pieno. Pietro vede
le bende (v. 20,6), Maria Maddalena vede gli angeli (v. 20,12) e Gesù “giardiniere” al v. 14, ma non
lo riconosce, la comprensione non è piena.
In Gv 2,23-25 e 6,2 molti vedono i segni che facevano credere in Lui, ma Gesù diffida di questa
“fede”. Anche la Samaritana (4,19) vede che Gesù è un profeta, ma non va oltre. La visione di un
prodigio di Gesù, dove cammina sull'acqua (6,19), sembra confermare questo valore semantico.
Di contro altri passi mostrano che l'evangelista usa theōrèin per una visione più profonda e
intellettiva (6,40), dove promette la vita eterna a chi vede il Figlio e crede in Lui. In 17,24 prega il
Padre perché i credenti possano contemplare la Sua gloria futura pervenuta dopo la morte e
risurrezione. In entrambi i casi si tratta di una visione dell'intelletto, uno sguardo che va oltre la
percezione del mondo. Pietro e la Maddalena vedono le bende, gli angeli o Lui stesso, ma questa
visione richiede uno sforzo ulteriore che va oltre la vista percettiva, come poi accadrà a Maria in
20,16.
Infine, propone la traduzione di horàn, insieme con idein, con percepire, in cui è prevista
un'intelligenza intuitiva. Questi verbi vengono usati quando si vede Gesù risorto e il risultato è la
fede (vv. 20,8.18.25).
A favore si può citare l'affermazione di Gesù durante l'ultima cena (16,16): «un poco e non mi
vedrete [theōrèin] più; ancora un poco e mi vedrete [horàn]». Altri esempi possono essere trovati in
1,50.51; 3,11.32; 11,40; 14,7.9; 19,35.37;20,29.
Vi sono invece casi in cui horàn indica la vista materiale, senza nessuna percezione. In Gv 4,45
viene usato per indicare la vista dei miracoli operati da Gesù come taumaturgo e il risultato non è la
6 BROWN R. E., Giovanni, p. 1442.
12
fede. Ancora, nonostante la visione di Gesù (v. 6,36), la gente ancora non crede. In quattro casi, nel
capitolo 20, il verbo horàn è associato a pistèuein «credere» (vv. 20,8.25.27.29), non può che
significare il più pieno incontro relazionale con chi è stato visto.
Nel secondo episodio l'oggetto del vedere è il corpo di Gesù che mostra le mani e il fianco: mani è
ripetuto cinque volte (vv. 20,20.25.27) e fianco tre volte (vv. 20,20.25.27). Come se l'evangelista
volesse accentuare la corporeità di Gesù risorto, in modo particolare il versetto 27: «Metti il tuo dito
qui e guarda le mie mani, e porgi la tua mano e mettila nel mio fianco». Ma è un rimarcare diverso
dal primo episodio, dove si voleva sottolineare la mancanza di un “cadavere”, ponendo l'accento su
sepolcro, bende e sudario (vedi sopra), ora si dà enfasi alla realtà del corpo di Gesù risorto.
Analisi esegetica: interpretazione, passi paralleli, tradizione e contemporaneità
v. 1. Il primo giorno della settimana. Questa espressione, mia sabbatōn, ripetuta anche al versetto
19, usa un numero cardinale come ordinale. Questo modo è un semitismo (ebraico – aramaico) e
dovrebbe essere tradotto come “nel primo dei sabati”. Sabbatōn in greco significa sia “settimana”
che “sabato”, in ebraico non ha il significato di settimana, ma solo di sabato7, sebbene più tardi
acquisisca questa accezione. Esprime un modo già affermato di indicare il giorno della
celebrazione eucaristica. Non si usa l'espressione kerygmatica “il terzo giorno”, ma primo giorno
della settimana, domenica, giorno dell'assemblea liturgica. Ricorre con piccole varianti nei quattro
vangeli: Giovanni, Luca 24,1 e Matteo 28,1 usano la stessa espressione, mentre Marco 16,9 usa
prōtē sabbatōn.
– Maria Maddalena. Maddalena è il soprannome dovuto al suo luogo di origine, Migdal (Magdala),
un villaggio sulla sponda occidentale del lago di Tiberiade8. Maria Maddalena è sola, ma nel v. 2
afferma: «non sappiamo». La forma plurale potrebbe essere un residuo del testo delle fonti. Questo
è avvalorato dal fatto che nei sinottici Maria Maddalena scopre il sepolcro vuoto insieme all'altra
Maria (Mt 28,1), in Mc 16,1 è con Maria, madre di Giacomo e Salomé e con un gruppo di donne in
Lc 23,55.
La Vetus Syriaca, manoscritto sinaitico, omette “Maddalena” lasciando solo una Maria non
identificabile9. La tradizione siriaca dei Padri della chiesa riconosce in questa Maria la madre di
Gesù. Questa ipotesi mariologica è attestata nel commento di Efrem al Diatessaron, 21, 27, ma
7 NICHOL F. D., Answers to objections, pp. 236-241. 8 BAGATTI B., Antichi villaggi cristiani di Galilea, p. 80: “essa sarebbe stata distrutta a causa dell'immoralità dei suoi
abitanti”. Il nome semitico «Migdal nunaja» (Torre dei pesci) o greco «Tarichea» (Pesce salato), rimanda alla principale attività cittadina, favorita dalla superba posizione sulla sponda occidentale del Lago di Tiberiade. Stando alle informazioni degli storici antichi era il più florido agglomerato urbano nella valle di Genezaret (cf. Mt 14,34; Mc 5,35). Fondata nel tardo periodo ellenistico, la città cadde durante la Prima rivolta anti-romana (65 d.C.) dopo l’assedio via mare capeggiato del generale Tito (cf. Giuseppe Flavio, Guerra giudaica, 3,10,3), dove persero la vita 6.000 rivoltosi.
9 BROWN R. E., Giovanni, p. 1228.
13
accoglie pochi consensi10.
Un'altra ipotesi la identifica con Maria di Betania sorella di Lazzaro11; è possibile che Maria fosse
originaria di Magdala, poi trasferitasi a Betania. Il gesto di toccare Gesù (vedi oltre v. 17) è più
congeniale a Maria di Betania, che aveva accolto Gesù abbracciando i suoi piedi (Gv 11,32), e nella
cena di Betania unse i suoi piedi (Gv 12,3). Una tale ipotesi contraddice la tradizione evangelica che
vuole Maria Maddalena facente parte del gruppo di donne che la mattina di Pasqua si recano al
sepolcro (Mt 28,1; Mc 16,1 e Lc 24,10).
– viene di buon mattino al sepolcro, mentre era ancora buio. Giovanni non specifica che cosa sia
venuta a fare Maria al sepolcro. In Gv 11,31, i giudei pensano che Maria, sorella di Lazzaro, si alzi
per andare a piangere al sepolcro, laddove va incontro a Gesù. Questo atteggiamento è compatibile
con il Midrash Rabbah C, 7 su Gn 1,1012, in cui viene citata una disputa sulla riduzione delle
lamentazioni funebri intense da tre a due giorni dopo la morte. In Mc 16,1 e Lc 24,1, le donne si
recano al sepolcro per ungere il corpo del Signore. Matteo (Mt 28,1) motiva la venuta per una visita
al sepolcro, ma già Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo avvolsero con bende assieme agli aromi il
corpo del Signore prima di deporlo nel sepolcro (19,40).
L'ora indicata da Giovanni si può stabilire tra le 3 e le 6 del mattino e faceva ancora buio13. Il buio
evoca il clima di paura in Gv 6,17, dove i discepoli erano soli al buio sul lago. Oppure, potrebbe
essere una metafora delle tenebre, dove l'assenza di Gesù è assenza di “luce della vita”. La tomba
vuota può significare questo per Maria, dove il sepolcro vuoto sta a indicare che il corpo di Gesù è
stato rubato. In realtà, alla conclusione della vita pubblica Gesù annuncia : «Solo ancora un po' di
tempo la luce è con voi» (Gv 12,35), la sua assenza ha calato un velo di tenebra per i discepoli.
Nei vangeli sinottici si dice che era l'alba (Mt 28,1 e Mc 16,1), mentre Lc 24,1 indica solo che era
“mattino presto”: la luce della risurrezione di Gesù ha trionfato sulle tenebre della morte.
– e vede la pietra rimossa dal sepolcro. L'evangelista racconta della pietra rimossa come se il
lettore sapesse, ma in 19,42 dice solo che deposero Gesù nel sepolcro. È in Mc 15,46 e Mt 27,60
che ci viene detto che Giuseppe fece rotolare una grossa pietra sulla porta del sepolcro. Forse
vengono conservate le parole di una tradizione più antica.
Da notare anche il parallelo con la tomba di Lazzaro, dove la pietra viene fatta togliere su ordine di
Gesù (Gv 11,38-41), qui viene messa in risalto la novità della resurrezione e non si dice chi abbia
rotolato via la pietra.
10 FABRIS R., Giovanni, nota 15 p. 1022.11 FABRIS R., Giovanni, p. 1022 e nota 15.12 BROWN R. E., Giovanni, p. 1229.13 La data della risurrezione di Gesù cadde l'anno 30 d.C. il giorno 8 aprile (Bibbia di Gerusalemme, 1973, p. 2676), si
può facilmente calcolare che a Gerusalemme il sole sorse alle 5,20 (http://www.ngc7000.org/astrotools/ephemtool.html accesso 01/02/2011).
14
Con “vedere” si traducono cinque verbi diversi a cui fa ricorso Giovanni, particolarmente in questo
capitolo (vedi Struttura). Qui è usato per tradurre blepein, che ha il significato di illustrare il
processo visivo o visione oculare. Anche in Gv 9,7 l'evangelista lo impiega per descrivere la vista
riacquistata dal cieco nato.
v. 2. Corre allora. Maria come si è accorta che il corpo di Gesù era assente? Due le possibili
risposte: lo ha dedotto perché il sepolcro non aveva più il sigillo, oppure ha guardato dentro il
sepolcro. La prima è di buon senso e potrebbe essere quella più ovvia, la seconda suscita difficoltà.
Era ancora buio e non viene detto che si chinò verso il sepolcro, come poi verrà detto al v. 11.
Secondo Brown14 molti ovviano alla difficoltà mediante la critica letteraria, supponendo che il v. 1
fosse una volta seguito dal v. 11.
Il verbo “threcho” significa “muoversi in tutta fretta, correre”, è usato da Giovanni qui, al v. 4 e in
Ap 9,9, dove viene utilizzato per descrivere i cavalli lanciati all'assalto. Maria corre, turbata da
questo avvenimento inaspettato per riferire ai discepoli l'accaduto.
– va da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava. L'identificazione dei due discepoli è
un particolare di Giovanni, mentre in Mt 28,8 l'annuncio viene fatto genericamente ai “suoi
discepoli” e Lc 24,9 agli “Undici e a tutti gli altri”. In Mc 16,7 l'angelo ordina alle donne di andare
a dirlo ai discepoli e a Pietro. Pietro potrebbe essere citato perché era il capo dei discepoli, però
bisogna ricordare che lui e il Discepolo prediletto non erano fuggiti come gli altri, ma avevano
seguito Gesù e le guardie dei Giudei nel cortile del sommo sacerdote (Gv 18,15). Il discepolo che
Gesù amava viene qui qualificato con phileō, non con agapaō come in Gv 13,23 e 19,26. Il cambio
non varia la sostanza in quanto Giovanni usa questi due termini indistintamente nella sua narrazione
(Gv 3,35; 5,20). Secondo Baum15 sarebbe da interpretare come nota autobiografica per mantenere
l'anonimato. Gli evangelisti, a differenza degli storici coevi greci e romani, volevano far valere la
presenza personale in alcuni punti cruciali della vicenda, tuttavia erano allo stesso tempo
intenzionati a rimanere il più possibile invisibili (Mc 14,51-52; Atti «sezioni noi»). Il quarto
evangelista ha deciso di nascondersi dietro la figura anonima del discepolo prediletto che ha
introdotto in terza persona, se avesse usato la prima persona sarebbe stato molto più visibile in tutto
il suo libro.
Il fatto che la Maddalena vada a riferirlo ai due discepoli è per convalidare la sua testimonianza del
sepolcro vuoto in modo conforme al diritto biblico, che dà validità testimoniale ad un fatto se
stabilito sulla parola di due o tre testimoni (Dt 19,15).
– Hanno portato via il Signore. La prima spiegazione che viene data è il furto di cadavere.
14 BROWN R. E., Giovanni, p. 1231.15 BAUM A.D., Autobiografische Wir- und Er-Stellen in den neutestamentlichen Geschichtsbüchern im Kontext der
antiken Literaturgeschichte, pp. 473-495
15
Giovanni non accenna alla presenza di guardie giudaiche presso il sepolcro come fa Matteo (Mt
27,62-66). Matteo infatti è il solo fra gli evangelisti che ricorda le precauzioni dei giudei circa il
sepolcro di Gesù e come abbiano messo delle guardie a protezione del sepolcro nel timore «che i
suoi discepoli, lo rubino e dicano al popolo: “È risorto dai morti» (Mt 27, 64).
Maria Maddalena riferisce ai discepoli che hanno portato via il “Signore”, Kýrios. Chiama Gesù con
questo titolo: colui a cui una persona appartiene, su cui ha il potere di decidere; padrone, signore; è
un titolo di onore espressivo di rispetto e riverenza, con cui i servi salutano il loro padrone. Perché
non dice che hanno portato via il “Maestro”, come poi farà vedendo Gesù (v. 16)? Discutibile è
l'ipotesi16 che si tratti di una risposta apologetica all'interpretazione giudaica della tomba vuota di
Gesù che accusavano i discepoli di aver rubato il corpo per dimostrare la risurrezione (Mt 27, 64).
Qui traspare l'ironia giovannea: l'autore gioca sul fatto che il lettore sa che né i suoi discepoli, né il
giardiniere hanno trafugato il corpo di Gesù. La polemica è attestata fino al III secolo e mostra a suo
modo che il cadavere di Gesù non fu mai ritrovato17.
– e non sappiamo dove l'abbiano posto. “Noi non sappiamo”, Maria era sola davanti alla tomba
vuota! La tradizione sinottica racconta che due donne andarono quel mattino a visitare la tomba (Mt
28,1), Marco ci parla di tre donne (Mc 16,1) e un gruppo di donne per Luca (Lc 24,1). Giovanni
potrebbe aver utilizzato la forma in prima persona plurale per armonizzare il racconto con quello
dei sinottici, oppure è il residuo della fonte che parlava di più di una donna e non corretto dal
redattore. Un'altra spiegazione è indicata da Dalman18: «Nell'aramaico di Galilea veniva spesso
usata la prima persona plurale al posto della prima persona singolare». Tuttavia, si chiede Brown19,
ci chiediamo perché compaia il singolare al v. 13.
La Maddalena in questo modo potrebbe essere la rappresentante o portavoce di un gruppo che ha
una soluzione pessimistica o negativa20. La tomba vuota non può far che ipotizzare un trafugamento
di cadavere, che ha come conseguenza il senso di impotenza nel sapere dove esso sia. Nel quarto
Vangelo il verbo “conoscere/oida” stabilisce quasi sempre una competenza in ordine alla
rivelazione cristiana portata da Gesù. Tuttavia, quando è utilizzato in una negazione, rivela proprio
l'incompetenza di coloro ai quali vengono attribuiti (vedi Gv 1,10), come in questo caso in cui la
donna mostra di essere incapace di comprendere l'avvenimento.
v. 3. Partì dunque Pietro e anche l'altro discepolo, e si avviarono. La traduzione letterale è: «Uscì
16 FABRIS R., Giovanni, p. 1023 e nota 17.17 LEON DUFOUR X., Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, p. 261 e nota 28.18 DALMAN G., Grammatik des judisch-palastinischen Aramaisch, p. 265 [citato da R.E. BROWN, Giovanni, p.
1233].19 BROWN R. E., Giovanni, p. 1233.20 SANTI GRASSO, Il Vangelo di Giovanni, p. 757.
16
dunque Pietro ... e andarono». Il primo verbo è al singolare, mentre il secondo al plurale.
Hartmann21 postula un racconto originario composto dai vv. 1-3.5.7-11.14-18 o di parte di essi.
Questa fonte racconterebbe della Maddalena che si reca al sepolcro e vede la pietra rimossa. Corre
da Simon Pietro e con lui ritorna alla tomba. Pietro entra nel sepolcro e vede le bende. Se così fosse,
anche la presenza della Maddalena al v. 11 non creerebbe problemi.
– verso il sepolcro. Secondo Brown22, eis si potrebbe anche leggere “dentro” se i vv. 4-6a fossero
stati aggiunti in una redazione posteriore (vedi sopra). Da notare che eis usato al v. 1 ha il
significato di “al” e lì è chiaro che Maria va al sepolcro e rimane fuori.
v. 4. Correvano ambedue insieme. Pietro e l'altro discepolo corrono insieme verso il sepolcro.
Giovanni ci tiene a sottolineare, in questa prima parte del versetto, che entrambi corrono appaiati,
alla stessa velocità.
– ma l'altro discepolo precedette Pietro nella corsa e arrivò primo . Ma qualcosa cambia, l'altro
discepolo corre più veloce e giunge prima di Pietro alla tomba. Le spiegazioni più plausibili
possono essere riassunte con tre enunciati. Il primo si rifà alla tradizione23: la maggiore energia nella
corsa del discepolo ha contribuito a pensare che fosse più giovane di Pietro. Un altro è perché il
Discepolo prediletto è spinto dall'amore. Fabris24 propende per una spiegazione di tipo
narratologico. Giovanni predilige gli accostamenti di due figure simmetriche che rappresentano due
diversi modi di reagire all'iniziativa o al rapporto con Gesù. Si confrontino anche le due sorelle di
Betania (Gv 11,20-29), Marta e Maria che reagiscono in modo diverso all'arrivo di Gesù. L'una gli
andò incontro, l'altra stava seduta in casa, ma si alzò in fretta quando il maestro la chiamò.
– al sepolcro. Anche in questo caso Brown25 sostiene che eis si potrebbe anche leggere “dentro” il
sepolcro (vedi v. 3). In questo caso però non si accorderebbe con il versetto successivo, dove dice
espressamente che non entrò.
v. 5. Chinatosi, vede le bende che giacevano distese. È passato del tempo da quando la Maddalena è
giunta al giardino, si è fatto giorno e c'è abbastanza luce. Il discepolo anonimo si china e guarda
oltre la soglia. Anche in questo caso Giovanni utilizza il verbo “blepein/vedere”, che ha il
significato di illustrare il semplice processo visivo. Letteralmente “vede giacenti le bende”, molti
traduttori26 rendono il greco con “giacenti per terra”, ma ciò da' un'impressione errata del luogo
dove si trovava il corpo. Se l'ipotesi di Parrot27fosse corretta, il sepolcro che Giuseppe d'Arimatea
21 HARTMANN G., “Die Vorlage der Osterberichte in John 20”, p. 220.22 BROWN R. E., Giovanni, p. 1233.23 AMBROSII, De officiis Ministrorum, 2.20.101, p. 16724 FABRIS R., Giovanni, p. 1024 e nota 18.25 BROWN R. E., Giovanni, p. 1234.26 BROWN R. E., Giovanni, p. 1235.27 PARROT A., Golgotha e Santo Sepolcro, pp. 33-34.
17
aveva nell'orto era quello di un ricco, scavato nella roccia viva, per contenere una sola salma. «La
tomba di Gesù era certamente del tipo a bancale con arcosolio: in una tomba a kokim, infatti, non
sarebbe stato possibile mettersi a sedere (Mc 16,5; Gv 20,12). E’ senza dubbio sulla tavola che
furono deposti il sudario e i pannilini, che erano serviti per avviluppare il corpo (Lc 24,12; Gv
20,7). ... Infatti, ci è riferito espressamente che uno dei primi testimoni della risurrezione, Giovanni,
non vi entrò immediatamente, e che dovette chinarsi per vedere nell'interno del sepolcro (Gv 20,5).
Questa osservazione è importante, perché le porte di un ipogeo sono così basse che per lo più
bisogna chinarsi per attraversarle e gli occhi di un uomo, che rimane in piedi, vengono a trovarsi al
di sopra dell'architrave della porta». Pertanto le bende potevano trovarsi sia a terra, sia appoggiate
sopra la tavola come osserva Parrot.
– tuttavia non entrò. Perché il discepolo arrivato per primo non entra nel sepolcro? Le spiegazioni
offerte dagli esegeti sono diverse28: non entrò perché era spaventato, perché voleva evitare la
contaminazione per aver toccato un cadavere, perché era sorpreso ed infine, non certo come ultima
ragione, ma principale nel dibattito esegetico, la priorità di Pietro. Molto di quello che è stato scritto
è sorto nel dibattito tra i cattolici romani e il resto dei cristiani con riferimento alla priorità del
vescovo di Roma. Altri non vedono il contrasto in termini di questione papale, ma per problemi
sorti all'interno della comunità giovannea. Loisy29 sostiene che Pietro rappresentava il cristianesimo
primitivo, il giudeo-cristianesimo e l'altro discepolo il cristianesimo più recente, il cristianesimo
ellenista, più mistico. Pietro avrebbe la priorità e dovrebbe entrare per primo nel sepolcro.
Ad ogni modo c'è anche da ricordare che nel racconto originale postulato da Hartmann30, Pietro era
presente da solo con la Maddalena (vedi anche Lc 24,12). L'evangelista non era perciò intenzionato
a mettere il discepolo prediletto sopra di lui, come evidenzierà poi nel capitolo 21.
v. 6. Arriva poi anche Simone Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro. Nella terminologia
giovannea “seguire” significa essere discepolo, è il termine per eccellenza che indica la
consacrazione dei discepoli31. Barrett32 pensa che qui forse potrebbe essere inteso per subordinare
Pietro al discepolo prediletto.
– ed entrò nel sepolcro. Sono le stesse parole che usa l'evangelista Marco (Mc 16,5). In Luca sono
le donne ad entrare nella tomba vuota (Lc 24,3), mentre in Matteo nessuno entra nel sepolcro,
l'angelo parla alle donne seduto fuori sulla pietra che aveva precedentemente rotolato (Mt 28,2).
– e vede le bende che giacevano distese. Nel v. 5 Giovanni utilizza le stesse parole riguardo al
28 BROWN R. E., Giovanni, p. 1235.29 LOISY A. F., Le quatrième évangile: les épîtres dites de Jean.30 HARTMANN G., “Die Vorlage der Osterberichte in John 20”. p. 220.31 BROWN R. E., Giovanni, p. 103.32 BARRETT C. K., The Gospel according to St. John, p. 563.
18
discepolo prediletto, ma qui usa un verbo diverso per “vede”, theōrèin. Qui a “vede” vuole dare un
significato diverso o è solo una finezza letteraria? Secondo Phillips33 theōrèin è un vedere limitato
intellettualmente, con attenzione ma senza comprensione. In Gv 6,19 i discepoli vedono Gesù
camminare sulle acque, ma l'imperfezione di questo vedere sfocia nella paura. La vera fede
promuove l'amore e l'amore perfetto scaccia il timore.
v. 7. e il sudario che era sopra il capo. Soudarion è un vocabolo di origine latina sudarion, che è un
panno usato per detergere il sudore (sudor). In Lc 19,20, la parabola dei talenti, il terzo servo lo usa
per conservare la moneta; mentre in At 19,12 i soudaria vengono posati sui malati dopo che sono
stati a contatto con Paolo34. Questo panno di lino non è specificamente menzionato da Giovanni
nella descrizione della preparazione del cadavere per il seppellimento (Gv 19,40), ove si parla
semplicemente di bende. Invece in Gv 11,44, l'evangelista afferma che: «il morto, legato mani e
piedi con bende e la sua faccia era avvolta in un sudario (soudario)».
– esso non stava assieme alle bende, ma a parte ripiegato in un angolo. La traduzione di questo
passo è molto controversa e gli antichi copisti intuirono alcune delle difficoltà incontrate dagli
studiosi di oggi, perché le testimonianze testuali di minor valore omettono in questa descrizione
qualche parola o frase35. Balaguè36 rende: «non spianato con i teli, ma invece arrotolato allo stesso
posto». Secondo l'Autore la negazione non si riferisce al luogo, ma al modo. Infatti non precede
immediatamente keimenon, ma meta. Sostiene che qui meta non vuol dire “con”, bensì “come” a
somiglianza del suo corrispondente ebraico 'im, facendo riferimento più al modo con cui i panni
sono stesi, che al luogo dove giacciono. Le parole eis hena topon significano “dentro un posto”, ma
Balagué vede qui un ebraismo per “nello stesso luogo”. Infine, dobbiamo notare l'espressione
“arrotolato”, Lavergne37 sostiene che tale significato non veniva attribuito al verbo entulissein prima
del IV secolo. San Girolamo nella Volgata traduce con involutum in unum locum, capendo che “il
luogo” in questione non era che il punto dove il sudario era stato avvolto intorno al capo. Egli pensa
che Giovanni volesse dire che il soudarion era “avvolto” dentro gli abiti funebri, nella stessa forma
che aveva quando stava intorno alla testa del morto.
Fortna38 risolve il problema a monte. Secondo l'Autore la menzione del soudarion usato per coprire
la testa è una glossa e la descrizione dettagliata che viene fatta è sproporzionata rispetto al flusso
narrativo. Il versetto è probabilmente redazionale, forse preso a prestito dalla tradizione di Lazzaro
33 PHILLIPS G. L., Faith and Vision in the Fourth Gospel, in Study in the four Gospel, pp. 87-88.34 La Bibbia CEI-UELCI (I coedizione 2008) traduce soudariw in Lc 19,20 con “fazzoletto” e soudaria in At 19,12 con
“fazzoletti”.35 BROWN R. E., Giovanni, p. 1237.36 BALAGUÈ M., La prueba de la Resurrección (Jn 20,6-7), p. 187; citato da BROWN R. E., Giovanni, p. 1236.37 LAVERGNE C., Le sudarium et la position des linges après la résurrection; citato da BROWN R. E., Giovanni, p.
1237.38 FORTNA R., The fourth gospel and its predecessor, p. 197.
19
per il soudarion. Il redattore descrive la funzione in modo differente, perché qui non si può dire che
la sua faccia era avvolta in un soudarion, e poi elabora il versetto ponendo attenzione alla
disposizione del soudarion nella tomba vuota.
v. 8. e vide e credette. In questo versetto troviamo due difficoltà. La prima riguarda la mancata
concordanza tra la terza persona singolare del “vide e credette” con la terza persona plurale in Gv
20,9. Può essere superata seguendo l'analisi della stratificazione del testo proposta da Fortna39. Il v.
8 da un lato riprende i temi giovannei dei vv. 4-5, ma dall'altro collide con l'evidentemente
tradizionale v. 9: la fede dell'altro discepolo è difficilmente spiegabile per il fatto che “non avevano
infatti ancora capito la scrittura”. Perciò anche il v. 8 estende, insieme al v. 7, l'inserimento
giovanneo dei vv. 4-6a. Al posto del v. 8, l'Autore congettura che di seguito al v. 6b la fonte dice che
Simon Pietro “si stupì” (vedi Lc 24,12). Pertanto la fonte pregiovannea, da un punto di vista
narrativo mantiene il senso e non presenta difficoltà40 (si leggano di seguito i vv. 3.6b.9-10).
La seconda difficoltà è la fede del Discepolo. Il redattore finale usa il verbo horàn per vedere, che
come abbiamo visto, Phillips41 tradurrebbe con “percepire”, in cui l'elemento intellettuale è
primario. “Vedere” come si presenterebbe la soluzione di un problema matematico: apice e
realizzazione dell'essere persuasi. Atteggiamento illusorio e specificamente religioso, quale
potrebbe essere una relazione tra persone, con una analogia dell'incontro amoroso umano.
Agostino42 sostiene che qualche lettore frettoloso ha creduto di trovare qui la prova che il discepolo
prediletto credette che Gesù era risorto, ma come abbiamo già visto, ciò che segue smentisce questa
supposizione (Gv. 20,9). Cosa vide e che cosa credette allora? Vide che il sepolcro era vuoto e
credette a quanto riferì la Maddalena. Che cioè il Signore era stato portato via.
Ma il redattore finale ci dice che il percepire del Discepolo, non il semplice vedere, sfocia nel
credere. La tomba vuota è un sēmeion, il segno della gloria di Dio. I segni della morte sono rimasti
intatti nella tomba, al loro proprio posto. Il Discepolo “percepisce” questo come il sēmeion che la
risurrezione di Lazzaro ha portato alla fede i giudei e lo fa approdare alla fede43. Qui alla luce del
suo profondo legame con Gesù riconosce il segno della presenza nell'assenza44.
v. 9. Non avevano infatti ancora capito la Scrittura. Il versetto richiede di approfondire due
questioni. Il verbo oĩda è al plurale, ma nel v. 8 il discepolo prediletto “vide e credette”, a chi si
riferisce dunque? La seconda domanda è a quale Scrittura faccia riferimento.
39 FORTNA R., The fourth gospel and its predecessor, p. 197.40 FORTNA R., The fourth gospel and its predecessor, p. 187.41 PHILLIPS G. L., Faith and Vision in the Fourth Gospel, in Study in the four Gospel, p. 85.42 AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, p. 116643 FABRIS R., Giovanni, p. 1025.44 LEON DUFOUR X., Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, p. 265.
20
Per Forestell45 il v. 9 è una glossa inserita successivamente con l'intento di spiegare la lentezza di
Pietro e degli altri discepoli a credere. La visione della tomba vuota è sufficiente a provocare la fede
in Cristo risorto e tutta la narrazione in Gv 20,3-10 mette in rilievo la fede del Discepolo amato. Nel
testo non ci sono motivi per estendere la fede del Discepolo a Pietro: i verbi sono al singolare in Gv
20,8. Sebbene il Discepolo amato non abbia necessità di vedere Cristo risorto per raggiungere la
fede, la presenza del sepolcro vuoto è un sēmeion adeguato per lui46. Che sia una glossa lo si può
anche vedere da oudepō, che appare tre volte nel Vangelo di Giovanni, sempre come glossa (Gv
7,39; 19,41, 20,9). Hartmann47 pensa che il plurale si riferisca a Pietro e a Maria Maddalena, in
quanto nella forma originale del racconto ella sola accompagnava Pietro alla visita del sepolcro
vuoto.
Quanto afferma Giovanni, cioè che la portata delle profezie dell'Antico Testamento fu compresa
solo dopo le apparizioni di Gesù, concorda con quanto scritto in Lc 24,25-2748. Questo però
contraddice la tesi dei Vangeli sinottici secondo la quale Gesù fece tre predizioni della sua
risurrezione (Mc 8,31; 9,31; 10,33-34). Se paragoniamo Mc 8,31 a Giovanni 3,14 troviamo che in
entrambi i casi il “bisogna” implica la volontà divina. La somiglianza di questi detti è un'altra
ragione per insistere che anistēmi per Giovanni significa qualcosa in più della crocifissione. Sulla
base comparativa, i detti giovannei sono molto meno particolareggiati e potrebbero essere più
antichi49. L'affermazione che il Figlio dell'uomo dei, “doveva essere resuscitato” riflette il tema che
il suo essere innalzato era stato predetto dalle Scritture (specialmente Isaia capitoli 52 e 53) e quindi
faceva parte della volontà divina. L'influenza principale sui detti giovannei sembra sia il tema del
“Servo sofferente” in Is 52,13: «Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato
grandemente».
Bernard50 sostiene che potrebbe probabilmente trattarsi del Salmo 16,10: «perché non abbandonerai
la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa». Ma come è chiaro che negli Atti
degli Apostoli viene citato il salmo 16,10 da Pietro (At 2,31) e Paolo (At 13,35), egli conclude che
questo potrebbe essere il versetto che Giovanni aveva in mente quando dice che i discepoli non
avevano ancora capito la Scrittura51.
Una terza proposta è stata suggerita da Dodd52: per Scrittura si potrebbero intendere le stesse parole
di Gesù scritte in un altro vangelo (Lc 24,46). Non si hanno prove che l'autore del quarto Vangelo
45 FORESTELL J. T., The Word of the Cross, p. 96.46 FORESTELL J. T., The Word of the Cross, p. 96 nota 160.47 HARTMANN G., “Die Vorlage der Osterberichte in John 20”. p. 220.48 BROWN R. E., Giovanni, p. 1238.49 BROWN R. E., Giovanni, p. 192.50 BERNARD J. H., Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, pp. 661-662.51 BERNARD J. H., Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, p. 67.52 DODD C. H., According to the Scriptures, p. 126f.
21
conoscesse il vangelo scritto da Luca53 né che egli volesse classificare le parole di Gesù come
scritte54.
– doveva resuscitare dai morti. Per Bultmann55, anastenai è una glossa redazionale che si trova
solo qui ed è stata aggiunta dal redattore ecclesiastico; l'interesse per la risurrezione è tipico della
teologia comunitaria.
v. 10. I discepoli poi ritornarono a casa. In questo versetto i discepoli, indicati in modo generico,
ritornano là dove Maria Maddalena era corsa a chiamarli. Nulla viene detto di quello che
pensavano, dei loro sentimenti, come invece precisa Lc 24,12 dove Pietro era “pieno di stupore”. Lo
scopo della narrazione potrebbe essere quello di far uscire di scena i discepoli per lasciare sola
Maria Maddalena.
v. 11. Maria invece era rimasta presso il sepolcro, fuori, in pianto. La narrazione prosegue con il
secondo episodio, l'apparizione di Gesù a Maria. Giovanni ci racconta che ella era rimasta fuori dal
sepolcro, non dice quando è tornata, se ha seguito i due discepoli, magari correndo anche lei.
L'evangelista ritiene naturale che fosse fuori dal sepolcro in attesa, e quando Pietro e l'altro
Discepolo se ne vanno, lei rimane lì. Un'altra questione è perché il Discepolo amato non comunica a
Maria la sua intuizione e la fede raggiunta? Questa imbarazzante incertezza ci rivela che ci
troviamo di fronte alla fusione redazionale di episodi originariamente indipendenti56.
Le testimonianze migliori leggono pros, “fuori, presso”, che con il dativo esprime prossimità,
significando “vicino, presso a”. Il Codex sinaiticus presenta una variante, invece di pros ha en, “in,
dentro”, intendendo che anche la Maddalena è entrata nel sepolcro, ma questo non concorda con “si
chinò verso il sepolcro” del v. 20,11b. Nella tradizione sinottica Maria entrò nella tomba (Mc 16,5;
Lc 24,3).
“Piange”: Brown57 ritiene che non sia la consueta lamentazione delle parenti di un morto, la
53 Luca e Giovanni sono stati al centro di alcune ricerche. Quattro in particolare possono essere ricordate: 1) SCHNIEWIND J., Die Parallelperikopen bei Lukas und Johannes, Hildesheim, 1958 [1914], ha concluso che tutte le somiglianze potrebbero essere attribuite a tradizioni comuni; 2) BAILEY J. A., The Traditions Common to the Gospels of Luke and John. Suppl. Novum Testamentum 7 (1963), che ha trovato molti punti di somiglianza nati da tradizioni comuni, ma anche alcuni punti che non potevano essere spiegati, e pertanto potrebbero essere attribuiti all'uso di Luca da parte di Giovanni; 3) DAUER A., Die Passiongeschichte im Johannesevangelium; Eine traditionsgeschichtliche und theologische Untersuchung zu Joh 18,1-19, 30 (Münich: Kösel-Verlag, 1972) e Johannes und Lukas: Untersuchungen zu den johanneisch-lukanischen Parallelperikopen John 4,46-54 / Lk 7,1-10 -- Joh 12,1-8 / Lk 7,36-50; 10,38-42 -- Joh 20,19-29 / Lk 24, 36-49, Echter Verlag, Würzburg (1984), ha trovato un numero di somiglianze troppo sorprendente per essere spiegato da tradizioni comuni, ma anche per lui è chiaro un rapporto letterario diretto, la sua spiegazione è che il Vangelo di Luca ha influenzato direttamente le tradizioni che Giovanni ha utilizzato; 4) MATSON M. A., In Dialogue with Another Gospel? The Influence of the Fourth Gospel on the Passion Narrative of the Gospel of Luke, SBL Press, Atlanta (2001), in cui si suppone addirittura l'influenza di Giovanni su Luca.
54 BROWN R. E., Giovanni, pp. 1238-1239.55 BULTMANN R., Teologia del Nuovo Testamento, p. 388.56 BROWN R. E., Giovanni, p. 1239.57 BROWN R. E., Giovanni, p. 1240.
22
Maddalena piange perché pensa che il corpo di Gesù sia stato trafugato.
v. 12. e vede due angeli biancovestiti. Maria “vede” gli angeli, Giovanni usa il verbo theōrèin, che
come abbiamo visto (vedi Struttura e Note v. 6) è un vedere imperfetto. Non viene fatto cenno alle
bende abbandonate nel sepolcro, piuttosto ella “vede” angeli vestiti di bianco. Giovanni non parla
del sentimento o delle emozioni provate dalla Maddalena. Nella narrazione sinottica il sentimento
che accompagna le donne è di paura (Mc 16,5; Lc 24,5), timore e gioia grande ((Mt 28,8).
Abbiamo qui la descrizione di un fatto eccezionale che sta accadendo a Maria, ella “vede” due
angeli. Giovanni usa il tempo presente per dare maggiore vivacità alla scena. Non possiamo
presumere che gli angeli siano oggetti fisici che riflettono la luce sulla retina. Si può presumere
invece che, quando gli umani “vedono” o “sentono” gli angeli, una intensa esperienza interiore di
un messaggio divino porti alla percezione di una immagine che viene vissuta come “vedere” o
“sentire” qualcosa. Certo è che la parola angelo designa l'ufficio e non la natura, e l'ufficio è quello
di portare un messaggio divino58. Ma la Maddalena non “vede” in modo pieno questa esperienza, lei
cerca ancora il corpo. Gli angeli annunciano la gloria di Gesù, che aveva preannunciato: «Vedrete
[horaō] il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e discendere sul Figlio dell'uomo (Gv. 1,51)», ma lì
c'era la fede.
In Mt 28,2 un angelo del Signore scese dal cielo, Marco descrive la presenza di un giovane (Mc
16,5), mentre Luca riferisce di due uomini in abiti sfolgoranti (Lc 24,4), che nel racconto successivo
diventano una visione di angeli (Lc 24,23).
– seduti, uno in corrispondenza del capo e l'altro dei piedi. Come abbiamo visto (v. 5), il bancale
su cui era posto il corpo, ora fa da panca per i due angeli, uno seduto alla testa e l'altro ai piedi. Ha
un significato preciso la loro posizione? Alcuni Autori59, ricordano come Giovanni abbia posto i due
ladroni ai lati della croce, mentre altri pensano ai due cherubini posti sull'Arca dell'Alleanza. Il loro
ruolo è quello di indicare che la tomba è vuota e Gesù bisogna cercarlo altrove.
v. 13. Donna. Gynē, “donna”, compare altre venti volte nel Vangelo di Giovanni, ma al vocativo
solo in sei. Nell'episodio delle nozze di Cana (Gv 2,4), Gesù si rivolge a sua madre con questo
termine. La donna samaritana presso il pozzo di Giacobbe (Gv 4,21), l'adultera (Gv 8,10), Sua
madre ancora per affidarle il Discepolo amato (Gv 19,26) e qui, vengono interpellate con questa
forma. Non ha il significato spregiativo come potremmo immaginare, al vocativo è un termine di
rispetto e offerta, con l'accezione di “Signora/Padrona”.
– perché piangi? Alcune testimonianze occidentali60 aggiungono: «chi è che stai cercando?», come
58 AGOSTINO, Esposizione sui salmi, 103, 1, 15.59 BROWN R. E., Giovanni, p. 1241.60 BROWN R. E., Giovanni, p. 1241.
23
in Gv 20,15. In Mt 28,5 e Mc 16,6 il messaggero sa' che le donne stanno cercando Gesù, ma in Lc
24,5 c'è una domanda: «perché cercate tra i morti colui che è vivo?»
– hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto. Maria ripete quasi le stesse parole
che aveva detto in Gv 20,2, aggiunge però “mio” davanti a Signore e il verbo “conoscere/oida” è in
prima persona singolare e non plurale come in v. 2.
v. 14. si voltò indietro e vide Gesù. La Maddalena si volge indietro e theōrèin Gesù. Abbiamo già
trovato questo verbo che per Giovanni significa 'guardare con concentrazione', ma non
necessariamente con un'alta percezione del significato di quello che si sta contemplando61.
Bernard62 ricorda che in Gv 14,19 si usa questo verbo quando Gesù dice che il mondo non lo “vedrà
(theōrèin) più, e Phillips63 interpreta Gv 14,17-19 così: «Voi, tuttavia, avrete almeno questa
opportunità. Molto presto cesserà la possibilità del mondo di guardare (theōrèin) a me (anche se
non può superare il puro mistero), ma avrete almeno quella possibilità (dopo la resurrezione),
sebbene il vostro vedermi (theōrèin) avrà una lunga strada da percorrere prima di trasformarsi prima
in fede poi in amore e successivamente in unione».
– ma non sapeva che era Gesù. Maria Maddalena non riconosce Gesù e i commentatori hanno
formulato numerose ipotesi per giustificare questo mancato riconoscimento: Maria non guarda
verso di Lui, come viene poi rimarcato nel v. 16; faceva ancora troppo buio; guardando fuori dalla
tomba è abbagliata dalla luce64. Altre spiegazioni sono argomentazioni teologiche. Di queste, una fa
riferimento alla tradizione del “Messia nascosto” ripresa dall'ambito giudaico e presente nel quarto
Vangelo, la mancanza di conoscenza da parte del popolo di Gesù come Messia: «Ma costui
sappiamo donde è; mentre il Cristo, quando viene, nessuno sa di dove è» (Gv 7,27)65. Altre ipotesi si
rifanno al mancato riconoscimento di un Gesù trasfigurato, si veda anche Lc 24,30-31 dove i
discepoli non lo riconoscono finché non spezza il pane.
v. 15. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Gesù si rivolge a Maria e le chiede chi stia cercando. È la
stessa domanda che indirizza ai due discepoli di Giovanni il Battista in Gv 1,38: «Che cercate?».
Andrea e il suo compagno avevano domandato: «Rabbi, dove stai?». Sia Maria Maddalena che i
due discepoli domandano riguardo alla Sua localizzazione in questo mondo66, cercano l'una il corpo
scomparso, gli altri il modo di restare più tempo con lui.
Nella costruzione della narrazione, l'evangelista si è ricordato del Cantico dei Cantici? Infatti così si
61 PHILLIPS G. L., Faith and Vision in the Fourth Gospel, in Study in the four Gospel, p. 85.62 BERNARD J. H., Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, p. 665.63 PHILLIPS G. L., Faith and Vision in the Fourth Gospel, in Study in the four Gospel, p. 89.64 BROWN R. E., Giovanni, p. 1241.65 Per saperne di più sulla tradizione del “Messia nascosto” si veda: BROWN R. E., Giovanni, p. 70, SANTI GRASSO,
Il vangelo di Giovanni, p. 78.66 LEON DUFOUR X., Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, p. 281.
24
esprime: «Ho cercato l'amore dell'anima mia; l'ho cercato ma non l'ho trovato» (Ct 3,19). Nello
sfondo del Cantico Maria rappresenterebbe la comunità messianica alla ricerca di Gesù67.
– pensando che fosse l'ortolano. Il vocabolo “kēpouros/ortolano” è una parola che in tutta la Bibbia
si trova solo qui, anche se nella letteratura dell'epoca era un vocabolo utilizzato68. Tertulliano ci
fornisce una traccia della leggenda che circolava a quei tempi, cioè di chi abbia sottratto il corpo di
Gesù dal sepolcro e per quale ragione:
«Questi è Colui che i discepoli cercarono di nascondere, perché apparisse come risorto un
giorno, e che fu allontanato da chi era il padrone dell'orto, perché appunto le insalate che quivi
crescevano non subissero danni, per il numero grande di coloro che accorrevano in quel
luogo»69.
Giovanni stesso ci dice che il sepolcro si trovava in un “kēpos/orto” (Gv 19,41). L'ortolano,
temendo che i visitatori della tomba di Gesù calpestassero le aiuole, spostò il corpo in un altro
luogo, per proteggere i suoi ortaggi e indirizzare i visitatori in un altro luogo.
v. 16. Le dice Gesù: «Maria!» Il nome di Maria è controverso, alcune testimonianze leggono
“Mariam” (Codex alexandrinus, papiri e tre unciali S e B, 565), altre “Maria”
(Byzantine/'Caesarean' con A, 038)70, il testo di Nestle-Aland27 legge “Mariam”. Poiché “Mariam” è
un nome che deriva dall'ebraico Miryam, alcuni Autori pensano che Giovanni volesse far parlare
Gesù in ebraico, così come anche Maria risponde in quella lingua al suo interlocutore71. Raramente
viene pronunciato il nome nel discorso diretto, per un semita il nome raggiunge l'interiorità della
persona72. Gesù conosce per nome le sue pecorelle e le sue pecore conoscono Lui (Gv 10,3.14)73.
– quella, voltatasi. Maria riconosce la voce del pastore (Gv 10,3) e si volta, tuttavia si era già girata
verso il suo interlocutore e gli aveva parlato (v. 14), come può girarsi ancora? La spiegazione non è
da ricercare in un diverso significato di stréphō, “ruotare attorno o da parte, girare”, ma nella critica
letteraria. Secondo Fortna74 la fonte pregiovannea omette la ripetizione:
14aSi voltò indietro e vide Gesù che stava lì! 15ale dice Gesù: «Chi stai cercando, 16Maria?». Gli
dice in ebraico: «Rabbunì».
Secondo l'Autore nel capitolo 20 si uniscono quattro storie, tre derivano dalle fonti e la quarta,
l'episodio di Tommaso, è dell'evangelista. Altri75 pensano che il greco traduca un originale aramaico
67 LEON DUFOUR X., Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, p. 282.68 Vedi PLATONE, Minosse, 316e.69 TERTULLIANO, De Spectaculis, XXX.70 DERRET J. D. M., Studies in the New Testament: Jesus among biblical exegetes, p. 169.71 BROWN R. E., Giovanni, p. 1243.72 LEON DUFOUR X., Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, p. 283.73 SEGALLA G., Giovanni, p. 462.74 FORTNA R., The fourth gospel and its predecessor, p. 188.75 BROWN R. E., Giovanni, p. 1244.
25
in modo non esatto. La Vetus syriaca sinaitica e Taziano leggono “lo riconobbe” anziché “si volse”.
Secondo Black76 la versione greca ha letto l'aramaico skl come shr per l'influenza del v. 14, dove
compare la forma shr. Ad ogni modo, questa ipotesi che elimina la difficoltà, potrebbe essere un
errore del copista.
– «Rabbunì!». La forma rabbuni è stata definita da Albright77 un vezzeggiativo, cioè un diminutivo
affettuoso come “mio caro maestro”. Giovanni usa il termine rabbi altre otto volte, pertanto si
ritiene che rabbuni debba avere un significato speciale. Tuttavia l'evangelista traduce rabbuni con il
greco didaskalos, “maestro”, la stessa traduzione di rabbi, di modo che lo scrittore non da' ai suoi
lettori greci alcune indicazioni del valore vezzeggiativo78.
Come sottolineato nel versetto precedente (vedi v. 15), si può notare un parallelo tra Gv 1,38-39 e
Gv 20,16. I discepoli chiamano Gesù dicendo rabbi, mentre Maria lo chiama rabbuni, una forma
più enfatica, ma più famigliare. Così come in Gv 1,38 Gesù dice ai due “che cosa cercate?”, in Gv
20,15 chiede a Maria “chi cerchi?”. Gesù alla Maddalena si rivolge affettuosamente con una
domanda più personale, vuole sapere – ma lo sa già – il nome della persona che sta cercando, se Lui
come corpo trafugato o come risorto.
v. 17. Le dice Gesù: «Non mi trattenere». La lettura del testo è di difficile comprensione. I
principali testimoni del testo e NA47 leggono: mē mou haptou; il Codex vaticanus e L1043
presentano una variante: mē haptou mou; altri (L473 e L47) omettono mou79. Haptou è l'imperativo
presente, seconda persona singolare del verbo haptomai che è il medio di “haptō”. Il significato di
questa voce verbale è “fissare a, aderire, toccare”. L'uso imperativo presente implica che già
toccava o stava toccando Gesù e doveva smettere. Secondo Dodd80, il presente imperativo significa
“smetti”, perciò “mē mou haptou” potrebbe significare “smettila di toccarmi”, con l'insinuazione
che la Maddalena lo stesse già toccando. Ma il presente haptesthai differisce dall'aoristo hapsasthai
più di una semplice “Aktionsart/qualità dell'azione”. Hapsasthai significa toccare (così
invariabilmente in Matteo e Marco), haptesthai significa “tenere, afferrare”, anche “aggrapparsi”.
Mē mou haptou potrebbe anche significare “non aggrapparti a me”, senza nessuna implicazione che
Maria lo stesse facendo, dal mē con l'imperativo che può semplicemente rendere il significato
negativo di quel tempo. Ma potrebbe anche essere che Maria potesse toccarlo, ma non aggrapparsi a
lui. Nella scena parallela in Mt 28,9 le donne stringono i piedi a Gesù e talvolta haptesthai equivale
a kratein; per esempio si confronti Mt 8,15 con Mc 1,3181.
76 BLACK M., An Aramaic approach to the Gospels and Acts, pp. 189-190.77 BROWN R. E., Giovanni, p. 1245.78 BROWN R. E., Giovanni, p. 1245.79 WILLKER W., A textual commentary on the greek gospels, TVU 264.80 DODD C. H., The interpretation of the fourth Gospel, p. 443 – nota 20.81 BROWN R. E., Giovanni, p. 1246.
26
Altro problema è che non si riesce a capire perché a lei vieta di toccarlo e una settimana più tardi
permette a Tommaso di mettere il dito nelle ferite (Gv 20,27). Anche prima della resurrezione
abbiamo notizia di una donna che gli toccò i piedi per ungerli con profumo di nardo e glieli asciugò
con i propri capelli (Gv 12,3). Molti sono gli Autori che si sono cimentati a dare risposte e
l'interpretazione di questo versetto è ricchissima, tuttavia si ricordano solo alcuni fra i commenti
più autorevoli. Sant'Agostino82 ammette che qui si nasconde un mistero. Secondo l'Autore in Maria
è raffigurata la Chiesa proveniente dai gentili, che non credette in Gesù Cristo se non dopo che era
asceso al Padre; o perché voleva che si credesse in Lui, cioè che lo si toccasse spiritualmente,
convinti che Egli e il Padre sono una cosa sola. Qual è il senso per Crisostomo83? Maria lo vedeva
come prima, voleva conversare con lui e nella sua gioia non ha percepito niente di grande in Lui.
Perciò le dice di non toccarlo, come a voler dire di avvicinarsi a Lui non come faceva prima, le cose
non sono più le stesse, né lui potrà essere ancora con loro. Tommaso d'Aquino84 riprende l'idea di
Sant'Agostino vedendo in Maria la chiesa dei gentili. Un altro motivo, sempre ripreso da
Sant'Agostino, è che quel tocco è l'ultimo stadio della conoscenza. Quando vediamo qualcosa, noi la
conosciamo in misura parziale, ma è quando la tocchiamo che la conoscenza diventa completa. Ora
Maria ha fede in Gesù, che era un sant'uomo e questa è la ragione per cui lo chiama maestro. Ma lei
non aveva ancora raggiunto il punto da credere che è uguale al Padre ed è uno solo con Lui.
Gli esegeti moderni hanno scelto un'altra strada. Bernard85 sostiene che l'originale leggesse mē
ptoou, “non temere”. Nei racconti sinottici è presente il tema della paura e l'invio. Nella scena
presso il sepolcro è presente l'esortazione “non temete” con il verbo mē phobeisthe (Mt 28,10),
anche se contemporaneamente c'è l'invito: «andate ad annunciare ai miei fratelli». La struttura dei
racconti sfocia in una missione, secondo Leon-Dufour86 Maria si sente dire che per andare a portare
un messaggio ai discepoli non può tenere abbracciato Gesù.
Il verbo haptō è un hapax legomenon nel vangelo di Giovanni, mentre se si prende tutta l'opera
giovannea lo ritroviamo un'altra volta nella prima lettera di Giovanni: «chi è stato generato da Dio
preserva se stesso e il maligno non lo tocca (aptestai)» (1Gv 5,18). Qui si potrebbe anche dire “e il
maligno non se ne appropria/non lo fa diventare suo”. Gesù dice a Maria di non toccarlo, di non
farsene sua proprietà, ma di andare a condividerLo con i fratelli.
– «va’ piuttosto dai miei fratelli». Dodd87 ritiene che per adelphois si debbano intendere i fratelli
parenti di Gesù, in quanto in 1Cor 15,7 si narra di un'apparizione a Giacomo fratello di Gesù.
Tuttavia nel versetto precedente (1Cor 15,6), Paolo dice che apparve a più di cinquecento
82 AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, p. 121.83 CRISOSTOMO, Homilies on the Gospel of St. John and the Epistle to the Hebrews, p. 50384 TOMMASO D'AQUINO, Commento al Vangelo di San Giovanni, p. 387.85 BERNARD J. H., Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, p. 1248.86 LEON DUFOUR X., Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, p. 287.87 DODD C. H., Historical Tradition in the Fourth Gospel, p. 147.
27
“adelphois/fratelli”. L'uso del termine “fratelli” per indicare i discepoli è in relazione con il concetto
espresso più avanti nel versetto, cioè che come Padre di Gesù è loro Padre88.
– Padre mio e Padre vostro e al Dio mio e Dio vostro. Con questo annuncio salvifico viene inviata
Maria. La Maddalena porta ai fratelli la buona notizia che Dio è Padre, non solo di Gesù, ma anche
dei discepoli. La sua salita presso il Padre, frutto della sua fedeltà, comporta il compimento della
sua opera: perciò non è per la morte subita, ma per l'esaltazione presso il Padre che ha ottenuto la
filiazione divina degli uomini89. Lo scopo del Figlio disceso sulla terra era quello di innalzare al
Padre ognuno di noi. La stessa relazione che c'era tra il Padre e il Figlio, Dio e Padre, ora è
relazione tra il Padre, il figlio e l'umanità. Utilizzando il pronome possessivo “Padre mio ... Dio
mio”, Gesù celebra colui che gli ha dato la vittoria sulla morte e una moltitudine di fratelli90.
v. 18. Maria Maddalena va ad annunciare ai discepoli. Maria Maddalena, nominata per intero
come in Gv 20,1, non tiene per sé l'incontro con Gesù, ma va ad annunciare la buona notizia ai
discepoli. Nulla vien detto di che cosa si sono detti lei e Gesù, di quanto tempo è durato l'incontro,
né come si sono congedati. Tutto sembra essersi svolto in un breve momento.
Anche in Mc 16,10 la Maddalena va a portare la notizia dopo la cristofania. Per il verbo “andare”
però Marco, non usa erchesthai come Giovanni, ma poreuein e i discepoli vengono detti “quelli che
erano con lui”91. Inoltre, nell'appendice marciana, essi stavano piangendo e lamentandosi; Giovanni
ci dice che i discepoli provavano paura. In Lc 24,8-9 le donne portano l'annuncio agli undici e a
tutti gli altri.
– ho visto il Signore. Il verbo usato da Giovanni in questo versetto per “vedere” è horaō, che è
l'apice e realizzazione della fede92. La fede di una donna, racconta Giovanni, con la sua bassa
considerazione nella scala sociale del I secolo e peraltro sola, senza che nessuno possa testimoniare
con lei (vedi Dt 19,15), è colei che va ad annunciare la risurrezione. Nonostante sia un testimone
inattendibile, è lei che dice agli apostoli e agli altri discepoli che ha visto il Signore vivo.
– e quanto le aveva detto. Il versetto si conclude con due frasi sintatticamente sconnesse: la prima
parte è formata da un discorso diretto, la seconda da uno indiretto93. Le varie testimonianze
mostrano i segni di un intervento dei copisti94. Per Fortna95 nella fonte Maria riferisce
semplicemente: «Ho visto il Signore!», ma il quarto evangelista aggiunge al discorso diretto il
88 BROWN R. E., Giovanni, p. 1248.89 LEON DUFOUR X., Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, p. 288.90 LEON DUFOUR X., Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, p. 289.91 BROWN R. E., Giovanni, p. 1249.92 PHILLIPS G. L., Faith and Vision in the Fourth Gospel, in Study in the four Gospel, p. 92.93 FABRIS R., Giovanni, p. 1035.94 BROWN R. E., Giovanni, p. 1248-1249.95 FORTNA R., The fourth gospel and its predecessor, p. 192.
28
predicato male adattato “e quanto le aveva detto”. Loisy96 ipotizza che quanto è stato riferito ai
discepoli dalla Maddalena appartiene alla redazione secondaria e imita Mt 28,8: «È risorto dai
morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete».
GESÙ DI NAZARET VISTO DAI DISCEPOLI
Yehoshua ben Yosef
Maria Maddalena è inquieta, non riesce a dormire, il dolore è troppo forte. Si alza, si veste e sola
nella notte va al sepolcro, il luogo della memoria. Il “fare” è un modo per placare il dolore,
attenuare i pensieri, sedare l'ansia.
Che cosa va cercando in quel giardino? La cura per quel corpo morto non è stata adeguata, forse
non erano sufficienti le cento libbre di mirra e aloe (Gv 19,39), ne vanno aggiunte altre (Mc 16,1;
Lc 24,1).
È ancora buio, ma non ha paura, la solitudine del luogo non la spaventa. Improvvisamente si ferma
stupita, la pietra che sigillava il sepolcro non è più al suo posto, è stata rimossa. Qualcuno l'ha
preceduta con gli aromi ed è già all'opera. Ma non c'è nessuno, chiama, nessuno risponde. Maria
capisce che il corpo del Signore non è più lì, qualcuno lo ha portato in un altro luogo. Ma perché
hanno fatto questo, non hanno infierito abbastanza su quel povero corpo? Corre allora ad avvertire
gli altri.
Sulla scena compaiono Simon Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava. Sono ancora a
Gerusalemme, non sono fuggiti come gli altri; hanno paura e stanno rinchiusi nel cenacolo. Maria
bussa alla porta, concitata e affannata, racconta della sparizione del corpo. Non ricorda le sue ultime
parole: «Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre» (Gv
16,28). Eppure allora i discepoli dissero che parlava apertamente senza usare nessuna figura (Gv
16,29).
La concitazione prende anche Pietro e con il Discepolo prediletto corre verso il sepolcro. Il più
giovane corre più veloce e lo precede. Arriva per primo, si china, guarda dentro e vede le bende
lasciate lì, ma il corpo non c'è. Non entra, non vuole guardare meglio, lascia la priorità a Pietro, il
maggiore degli undici. Simone entra nel sepolcro e come lui vede le bende ed anche il sudario. Non
sta con gli altri panni, è al suo posto. Anche il discepolo prediletto entra, vede e crede. Tuttavia non
dice nulla, né a Pietro, né alla Maddalena. Insieme a Simon Pietro se ne torna a casa muto e
stupefatto97. L'evangelista ci dice che non avevano ancora capito la Scrittura: «che egli doveva
resuscitare dai morti» (Gv 20,9).
96 LOISY A. F., Le quatrième évangile: les épîtres dites de Jean, p. 506.97 CRISOSTOMO, Homilies on the Gospel of St. John and the Epistle to the Hebrews, p. 446.
29
Mantenere la tensione del lettore è molto importante nella moderna letteratura come in quella
antica. L'evangelista non si avvede di creare malintesi? Egli li crea deliberatamente, in modo che il
lettore sperimenti da sé quanto descritto98. Così, prosegue O'Brien99, si potrebbe tranquillamente
presumere che il lettore si identifichi con i personaggi che provano confusione, incertezza o
incomprensione e che traggono profitto dall'esperienza. Il lettore si identifica, fa gli stessi errori e
impara da loro.
Chi era Yehoshua ben Yosef? Chiediamolo a chi lo ha incontrato, a chi ha vissuto con Lui, al sui
discepoli più vicini. Filippo incontra Natanalele e gli dice. «Quello che Mosè ha scritto nella legge,
ed i profeti, noi l'abbiamo trovato: Gesù, figlio di Giuseppe da Nazaret» (Gv 1,45). Un parallelo di
Giovanni lo possiamo trovare nel racconto dei due discepoli sulla strada di Emmaus. Scrive Luca:
«E, cominciando da Mosè e tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui»
(Lc 24,27).
Prima di addentrarci nella comprensione delle parole di Filippo è utile, come richiamato da
Kaiser100, ricordare che : «Nel tentativo di mostrare che il Messia, e molti altri eventi della chiesa
del primo secolo, sono stati anticipati negli scritti del Vecchio Testamento, gli Autori del Nuovo
Testamento hanno menzionato onestamente le citazioni dell'Antico Testamento secondo il vero
intendimento e il significato originale degli Autori?». Noi preferiamo credere che abbiano
richiamato i passi della Scrittura in modo onesto, ma non ne abbiamo le prove. Tuttavia, è plausibile
che i redattori del Nuovo Testamento abbiano riportato le citazioni dell'Antico testamento così come
venivano interpretate nel loro contesto vitale.
Le idee fondamentali che circolavano nel giudaismo del tempo di Gesù erano: la fede in un Dio che
si è rivelato nella storia, il giudizio di Dio sul mondo e l'attesa di un Messia, importanza della
Legge, senso del peccato e origine del male101. Mosè in Dt 18,15 scrisse: «Il Signore tuo Dio,
susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto». Queste
parole hanno originato la tradizione di un Mosè redivivo e l'attesa simile del ritorno di Elia, che fu
rapito in cielo e non morì (2Re 2,11); Israele attendeva un Messia profeta. Tuttavia è l'ideologia
regale che ha il rilievo maggiore nella nascita dell'attesa messianica102. Questa attesa si origina dalla
concezione della regalità di Dio, che mediante l'unzione, costituisce un re terreno che governa nel
suo nome. La regalità di Dio è un'immagine relativamente tarda nell'Antico Testamento, che venne
dapprima collegata con la vittoriosa uscita dall'Egitto dai redattori del Pentateuco (Es 15,18; Nm
98 O'BRIEN K., Written that you may believe: John 20 and narrative rhetoric, p. 288.99 O'BRIEN K., Written that you may believe: John 20 and narrative rhetoric, p. 292.100 KAISER W.C. Jr., The uses of the Old Testament in the New, pp. X-XI. 101 SACCHI P., È possibile ricostruire il background culturale di Gesù? CHARLESWORTH J.H., In Gesù e la
comunità di Qumran, p.151.102 Per una trattazione più completa si veda FABRY H. J., SCHOLTISSEK K., Il Messia, Editrice Dehoniane, Bologna
2004.
30
23,21; Dt 33,5). Chi regge il mondo è Dio in quanto è Lui che lo ha creato, lo regge secondo
giustizia e opera per la vita e il benessere delle sue creature. Scrive Isaia: «il Signore è seduto su un
trono alto ed elevato» (Is 6,1). Gli altri profeti ne parlano diversamente e lo immaginano come re
quando egli interviene nella storia con la sua potenza. Dopo l'esilio, l'immagine del Messia regale si
proietta nel futuro (Is 24,23; 33,17-24) diventando escatologica. Assume anche un'altra
connotazione, non è più un Messia che libererà solo il popolo di Israele. Diventa universale, si
manifesterà anche agli altri popoli (Ger 46,18; 48,15; 51,57). Il Messia condurrà il gregge come un
pastore alla sua testa (Mi 2,13).
Nel tempo postesiliaco, con la caduta del regno e della dinastia davidica, il sacerdozio e in
particolare il Sommo sacerdote diventa l'oggetto della speranza, ma con l'esperienza fallimentare
degli asmonei (re di stirpe sacerdotale), la la concezione di un re-sacerdote escatologico sparisce dal
giudaismo.
Un'altra figura messianica è quella del servo di YHWH descritto da Isaia, che può simboleggiare
Israele oppure il profeta stesso. Visto che ha un compito nei confronti di Israele potrebbe
identificare anche un gruppo determinato. Il testo però non permette di essere interpretato
messianicamente se non alla luce dell'interpretazione messianica-cristologica.
A partire dal II secolo a.C. si fa strada l'idea di una catastrofe universale che nasce dall'elaborazione
scenica del dualismo cosmico (Libro di Daniele, Libro di Enoch). Il Figlio dell'uomo è in origine un
cavaliere escatologico che ha sembianze d'uomo, sta seduto sul trono di Dio e con l'aiuto delle
schiere celesti giudicherà l'umanità. Il suo giudizio separerà i giusti per la beatitudine e i malvagi
per lo stagno di fuoco. Viene talvolta identificato con il Messia, tal altro con Enoch, che fu rapito in
cielo (Libro etiopico di Enoch).
Quel che è certo, e come dimostrano anche i documenti ritrovati a Qumran, nel protogiudaismo era
presente una differenziazione delle aspettative messianiche, basate sulle diverse tradizioni bibliche.
La disparità delle concezioni indica che i discepoli non avevano una conoscenza certa riguardo alla
figura concreta del messia. Anche Pietro, quando fa la sua professione di fede, lo chiama con un
termine che la tradizione giudaica non designa il Messia103 (Gv 6,69).
Gesù, il Cristo, Figlio di Dio
Per Martyn104 la pericope in Gv 1,35-49 costituisce parte di un'omelia antica. Lo scopo di questa
omelia era quella di convincere i giudei a “venire” (Gv 1,39.46-47) a Gesù e diventare suoi
discepoli. Il gruppo dei giudeo-cristiani non aveva un comportamento lassista riguardo alla Torah,
103 SEGALLA G., Giovanni, p. 243.104 MARTYN J.L., History and theology in the Fourth Gospel, p. 147-148.
31
ma piuttosto manifestava la confessione che Gesù è il Messia105. Infatti la birkath ha minin
(benedizione contro gli eretici) sembra essere più diretta verso il riconoscimento che Gesù è il
Cristo (Gv 9,22), piuttosto della discreta violazione della Torah operata dai giudeo-cristiani. La
risposta data da Natanaele: «Rabbi, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re di Israele» (Gv 1,49), è la
confessione di fede di un vero israelita e Gesù viene identificato con quel Figlio dell'uomo descritto
dal profeta Daniele (Dn 7,13).
Così Maria se ne sta fuori dalla tomba e piange. Questo pianto, che sia associato alla lamentazione
funebre o alla sparizione del corpo di Gesù per trafugamento, sta comunque ad indicare che
l'oggetto del pianto è una persona morta. Maria Maddalena cerca il suo maestro, il sant'uomo che è
stato innocentemente appeso alla croce e dopo una lunga agonia ha lasciato orfani i suoi discepoli.
Così come Critone piange: «un uomo, lo possiamo dire, che, fra quanti allora conoscevamo, fu il
migliore e anche il più sapiente e più giusto»106.
Accade però qualcosa di eccezionale, Maria vede due angeli. L'autore del quarto Vangelo cerca di
farci capire che qualcosa di straordinario sta accadendo. La Maddalena, pur essendo ancora legata
nel suo pensare Gesù ad un essere umano, comincia a sperimentare un “vedere” diverso. Il verbo
cambia, è un verbo che esprime ancora un'imperfezione, ma ci prepara a qualcosa di più grande.
Maria Maddalena – e il lettore implicito – riuscirà a capire la rivelazione che in lei si sta
compiendo107? Simbolicamente è la prova di Gesù come il Nuovo Essere che mette in grado l'essere
umano di distogliere lo sguardo da sé stesso e dal suo grado di alienazione e di auto-distruzione, per
rivolgerlo verso Dio108. È il nuovo essere umano (o uios tou anthropou) su cui poggia la scala
celeste che unisce il cielo e la terra (Gv 1,51)? Gli angeli sono, per loro natura, dei messaggeri che
contribuiscono a mantenere in relazione Dio con l'uomo. La posizione dei due angeli: «uno in
corrispondenza del capo e l'altro dei piedi» (Gv 20,11), implicano un rifiuto del dualismo filosofico
lasciando intendere l'unificazione dell'essere umano celeste e l'essere umano sulla terra che Gesù ha
incarnato durante il suo ministero e che continua ad incarnare spiritualmente nella risurrezione109.
Da un lato, pensa Maria Maddalena, egli è il figlio di Giuseppe il falegname di Nazaret, su cui è
sceso lo Spirito di Dio e sul quale è rimasto (Gv 1,32-33). Dall'altro, sembrano dire gli angeli, è il
Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo (Gv 3,13).
Mentre “osserva” tutto questo, Maria non capisce quello che sta vedendo. Quando gli angeli le
chiedono perché piange, ella non interloquisce con loro. Non entra nella loro realtà per indagare
105 MARTYN J.L., History and theology in the Fourth Gospel, p. 152.106 PLATONE, Fedone, p. 289.107 WAETJEN H. C., The Gospel of the Beloved Disciple: a work in two editions, p. 415.108 TILLICH P., Teologia sistematica, l'esistenza e il Cristo, vol. 2, p. 195.109 BARRETT C. K., The Gospel according to St. John, p. 564
32
sulla loro rappresentazione del paradosso dell'attualità della persona di Gesù110. Ella spiega loro
semplicemente quello che ha riferito a Pietro e al Discepolo prediletto: «Hanno portato via il mio
Signore, e non so dove l'abbiano posto» (Gv 20,13).
Non dice altro Maria, sente la presenza di qualcun altro e si volta indietro. “Vede” Gesù, ma non lo
riconosce. Ancora è un vedere non pieno, è ancora un osservare. Gesù ripete la domanda che già
hanno fatto gli angeli, ma lei pensa che sia il giardiniere e persiste nella sua cecità. Allora Gesù la
chiama per nome : «Mariam!». È l'atto creativo che finalmente le rivela l'identità della sua presenza
ed ella riconosce il maestro, il pastore che chiama per nome le sue pecore (Gv 10,3-4). Si getta
verso di lui per abbracciarlo, lui la ferma: «non mi trattenere» (Gv 20,17).
«La via che dovete seguire, io l'ho mostrata a voi e conduce là sulla croce – sembra dirle Gesù – ma
non si è fermata là». Gesù si è sottomesso all'alienazione esistenziale, malgrado ciò l'ha vinta. La
sua vittoria sull'esistenza è espressa dalla risurrezione del Cristo111. Si è incarnato uscendo da Dio e
compiendo la sua missione fino in fondo. La sua salita al Padre, frutto della sua fedeltà, è il
compimento della sua opera, perciò non è per la morte subita, ma per l'esaltazione presso il Padre
che ha ottenuto la filiazione divina degli umani112. Questa è la ragione per cui Maria non può
trattenerlo tutto per sé, come quando era “vero uomo”. Maria non può tenere per sé il Cristo. Il
rifiuto di Gesù, il Cristo, a Maria non indica una volontà di separazione, di allontanamento, come se
fosse reso impuro se toccato da una donna. Gesù, il Cristo, affida a Maria una missione prioritaria a
questo abbandono umano-emozionale. Lui ritorna da chi lo ha mandato. Colui che lo ha inviato è
suo Padre e suo Dio. Ma questo Padre e Dio è anche Padre e Dio nostro, di noi umani. Questa è la
missione, portare questo annuncio ai discepoli. Il Padre non è solo Padre di Gesù, il Cristo, Figlio di
Dio, ma anche Padre nostro e Dio nostro.
Gesù non è semplicemente un uomo, è il Messia inviato dal Padre perché: «Chi ascolta la mia
Parola e crede a Colui che mi ha mandato ha la vita eterna, e non incorre nel giudizio ma è passato
dalla morte alla vita» (Gv 5,24). La morte non è stata capace di trattenerlo nella alienazione
esistenziale, la vita individuale concreta dell'uomo Gesù di Nazaret viene innalzata dalla
transitorietà alla presenza eterna di Dio come Spirito113. Ma per far questo la Parola doveva
diventare carne, subire la sofferenza dei poveri, dei perseguitati, degli emarginati. Portando al suo
estremo l'incarnazione, Gesù rivela l'interesse più urgente per il Padre, che non è la sua “gloria” né
l'essere servito, ma la sofferenza delle sue figlie e dei suoi figli114. Questo è il messaggio che deve
portare Maria Maddalena ai discepoli, non può tenerlo per sé, deve gridarlo al mondo, Gesù, il
110 WAETJEN H.C., The Gospel of the Beloved Disciple: a work in two editions, p. 415.111 TILLICH P., Teologia sistematica, l'esistenza e il Cristo, vol. 2, p. 168-169.112 LEON DUFOUR X., Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni, p. 288.113 TILLICH P., Teologia sistematica, l'esistenza e il Cristo, vol. 2, p. 173.114 TORRES QUEIRUGA A., Il mistero di Gesù il Cristo: divinità nell'umanità, p. 458
33
Cristo, venuto per noi ritorna al Padre!
L'incontro con il risorto ha aperto gli occhi di Maria, non solo gli occhi, anche la mente e il cuore.
L'esperienza con il risorto, ascoltare le sue parole, entrare in relazione con Lui, è la “visione” che
porta alla fede. Questo ha “visto” Maria Maddalena, perciò va dai discepoli e annuncia: «Ho visto
il Signore» (Gv 20,18). In quel momento nasce la Chiesa, quando donne e uomini discepoli di Gesù,
il figlio del falegname di Nazaret, proclamano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio.
Il quarto Vangelo aiuta a ricreare l'esperienza dei discepoli che hanno incontrato Gesù e il percorso
di fede che devono fare i suoi lettori. Sottoponendoci alla confusione iniziale sperimentata da Maria
Maddalena e portandoci a nuovi modi di vedere, fa in modo che possiamo acquisire una
comprensione più chiara di chi è entrato nel mondo e nel suo grande amore ha parlato agli uomini
come ad amici e si intrattenuto con essi115. Ci aiuta a credere, senza aver visto, che Gesù è il Cristo,
Figlio di Dio.
«Umano così come è stato Gesù può esserlo solo Dio stesso»
Leonardo Boff, Jesus Cristo Libertador.
115 DEI VERBUM, n. 2.
34
BIBLIOGRAFIA
1. Fonti
• Le citazioni dalla Bibbia sono riprese da “La Sacra Bibbia”, CEI UELCI, Roma, 2008;
mentre per il Vangelo di Giovanni ci si è riferiti alla traduzione di SEGALLA G., Giovanni,
Edizioni San Paolo, Roma 200811;
• NESTLE E. - ALAND K., Novum Testamentum Graece, Stuttgart 199527;
• WILLKER W., A textual commentary on the greek gospels, www-user.uni-
bremen.de/~wie/TCG/TC-John.pdf - 14/12/2010
2. Strumenti di lavoro
• DANKER F. D., The concise Greek-English lexicon of the New Testament, The University
of Chicago Press, 2009;
• BURER M. H., MILLER J. E., A New Reader's Lexicon of the New Testament, Kregel
Publications, Grand Rapids MI, 2008.
3. Commentari
• AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, Città Nuova, Roma, 2005;
• BARRETT C. K., The Gospel according to St. John, The Westmister Press, Philadelphia,
19782;
• BERNARD J. H., Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John,
Clark - 2 volumi, Edinburgh 1928 (ristampa 1999);
• BROWN R. E., Giovanni, Cittadella Editrice, Assisi 20056;
• CRISOSTOMO, Homilies on the Gospel of St. John and the Epistle to the Hebrews, Schaff
P, T&T Clark, Peabody (MA), 1995;
• DODD C. H., The interpretation of the fourth Gospel, University Press, Cambridge, 1953;
• FABRIS R., Giovanni, Roma 1992;
• LEON-DUFOUR X., Lettura dell’Evangelo secondo Giovanni, 4 voll, Cinisello Balsamo
1990-1998;
• LOISY A. F., Le quatrième évangile: les épîtres dites de Jean, Emille Nourry Editeur, Paris
1921;
35
• SANTI GRASSO, Il vangelo di Giovanni, Roma 2008;
• SEGALLA G., Giovanni, Edizioni San Paolo, Roma 200811;
• TOMMASO D'AQUINO, Commento al Vangelo di San Giovanni, Città Nuova, Roma,
1992;
• WILCKENS U., Il vangelo secondo Giovanni, Brescia 2002;
4. Altri studi
• AGOSTINO, Esposizione sui salmi, 103, 1, 15;
• AMBROSII, De officiis Ministrorum, Henrici Laupp, Tubingen 1857;
• BAGATTI B., Antichi villaggi cristiani di Galilea, (SBF Collectio Minor 13), Gerusalemme
1971;
• BALAGUÈ M., La prueba de la Resurrección (Jn 20,6-7), Estudios Bìblicos 25 (1966),
169-92;
• BAUM A. D., «Autobiografische Wir- und Er-Stellen in den neutestamentlichen
Geschichtsbüchern im Kontext der antiken Literaturgeschichte», Biblica 2007; Vol. 88:473-
495;
• BLACK M., An Aramaic approach to the Gospels and Acts, Clark, Edinburgh, 1928;
• BULTMANN R., Teologia del Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia, 19922;
• DALMAN G., Grammatik das judisch-palastinischen Aramaish, Leipzig, 1905;
• DERRET J. D. M., Studies in the New Testament: Jesus among biblical exegetes, Leiden,
1995;
• DODD C.H., According to the Scriptures: the sub-structure of New Testament theology,
London, 1952;
• DODD C. H., Historical Tradition in the Fourth Gospel, Cambridge University Press, 1963;
• FORESTELL J. T., The Word of the Cross, Analecta Biblica 57, Biblical Institute Press,
Roma, 1974;
• FORTNA R., The fourth gospel and its predecessor, T&T Clark International, New York,
20042;
• GEORGE L.D., Reading the Tapestry: A Literary-Rhetorical Analysis of the Johannine
Resurrection Narrative (John 20-21), P. Lang Pub Inc, New York, 1999;
36
• HARTMANN G., “Die Vorlage der Osterberichte in John 20”. Zeitschrift für die
Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Älteren Kirche (1964). Volume 55,
Issue 2, Pages 197–220;
• KAISER W.C. Jr., The uses of the Old Testament in the New, Moody, Chicago, 1985;
• LAVERGNE C., Le sudarium et la position des linges après la résurrection, parte di un
articolo in Sindon 3, 5/6 (1961), 1-58;
• MARTYN J.L., History and theology in the Fourth Gospel, Westminster John Knox Press,
Louisville US-KY, 2003;
• NICHOL F.D., Answers to objections, (Teach Services, Inc), Washington, D.C., 2005;
• O'BRIEN K., Written that you may believe: John 20 and narrative rhetoric, The Catholic
Biblical Quarterly, 2005; 67,284-302;
• PARROT A., Golgotha e Santo Sepolcro, Ed.Paoline, Roma 1972;
• PHILLIPS G. L., Faith and Vision in the Fourth Gospel, in Study in the four Gospel, p. 83-
96, ed. F.L. Cross, London, 1957;
• PLATONE, Fedone, a cura di Reale Giovanni, Bompiani, Milano, 2000;
• SACCHI P., È possibile ricostruire il background culturale di Gesù? CHARLESWORTH
J.H., In Gesù e la comunità di Qumran, Piemme, Casale Monferrato 1995;
• TERTULLIANO, De Spectaculis, XXX;
• TILLICH P., Teologia sistematica, l'esistenza e il Cristo, Claudiana, Torino, 2001;
• TORRES QUEIRUGA A., Il mistero di Gesù il Cristo: divinità nell'umanità, Concilium
2008; 3,44-57;
• WAETJEN H.C., The Gospel of the Beloved Disciple: a work in two editions, T & T Clark
International, New York, 2005.