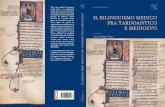"Un'ipotesi di "scarico" medievale nel porto di Messina", in Archeologia Postmedievale, n°16, dal...
Transcript of "Un'ipotesi di "scarico" medievale nel porto di Messina", in Archeologia Postmedievale, n°16, dal...
89
Archeologia Postmedievale16, 2012, pp. 89-98
Un’ipotesi di “scarico” medievale nel porto di MessinaPhilippe Tisseyre, Giuseppe Cambria
1. Premessa
La topografia della città di Messina e la geomor-fologia della cosiddetta zona falcata sono state ampiamente studiate, mentre il porto e le sue immediate vicinanze sono stati oggetto di una vasta bibliografia1. Tali studi hanno evidenziato lo spostamento diacronico del fronte mare dell’an-tica colonia di Zancle da sud verso nord: a sud del porto, gli scavi effettuati durante i dragaggi negli anni 1970-1980, alla banchina Egeo, hanno evidenziato una stratigrafia dei depositi marini, col ritrovamento a -1 m sotto il livello del mare di sab-bie contenenti ceramiche protocorinzie e corinzie, mentre all’epoca romana, lo sviluppo della città si è concentrato nell’area tra i torrenti Portalegni a sud e Boccetta a nord (fig. 1).In questa zona, gli scavi archeologici del 2001 avevano permesso di conoscere il limite dell’abitato e la sua distanza dal mare, più specificatamente davanti all’attuale Municipio2.I recenti studi effettuati sulla distribuzione dei siti archeologici hanno messo in corrispondenza queste stratigrafie con quella della Piazza Caval-lotti, distante 150 m a sud dell’area interessata dai nostri sondaggi. Lì, il livello stratigrafico, sabbie contenenti ceramica di epoca romana, testimo-niava il sollevamento dell’area e la conseguente formazione della zona falcata. Sotto le banchine attuali si estendeva una spiaggia, che nel tempo si è allargata e consolidata grazie ai coni alluvionali dei due torrenti, creando uno spazio poco a poco occupato dalla città medievale, secondo un’espan-sione ancora tutta da studiare3.Durante questo periodo, l’attracco delle numerose navi dirette verso il Vicino Oriente, come lo de-scrive Ibn Qubayr nel XII sec., avveniva nella zona di maggiore profondità del bacino, forse vicino all’odierna Capitaneria: «Mirabilissimo poi tra tutti i porti di mare, poiché non vi è grosso legno (nave)
che non possa avvicinare da toccare la terra, e vi si passa mettendo soltanto un asse sulla quale salgono i facchini co’ pesi in spalla».Questa immediata profondità del bacino portuale, di una praticità unica per lo scarico e il carico delle merci, si trovava in corrispondenza con una porta urbana, aperta nella cinta della città dal XVI sec. al-meno fino al XVIII sec., poi successivamente chiusa. Sulle carte topografiche del XVI-XVIII sec.4, parti-colarmente sulla carta dell’architetto Gianfrancesco Arena del 1763, si possono osservare, sulla linea di riva all’altezza dell’attuale municipio, due grandi coni di avanzamento sedimentari coni alluvionali.È molto probabile che queste strutture naturali, parzialmente edificate, furono inglobate sotto il molo moderno. La zona indagata, come si può anche notare sulla carta di Braun Georg e Franz Ho-genberg (Civitates Orbis Terrarum – Messana Urbs est Sicilie incisa a Colonia tra il 1572 e il 1612) (fig. 2) ha interessato la parte terminale di questi coni allu-vionali, dovuti allo sbocco dei fiumi, forse diventati zone di scarico del materiale cittadino, in seguito allo smantellamento delle fortificazioni urbane e alla deviazione del fiume Portalegni nel XVI sec. (fig. 3b). La carta attesta anche la densità dell’attracco delle navi proprio di fronte alla porta urbana, e cor-risponde all’area interessata ai nostri ritrovamenti, dalle banchine Colapesce e Vespri, all’altezza di via di Santa Maria la Porta all’incirca, all’altezza vicino al largo San Giacomo-Via Garibaldi.I lavori odierni di ristrutturazione delle banchine del porto consistevano in un riallineamento della rientranza compresa tra l’antico sbocco del fiume Portalegni (figg. 3a e 3b, freccia nera), corrispon-dente al lato sud dell’attuale Piazza Europa, fino alla banchina della Capitaneria di Porto. La Soprin-tendenza del Mare ordinò una indagine preventiva nel luglio 2008 con ricerche strumentali e verifica autoptica dei targets rinvenuti5, mentre la missione
1 In particolare nei volumi di Bacci, Tigano 2001.2 Fiorilla 2001, pp. 110-140.3 Bacci 2001, p. 55.
4 Particolarmente sulla carta dell’arch. Gianfrancesco Arena del 1763, Bacci 2001, tav. I.
5 Indagine e grafici realizzati da G. Lezziero. Le zone dei saggi 10/12 (N) e 13/15 (S) sono segnalate con un alta densità di reperti.
90
Philippe Tisseyre, Giuseppe Cambria
fig. 1 – Localizzazione del fronte mare dell’antica colonia di Zancle.
fig. 2 – La zona indagata localizzata sulla carta di Braun Georg e Franz Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum- Messana Urbs est Sicilie, incisa a Colonia tra il 1572 e il 1612.
di scavo invernale fu congiunta con il 3° Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera di Messina, già formato alle ricerche subacquee dalla Soprin-tendenza del Mare6.Le problematiche riguardante i ritrovamenti in zona erano particolarmente complesse: erano già
stati segnalati ritrovamenti fortuiti di ceramica tipo Spiral Ware durante i lavori preliminari dei sondaggi sui pilatri dalla banchina Vespri, destinata all’attracco delle navi da crociera.Sono state eseguite ricerche con subbottom profiler, e successivamente alcuni sondaggi su targets, in una zona di maggiore densità, di 20 m ca., laddove il fondale fangoso sprofonda rapidamente sulla ba-timetria di -34 m (fig. 3a), mentre i lavori erano in corso.Lungo tutta la banchina, la partenza e l’arrivo delle navi da crociera hanno creato, con il movimento delle grandi eliche, un fosso parallelo di 7/8 m ca. di larghezza per una profondità di 8 m ca., provo-cando l’asportazione dei livelli di sabbie primarie – a differenza di Piazza Cavalotti –, privandoci del dato allora segnalato e creando di fatto un’inver-sione stratigrafica.Verso sud, il fondale risale di tre metri ca. per scendere rapidamente di quota, segnando la fine del conoide alluvionale del torrente Portalegni (fig. 3b).La quasi assenza sott’acqua di elementi di divisione stratigrafica percettibili, come spesso accade in contesti subacquei, lascia presupporre un’unitarietà che non corrisponde alle ovvie successioni stratigra-fiche e diacroniche. L’unico elemento di divisione autoptico tra gli strati del fondale, sotto il deposito
6 Si ringrazia il Cmdt Majko Aldone e la Capitaneria di Porto di Messina – III Nucleo Sommozzatori, per il sopporto logistico.
91
Un’ipotesi di “scarico” medievale nel porto di Messina
fig. 3a – Localizzazione delle ricerche con subbottom profiler e sondaggi su targets.
alluvionale sabbioso, è la presenza, sul lato nord, di un settore di rocce naturali miste a pietrame, probabile strato primario di deposito sedimentario, non intaccato dalle eliche delle navi, né da pilastri
di pontili, ma non indagato per ragioni di tempo durante questa breve campagna.A differenza delle altre zone del porto – sud e sud-est7 –, tuttavia, non era stata mai segnalata la presenza di reperti archeologici in quest’area del porto, mentre i saggi odierni hanno evidenziato la concentrazione di materiale ceramico del periodo tardo-medievale, soprattutto nella parte nord della banchina Colapesce (sondaggi 10/12 e 13/15).A dispetto delle considerazioni generiche raccolte in loco sul riversamento nel porto delle rovine dei fabbricati distrutti dopo il terremoto e tsunami del 1908, in atto mai verificati, non si sono rinvenuti scarichi di epoca recente, ma, al contrario, si è evidenziato un deposito di materiale ceramico da-tabile in gran parte tra il XIII e il XVIII sec., in una zona comunque già profondamente antropizzata dalla creazione delle banchine portuali e dall’allar-gamento della strada del lungomare dopo il 1908. Tali accumulazioni di materiale potrebbero corri-spondere ad operazioni di scarico legate a l’attività mercantile e alla vita delle navi ormeggiate. Le ri-cerche effettuate hanno in un breve tempo restituito una grande quantità di frammenti ceramici e altri materiali (200 frammenti ca.). In particolare, sono stati rinvenuti, in un primo controllo (v. tab. 1).Da questo breve elenco si evince la varietà cro-nologica e tipologica dei ritrovamenti nell’area, ancora in corso di studio. Il materiale possiede una stretta affinità cronologica con i reperti prove-
7 Bonofiglio 2001, pp. 9-17.
fig. 3b – Fine del conoide alluvionale del torrente Portalegni.
92
Philippe Tisseyre, Giuseppe Cambria
periodo tipologia quantità sondaggioIII-II a.C. ceramica antica 2 13 lato EVII d.C. anfora tipo L52 2 13 lato E, 10 lato WX-XI bacini invetriati 2 10 lato WXI-XII lucerne invetriate 2 10 lato W
XII anfore à cannelures 8 15 lato W, 13 lato E, 10 lato W
XII-XIII spiral ware 1 13 lato EXIII ceramica graffita arcaica 1 13 lato EXIII ceramica invetriata 2 13 lato EXIII protomaiolica Gelaware 4 13 lato EXIII-XIV ceramica da cucina 10 12 lato WXIV ceramica da cucina 5 13 lato EXV ceramica maiolicata 3 13 lato EXV ceramica a lustro 1 15 lato WXV-XVI ceramica smaltata 1 10 lato WXV-XVI ceramica invetriata 1 13 lato EXVI ceramica graffita 2 15 lato WXVII lucerne 6 13 lato EXVII anfore/giare 6 15 lato W, 13 lato EXVIII-XIX bottiglie di vetro 4 15 lato W
XIX ceramica da cucina prod. Patti 6 13 lato E
? Tegole 5 15 lato W, 12 lato W
tab. 1 – Distribuzione cronotipologica.
nienti dagli scavi del Municipio, sito sulla riva ad una cinquantina di metri in direzione sud-ovest8 (fig. 3b, puntini neri), e conferma la destinazione commerciale di alcune produzioni, legate alla vita quotidiana (ceramica da cucina, pentole, tegami, ma anche d’igiene) e si differenziano tra produzioni locali e importazioni. Lo studio di questi materiali, alcuni dei quali abbandonati durante lo scalo, e l’a-nalisi delle ceramiche provenienti da altri contesti immersi, chiusi, come i relitti, potrebbe evidenziare l’uso di determinare produzioni, permettendo di definire quelle specificatamente in uso a bordo, mentre il contesto diacronico permetterebbe anche di localizzare le aree di distribuzione delle diverse produzioni di ceramica rinvenute. L’analisi delle ceramiche provenienti da altri contesti immersi, chiusi, come i relitti, potrebbe evidenziare l’uso di determinate produzioni, permettendo di definire quelle specificatamente in uso a bordo, mentre il contesto diacronico permetterebbe anche di localiz-zare le aree di distribuzione delle diverse produzioni di ceramica rinvenute.La quasi assenza di reperti metallici (una sola pen-tola in rame), la numerosa presenza di resti ossei animali, la concentrazione dei reperti ceramici,
8 Fiorilla 2008, pp. 27-35. Non si possono ignorare la presenza delle vicine fornaci medievali di Piazza S. Pugliatti, databili della fine del XII-primo quarto del XIII sec.
elevata per l’esiguità della zona indagata, ma non cronologicamente unitaria, ci permette dunque di avanzare l’ipotesi di una zona di scarico del tipo domestico (differenziandola in tale senso dalle discariche di tipo preindustriale o specifiche a materiali definiti), ipotesi ancora da verificare.Tuttavia la puntualità dei sondaggi, che ci hanno fatto percepire la ricchezza della zona, rimane un’arma a doppio taglio, in assenza di scavo siste-matico, per le scelte interpretative, rese particolar-mente complesse dalla successione degli interventi sulle sponde e le banchine, dall’interramento e dal dirottamento del corso dei fiumi urbani, dalla chiusura della porta urbana, dal rifacimento e della distruzione delle muraglie urbane, in presenza di una stratigrafia praticamente unitaria.Resta sempre da determinare se i rinvenimenti riguar-dano una zona volutamente trasformata in discarica (dunque una zona preferenziale per una discarica “pubblica”), o se per lo più, si tratta di materiali persi o buttati a mare durante le operazioni di scarico/ca-rico merci, o attinenti alla vita del porto, nell’ambito di una fitta rete di contatti commerciali estesi da nord verso sud, o se l’apporto del materiale detritico dei fiumi è stato rimescolato o dragato al fine di evitare il rischio di chiusura naturale del porto9.
2. Catalogo
1. Bacino carenato invetriato (fig. 4)Banchina Colapesce (ME)Frammento di bordo di bacino carenato.Ceramica.Lunghezza fr. 8 cm, H. 4 cmLabbro dritto ingrossato, tracce sbiadite di colore verde e giallo.Fine X-XI sec. (?)Cfr: Molinari 1995, p. 192.
2. Lucerna invetriata verde (fig. 5)Banchina Colapesce (ME)Frammento di parete, con inizio di piccolo manico trian-golare verticale.Ceramica impasto rosastroLunghezza fr. Circa 10 cm.Corpo di lucerna con attaccatura di ansa. Invetriatura verde.XI-XII sec.Cfr: Ghizolfi 1993, p. 213, figg. 19-20.
3. Pentola invetriata verde (fig. 6)Banchina Colapesce (ME)Frammento.Ceramica da cucina.
9 Provansal, Morhange, Vella 1995, pp. 93-100.
93
Un’ipotesi di “scarico” medievale nel porto di Messina
Lunghezza fr. 12 cm, alt. 13, 2.Orlo estroflesso, ansa a nastro, invetriata verde spessa, decorazione a zigzag sotto l’orlo.XII sec.Cfr: Ardizzone 1990, p. 313 per la forma, fig. 59b e tav. XXIIIb per la decorazione.
4. Scodella graffita arcaica (fig. 7)Banchina Colapesce (ME)Frammento.Ceramica biancastra con inclusi di chamotte e frag. di quarzite.Lunghezza fr. circa 10 cmFondo di scodella con base e piede ad anello dritto. Deco-razione con figure geometriche graffite a reticolo.Fine del XII-prima metà del XIII sec. prod. Ligure (Savona)Cfr. http://www2.archeo.unisi.it/testi/ceramica/Cera-mica_15_Grassi.pdf – Grassi, pp. 251-255, p. 261, fig. 140a, prima immagine in basso a sx.
5. Scodella Spiral Ware tipo IV (fig. 8)Banchina Colapesce (ME)Frammento di scodella, fondo.Ceramica tipo Spiral Ware.Diam. 0,8 cm,Fondo di scodella con base ad anello. Decorazione a cerchi concentrici e macchie tipo IV Spiral warefine XII-meta XIII sec. Prod. Italia meridionale.Cfr: Italiano 2009, pp. 151-172, tav. 1, n. 1, p. 163.http://www.arcmed-venezia.it/IXaiecm2/posters/06_ce-ramiche_contesti_sociali.pdf – Cuteri et al., tav. 5 tre esempi di Spiral Ware, fr. N. 5-12-14.Lesnes 1998, pp. 29-30-31, cat. 3, fig. 2.a, tav. I, n. 1, p. 39, cat. 2, fig. 2b, tav. I, n. 1b, p. 40.
6. Scodella proto maiolica (fig. 9)Lato Est, Messina-Colapesce (ME)Parzialmente integra.Tracce di invetriatura gialla e verde.Diam. 18 cm, H. 3,4 cmOrlo arrotondato, leggermente concava al centro, piede ad anello, cordolo all’attacco del corpo.Decorazione rovinata dagli agenti marini e concrezioni.Probabile XIII sec. (?) produzione Messinese.Per la forma cfr. Italiano 2009, p. 158, n. 19.
7. Piatto protomaiolica Gelaware (fig. 10)Banchina Colapesce (ME)Frammento di tesa.Ceramica tipo Gelaware. Prod. Salentina?. Pasta molto depurata colore rosaLunghezza fr. 8 cm.Labbro di piatto, estroflesso. Decorazione in bianco e verde con un motivo geometrico ad arco.XIII sec.Cfr: Ragona 1997, pp. 5-16.
8. Boccale invetriato verde (fig. 11)Banchina Colapesce (ME)Lacunario del becco e della parte superiore.Corpo a conoide, base piatta. Ansa a nastro. Decorazione
in verde con linea orizzontale ancora visibile e tracce di decorazione verde sul corpo. Tracce di invetriatura traspa-rente sul manico e interna.Argilla colore marrone chiaro, depurata.sec. XIII.Cfr: Fiorilla 2001, pp. 110-140, Catalogo, n. 18, p. 121.
9. Pentola (?) invetriata (fig. 12)Banchina Colapesce (ME)Frammentario.Ceramica.Lunghezza fr. 25 cm, H. 20 cmOrlo rigonfio, parete concava. Invetriatura miele. Bordo “a onde” estroflesso.XIII-XIV sec. Produzione messinese (?)Cfr: Molinari 1997, fig. 167, n. 1.1.4 per la forma dell’orlo.
10. Protocantaro (?) (fig. 13)Banchina Colapesce (ME)Frammentario.Ceramica fina argilla depurata, cassante.diam. 20 cmOrlo ingrossato, parete concava. Lacunaria del corpo. Becco versatoio sporgente.XIV sec. Produzione messinese (?)Cfr: Fiorilla 2008, p. 32, n. 17.
11. Piatto decorato a lustro (fig. 14)Banchina Colapesce (ME)Frammento di bordo.Ceramica decorata a lustro (?)Lunghezza fr. 15 cmOrlo leggermente estroflesso, parete concava. Invetriata in bruno rossiccio, pasta molto depurata, Decorazione a motivi geometrici sull’orlo, colore slavato da agenti marini.Fine XIV sec. (?)Cfr: Fiorilla 2001, pp. 110-120, Catalogo p. 133 – M/82.
12. Piatto prod. Pesarese (fig. 15)Banchina Colapesce (ME)Frammento di tesa con motivi italo-moreschi.Ceramica in lustro e blu cobalto, decorazione a fiore tri-lobata, tipo “Bryonia”prod. Pesarese (?)lugnh. Fr. 4 cm.meta XV sec.Cfr: Caminneci, Rizzo 2008, p. 60 n. 78.http://www.maiolichedelduca.it/fileadmin/grpmnt/5608/VocabDECORO.pdf – motivi italomoreschi, fr. N. 37, Pesaro Musei Civici inv. FR000562, p. 22
13. Piatto maiolicato tipo Brindisi (fig. 16)
Banchina Colapesce (ME)Frammento.Ceramica. Lunghezza fr. Circa 15 cmPiccolo labbro estroverso obliquo, tracce di decorazione in giallo (?) e verde. Concrezioni sul corpo.XV sec. (?). Produzione Pugliese (?).inedito.
94
Philippe Tisseyre, Giuseppe Cambria
fig. 4-16 – 4. Bacino carenato invetriato; 5. Lucerna invetriata verde; 6. Pentola invetriata verde; 7. Scodella graffita arcaica; 8. Scodella spiral ware tipo IV; 9. Scodella protomaiolica; 10. Piatto protomaiolica Gelaware; 11. Boccale invetriato verde; 12. Pentola (?) invetriata; 13. Protocantaro (?); 14. Piatto decorato a lustro; 15. Piatto prod. Pesarese.
4
9
6
8
5
10
7
151413
1211
95
Un’ipotesi di “scarico” medievale nel porto di Messina
figg. 16-23 – 26. Piatto maiolicato tipo Brindisi; 17. Scodella invetriata; 18. Scodella invetriata; 19. Catino maiolicato; 20. Piatto smaltato monocroma bianco; 21. Piatto maiolicato; 22. Lucerna su piede; 23. Lucerna su piede. candelabro; 24. Bottiglie in vetro nero; 25. Pentola quadriansata; 26. Stampo.
2120
1817
25
22
19
16
26
2423
96
Philippe Tisseyre, Giuseppe Cambria
14. Scodella invetriata (fig. 17)Banchina Colapesce (ME)Frammentario.Ceramica impasto rosastro, depurato.Diam. 0,13 cm, H. circa 8 cmOrlo leggermente obliquo, pareti verticali che diventano concave all’altezza della parte sovrastante la base con pie-de ad anello. Invetriatura piombifera colore miele (int.) tracce verdi (est.) decolorata, linea in bruno sulla parte superiore dell’orlo.Fine XV sec.-inizi XVI, prod. Sciacca (?)Cfr: Rizzo 2008, pp. 49-50.
15. Scodella invetriata (fig. 18)Banchina Colapesce (ME)Frammentario.Ceramica graffita.Lunghezza fr. 15 cm, H. 20 cmOrlo a tesa, parete concava e base ad anello. Internamente invetriato e decorato in verde e giallo con motivi periferici ad archi concentrici incrociati.Inizi XVI sec. Produzione padana o veneta (?)Cfr. http://www2.archeo.unisi.it/testi/ceramica/Cerami-ca_15_Grassi.pdf – Grassi, pp. 251-255, p. 266, fig. 141a.Caminecci, Rizzo 2008, p. 62, nn. 92-93.
16. Catino maiolicato (fig. 19)Banchina Colapesce (ME)Frammento di pareteCeramica rosastra impasto scurito dagli agenti marini.Lunghezza fr. 9 cm.Labbro bifido per coperchio, con parete verticale legger-mente svasata e parte di piede ad anello. Invetriato con decorazione geometrica a lampo, di colore giallo. Fondo con tracce di azzurro chiaro. Concrezioni sull’estremità inferiore del frammento.XV-XVI sec. Prod. Pugliese (?)Per una decorazione simile con motivo a monticello, cfr. Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, inv. FRC593 (ultimo quarto del XV sec.) http://www.maoilichedelduca.it/fileadmin/grpmnt/5608/VocabDECORO.pdfPer la decorazione vedere anche Rotili 2011, pp. 117-138; decorazione sulle invetriate dipinte f. 2 ma anche sulle “smaltate di transizione” f. 6 p. 133 databili al XIV-XVI sec.
17. Piatto smaltato monocroma bianco (fig. 20)Banchina Colapesce (ME)Frammento di tesa di piatto e cavetto profondoCeramica decorata a smalto, pasta rosastra ben depurata.Diam. calcolato 16 cm.Fine XV-primi decenni XVI sec.Produzione burgitana o calabrese (?)Cfr: Rizzo 2008, p. 68, fig. 8.; Busino 2011, p. 164, fig. 1, n. 6, terzo tipo con datazione al XIV-XV sec.
18. Piatto maiolicato (fig. 21)Banchina Colapesce (ME)Due frammenti.Ceramica molto depurata marrone chiaro.Lunghezza fr. 20 cm, H. 10 cm
Orlo obliquo, fondo piatto. Decorato con motivi con-centrici di colore blu, giallo e arancione, decorazioni geometriche sull’orlo.XVI-XVII sec. Produzione pugliese (?)Cfr: Parello 2008, p. 57.
19. Lucerna su piede (fig. 22)Banchina Colapesce (ME)Frammento di collo di lucernaCeramica rossastra.Lunghezza fr. 28 cmCollo di lucerna su piede, allungato, smalto verde. Ansa a nastro con presa piatta per pollice. Lacunaria del serbatoio.XVI-XVII sec.(?)Inedito.
20. Lucerna su piede-candelabro (fig. 23)Banchina Colapesce (ME)Candelabro frammentario.Ceramica depurata marrone chiaro, invetriatura marrone.Diam base del piede 12 cm.Corpo di lucerna su piede, probabile candelabro, con raccoglitore di cera a disco a mezz’altezza del corpo.XVI-XVII sec.(?)Inedito.
21. Bottiglie in vetro nero (fig. 24)Banchina Colapesce (ME)Frammento di fondo e parete di due bottiglie.Vetro nero.diam fr. 4,2 cmFondo di bottiglie, ad umbone arrotondato, apode. Vetro nero spesso.Produzione inglese? XVIII-XIX sec. d.C.Cfr: Serra 2006.
22. Pentola quadri ansata (fig. 25)Lato Est, 22/01/2009 Messina-ColapesceFrammentario.Ceramica da fuoco.Diam. 0,23 cm, H. 5 cmOrlo ingrossato a fascia, scanalato, per l’appoggio del co-perchio, forma circolare, con due manici con anse attaccate alla parete del corpo.Concrezioni sul fondo della pentola.XIX sec. produzione Messinese. Probabile Fornace di Patti. È stata segnalata a Patti Marina una zona di scarti in mare di questo tipo di produzione, in Archivi della Soprinten-denza del Mare, SIT 2013.Per la tipologia cfr. Puglisi 1997, p. 31, n. 11.
23. Stampo (fig. 26)Banchina Colapesce (ME)integro.Ceramica.Diam. 5,2 cm, H. 4 cmStampo o forma con in negativo un motivo geometrico-floreale.Inedito.Per tecnica cfr: Cuomo di Caprio 2007, pp. 221-222, fig. 59a.
97
Un’ipotesi di “scarico” medievale nel porto di Messina
BibliografiaArdizzone F. 1990, La ceramica, in S. Scuto (a cura di), L’età di
Federico II nella Sicilia Centro meridionale, Gela, pp. 310-321.Arthur P., Patterson H. 1994, Ceramics And Early Medieval
Central And Southern Italy: A Potted History, in R. Franco-vich, G. Noyé (a cura di), La Storia dell’altomedioevo italiano alla luce dell’archeologia, Firenze, pp. 191-240.
Bacci G.M., Tigano G. 2001 (a cura di), Da Zancle a Messina, un percorso archeologico attraverso gli scavi, 3 voll., Messina.
Bacci G.M. 2001, La carta archeologica, in Da Zancle a Messina, Messina 2001, Vol. II, tav. I.
Berti G., Tongiorgi L. 1983, I bacini ceramici medievali delle chiese di Pisa, Roma.
Berti G., Cappelli L. 1994, Lucca. ceramiche medievali e post-medievali (Museo Nazionale Di Villa Guinigi). I. Dalle ceramiche islamiche alle “maioliche arcaiche”, secc. XI-XV, Ricerche di archeologia altomedioevale e medievale, Firenze, pp. 19-20.
Berti G., Gelichi S. 1997, Mille Chemins Ouverts En Italie, in Le Vert Et Le Brun. De Kairouan À Avignon. Céramiques Du Xe Au Xve Siècle, Atti del Convegno (Avignon 1995), Firenze, pp. 129-151.
Bonofiglio L. 2001, La distribuzione dei siti archeologici, il contesto stratigrafico e la ricostruzione paleoambientale, in Da Zancle a Messina, vol. I., Messina, pp. 9-17.
Busino N. 2011, Aspetti innovativi e persistenze nella ceramica da mensa dal castello di Ariano Irpino tra basso medioevo ed età moderna, «Albisola» XLIII (2010), pp. 161-172.
Caminneci V., Rizzo M.S. 2008, Dal Butto alla Storia, vita al castello nuovo di Sciacca tra il XIV e il XVI secolo, Agrigento, pp. 48-60.
Cuomo di Caprio N. 2007, Ceramica in archeologia 2, Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine, Roma.
Fiorilla S. 1991, Considerazione sulle ceramiche medievali della Sicilia centro-meridionale, in S. Scuto (a cura di), L’età di Federico II, Gela, pp. 115-169.
Fiorilla S. 2001, Primi dati sulla produzione e la circolazione ce-ramica fra XIII e XIV secolo a Messina alla luce dei rinvenimenti del Municipio, in Da Zancle a Messina, pp. 110-140.
Fiorilla S. 2008, Produzione e circolazione ceramica tra XIV-XV secolo a Messina, in Messina, Palazzo Zanca, Guida alla visita dell’Antiquarium e dello scavo, Catanzaro, pp. 27-35.
Francovich R., Valenti M. 1997, La ceramica di uso comune in tToscana tra V-X secolo. il passaggio tra età tardoantica ed altomedioevo, in La céramique médiévale en Méditerranée, Actes du VIe congrès de l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 novembre 1995), Aix-en-Provence, pp. 129-137.
Gelichi S. et al. 1993, La ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti con l’Italia, Firenze.
Ghizolfi P. 1993, Ceramiche medievali da Entella (prime cam-pagne archeologiche), in G. Nenci (a cura di), Alla ricerca di Entella I, Pisa, pp. 189-217.
Italiano S. 2009, I reperti ceramici dei contesti medievali, in G. Tigano (a cura di), Mylai II, Messina, pp. 151-172.
Lesnes E., Tisseyre P. 1995, Castel San Pietro (Palermo). La ceramica e il vetro, in C.A. Di Stefano, E. Caddei (a cura di), Federico II, dalla terra alla corona, archeologia e architettura, Palermo, pp. 320-324.
Lesnes E. 1998, Ceramiche rivestite medievali e rinascimentali dal Castello di Lipari, in U. Spigo, A. Raffa, M. Saija (a cura di), Dal “constitutum” alle “controversie liparitane”, le chiavi di lettura della storia eoliana nell’ultimo millennio, Palermo, pp. 29-31.
Molinari A. 1995, La produzione e la circolazione delle ceramiche siciliane nei secoli X-XIII sec., in Actes du 5ème colloque sur la céramique médiévale en Méditerranée occidentale, Rabat, pp. 185-196.
Molinari A. 1997, Segesta II. Il castello e la moschea (scavi 1989-1995), Palermo.
Parello M.C. 2008, Le fornaci di Burgio, indagine archeologica nell’area delle officine, in Museo della ceramica di Burgio, Palermo, pp. 49-52.
Paroli L., Saguì L. 1990, L’esedra della Cripta Balbi nel medioevo (XI-XV Secolo), Firenze.
Patitucci Uggeri S. 1997, Le Protomaioliche. Bilanci e aggior-namenti, Firenze.
Patterson H., Whitehouse D. 1992, The Medieval Domestic Pottery, in Excavation At Otranto, Vol. II, Galatina, pp. 89-195.
Puglisi M. 2009, Una scelta di materiali medievali e moderni provenienti della Marina Garibaldi e della Cala dei Liparioti di Milazzo, in Ritrovamenti subacquei a Milazzo e il relitto di Punta Mazza, Messina, estratto s.n.
Rizzo M.S. 2008, Prima delle fornaci, dati dello scavo dell’edificio della prima fase, in Museo della ceramica di Burgio, Palermo, pp. 49-52.
Rotili M. 2011, Nuovi produzioni nel Mezzogiorno fra l’età nor-manna e l’età aragonese, «Albisola» XLIII (2010), pp. 117-138.
Serra L. 2006, Le transport fluvio-maritime des bouteilles en verre noir en Provence, «Bulletin de l’Association Française Histoire du Verre», XXI, nov. 2006.
Tisseyre P. 1995, Un abbazia siciliana nel XIII sec. Lo scavo e i materiali, in C.A. Di Stefano, E. Caddei (a cura di), Federico II, dalla terra alla corona, archeologia e architettura, Palermo, pp. 254.
Varaldo C. 1997, La graffita arcaica tirrenica, in La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du VIe congrès de l’AIECM2 (Aix-en-Provence 13-18 novembre 1995), Aix-en-Provence, pp. 439-452.
Whitehouse D. 1984, Note sulla ceramica tardomedievale della Puglia settentrionale, In Il Medioevo e il Gargano, Atti della VII Esposizione Archeologica, Vico Del Gargano.
SitografiaCuomo di Caprio N. 2007, Ceramica in archeologia 2, antiche
tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine, “L’erma” di Bretschneider, Roma 2007, pp 221-222, fig 59a.: http://books.google.it/books?id=hG6xA8nO5scC&pg=PA402&lpg=PA402&dq=ingobbio+monocromo&source=bl&ots=LxtvxPDH0b&sig=lYUUSz_C1FNqWbI9XYx87b7aYh8&hl=it&ei=lJ6ETrbaOMaz8QOg6N1G&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEQQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false
Cuteri et al. = Cuteri F.A., Iannelli M.T., Hyeraci G., La Serra C., Salamida P., Le ceramiche dai butti medievali di Vibo Valentia (Calabria-Italia), tav. 5 tre esempi di Spiral Ware, fr. N. 5-12-14. http://www.arcmed-venezia.it/IXa-iecm2/posters/06_ceramiche_contesti_sociali.pdf
Grassi F., Il Bassomedioevo: X-XIV secolo, pp. 251-255, p. 266 – fig. 141a http://www2.archeo.unisi.it/testi/ceramica/Ceramica_15_Grassi.pdf
http://www.maiolichedelduca.it/fileadmin/grpmnt/5608/Vocab-DECORO.pdf – Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, Piatto maiolicato:inv. FR C 593, fr. 40, p. 23
http://www.maiolichedelduca.it/fileadmin/grpmnt/5608/Vo-cabDECORO.pdf – motivi italomoreschi, fr. N. 37, Pesaro Musei Civici inv. FR000562, p. 22
98
Philippe Tisseyre, Giuseppe Cambria
AbstractBefore the construction of a new dock for ships, an instrumental research with sub bottom profiler was carried out in the port of Messina. This research has brought to the discovery of targets, verified with short exact probing on the area of interest. More than 200 ceramic fragments, osseous remains, few metallic remains, most of then are datable between the XIII and XVIII century. A few fragments are referable to XIX cent., showing that the area was not of interest for the filling up post-earthquake in 1908. It’s presumed that this discharge was in relation with one of the main doors of the city, after it was closed in XVIII century. It corresponds to a urban discharge not yet known.
Key words: underwater archaeology, Messina, medieval and post-medieval pottery.
RiassuntoI lavori di prolungamento delle banchine del porto di Messina sono stati preceduti da ricerche in archeologia subacquea pre-ventiva, prima con strumenti poi con sondaggi subacquei. Più di 200 frammenti di ceramica medievale e post-medievale sono stati esaminati, databili tra il XIII e il XVIII secolo, dimostrando che la zona non fu soggetta a riempimento dopo il terremoto del 1908, ma probabilmente, le ricerche hanno evidenziato una zona di discarica di materiale di consumo urbano, in relazione con una delle porte della città, in uso fino al XVIII sec.
Parole chiave: archeologia subacquea, Messina, ceramica medievale e post-medievale.