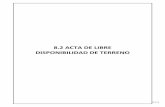Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del Barigadu (Sardegna, Italia)
\"Riti di iniziazione in Grecia antica? Un terreno d’indagine interdisciplinare”, in Dalla...
Transcript of \"Riti di iniziazione in Grecia antica? Un terreno d’indagine interdisciplinare”, in Dalla...
ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA A CONFRONTO
ATTI DEL 1° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
Dall
a nascita alla morte
DALLA NASCITA ALLA MORTE: ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA
A CONFRONTOAtti dell’Incontro Internazionale di studi in onore di
Claude Lévi-Strauss
ROMA, MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ETNOGRAFICO “LUIGI PIGORINI”21 MAGGIO 2010
A cura diVALENTINO NIZZO
ROMA 2011
E.S.S.EDITORIAL
SERVICESYSTEM S.r.l.
DALLA NASCITA ALLA MORTE: ANTROPOLOGIA E ARCHEOLOGIA A CONFRONTOAtti dell’Incontro Internazionale di Studi in Onore di
Claude Lévi-Strauss
Proprietà riservata-All Rights Reserved© COPYRIGHT 2011
Progetto GraficoSystem Graphic Srl
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qual-siasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro, senza l’autorizzazione scrittadei proprietari dei diritti e dell’Editore.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recordingor otherwise, without the prior permission of the publishers.
IN COPERTINA:Fotomontaggio: Apoxyomenos, Museo di Zagabria; Maschera Azteca a mosaico,Museo Preistorico Etnografico “L. Pigorini” Roma; Scheletro umano; Porzionedi volto: gentile concessione Loris Del Viva. Ideazione ed elaborazione grafica:VALENTINO NIZZO con la collaborazione di GIANFRANCO CALANDRA
PROGETTO SCIENTIFICO:Valentino Nizzo (Soprintendenza Archeologica per l’Emilia Romagna)
Con la collaborazione diSoprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”Elisa Cella (Università del Salento)
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E SEGRETERIA:Valentino Nizzo, Elisa Cella, Simona Sanchirico, Laura Pasquali, Ediarché-Editoria per l’Archeologia Srl.
5
CASA EDITRICE:E.S.S. Editorial Service System srlVia di Torre Santa Anastasia 61-00134 RomaTel 06.710561 Fax 06.71056230 [email protected] www.editorial.it
DIRETTORE EDITORIALE:Simona Sanchirico
REDAZIONE:Simona Sanchirico, Valentino Nizzo, Elisa Cella
COLLANA:Antropologia e Archeologia a confronto 1
DIRETTORE DI COLLANA:Valentino Nizzo
Finito di stampare nel mese di maggio 2011dalla tipografia System Graphic SrlVia di Torre Santa Anastasia 61-00134 RomaTel 06.710561 Fax 06.71056230 [email protected] www.sysgraph.com
SOSTEGNO LOGISTICO:System Graphic Srl - Tipolitografia Stampa DigitaleEdiarché - Editoria per l’Archeologia Srl Via di Torre Santa Anastasia 61-00134 RomaTel 06.710561 Fax 06.71056230 www.ediarche.it [email protected] Luciano Pasquali
6
Dalla nascita alla morte: Antropologia e Archeologia a Confronto, Atti dell’IncontroInternazionale di Studi in onore di Claude Lévi-Strauss [Atti del Congresso tenutosi aRoma, Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, il 21 Maggio 2010] / a cura diVALENTINO NIZZO. Roma: E.S.S. Editorial Service System, 2011, pp. 824.
ISBN 978-88-8444-114-0
CDD D.930.1
1. Archeologia – Antropologia Culturale – Antropologia Fisica – Atti di Congressi2. Claude Lévi-Strauss – Atti di CongressiI. Valentino Nizzo
INDICE
VALENTINO NIZZO, Premessa..................................................................p. 11Programma del convegno ......................................................................p. 19Abbreviazioni e norme bibliografiche ...................................................p. 23
INTRODUZIONE DEI LAVORIVALENTINO NIZZO, Introduzione ............................................................p. 27STEFANO DE CARO, Apertura del Convegno ..........................................p. 41LUIGI LA ROCCA, Il museo delle differenze culturali: radici per un futuro del Museo “Pigorini” ..................................................................p. 45
I SESSIONE. NASCITA E INFANZIAVALENTINO NIZZO, “Antenati bambini”. Visibilità e invisibilità dell’infanzianei sepolcreti dell’Italia tirrenica dalla prima età del Ferro all’Orientalizzante: dalla discriminazione funeraria alla costruzione dell’identità................p. 51CECILIA PENNACINI, Concezioni dell’infanzia nell’Africa dei Grandi Laghi..........................................................................................p. 95
II SESSIONE. ADOLESCENZA E RITI DI PASSAGGIO VERSO L’ETÀ
ADULTAFRANÇOISE HÉLENE MASSA-PAIRAULT, Qualche considerazione sui passaggi dell’adolescenza e i suoi paradigmi: dai boschi alla città .......p. 107ALESSANDRO LUPO, Il rito e la costruzione sociale della persona..........p. 121
III SESSIONE. UNIVERSO FEMMINILE. MADRI, MOGLI, REGINE, SACERDOTESSEGILDA BARTOLONI, FEDERICA PITZALIS, Madri e mogli nella nascente aristocrazia tirrenica...............................................................................p. 137MASSIMO VIDALE, La visibilità della donna nelle stratigrafie archeologiche: il corto circuito etnoarcheologico..................................p. 161
7
IV SESSIONE. UNIVERSO MASCHILE (GUERRIERI, PRINCIPI, SACER-DOTI ED EROI)ANNA DE SANTIS, L’ideologia del potere: le figure al vertice delle comunità nel Lazio protostorico (con una Nota Antropologica a cura di PAOLA CATALANO, FLAVIO DE ANGELIS, STEFANIA DI GIANNANTONIO) ..p. 171FABIO VITI, I guerrieri degli Antichi e dei (Pre)Moderni (America, Africa) ..p. 199
DISCUSSIONE
VINCENZO PADIGLIONE, CECILIA PENNACINI, VALENTINO NIZZO, PIERO GIOVANNI GUZZO..........................................................................p. 233
V SESSIONE. ORIGINI DELLA COMPLESSITÀ SOCIALE
A) SVILUPPO DEI SISTEMI PROTO-URBANI E NASCITA DELLE CITTÀ
ANDREA CARDARELLI, L’origine delle comunità protourbane in Italia ..p. 247MARIANO PAVANELLO, Modelli di insediamento e complessità sociale: la tesi del “big bang” Akan e la transizione dalla caccia-raccolta all’agricoltura ..p. 259B) EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PARENTELA E NASCITA DELLE ARISTOCRAZIE
EUGENIO BORTOLINI, MAURIZIO TOSI, Dal Kinship al Kinship: Le tombe collettive nell’Oman del terzo millennio a.C. e la costruzione della civiltà di Magan .....................................................................................p. 287PATRIZIA RESTA, Il modello segmentario della nazione albanese, dai lignaggi alle reti di parentela in una società agropastorale....................p. 319
VI SESSIONE. DONO E SCAMBIO: ALLE ORIGINI DEL COMMERCIO E
DEI SISTEMI DI SCAMBIO PRIMITIVI
NICOLA PARISE, CARMEN MARTINELLI, EMANUELA ALBERTI, Reciprocità e ridistribuzione, modelli meccanici e modelli statistici .......................p. 345FABIO DEI, Alla ricerca dello hau. Persone, cose, scambi......................p. 381
VII SESSIONE. MORTE. RITI DI PASSAGGIO, PROBLEMI LIMINALI, TANATOMETAMORFOSI, PALEOPATOLOGIAANNA MARIA BIETTI SESTIERI, Archeologia della morte fra età del bronzo ed età del ferro in Italia. Implicazioni delle scelte relative alla sepoltura in momenti di crisi o di trasformazione politico-organizzativa.............p. 397HENRI DUDAY: L’Archéothanatologie et ses incidences sur la compréhension des pratiques funéraires. Quelques applications relatives à des nécropoles protohistoriques et historiques de l’Italie méridionale et de la Sicile....p. 419
8
LUCA BONDIOLI, ALESSANDRA SPERDUTI, Comunità dei morti e individui scheletrici: dallo studio di popolazioni alla ricostruzione della storia biologica individuale .............................................................................p. 431ADRIANO FAVOLE, L’ambivalente statuto dei resti umani: il caso del nuovo Museo Cesare Lombroso di Torino ............................................p. 461
CONCLUSIONIMICHEL GRAS, Riflessioni conclusive....................................................p. 481
SESSIONE POSTER (A CURA DI E. CELLA)ELISA CELLA, Antropologi e archeologi a confronto: il convegno on-line ..p. 487NASCITA E INFANZIA
SONIA MODICA, Suoni dal silenzio eterno: idiofoni, aerofoni, oggetti sonori e morti premature del Lazio antico.............................................p. 503SILVIA AGLIETTI, La Mors Acerba. Alcuni spunti di riflessione sulla sepoltura degli infanti in età romana .....................................................p. 517ADOLESCENZA E RITI DI PASSAGGIO VERSO L’ETÀ ADULTA
IDA BRANCACCIO, Parthenoi dell’acropoli, salvezza della città.............p. 531RACHELE DUBBINI, Lo spazio dell’aggregazione: choros e dromos nei riti d’istituzione in Grecia......................................................................p. 545ELENA FRANCHI, Riti di iniziazione in Grecia antica? un terreno d’indagine interdisciplinare ...................................................................p. 553VERA ZANONI, Nella terra di nessuno. Antropologia fisica e cultura materiale nella giacitura del cacciatore della Busa Brodeghera ............p. 563PIA GRASSIVARO GALLO, DEBORA MORO, ALESSIA PASSAQUIETI, Le ragazze di Mangochi (Malawi) raccontano il longininfismo rituale (genital stretching).................................................................................p. 575UNIVERSO FEMMINILE. MADRI, MOGLI, REGINE, SACERDOTESSEGIANLUCA MELANDRI, La donna e il potere a Capua tra ostentazione suntuaria e ritualità funebre: il caso della t. Fornaci 722 di età orientalizzante...p. 591SABRINA BATINO, Il mondo delle spezie e degli aromi: l’immaginario dello zafferano .......................................................................................p. 613SIMONA SANCHIRICO, La Pizia di Delfi. Metodi oracolari e rituali catartici di contatto ................................................................................p. 629ORIGINI DELLA COMPLESSITÀ SOCIALE: SVILUPPO DEI SISTEMI
PROTO-URBANI E NASCITA DELLE CITTÀ
MARIO FEDERICO ROLFO, FRANCESCO MESSINA, GABRIELE SCORRANO, VALERIA TRUPIANO, AGOSTINAAPPETECCHIA, Analisi genetica di comunitàmontane in aree isolate del centro Italia tra preistoria e storia ..............p. 649
9
ORIGINI DELLA COMPLESSITÀ SOCIALE: EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI PAREN-TELA E NASCITA DELLE ARISTOCRAZIE
MASSIMO OSANNA, MICHELE SCALICI, Nascita delle aristocrazie e sistemi di parentela in area nord-lucana ................................................p. 669GABRIELLA CETORELLI SCHIVO, Un singolare caso di social inclusionnell’insediamento protostorico di Caracupa - Sermoneta (LT) .............p. 683GIANCARLO GERMANÀ BOZZA, Necropoli e società aristocratica a Siracusadurante l’età arcaica...............................................................................p. 689DONO E SCAMBIO: ALLE ORIGINI DEL COMMERCIO E DEI SISTEMI DI SCAMBIO
PRIMITIVI
DANIELE F. MARAS, FERDINANDO SCIACCA, Ai confini dell’oralità. Le forme e i documenti del dono nelle aristocrazie orientalizzanti etrusche ..p. 703MORTE. RITI DI PASSAGGIO, PROBLEMI LIMINALI, TANATOMETAMORFOSI, PALEOPATOLOGIAMASSIMILIANO DI FAZIO, “La morte è dura; ancora più duro il cordoglio”. Primi appunti da una indagine sul pianto rituale nel mondo etrusco.....p. 717GIOVANNI DI STEFANO, GIUSI VENTURA, Una sepoltura principesca nella necropoli greca di Castiglione: un “festino” per i morti e un “banchetto” per i vivi.............................................................................p. 727SABRINA MASOTTI, EMANUELA GUALDI-RUSSO, Il rito della cremazione: osservazioni antropologiche su alcuni casi studio di particolare interesse da necropoli dell’Italia settentrionale .....................................p. 735AMEDEO BOROS, Una comunità rurale ungherese e il suo particolare sistema funerario. Il rituale comunitario di Szatmárcseke come motore di continuità culturale ............................................................................p. 747ROBERTO LIBERA, Il ponte: un passaggio nell’Aldilà attraverso l’indefinito .............................................................................................p. 759
BIBLIOGRAFIA RAGIONATA DI CLAUDE LÉVI-STRAUSSANNAMARIA FANTAUZZI, L’opera e l’eredità critica di Claude Lévi-Strauss. Promemoria bio-bibliografico ...............................................................p. 771
ABSTRACTS E KEYWORDSRelazioni ................................................................................................p. 809Posters ...................................................................................................p. 817
10
CHIRASSI COLOMBO 1968: I. CHIRASSI COLOMBO, Elementi di culture precerealinei miti e riti greci, Roma 1968.
DE MARTINO 2003: E. DE MARTINO, Il mondo magico. Prolegomeni a una sto-ria del magismo, Torino 2003 (Ed. orig. 1973).
JEANMAIRE 1939: H. JEANMAIRE, Couroi et Couretes. Essai sur l’éducationspartiate et sur le rites d’adolescence dans l’antiquité hellénique, Lille1939.
JOUAN, VAN LOOY 2000: JOUAN, VAN LOOY (éd.), Euripides. Fragments, 8, Paris2000.
MERITT 1940: B. D. MERITT, “Greek Inscriptions”, in Hesperia 9, 1940, pp.51-140.
PETTERSSON 1992: M. PETTERSSON, Cults of Apollo at Sparta. The Hyakinthia,the Gymnopediai and the Karneia, Stockolm 1992.
PICCIRILLI 1967: L. PICCIRILLI, “Ricerche sul culto di Hyakinthos”, in StClOr16, 1967, pp. 98-116.
RICHER 2004: N. RICHER, “Les Hyakinthies de Sparte”, in REA 106, 2004, pp.389-419.
SERGENT 1986: B. SERGENT, L’omosessualità nella mitologia greca, Roma-Bari 1986 (Ed. orig. 1984).
SIEWART 1977: P. SIEWART, “The ephebic oath in fifth-century Athens”, in JHS97, 1977, pp. 102-111.
VERNANT 1988: J. P. VERNANT, “Artemis et le sacrifice préliminaire au com-bat”, in REG 101, 1988, pp. 221-239.
WILKINS 1990: J. WILKINS, “The young of Athens: Religion and Society inHerakleidai of Euripides”, in ClQ 40, 1990, pp. 329-339.
DISCUSSIONE SUL FORUM ONLINE
SPOSE E GUERRIERI. DIVINITÀ CUROTROFICHE IN GUERRA: TELESILLA, MARPESSA E LE ALTRE
ELENA FRANCHI (maggio 2010): Nell’interessante e stimolante poster di Ida Brancaccio sitrova un’osservazione che - come molte altre - è meritevole di approfondimento. Dice l’Au-trice che “anche se a prima vista potrebbe sembrare poco plausibile che figure femminili so-vrintendano alla dimensione militare dei giovani (chiaramente dominata dalla componentemaschile che, anzi, vede nella donna armata una pericolosa inversione del nomos), assicurandoprotezione, assistenza e vittoria a coloro che devono andare in battaglia, il patrocinio esercitatodalle Erechteides-Hyakinthides, come da Aglauros e dalle Leokorai risiede nella loro compe-tenza curotrofica”. È facile immaginare che dietro alla prima parte di quest’asserzione vi è ilriferimento a diverse vicende mitistoriche nelle quali una figura femminile, armata, è prota-
540 IDA BRANCACCIO
gonista di episodi interpretabili anche sullo sfondo del paradigma iniziatico (la battaglia comerito di passaggio), e in qualche modo sovrintende, quanto meno a livello simbolico, al ‘rito diiniziazione’ dei combattenti maschi. In particolare, richiamiamo brevemente l’attenzione sutre vicende, per l’interpretazione approfondita delle quali rimandiamo a un celebre articolodi Fritz Graf51, alle più recenti monografie di Katharina Waldner e di Gabriella Pironti52 e aun saggio di Mauro Moggi53.La prima vicenda riguarda la battaglia di Sepia, combattuta tra Sparta e Argo tra la fine delVI e gli inizi del V sec. a.C., ed è riferita da Socrate di Argo (FGrHist 310 F 6), Pausania(2.20.7-10), Plutarco (Mulier. 245 C-F; Lacae. 223 A-C) e Polieno (1.14; 8.33), anche se gliantefatti si trovano già in Erodoto (6.76-83). Dopo aver sconfitto gli Argivi a mezzo di nume-rosi inganni, il re spartano Cleomene penetra nella città di Argo, ormai deserta, ma il suo at-tacco è respinto da Telesilla, poetessa argiva che molti versi ha dedicato alle fanciulleadolescenti e che, nell’occasione, difende la città vuota di uomini alla guida di donne (secondoSocrate di Argo) e di vecchi e bambini (secondo Pausania); l’impresa di Telesilla è in qualchemodo stata preannunciata dalla Pizia che aveva vaticinato agli Argivi femmine che vinconomaschi (l’oracolo epiceno, che riferisce anche di donne argive che si deturpano il viso, e infinedi un terribile serpente senza spire – o con la triplice spira – che muore). Alle donne guerrieredi Argo si accorda il privilegio di erigere una statua, o forse addirittura di fondare un santuario,in onore di Enyalios. Divinità che dall’età arcaica in poi si sovrappone spesso ad Ares, Enya-lios è venerato di frequente da efebi, come racconta Pausania a proposito degli efebi spartaniche, divisi in squadra prima della battaglia nel Phobaion, sacrificano un cucciolo di cane aEnialio (3.14.8-9). Ma il nesso tra le donne argive guidate da Telesilla e le armi non è istituitounicamente dal culto di Enialio, di cui è aition. Pausania racconta di aver visto un rilievo, incui è raffigurata Telesilla mentre guarda l’elmo che ha in mano ed è in procinto di metterselosul capo. Il rilievo si trova di fronte alla statua di culto di Afrodite, posizionata vicino al tempiodi Afrodite che è “al di là del teatro”.Afrodite viene a sua volta raffigurata con le armi in altre sedi: di un’Afrodite armata si ha notiziaa Sparta e a Corinto; anche qui, tra donne guerriere nel mito e dee armate nel culto le corrispon-denze non sono esatte, ma comunque riconducibili in entrambi i casi al binomio patrocinio degliadolescenti-difesa militare della città. Del culto a Sparta, in particolare, conosciamo una storiache presenta stringenti analogie con quella delle eroine argive guidate da Telesilla: e siamo allaseconda vicenda di cui sopra. In un’imprecisata guerra spartano-messenica, mentre gli Spartanisono impegnati ad assediare la città di Messene, un gruppo di abitanti riesce a sfuggire al con-trollo e si reca a Sparta, dove attacca le donne spartane rimaste sole. Queste indossano allora learmi e affrontano i nemici in una battaglia sconfiggendoli. Nel frattempo, gli Spartani, avendoappreso dell’attacco a Sparta, accorrono in aiuto, ma vedendo le proprie donne armate non le ri-conoscono e sono sul punto di ingaggiare battaglia. Le donne si spogliano allora di armi e ve-stiario per farsi riconoscere, e i soldati, compreso l’errore, sono presi da irrefrenabile desiderioe si danno a un’orgia. Dall’unione tra i giovani soldati (iuvenes) e le vergini (virginibus) nasconoi Parteni (Partheniae) e, in memoria di questo fatto, a Sparta vengono eretti un tempio e una
DALLA NASCITA ALLA MORTE 541
51 F. GRAF, “Women, War, and Warlike Divinities”, in ZPE 55, 1984, pp. 245-254.52 K. WALDNER, Geburt und Hochzeit des Kriegers: Geschlechterdifferenz und Initiation inMythos und Ritual der griechischen Polis, Berlin 2000; G. PIRONTI, Entre ciel et guerre: Fi-gures d’Aphrodite en Grèce ancienne, Liège 2007.53 M. MOGGI, “Marpessa detta Choira e Ares Gynaikothoinas”, in AA.VV., Ancient Arcadia,Athens 2004, pp. 139-150.
statua in onore di Afrodite armata (LACT., Inst. div., 1.20.29-32).Femminile e maschile, amore e guerra si mescolano e sono lo specchio l’uno dell’altro anche inaltre storie. Se le eroine argive praticano un culto in onore di Ares Enyalios, divinità maschile dellaguerra in genere venerata dagli efebi, e se in ricordo delle eroine spartane si venera un’Afroditearmata, divinità dell’amore che però sovrintende alle iniziazioni dei guerrieri, nel caso delle eroinetegeati il culto è in onore Ares Gynaikothoinas. E veniamo alla terza vicenda: dice Pausania (8.5.9;47-48) che quando il re spartano Carillo guida una spedizione contro Tegea, a difesa di quest’ultimaconcorrono, oltre agli uomini, le donne; esse sono guidate da Marpessa, e, dopo essersi poste inagguato presso la collina Phylatrix, ingaggiano uno scontro con i nemici, che sconfiggono e cat-turano. Gli Spartani saranno costretti a lavorare, in catene, la pianura dei Tegeati, mentre le donne,per celebrare la vittoria, offrono un sacrificio ad Ares, da cui i maschi sono esclusi.Tutte e tre le vicende – quella argiva, quella spartana e quella tegeate – rivelano le tracce diuna trasfigurazione mitica che ha caricato episodi storici (la battaglia di Sepia; una guerraspartano-messenica; una guerra spartano-tegeate) di significati che rinviano all’universo sim-bolico delle iniziazioni e in particolar modo alle iniziazioni maschili e al ruolo svolto, nel-l’ambito di queste ultime, da divinità talora maschili (Enyalios; Gynaikothoinas) talorafemminili (Afrodite), ma in entrambi i casi venerate esclusivamente da donne, e almeno inparte interpretabili come curotrofiche (Enyalios?).L’interpretazione suddetta delle tre vicende citate rafforza l’ipotesi formulata dalla Brancaccio,per la quale “il patrocinio esercitato dalle Erechteides-Hyakinthides, come da Aglauros e dalleLeokorai, risiede nella loro competenza curotrofica. Esse svolgono funzione protettrice e nu-trice di bambini e giovani, che saranno i futuri politai nel ruolo di spose e guerrieri”.
A PROPOSITO DELLE IACINTIDI E DEI FOCIDESI: ALCUNE OSSERVAZIONI
PER UNA TEORIA SOCIOLOGICA DELLA CONTINUITÀ DELLA SOCIETÀ
ELENA FRANCHI (maggio 2010): A conclusione del proprio poster Ida Brancaccio sostiene chedietro al mito delle Iacintidi “è la salvezza del popolo e la continuità dell’esistenza del corpocivico. Alla base c’è un rituale di iniziazione, il cui scopo è consentire il superamento dellacrisi della presenza dell’individuo senza danni, lungo una via pericolosa, determinata dallafase di passaggio, il cui scopo è perfezionare l’adolescente per la vita [...] una sorta di teoriasociologica della continuità della società”. È possibile richiamare a proposito della convincenteinterpretazione della Brancaccio della vicenda mitica delle Iacintidi l’interpretazione chePierre Ellinger54 ha proposto per la leggenda nazionale focidese, laddove la disperata lotta deiFocidesi contro i Tessali viene a configurarsi come l’iniziazione di un intero popolo, comple-tata attraverso la guerra e il sacrificio. Richiamiamo, in breve, le vicende. Come è noto, se-condo alcune tradizioni antiche Tessali e Focidesi sarebbero in conflitto “da sempre” (cfr.HDT. 8.27; EFORO FGrHist 70 F 93; PAUS. 10.13.4). Stando a Erodoto (7.127), i primi attritirisalirebbero in effetti all’epoca dell’entrata dei Tessali nelle loro sedi storiche. È a questopassaggio storico cruciale cui le fonti antiche fanno risalire una serie di episodi di ostilità traTessali e Focidesi. I primi due episodi si leggono in Erodoto (8.27-28): i Tessali, che dopoaver occupato la terra che da loro prenderà il nome hanno invaso anche parte della Focide,sarebbero stati sconfitti dai Focidesi in seguito a due stratagemmi. A suggerire il primo stra-
542 IDA BRANCACCIO
54 P. ELLINGER, La légende nationale phocidienne. Artémis, les situations extrêmes et les récitsde guerre d’anéantissement, Paris 2003.
tagemma ai Focidesi, riparatisi sul Parnaso, sarebbe stato il veggente Tellias: seicento uominiscelti sarebbero stati spalmati di gesso e la notte avrebbero attaccato i Tessali, spargendo untale terrore con la loro apparizione, da poterne massacrare ben 4000. A questo punto, i Tessaliavrebbero schierato la leggendaria cavalleria, che sarebbe penetrata nella Focide attraversoHyampolis. In tutta risposta, i Focidesi avrebbero ideato un secondo stratagemma: scavatauna grande fossa sulla via obbligata dell’irruzione, l’avrebbero riempita di anfore vuote rico-perte con uno strato di terra; così, i cavalli tessali sarebbero caduti nella fossa.In Pausania (10.1.3) si ritrovano entrambi gli stratagemmi, sebbene in ordine invertito e conlocalizzazione diversa: l’episodio situato da Erodoto a Hyampolis si svolge secondo il Perie-geta presso l’esbolé nella Focide (che forse coincide con quella citata da Erodoto presso Hyam-polis), e gli uomini spalmati di gesso sono 500 e non 600. Per l’attacco i Focidesi attendonouna notte di plenilunio. Pausania inserisce inoltre tra i due già raccontati da Erodoto un terzoepisodio: dopo l’insuccesso del primo attacco della cavalleria, dovuto allo stratagemma delleanfore, i Tessali avrebbero radunato ingenti forze. I Focidesi si sarebbero allora rivolti a Delfi,apprendendo che secondo il responso il dio avrebbe opposto in battaglia mortali e immortalie avrebbe dato la vittoria a entrambe le parti, ma più ai mortali; di conseguenza, i Focidesiavrebbero mandato trecento uomini in ricognizione, ma questi sarebbero stati sorpresi e uccisidai nemici. Alle soglie di un imminente e quasi certo disastro, avrebbero riunito in un luogole donne, i bambini, tutti i loro beni (compresi vestiario, oro e argento) e le immagini divine,avrebbero costruito un immenso rogo e lasciato sul posto trenta uomini con l’ordine, operativoin caso di sconfitta, di uccidere le donne e i bambini, e di metterli come vittime sacrificali(hos iereìa) sul rogo insieme con i beni, di accendere il rogo e darsi alla morte. Da questoevento avrebbe avuto origine l’espressione proverbiale di “disperazione focidese”. Ma proprioal culmine della disperazione i Focidesi avrebbero ottenuto una grandiosa vittoria, come delresto aveva predetto il responso delfico: la parola d’ordine dei Tessali era il nome dell’im-mortale dea Athena Itonia, mentre quella dei Focidesi il nome dell’eroe (mortale) Phokos.L’episodio aggiunto da Pausania si ritrova in Plutarco (Mulier., 244 A ss): alcune delle lievidivergenze dipendono dall’intenzione di Plutarco di mettere in luce le gesta femminili e l’eroi-smo delle donne focidesi, che avrebbero acconsentito alla decisione disperata degli uomini.Il Cheronense aggiunge inoltre che i Tessali avrebbero ucciso gli ostaggi e iniziato un áspon-dos pólemos, e che l’episodio non sarebbe stato ricordato da autori celebri, ma sarebbe atte-stato (martyroúmenon) dalle grandi azioni cultuali che i Focidesi ancora compiono aHyampolis e da antichi decreti. Alla fine del racconto precisa che i Focidesi ancora oggi ce-lebrano a Hyampolis la loro più grande festa, gli Elaphebolia, in onore di Artemide.Angelo Brelich55 aveva interpretato le ostilità come guerre deritualizzate che sarebbero l’esitodi antichi combattimenti iniziatici funzionali all’iniziazione degli adolescenti delle comunitàcoinvolte. In La légende nationale phocidienne Artémis, les situations extrêmes et les récitsde guerre d’anéantissement (Paris 2003), Pierre Ellinger propone, come Brelich, una inter-pretazione di tipo ‘iniziatico’, ma senza chiamare in causa le iniziazioni tribali. Le tradizioniintorno ai conflitti tra Tessali e Focidesi sarebbero parte di una leggenda nazionale focideseelaborata a uso e consumo dei promotori della confederazione focidese (nata proprio in etàarcaica in funzione antitessalica): le tradizioni in oggetto avrebbero rappresentato le originidel popolo focidese come una drammatica iniziazione collettiva, e la confederazione non unanascita dal nulla, bensì una rinascita, allo stesso modo in cui un giovane iniziando vive, conl’iniziazione, una seconda nascita.
DALLA NASCITA ALLA MORTE 543
55 A. BRELICH, Guerre, agoni e culti nella Grecia arcaica, Bonn 1961.
IDA BRANCACCIO (maggio 2010): Concordo pienamente. Il confronto con la tradizione focideseè quanto mai puntuale. Tanto più che è proprio in questo contesto di età arcaica, parallelamentealla lotta per la liberazione della regione dalla dominazione tessala e all’ascesa separatisticadel santuario di Delfi (che sottrae all’ethnos focidese tutto il settore occidentale della regione)che si assiste anche allo sviluppo politico delle poleis, che si riuniscono in un organismo co-mune e unitario, il quale si proponeva di preservare l’integrità sociale e territoriale della Focideorientale, e la cui manifestazione più evidente sembra essere proprio la costruzione della ge-nealogia di un eroe eponimo comune, risalente appunto a Phokos figlio di Ornytion e nipotedi Siyphos, il cui mito acquista i tratti di leggenda nazionale.In questa prospettiva vanno letti da un lato la costituzione del Phokikon, ossia l’ente di rap-presentanza del koinon e luogo fisico in cui si riuniva l’assemblea dell’ethnos, con sede aDaulide, dall’altro la promozione del culto nazionale di Artemis Elaphebolos a Hyampolis.Da una parte, quindi, si assiste alla crescita del ruolo panellenico del santuario di Apollo del-fico, che consentiva agli abitanti di Delfi di dichiarare la propria non appartenenza alla stirpefocidese, dall’altra alla definizione del koinon focidese, ristretto nella parte orientale della re-gione, che rifondava la sua storia mediante un’unità cultuale ed etnica che si riconnetteva aun comune capostipite ed eponimo. Inoltre tra il santuario di Hyampolis e il Phokikon esisteuna stretta relazione: se infatti Hyampolis rappresenta il punto geografico in cui comincia ilterritorio della Focide e metaforicamente il luogo in cui inizia anche la sua storia, presentan-dosi allo stesso tempo come confine regionale e luogo d’origine, d’altro canto il Phokikonnon è solo il centro geografico, ma anche il cuore politico del paese. Vicino al Phokikon ècollocato l’heroon dell’eroe archegetes, onorato da sacrifici giornalieri. In questi due centrinevralgici, nella continuità dei sacrifici rinnovati quotidianamente, si esercitava il potere po-litico. Una volta l’anno invece i Focidesi si riunivano sulla frontiera, per gli Elaphebolia, lefestività in onore di Artemis presso il santuario della dea a Hyampolis, allo scopo di comme-morare, nel luogo dove avvenne, la nascita dello stato. In questa relazione fra centro e confine,fra il potere e la sua origine, si ritrova anche la dialettica bipolare fra santuario centrale e san-tuario periferico.
544 IDA BRANCACCIO
RITI DI INIZIAZIONE IN GRECIA ANTICA? UN TERRENO D’INDAGINE
INTERDISCIPLINARE
Di iniziazioni tribali in Grecia antica non si ha alcuna attestazione. Tuttavia,dell’ipotesi della loro esistenza, desunta da alcuni miti e riti che presentereb-bero notevoli somiglianze con i riti di iniziazione nella forma in cui sono de-scritti in molti resoconti etnografici, si sono occupati studiosi delle disciplinepiù svariate: storici, archeologi, antropologi, etnologi, filologi, filosofi. Tutticoncordano oggi nel giudicare superata la nozione di “rito di iniziazione”,anche in riferimento alla Grecia antica: quest’unanimità è l’esito di percorsidi ricerca interdisciplinari.È curioso che la storia dello studio delle iniziazioni in Grecia abbia inizio conun missionario, J. F. Lafitau1. Estendendo il campo d’indagine dell’etnologiaalle società antiche e paragonando i riti di iniziazione praticati dagli Irochesia quelli che ipoteticamente avrebbero praticato gli antichi Greci, “rivelò almondo questa semplice verità: anche i Greci un tempo sono stati selvaggi”2.Tuttavia, bisognerà attendere un antropologo, l’inglese E. B. Tylor3, perchél’intuizione di Lafitau venga sviluppata: laicizzata e adattata alla concezioneevoluzionistica, essa consacrò definitivamente l’argomento principale che con-sentiva di interpretare in un medesimo quadro le iniziazioni antiche e quellemoderne: i selvaggi moderni sono ciò che un tempo eravamo noi, e quindierano anche gli antichi Greci; come altri, questi ultimi nella loro fase selvaggia,devono aver praticato riti iniziatici, caratteristici di uno stadio evolutivo arre-trato, poi conservatisi a livello di survival in Grecia classica.La monografia che segnò indelebilmente gli studi sulle iniziazioni in generalee in particolare in Grecia antica è invece opera del folclorista belga A. Van Gen-nep4. Le iniziazioni venivano classificate nella categoria più ampia dei riti dipassaggio, di cui condividerebbero la struttura tripartita in tre fasi: separazione,margine, integrazione. La sociologia francese dell’epoca accolse l’opera di VanGennep piuttosto freddamente: M. Mauss pubblicò una recensione decisamentepoco benevola5, nella quale osservava che Van Gennep non avrebbe visto altro
DALLA NASCITA ALLA MORTE 553
1 LAFITAU 1724.2 MOMIGLIANO 1966, p. 141.3 TYLOR 1871.4 VAN GENNEP 1909.5 MAUSS 1910.
che passaggi, adottando il metodo impiegato dalla scuola antropologica inglesee prendendo in esame un alto numero di contesti storici ed etnografici senzaesaminare in profondità alcuni aspetti tipici selezionati. In effetti, Les rites depassage era più vicino all’antropologia inglese della fine dell’Ottocento chenon alla scuola sociologica francese. Bisognerà attendere la fine degli anni Ses-santa perché una nuova edizione dell’opera e la rilettura di Van Gennep stimo-lata da C. Lévi-Strauss consacrino il suo definitivo successo.In ambito classico l’ipotesi dell’esistenza di iniziazioni tribali in Grecia anticasi riallacciava ancora agli studi evoluzionistici ed era divenuta oggetto di stu-dio di filologi e storici: nella prima metà del Novecento il filologo H. Jean-maire istituiva un paragone tra l’agoge spartana, che sarebbe la sopravvivenzadi precedenti iniziazioni tribali, e le iniziazioni tribali praticate nelle tribù afri-cane contemporanee6. L. Gernet, allievo di Durkheim formatosi nei medesimiambienti intellettuali di Jeanmaire, pubblicò un articolo fortemente critico aproposito della ricostruzione di quest’ultimo7, tacciata di un grado di ipoteticitàtroppo elevato. Lo stesso Gernet aveva a sua volta proposto, nel 1936, un’in-terpretazione iniziatica della vicenda del troiano Dolone8. Le sue intuizioniverranno sviluppate dal suo grande allievo, Jean-Pierre Vernant9.Nel frattempo, si erano avvicinati al tema delle iniziazioni in Grecia anche gliinglesi: J. E. Harrison, fondatrice assieme a G. Murray e a F. M. Cornford delcircolo dei ritualisti di Cambridge, collegò alle iniziazioni l’inno dei Cureti inonore di Zeus Kouros, riportato su di un’epigrafe di Palaikastro10; formatosicome la Harrison negli ambienti culturali del classicismo di Cambridge, G. D.Thomson propose di ricondurre le origini del dramma antico alle iniziazionitribali, coniugando l’impostazione tradizionale degli studi classici con l’ar-cheologia, l’etnologia e l’analisi sociologica11.La nozione di “iniziazione tribale” non sollevava ancora dubbi, mentre l’in-sieme di riti di cui essa farebbe parte, i riti di passaggio, iniziava a suscitareperplessità sempre più pesanti: nel 1962 M. Gluckman, il fondatore della Man-chester School, riteneva che la teoria vangenneppiana sui riti di passaggio nonfosse valida, in quanto costruita per accumulazione e fondata su di una con-cezione poco coerente sulla natura della società12.
554 ELENA FRANCHI
6 JEANMAIRE 1913; ID. 1939.7 GERNET 1944.8 GERNET 1936.9 CFR. VERNANT, VIDAL-NAQUET 1992.10 HARRISON 1912.11 THOMSON 1941.12 GLUCKMAN 1962.
Tali polemiche non ebbero però un’eco immediata negli ambienti classicisti,nei quali invece la possibilità dell’esistenza di iniziazioni in Grecia ancora at-tendeva uno studio organico, che arriverà con A. Brelich. Ungherese, formatosiprima con A. Alföldi, archeologo, numismatico, epigrafista e storico, e poi conK. Kerény, filologo e storico delle religioni, studiò a Roma e fu chiamato daR. Pettazzoni come assistente straordinario alla sua cattedra. In Paides e par-thenoi13 sosteneva che l’esistenza di iniziazioni tribali nella Grecia preistoricasarebbe suggerita da tutta una serie di sopravvivenze defunzionalizzate ma di-versamente rifunzionalizzate riscontrabili nella Grecia arcaica, classica ed el-lenistica. Quanto quest’interpretazione sia debitrice al funzionalismo e allesue declinazioni etnografiche, risulta chiaro dalle ricerche di un altro studiosoche della funzione fa l’elemento principe per interpretare l’istituto iniziaticoin Grecia: un francese, per formazione strutturalista, ma che, come Brelich,guardava all’antropologia britannica: P. Vidal-Naquet. Nel 1960 Vidal-Naquetiniziò a seguire le lezioni di J. P. Vernant, che pubblicherà di lì a pochi anniuna raccolta di scritti di Gernet14, attirando così finalmente l’attenzione meri-tata su “Dolon le loup”. Di Vidal-Naquet nel 1968 uscì, contemporaneamentea Cambridge e a Parigi15, “Le Chasseur noir”, una pietra miliare per l’inter-pretazione iniziatica dell’efebia ateniese; nel 1974, pubblicò “Le Cru, l’enfantgrec et le cuit”16, nel quale sosteneva che, nel caso delle sopravvivenze di ele-menti rituali iniziatici, la coerenza tra la funzione attuale e quella originaria sicollocava più a livello dei quadri mentali.In quegli anni si trovava a Parigi per la sua formazione dottorale un brillantestudente svizzero, che dopo la laurea aveva studiato anche a Urbino sotto laguida di B. Gentili, professore di letteratura greca: C. Calame. Nel 1977 Ca-lame pubblicò una monografia in cui esaminava i cori femminili in una pro-spettiva iniziatica17. Quest’ultima veniva adottata con estremo senso criticoma si rivelava la chiave fondamentale.Anche il mondo tedesco, nel quale pure pesava la prestigiosa e a un tempo in-gombrante eredità della Altertumswissenschaft, non rimase indifferente al pa-radigma iniziatico. Pioniere fu il bavarese W. Burkert: formatosi in filologia,storia e filosofia alle università di Erlangen, Monaco e Washington, insegnò aBerlino e a Harvard. Per quanto concerne le iniziazioni, Burkert ipotizzavauna certa continuità tra il II e il I millennio; determinate cerimonie, come i
DALLA NASCITA ALLA MORTE 555
13 BRELICH 1969.14 GERNET 1968.15 VIDAL-NAQUET 1968a; ID.1968b.16 VIDAL-NAQUET 1974.17 CALAME 1977.
servizi templari di un numero limitato e scelto di giovani, ragazzi e ragazze,e i culti segreti, venivano interpretate come lo sviluppo di originarie iniziazionitribali, il riflesso delle quali si può ancora ravvisare in determinati patternsmitici e nell’importanza del concetto di margine nell’attività rituale18. Seguiràle sue orme l’allievo F. Graf19.Il paradigma iniziatico cominciò ad avere ampia diffusione tra i classicisti;l’olandese J.N. Bremmer osservava come esso fosse in molti casi “the mosteconomic hermeneutic key”, approntando un’interpretazione iniziatica di moltieroi omerici, di cui venivano messi in rilievo alcuni aspetti o atteggiamenti ini-ziatici20: negli anni Novanta H. S. Versnel criticherà i fondamenti metodologicidi questo articolo, polemizzando contro l’abuso dell’idea di marginalità21. Comealtri, sostenevano un’ipotesi più o meno marcatamente continuistica nel sensoindicato da Burkert anche Ch. Sourvinou-Inwood e K. Dowden22.Pur prendendone distanza, i classicisti desumevano buona parte dei paradigmiiniziatici poi applicati allo studio delle iniziazioni in Grecia anche dalle operedi studiosi afferenti alle correnti irrazionalistiche della scuola etnologica diFrancoforte23 e a quelle del misticismo (l’esame della trasformazione ontolo-gica dell’iniziando, che muore e rinasce, si deve a M. Eliade, filosofo, letterato,storico delle religioni24).Da questi studi prenderà tuttavia le distanze la cd. scuola di Roma, formatasitra allievi di Pettazzoni, e più vicina alla social anthropology: essa promuovevaanche convegni a carattere metodologico sui riti di transizione25, ma ancoranon si poneva il problema della validità euristica della nozione di iniziazionetribale, come invece già facevano alcuni contributi, ancora isolati, a carattereantropologico26.La nozione di “iniziazione” è tuttavia ancora adottata in lavori che per altriversi sono innovativi27, ed è chiave d’interpretazione anche per M. Allen, checonciliava impostazioni evoluzionistiche e metodi funzionalisti, e per J. S. LaFontaine, formatasi a Cambridge, anche lei di impostazione funzionalista28.
556 ELENA FRANCHI
18 BURKERT 1966.19 GRAF 1979; ID. 1993.20 BREMMER 1978.21 VERSNEL 1993.22 SOURVINOU-INWOOD 1971; DOWDEN 1989.23 FROBENIUS 1898; JENSEN 1933.24 ELIADE 1958.25 Atti Roma 1986.26 GESCH 1985.27 GODELIER 1986.28 ALLEN 1961; ID. 1981; LA FONTAINE 1985.
Dalla metà degli anni Ottanta tuttavia di iniziazioni si parlava in genere soloin sede di puntuale problematizzazione. Nel 1992 J. G. Carrier, americano for-matosi alla London School of Economics, stigmatizzava la terminologia de-sueta ancora in uso nell’oceanistica e privilegiava la prospettiva dellasociologia dell’educazione29. Pochi anni prima l’olandese J. A. M. Snoekaveva esaminato l’insieme degli elementi ritenuti dagli studiosi caratteristicidei riti iniziatici per redigere una definizione di “iniziazioni” universalmentevalida, di fatto però estremamente riduzionistica30.La nozione di “riti di iniziazione” iniziava a essere sostituita da quelle di “ritidi socializzazione”, “riti civici”, “antropopoiesi”. “The Sambia Ritual andGender in New Guinea” è significativo in tal senso: lo storico specializzato inpsicanalisi e antropologia Gilbert Herdt vi descriveva un rito iniziatico secondogli schemi più comuni della prima metà del Novecento, per poi rivedere i fon-damenti teorici della sua descrizione in chiave andropoietica31.Negli anni finali del Novecento si registra un declino del paradigma iniziaticoanche tra i classicisti. Il convegno organizzato nel 1991 a Montpellier32, cherichiamava nel titolo e nei metodi la nozione di “iniziazione”, rappresentaun’eccezione. Divenivano più frequenti invece interventi assai critici della tra-dizionale interpretazione iniziatica, fondati però su argomentazioni interne allediscipline classiche, più che sulle parallele critiche avanzate nell’africanisticae nell’oceanistica, e sugli studi condotti sulle evidenze archeologiche.Un primo segnale forte proviene dalla scuola di Vernant: P. Ellinger, avvalen-dosi di ricerche archeologiche, ridimensiona notevolmente la lettura iniziaticadi Artemide e di presunte guerre rituali33. Pochi anni dopo N.M. Kennell, stu-diando il materiale epigrafico relativo ai riti di socializzazione spartani, cherisale in gran parte all’età romana, respinge la possibilità di desumere da essol’esistenza di riti di iniziazione tribale34.La nozione di “rito di iniziazione” viene esplicitamente rifiutata dalla fine deglianni Novanta: riferendosi ad alcuni riti ateniesi da Burkert interpretati comeiniziatici, G. Donnay mette in discussione come già N. Robertson tale inter-pretazione, e propone la definizione di “rite civique”; similmente, P. Bordeauxsostituisce la categoria di riti di passaggio con quella di “rites d’institution”35.
DALLA NASCITA ALLA MORTE 557
29 CARRIER 1992a; ID. 1992b.30 SNOEK 1987.31 HERDT 1987; ID 1993.32 Atti Montpellier 1992.33 ELLINGER 1993.34 KENNELL 1995.35 BORDEAUX 1982; ROBERTSON 1983; DONNAY 1997.
Alla fine dello scorso millennio iniziano a convivere, in opere collettive dedi-cate ai riti di passaggio o alle iniziazioni, impostazioni metodologiche spessocontrastanti, come accade in “Rites of Passage in Ancient Greece”, e in “Ini-tiation in Ancient Greek Rituals and Narratives36”. Nell’opera collettiva curatada Padilla, gran parte dei contributi rivelano scarsa attenzione per problema-tiche definitorie; fanno eccezione i saggi di C. Calame e D. D. Leitao. Si porràsulla stessa linea di Leitao K. Waldner, allieva di Burkert37.Sul versante antropologico, nel frattempo, un gruppo di studiosi delle Univer-sità di Pavia, Torino, Losanna e del Collège International de Philosophie diParigi si occupa del tema dell’antropopoiesi, del “processo di costruzionedell’uomo”, cui contribuirebbero anche i riti solitamente denominati di inizia-zione, che però non condurrebbero il candidato alla completezza, ma sempli-cemente a una minore incompletezza, come altri riti di passaggio. Stando aCalame, anche i riti d’iniziazione della Grecia antica vanno osservati da unaprospettiva antropopoietica38.Pioniere dell’antropopoiesi nella storia romana antica è stato, almeno in Italia,G. Bonabello, allievo di Remotti, che ha proposto un’interpretazione in chiaveantropopoietica della cerimonia del tollere liberos e dei processi di fabbrica-zione dello schiavo39. Nella storia greca antica dopo Calame (cfr. supra), va aM. Lupi il merito di aver introdotto questa categoria40. Lupi ritiene che la ge-nerazione a Sparta strutturi l’intera società ripartendo i padri e i figli in classidiverse situate a una distanza socialmente stabilita. In una prospettiva di questogenere non vi è un solo momento di transizione per l’individuo, che è il mo-mento di transizione per eccellenza, quello che un’autorevole tradizione distudi colloca a ridosso dei 20 anni e chiama “rito di iniziazione”, ma vi sonodiversi momenti di passaggio, interpretabili nel quadro di una lettura antropo-poietica. Dopo 3 secoli di ricerche non sempre condivise in chiave interdisci-plinare, è attraverso il dialogo con le discipline archeologiche (Ellinger),epigrafiche (Kennell), e antropologiche (Lupi), che, come altre discipline,anche la storia antica supera la nozione di “rito di iniziazione”.
ELENA FRANCHIUniversità degli Studi di Trento
558 ELENA FRANCHI
36 PADILLA 1999; DODD, FARAONE 2003.37 WALDNER 2000.38 CALAME 2003.39 BONABELLO 1999.40 LUPI 2000.
BIBLIOGRAFIA
ALLEN 1961: M. ALLEN, Male Cults and Secret Initiations in Melanesia, Mel-bourne 1961.
ALLEN 1981: M. ALLEN, Vanuatu, Sydney 1981.Atti Montpellier 1992: A. MOREAU (éd.), L’initiation, Actes du colloque in-
ternational (Montpellier 1991), Montpellier 1992.Atti Roma 1986: U. BIANCHI (ed.), Transition Rites. Cosmic, Social and Indi-
vidual Order. Proceedings of the finnish-swedish-italian Seminar(Roma 1984), Roma 1986.
BONABELLO 1999: G. BONABELLO, “La fabbricazione dello schiavo nell’anticaRoma”, in F. REMOTTI (a cura di), Forme di umanità, Torino 1999, pp.53-72.
BORDEAUX 1982: P. BORDEAUX, “Les rites comme actes d’institution”, in Actesde la recherche en sciences sociales 43, 1982, pp. 58-63.
BRELICH 1969: A. BRELICH, Paides e parthenoi, Roma 1969.BREMMER 1978: J. BREMMER, “Heroes, Rituals and the Trojan war”, in StStor-
Rel 2, 1978, pp. 5-38.BURKERT 1966: W. BURKERT, “Kekropidensage und Arrephoria”, in Hermes
94, 1966, pp. 1-25.CALAME 1977: C. CALAME, Les choeurs des jeunes filles en Grèce archaïque,
Roma 1977.CALAME 1999: C. CALAME, “Indigenous and Modern Perspectives on Tribal
Initiation Rites: Education according to Plato”, in PADILLA 1999, pp.278-312.
CALAME 2003: C. CALAME, “Modes rituels de la fabrication de l’homme: l’ini-tiation tribale”, in F. AFFERGAN, S. BORUTTI, C. CALAME, U. FABIETTI,M. KILANI, F. REMOTTI (éd.), Figures de l’humain, Paris 2003, pp. 129-173.
CARRIER 1992a: J. C. CARRIER (ed.), History and Tradition in Melanesian An-thropology, Berkeley et al. 1992.
CARRIER 1992b: J. C. CARRIER, Education and Society in a Manus Village,Waigani 1992.
DODD, FARAONE 2003: D.B. DODD, CH. A. FARAONE, Initiation in AncientGreek Rituals and Narratives, London-New York 2003.
DONNAY 1997: G. DONNAY, “L’arréphorie: initiation où rite civique? Un casd’école”, in Kernos 10, 1997, pp. 177-205.
DOWDEN 1989: K. DOWDEN, Death and the Maiden, London 1989.ELIADE 1958: M. ELIADE, Birth and Rebirth, New York 1958.
DALLA NASCITA ALLA MORTE 559
ELLINGER 1993: P. ELLINGER, La légende nationale phocidienne, Paris 1993.FROBENIUS 1898: L. FROBENIUS, Die Masken und Geheimbünde Afrikas, Halle
1898.GERNET 1936: L. GERNET, “Dolon le loup”, in AIPhOr 4, 1936, pp. 189-208.GERNET 1944: L. GERNET, “Structures sociales et rites d’adolescence de la
Grèce antique”, in REG 57, 1944, pp. 242-248.GERNET 1968: L. GERNET, Anthropologie de la Grèce antique, Paris 1968.GESCH 1985: P. GESCH, Initiative and Initiation, St. Augustin 1985.GLUCKMAN 1962: M. GLUCKMAN, Essays on the Ritual of Social Relations,
Manchester 1962.GODELIER 1986: M. GODELIER, La production des Grands Hommes, Paris
1982, citato nell’edizione inglese (Cambridge 1986).GRAF 1979: F. GRAF, “Apollon Delphinios”, in MH 36, 1979, pp. 2-22.GRAF 1993: F. GRAF, “Initiationsriten in der antiken Mittelmeerwelt”, in AU
36, 2 (1993), pp. 29-40.HARRISON 1912: J.E. HARRISON, Themis: A Study of the Social Origin of Greek
Religion, Cambridge 1912.HERDT 1987: G. HERDT, The Sambia Ritual and Gender in New Guinea, New
York 1987.HERDT 1993: G. HERDT, “Sexual Repression, Social Control, and Gender
Hierarchy in Sambia culture”, in B.D. MILLER (ed.), Sex and GenderHierarchies, Cambridge 1993, pp. 193-211.
JEANMAIRE 1913: H. JEANMAIRE, “La cryptie lacédémonienne”, in REG 26,1913, pp. 121-150.
JEANMAIRE 1939: H. JEANMAIRE, Couroi et Courètes, Lille 1939.JENSEN 1933: A. JENSEN, Beschneidung und Reifezeremonien bei Naturvölkern,
Stuttgart 1933.KENNELL 1995: N. KENNELL, The Gymnasium of Virtue, London 1995.LA FONTAINE 1985: J. S. LA FONTAINE, Initiation, Washington 1985.LAFITAU 1724: J. F. LAFITAU, Moeurs des sauvages amériquains comparées
aux moeurs des premiers temps, Paris 1724.LEITAO 1999: D. D. LEITAO, “Solon on the Beach: Some Pragmatic Functions
of the Limen in Initiatory Myth and Ritual” in PADILLA 1999, pp. 247-277.
LUPI 2000: M. LUPI, L’ordine delle generazioni, Napoli 2000.MAUSS 1910: M. MAUSS, “A. Van Gennep. Les rites de passage”, in L’Annèe
sociologique 11, 1906-1909, pp. 200-202.MOMIGLIANO 1966: A. MOMIGLIANO, Studies in Greek Historiography, London
1966.
560 ELENA FRANCHI
PADILLA 1999: M.W. PADILLA (ed.), Rites of Passage in Ancient Greece, Lon-don-Toronto 1999.
ROBERTSON 1983: N. ROBERTSON, “The Riddle of the Arrephoria at Athens”,in HarvStClPhil 87, 1983, pp. 241-288.
SNOEK 1987: J. A. M. SNOEK, Initiations, Pijnacker 1987.SOURVINOU-INWOOD 1971: CH. SOURVINOU-INWOOD, Recensione a Paides e
Parthenoi, in JHS 91, 1971, pp. 172-177.THOMSON 1941: G. D. THOMSON, Aeschylus and Athens. A Study in the Social
Origin of Drama, London 1941.TYLOR 1871: E.B. TYLOR, Primitive Culture, London 1871.VAN GENNEP 1909: A. VAN GENNEP, Les rites de passage, Paris 1909.VERNANT, VIDAL-NAQUET 1992: J.P. VERNANT, P. VIDAL-NAQUET, La Grèce
ancienne 3. Rites de passage et transgressions, Paris 1992.VERSNEL 1993: H. S. VERSNEL, Transition and Reversal in Myth and Ritual,
Leiden 1993.VIDAL-NAQUET 1968a: P. VIDAL-NAQUET, “Le chasseur noir et l’origine de
l’éphébie athénienne”,in AnnEconSocCiv 23, 1968, pp. 947-964.VIDAL-NAQUET 1968b: P. VIDAL-NAQUET, “The Black Hunter and the Origin
of the Athenian Ephebeia”, in ProcCambrPhilSoc 194, 1968, pp. 49-64.
VIDAL-NAQUET 1974: P. VIDAL-NAQUET, “Le cru, l’enfant grec et le cuit”, inJ. LE GOFF, P. NORA (éd.), Faire de l’histoire, 3, Paris 1974, pp. 137-168.
WALDNER 2000: K. WALDNER, Geburt und Hochzeit des Kriegers, Berlin 2000.
DALLA NASCITA ALLA MORTE 561
RELAZIONI
VALENTINO NIZZO
“Antenati bambini”. Visibilità e invisibilità dell’infanzia nei sepolcretidell’Italia tirrenica dalla prima età del Ferro all’Orientalizzante: dalladiscriminazione funeraria alla costruzione dell’identitàThe part of community affected more than others by a selective process that changes itsrepresentativity, is the one composed of subjects deceased before having reached puberty,especially children younger than 3-4 years.The analysis of the funerary treatment of this large part of society (which could reach up to50% of the population) can offer clues for the interpretation of the evolution of social systemsand, at the same time, ritual beliefs connected with these delicate phases of life preceding theintroduction of the individual in society. Towards the end of the Early Iron Age, the represen-tativity of infants starts to increase: some individuals present attributes of a type and rang thatwould qualify them as adults, to the point that the burial and the entire funerary ceremonyseem to constitute a ritual intended to grant to the deceased the “signs” of a social conditionthat death has prevented them to reach. This new perspective forms part of a broader frame-work of cultural and economic changes that collide with the indigenous communities fromthe middle of the eighth century BC on, and which are amply testified by the funerary evi-dence, of which some examples of Osteria dell’Osa, Veio, Pontecagnano and Pithekoussaiare presented here.
KEY-WORDSInfanzia, discriminazione funeraria, identità, Veio, Osteria dell’Osa, Pontecagnano, Pithe-koussai.
CECILIA PENNACINI
Concezioni dell’infanzia nell’Africa dei Grandi LaghiIn the Great Lakes region of Africa the idea of child was relevantly different from the one de-veloped in the Western world. Infancy was understood as a partial fulfillment of the person,whose spirit survived after death. During the colonial period traditional institutions devotedto the development of the person – namely the extended family – was substituted by schools,but a vacuum was created in the construction of human beings. In some cases the conse-quences of this change were dramatic, like in the phenomenon of child witchcraft and childsoldiers in Congo, and of child sacrifices of Uganda.
KEY-WORDSAfrica dei Grandi Laghi, infanzia, persona, spiriti, possessione spiritica.
DALLA NASCITA ALLA MORTE 809
810 ABSTRACTS E KEYWORDS
FRANÇOISE-HÉLÈNE MASSA-PAIRAULT
Qualche considerazione sui passaggi dell’adolescenza e i suoi paradigmi:dai boschi alla cittàHow can we illustrate adolescents’ anthropological and religious status in the Latin and EtruscanWorld? Two main examples are analysed in order to show the complex aspects of transitiontowards maturity and adult age. The first one is referred to the case of Camilla in Vergil’sAeneid, an adolescent whose transition to adult age and normal destiny is denied. A Praenes-tine mirror of the V Century B. C. tells us a very similar story, unveiling an analogous religiouspattern, where Diana and the woods personify the “non-maturity” status.The second example illustrates on the contrary a successful passage to maturity in presenceof Diana and Apollo: the Cantolle mirror shows the transitional moment of the Etruscan youthunder the guide of Heracles. They are the new class of Juvenes Herculanei.The dialectic opposition between woods and city offers the religious and anthropological background of the examined paradigms we have to replace too in their proper historical context.
KEY-WORDSCamilla, Rex Nemorensis, Diana, Heracles, Juvenes Herculanei.
ALESSANDRO LUPO
Il rito e la costruzione sociale della personaMany human societies confer the utmost importance to the process through which theiryounger members acquire the cultural models shared by the group. Some of these modelsshape their identity as persons, i.e. subjects with agency, capable of a conscious and respon-sible behaviour. Ritual actions accompanying this process sometimes leave permanent markson the bodies, thus exhibiting the status changes imposed by the community. A few ethno-graphic examples will be discussed, analyzing the different options employed in representingthe process that Marcel Mauss has called the person’s “moral career”.
KEY-WORDSRiti di passaggio, plasmazione socio-culturale, agentività, persona.
GILDA BARTOLONI, FEDERICA PITZALIS
Mogli e madri nella nascente aristocrazia tirrenicaThis paper aims different topics concerning the two main roles played by women, not onlyduring the antiquity, while affirming their gender identity: the wife and the mother, whichboth are considered compatible with any assumption of social and religious responsibilities.The analysis is based both on the examination of the iconographic and literary sources, andmainly on the study of medium Tyrrhenian area female graves, dating between the 8th and the7th century BC. This is a period of deep cultural foreign influences towards the Etruscancivilization with the aristocracy spread out.
KEY-WORDSGenere, donne, mogli, madri, Orientalizzante.
MASSIMO VIDALE
La visibilità della donna nelle stratigrafie archeologiche: il corto circuitoetnoarcheologicoStarting from a seminal paper written by Nicholas David in 1971, the article presents someideas on the actual weight of household activities in the formation of the archaeological record.The focus is to which extent male activities and social functions are actually represented insettlement sites where most of the technical processes are monitored to the economical repro-duction of the household. As female domestic activities are constantly overlooked in archaeo-logical reconstructions, ethnoarchaeology may create a peculiar short-circuit in archaeologicalinterpretation. This latter can be solved only by acknowledging female household tasks as themost important type of craft production carried out in an extint social system.
KEY-WORDSArcheologia del genere, femminismo, lavoro domestico, unità domestica, documentazionearcheologica.
ANNA DE SANTIS
L’ideologia del potere: le figure al vertice delle comunità nel Lazio proto-storicoRecent research studies have highlighted the potential of the funerary ritual which was adoptedin ancient Latium during the FBA (Period I) for the identification of social identities and roles.The funerary record consists of small groups of cremation burials, apparently exclusive tothose members of each community who were appointed the main vertical roles. These burialsare equipped with a highly formalized combination of miniature grave goods, almost invariablycomprising the isomorphic indicators of the two most important vertical roles: military/political(the sword) and religious (knife, statuette, double shields). Their frequent association in thesame burial apparently indicates that single men were often appointed both political and reli-gious leadership. This combination of elements may support the hypothesis that the latterwere the agents of the cultural change which took place in this period, possibly as a reactionto the previous influence from Etruria, whose specific action consisted of the enhancementand reinforcement of the local cultural/ethnic identity.The ritual of Latial period I is still practiced in similar forms in the subsequent phases of theIron Age, in relation to individuals holding important vertical roles.
KEY-WORDSIncinerazione; miniaturizzazione; ruolo politico-militare; ruolo religioso; identità etnica.
FABIO VITI
I guerrieri degli Antichi e dei (Pre)Moderni (America, Africa)A comparison between ancient and primitive or pre-modern societies can be made basing notonly on formal resemblances and historical derivations, but also on descriptions in literatureof worlds far away which are the work of authors whose cultural background is marked by
DALLA NASCITA ALLA MORTE 811
references to Classical Antiquity.While the Native American warrior is portrayed as a tragic and lonely hero evoking those ofAncient Mythology, the African warrior is rather placed within a political order that is able toorganize and manage the army in ways analogous to the ancient Romans.
KEY-WORDSGuerra, Guerrieri, Antichità, America, Africa.
ANDREA CARDARELLI
L’origine delle comunità protourbane in ItaliaIn Italy, there have been two approaches to analyzing the developing way of the protourbansociety. The first approach, which assumes a perspective based on a brief time-span, does notascribe significance to previous Late Bronze Age evidences. The second one, which assumesa perspective based on a wider time-span, moves within a framework where economic andsocial change are recognizable at least from the Middle Bronze Age (XVII BC) onwards. Thelatter is used in this brief overview, in which the growth of the protourban community is analyzedchiefly in the southern Etruria context.
KEY-WORDSItalia, Etruria, Età del Bronzo, comunità.
MARIANO PAVANELLO
Modelli di insediamento e complessità sociale: il contributo dell’antropo-logia ecologicaWilks assumes that a rapid transition from a foraging economy to a labor intensive agrariansystem characterized the history of the Akan people during the 16th century in the forest areaof present-day Ghana. This article challenges this assumption and shows, from an evolutionarypoint of view and on the basis of a set of elements from the literature on foraging and swiddensocieties, that such a transition is not possible in a span of one or two centuries. Moreover,the Author analyses and criticizes the models elaborated by R.L. Carneiro on the correlationbetween techno-economic systems and social complexity.
KEY-WORDSAgricoltura, Akan, Caccia-raccolta, Carneiro (R. L.), Transizione (processi di).
EUGENIO BORTOLINI, MAURIZIO TOSI
Dal Kinship al Kinship: Le tombe collettive nell’Oman del terzo millennioa.C. e la costruzione della civiltà di MaganFrom the end of 4th millennium BC Eastern Arabia knew a rapid accretion of social com-plexity connected to the expansion of trade networks, at the outcome of Middle Holoceneadaptive strategies. However, contrary to other areas across South West Asia, neither state
812 ABSTRACTS E KEYWORDS
nor urban centres developed in the region. Water management systems were built and the re-sulting oases and coastal plateaus were closely overlooked by hundreds of monumental col-lective burials. A novel approach is proposed to explain the socio-cultural evolution underlyingthe formation of Magan by means of an architecture of tribal alliances testified by complexfunerary practices.
KEY-WORDS
Evoluzione Culturale; Complessità Sociale; Tombe Collettive; Età del Bronzo; Oman.
PATRIZIA RESTA
Il modello segmentario della nazione albanese, dai lignaggi alle reti di pa-rentela in una società agropastoraleThe essay describes the changes involving the segmentary lineage kinship system in Albania,showing how the principle of segmentarity has played an active role in mediating the transitionto the contemporary social organization. The general objective is to demonstrate, on the basisof proposed ethnography, that the lineage segments, in a conflict situation faced after the fallof Socialism, have acted as a mobile group in which there was activated alliance networksthat, founded on the sibling solidarity, have organized their own leadership privileging thesituational fields rather than kinships ones.
KEY-WORDSLignaggi segmentari; Discendenza unilineare; Reti cognatiche; Albania; Trasformazioni.
NICOLA PARISE, CARMEN MARTINELLI, EMANUELA ALBERTI
Reciprocità e ridistribuzione, modelli meccanici e modelli statisticiKarl Polanyi’s models of economic institutional structure in different societies have been re-vised in a debate that began since the publication of his works. Here are discussed two sam-ples, showing processes that configure more dynamic models (PARISE). In the recent debate on Bronze Age Near Eastern and Aegean societies, Polanyi’s redistributivemodel has been widely criticized and revised, in favor of a more articulated and multi-facedperspective. Large social and economic sectors appear since the first formation of the cen-tralized state to be substantially autonomous, being linked to the central power only indirectly.This holds true both within the internal (primary and related productions and craft activities)and the external (exchange and trade) economic spheres. Mycenaean trade has to be seenwithin this complex framework: it is a phenomenon so widely attested in the archaeologicalrecord as much substantially absent from the contemporary texts. While Near Eastern andAegean archives give almost no mention of the fact, the circulation of Mycenaean productsis widely documented, both in the Eastern and Central Mediterranean. The diffusion of Myce-naean decorated pottery (and of its contents) is especially important, reaching imposing pro-portions during the 14th and 13th centuries BCE, with correlated phenomena of delocalization,imitation, hybridization and reverberation. Despite some hints of palatial involvement in thephase of production, this wide range of Mediterranean evidences points to the existence of acomplex network of multiform trade relationships and economic partnerships, too variously
DALLA NASCITA ALLA MORTE 813
organized to be forced exclusively within the official codes of directional exchange (ALBERTI). Polanyian Port of Trade as first institutional place of commerce proper of society whose economyis embedded, is a place created in a periphery region, on the coast or along rivers where tradepartners may meet avoiding cultural impact on the host society. Transactions are regulated byagreements and organized through government controlled channels (administrated trade).The model, established by empiric approach that covers a too large chronologic period anddifferent geographic areas, sometimes in a romantic view of pre-capitalist societies, produceda too static framework. This approach explains the disagreement of ancient economy studentson interpreting archaeological and epigraphic data on nature, dynamics and implications oftrade activities in a Port of Trade. Anyway the idea is relevant, because it focus on the ‘contactsurfaces’ between cultures, through which a sort of “cultural osmosis” takes place. Epigraphicdocuments show relevant changing dynamics in wood trade between the Reign of Macedoniaand Greek cities on the coast, traditionally related to the king figure and gift exchange(MARTINELLI).
KEY-WORDSKarl Polany, Ridistribuzione, Porti di traffico.
FABIO DEI
Alla ricerca dello hau. Persone, cose, scambiAnthropological theories on the concept of “gift” have constantly grown since the publicationof Marcel Mauss’ celebrated essay (1924). In this paper, I discuss some recent trends on thetopic, starting from the problem of the hau – the maori spirit of the thing given which compelsthe recipient to make a return. Harshly criticized by Lévi-Strauss in the ‘50s, the theory ofhau can nowadays open new perspectives on exchange, material culture and the relationshipbetween things and persons. In particular, I argue that the category of “inalienable possession”is an intriguing field of dialogue between archaeology and cultural anthropology.
KEY-WORDSDono, hau, Marcel Mauss, cultura materiale, oggetti inalienabili.
ANNA MARIA BIETTI SESTIERI
Archeologia della morte fra età del bronzo ed età del ferro in Italia. Im-plicazioni delle scelte relative alla sepoltura in momenti di crisi o di tra-sformazione politico-organizzativaChanges in funerary ritual in connection with organizational and socio-political transformationin Late Bronze Age and Early Iron Age Italy.A generalized change in ritual may often constitute a visible indication of crisis and transfor-mation in the corresponding community. This paper takes into consideration the different, butuniformly significant implications of the adoption of cremation, which took place in northernand central Italy from the initial phase of the Recent Bronze Age (ca. XIV-XIII sec. BC). Theconsidered complexes include the cemetery of Olmo di Nogara (Verona), single cremation
814 ABSTRACTS E KEYWORDS
tombs from the Marche (Early Iron Age), the small groups of ancient Latium cremation tombswith miniature funerary outfits (Latial period I, Final Bronze Age). In all three cases, thechange in ritual appears to be in close connection with a crucial socio-political innovation:the transition from shared to centralized political and religious power.
KEY-WORDSNecropoli, contesto, rituale funerario, incinerazione, armi.
HENRI DUDAY
L’Archéothanatologie et ses incidences sur la compréhension des pra-tiques funéraires. Quelques applications relatives à des nécropoles proto-historiques et historiques de l’Italie méridionale et de la Sicile
The archaeothanatologic approach renewed the methods of burial archaeology. At Cumae,taphonomic observations led a reconstruction of the Iron Age burial containers: U-sectioncoffins (hollow tree trunks?), with narrow sides and much thicker ends. At Megara Hyblaea(Sicily), a Hellenistic grave stored the simultaneous deposition of six individuals probablydied a violent death and buried face down. In that regard, the Author emphasizes the wealthof information that can be taken out by the old excavation reports.
KEY-WORDSArcheologia funeraria, Archeotanatologia, bara monossile, sepolture multiple, tafonomia delcadavere.
LUCA BONDIOLI, ALESSANDRA SPERDUTI
Comunità dei morti e individui scheletrici: dallo studio di popolazioni allaricostruzione della storia biologica individualeReconstructing patterns of life and death of ancient populations from their odonto-skeletal re-mains is a rather delicate, complex and, mostly, unattainable task. Nevertheless, the informativevalue of bones and teeth as an alternative data source for historical studies has been increasinglyacknowledged. This kind of date are certainly more “talkative” when “handled”, in a combinedindividual/population approach, and when interpreted in a broader, multidisciplinary-derivedframe. This study demonstrates the value of a multidisciplinary approach which brings togetherhistorical and paleoanthropological evidence.
KEY-WORDSPaleobiologia, età romano imperiale; paleonutrizione; paleotraumatologia; esostosi del meatoacustico.
DALLA NASCITA ALLA MORTE 815
ADRIANO FAVOLE
L’ambivalente statuto dei resti umani: il caso del nuovo Museo CesareLombroso di TorinoThe aim of this article is to reflect on the ambivalent status of human remains. Suspendedbetween being and nothingness, subject and object, person and thing, matter and meaning,the human remains are frequently used as instruments of negotiation and political confrontation.Beginning with reconstructing the debates on “repatriation” that have involved cultural anthro-pologists, physical anthropologists, archaeologists and museums in recent decades, this articleexamines the controversies over the opening of the new Cesare Lombroso Museum in Turin.The thesis argues that the presence of human remains, their inherent ambivalence, is an im-portant source of conflict and ethnic polarization between “meriodionali” or “Borboni” and“settentrionali” or “Sabaudi”.
KEY-WORDSResti umani, Museo Lombroso, Antropologia culturale, Antropologia fisica, Restituzione.
816 ABSTRACTS E KEYWORDS
POSTERS
ELISA CELLA
Antropologi e archeologi a confronto: il convegno on-lineIn the last decade a new way of communicating archaeology is taking place, due to the de-veloping of the web and the diffusion of on-line journals and forum dedicated to anthropologyand archaeology. The meeting “Dalla nascita alla morte: antropologia e archeologia a con-fronto” has in the Poster and Forum on-line section some of his main peculiarities, both in-tended as tools for the improvement for an innovative way of dialogue between archaeologistsand anthropologists.
KEY-WORDSForum, antropologia, archeologia, comunicazione, Poster
SONIA MODICA
Suoni dal silenzio eterno: idiofoni, aerofoni, oggetti sonori e morti pre-mature del Lazio anticoThe well-known treatment of children remains provides another way to interpreting the evi-dence of the so-called ‘liminal rite’. Sounding objects of different mechanism and shape(tintinnabula, whistles, wind chimes, castanets and so on) characterize several child burialsin the same way as some adult ones. Spaces, ritual behaviour and mortuary patterns are thesymbolic recall to special categories of deceased, maybe those mentioned with the definitionof ‘exsequiae immaturae’. Archaeological remains and ritual options suggest new readingsabout the burial area setting connected to private choices, transmission of memory, traditionperpetuation and gender ritual.
KEY-WORDSLatium Vetus, protostoria, aerofoni, sepolture infantili, rituale.
SILVIA AGLIETTI
La Mors Acerba. Alcuni spunti di riflessione sulla sepoltura degli infantiin età romanaThe Roman literary sources, compared with the rare burials of the Imperial Age, show howthe infants, died before their first birthday, had no legal dignity. On the contrary, the rare epi-graphic data testify the will of self-affirmation of the lower classes of society. In particular,the inscriptions of cemeteries surrounding the castra Albana, the legionary camp built in the3rd century AD, 20 km south of Rome, seem to be associated with the growth of a new localcommunity, from which the infants were not excluded.
DALLA NASCITA ALLA MORTE 817
KEY-WORDSSepolture infantili, età imperiale, epigrafia, classi sociali, castra Albana.
IDA BRANCACCIO
Parthenoi dell’acropoli, salvezza della cittàThe myth and the cult of Hyakinthides can be considered as an interesting explanation of therelationship between young women and urban civic context of Athens. Focal point is the sal-vation of social community, which can be in young women’s power, as long as they assurepolis survivorship by new generations birth. Basic element is the initiation ritual which allowsto overcome the individual “presence crisis” during the transition age from adolescence toadult life. As a sociological theory of social existence, final aim is the integration of newpolitai in Athenian citizenship.
KEY-WORDSPolis, parthenoi, sacrificio, hyakinthides-erechtheides, salvezza.
RACHELE DUBBINI
Lo spazio dell’aggregazione: choros e dromos nei riti d’istituzione in GreciaThe comparison between the archeological remains in the agorai of Corinth and Argos andthe literary sources seems to confirm the primary role played by the agonistic structures inthe context of the rites of aggregation. Many scholars already studied the meaning of the ini-tiation cycle and its phases, but only few of them worked on its spatial dimension. If the mar-ginal period is generally spent outside the polis, the integration into the citizen body throughinstitution rites took the form of athletic tests and lyric competitions set in the city center,under the gaze of the assembled community.
KEY-WORDS
Agoni rituali, iniziazione, riti di aggregazione, dromos, choros.
ELENA FRANCHI
Riti di iniziazione in Grecia antica? un terreno d’indagine interdiscipli-nareAlthough there’s no evidence of tribal initiation rites in ancient Greece, scholars of differentbranches studied this subject. Through the dialogue with archaeology, epigraphy and anthro-pology, as well as with other branches, ancient history has overcome the notion of “initiationrites” to create those, at present more fashionable, of “civic rites” or “institution rites”; theybelong to a general process of anthropopoiesis that leads, through many rites, from the birthto the death, from the inherent incompleteness of the anthropos to a minor one.
KEY-WORDSIniziazioni, riti di passaggio, anthropopoiesis, ephebeia, agogé.
818 ABSTRACTS E KEYWORDS
VERA ZANONI
Nella terra di nessuno. Antropologia fisica e cultura materiale nella gia-citura del cacciatore della Busa BrodegheraIn 1976 human skeletal remains were recovered from the deep fissure known as BusaBrodeghera: the skeleton belonged to a young male, dead at the age of 19-20, who sufferedfrom several skeletal alterations, both congenital and traumatic.The discrepancy between the skeletal age and the socio-cultural meaning of the metal objectsfound together with the bones, i.e. a Certosa fibula, three bronze rings, an iron knife and abelt-hook - which is a typical feature of non adult’s venetic graves - shows the difficulties ofancient societies in depicting the “no man’s land” of adolescence.
KEY-WORDSBrodeghera, riti, passaggio, adolescenza, liminalità.
PIA GRASSIVARO GALLO, DEBORA MORO, ALESSIA PASSAQUIETI
Le ragazze di Mangochi (Malawi) raccontano il longininfismo rituale (ge-nital stretching)In 2004, Padua’s Working Group on FGM organized a mission to Malawi (Mangoci district)to analyze the pre-pubertal rites of passage (chiputu) within which the stretching of the labiaminora occurs. The psychological experiences of the rite were emphasized by the analysis ofthe drawings and the comments on the rite made by 95 schoolgirls (mean age, 13.98). 50% ofthe examined girls underwent genital stretching. The results highlighted two different groupsof subjects: those who adhere to and those who criticize and are somewhat opposed to tradi-tional stretching.
KEY-WORDSMalawi, riti di passaggio prepuberali, genital stretching, esperienze psicologiche, drawingtest.
GIANLUCA MELANDRI
La donna e il potere a Capua tra ostentazione suntuaria e ritualità fune-bre: il caso della t. Fornaci 722 di età orientalizzanteThe item analyzes the richest tomb 722 of Capua, dated to the Orientalizing period. The gravegoods are prestigious and foreign objects are together with local stuff. The ritual is exceptional:the cremation type is comparable with that known at Proto-attic Athens. It is possible to re-construct the various stages of the funeral process through the analysis of the documentation.However, the distinctive feature of the tomb is that this kind of ritual is reserved to a woman.This leads to analyze, from an archaeological and anthropological point of view, the difficultcorrelation between women and power in Capua.
KEY-WORDSDonna, potere, Capua, cremazione, Orientalizzante
DALLA NASCITA ALLA MORTE 819
SABRINA BATINO
Il mondo delle spezie e degli aromi: l’immaginario dello zafferanoThe sphere of aromatic plants and spices is an intriguing field of research, a virtual bridgenot only for intercultural communication and networks among complementary disciplines,but also between past and present.It can contribute to promote a valorisation of modern saffron spice cultivations as a culturalproduct, an important cultural heritage whose links reach back more than three millennia inthe late Bronze Age Mediterranean.
KEY-WORDSZafferano/croco, rituali di passaggio, alterità, giardino, Thera.
SIMONA SANCHIRICO
La Pizia di Delfi. Metodi oracolari e rituali catartici di contattoThe Ancient Greeks created many oracular centers where - according to earlier myths - thegod Apollo spoke to the people to predict their future. The priests of Apollo were mostly men, but there was also a woman - called Pythia - to deliveroracles: she was regarded as the unconscious instrument of a divine revelation. This peculiarityhas its origin in a pre-apollinean phase of the delphic sanctuary, when the shrine was dedicatedto Gea, the goddess of Earth.The Pythia descended into the adyton and ascended her tripod seat, holding laurel leaves anda dish of water from the Kassotis spring, into which she gazed.Using various oracular methods, she announced to the supplicants the will of Apollo.
KEY-WORDSPizia, Gea, sacerdozio femminile, catarsi, metodi oracolari, Delfi.
MARIO FEDERICO ROLFO, FRANCESCO MESSINA, GABRIELE SCORRANO,VALERIA TRUPIANO, AGOSTINA APPETECCHIA
Analisi genetica di comunità montane in aree isolate del centro Italia trapreistoria e storiaThe genetic variability in Italy is the result of population movements and invasions whichtook place in both historical and prehistoric times. The aim of this study is to reconstruct thegenetic background of mountain communities between Lazio and Abruzzo (central Italy) andto establish if the genetic pool held before Roman colonization. Preliminary results will becompared with the ancient genetic data obtained from the prehistoric site (Mora Cavorso Cavenear Jenne) and from some necropolis of pre-roman age. For a correct interpretation of theresults it’s important to consider the cultural and archeological context of this area.
KEY-WORDSDNA, genetica, comunità montane, Mora Cavorso Cave, Jenne.
820 ABSTRACTS E KEYWORDS
MASSIMO OSANNA, MICHELE SCALICI
Nascita delle aristocrazie e sistemi di parentela in area nord-lucanaThe NW Lucanian territory plays a fundamental role in understanding the development andthe construction of pre-roman societies in southern Italy. By the end of 7th century B.C. thepopulation of this area seems to have had a deeper and stronger contact with different Greekgroups of the coast. Many of these ancient Lucanian sites have been discovered and studiedin the last few years, such as Torre di Satriano, where a very important social and politicalcentre of 7th -6th cent. B.C. has been recently discovered thanks to the excavations. Recentanalysis in the Ruvo del Monte necropolis showed as well, in the same period, the prominentrole of ancestors’ memory in the construction process of local societies.
KEY-WORDSBasilicata, potere, memoria, Torre di Satriano, Ruvo del Monte.
GABRIELLA CETORELLI SCHIVO
Un singolare caso di social inclusion nell’insediamento protostorico di Ca-racupa-Sermoneta (LT)
From antiquity to present day, when the model of being in good health is strongly followedand proposed, disease has been commonly regarded as a phenomenon, if not to be removeddrastically, at least to be marginalized and hidden, or even to be ignored. In this perspective,a discovery among the archaeological excavations at the necropolis of Monte Carbolino-Caracupa (Sermoneta), in the province of Latina, is offered as an interesting case of “socialinclusion” of the past. The investigation of the tomb 12 (8th – early 7th century BC.) has re-vealed the remains of a deceased suffering from serious genetic abnormalities, whose gravegoods and whose living conditions were optimal (thanks to the observation of a proper diet,as shown by the paleopathological diagnosis). It shows, therefore, as in the context of thelocal community the deceased was accepted and supported by forms of parental assistance.
KEY-WORDSPatologico, sociale, integrazione, Caracupa-Sermoneta, Latium Vetus.
GIANCARLO GERMANÀ BOZZA
Necropoli e società aristocratica a Siracusa durante l’età arcaicaAfter the founding of Greek colonies in Sicily, new relationships of identity took place amongthe native world. The study of Syracuse necropolis offers new data, that, compared to thenecropolis of the motherland Corinth, provide new important evidences about an overwhelm-ingly aristocratic society until the expulsion of gamoroi and the advent of tyranny.
KEY-WORDSSepoltura, Corinto, necropoli, Sicila, Siracusa.
DALLA NASCITA ALLA MORTE 821
DANIELE F. MARAS, FERDINANDO SCIACCA
Ai confini dell’oralità. Le forme e i documenti del dono nelle aristocrazieorientalizzanti etruscheAmong the different values which can be identified in the aristocratic gift-exchange system,we can point out some cases to be referred to opening-gifts in the context of international re-lationships. That is the case of some gold and silver oriental bowls found in Etruscan andLatin Orientalizing funerary contexts. Furthermore, analyzing Homeric tradition and epi-graphic texts − specially those occurring on the bucchero kyathoi of the Caere-Vetulonia series− the authors try to recognize the meaning of gift in some selected cases and to identify themost ancient ceremony aspects of gift, including oral tradition, sometimes recorded by 7th
century inscriptions.
KEY-WORDSDono, principi etruschi, kyathoi Caere-Vetulonia, epica omerica, scrittura e oralità.
MASSIMILIANO DI FAZIO
“La morte è dura; ancora più duro il cordoglio”. Primi appunti da unaindagine sul pianto rituale nel mondo etruscoThis text is part of a wider research, whose main topic has been the investigation of ritualmourning as one of the aspects of the Etruscan funerary customs. Primary aim of the researchhas been the creation of a database of all the images of mourners and prothesis (the expositionof the dead). All the data were compared with the current anthropological debate on the valueof mourning. Finally, images have been analysed with a perspective connected with the studiesof gesture.
KEY-WORDSLutto, morte, pianto, Etruschi, rituali.
GIOVANNI DI STEFANO, GIUSI VENTURA
Una sepoltura principesca nella necropoli greca di Castiglione: un “fe-stino” per i morti e un “banchetto” per i viviDuring the digging campaign of 1999 in the necropolis of Castiglione emerged 14 tombswhich, for typology and funeral rites, can be assigned to the archaic Greek type; betweenthem, tomb 12 can be considered as a funeral complex and original area: it is circumscribedby circular stone fence and distinguished by the other tombs through its use as a multiple bur-ial, rich outfits and an anomalous deposition of eight skulls, without post cranial remains,connectable to a complex ritual which has no comparison beneath other coeval necropolises.
KEY-WORDSSepoltura, crani, banchetto, Castiglione.
822 ABSTRACTS E KEYWORDS
SABRINA MASOTTI, EMANUELA GUALDI RUSSO
Il rito della cremazione: osservazioni antropologiche su alcuni casi studiodi particolare interesse da necropoli dell’Italia settentrionaleCremation is a funeral custom that consists in corpse burning on funeral pyre. From theanthropological study of burned bones we can determine physical and pathological characteristicsof the deceased, in order to reconstruct the population lifestyle they belonged. This paperdescribes some interesting case studies from two Italian burial contexts, the Ponte Nuovonecropolis (Verona, 10th - 9th century B.C.) and the necropolis of Bologna Centrale railwaystation (1st – 3rd century A.D.).
KEY-WORDSCremazione, ossa, frammentazione; età del Ferro, età romana, Ponte Nuovo (Verona), BolognaCentrale.
AMEDEO BOROS
Una comunità rurale ungherese e il suo particolare sistema funerario. Ilrituale comunitario di Szatmárcseke come motore di continuità culturaleEvery funeral is a separation rite, inside which, in some cultural context, the aggregation riteshold a prominent position. This happened in the last century in the Calvinistic community ofSzatmárcseke, a village in the Northeast of Hungary, where we have studied the communityfuneral rite. The Calvinistic people use a particular wooden grave symbol named csónakalakú(in the shape of a boat), and the Calvinistic cemetery too presents several peculiarities. Thefuneral rite had a strong community content, which defended the family of the deceased fromthe solitude of the death.
KEY-WORDSAntropologia culturale, rituali funerari, cultura ungherese, continuità culturale, simbolo tom-bale ligneo
ROBERTO LIBERA
Il ponte: un passaggio nell’Aldilà attraverso l’indefinitoThe symbolism of the bridge is part of a vision of dangerous passage between two worlds,often used in religious beliefs and traditions, as a metaphor for the transit of the soul in theafterlife. In ancient Rome, the pontifex seems to have, in the etymology of his name, a partic-ular relationship with this symbolism.The bridge is a path that connects two different realities, as a magical and dangerous site. Thepontifex is the “medium” that may link with the afterlife, as the intermediary between the sa-cred and the profane.
KEY-WORDSPonte, pontefice, morte, anima, diavolo.
DALLA NASCITA ALLA MORTE 823