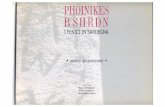Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del Barigadu (Sardegna, Italia)
Transcript of Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del Barigadu (Sardegna, Italia)
Links between
Megalithism and Hypogeism in Western Mediterranean Europe
Edited by
Juan Antonio Cámara Serrano José Andrés Afonso Marrero
Liliana Spanedda
BAR International Series 2151 2010
Published by Archaeopress Publishers of British Archaeological Reports Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED England [email protected] www.archaeopress.com BAR S2151 Links between Megalithism and Hypogeism in Western Mediterranean Europe © Archaeopress and the individual authors 2010 ISBN 978 1 4073 0692 6 Printed in England by 4edge Ltd, Hockley All BAR titles are available from: Hadrian Books Ltd 122 Banbury Road Oxford OX2 7BP England [email protected] The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com
95
INCONTRO FRA IPOGEISMO E MEGALITISMO NEL TERRITORIO DEL BARIGADU (SARDEGNA,
ITALIA)
Cinzia Loi∗
Abstract New contributions to the knowledge of Sardinian megalithism are offered by dolmenic monuments recently discovered in some up to now unknown sites of Barigadu, geographical area of the central Sardinia. A study of these structures has, also permitted some considerations about relations between the dolmenic monuments and the rock-cut tombs (the so called “domus de janas”), that are falling in the same geographical area. Moreover the “domus de janas” graves are often rich of architectonic elements reproducing the structures of the prehistoric dwellings, that are located in the same area. Results about the environmental study are specially interesting as we study these relations. The obsidian lithic artefacts analysis “the black gold of Prehistory” found in the dolmenic sites, could provide useful guidance for dating both dolmen and “domus de janas” graves and allocating them in the same cultural context. Keywords: Barigadu, prenuragic age, rock-cut tombs, dolmenic monuments, territorial analisys. Resumen Los monumentos dolménicos recientemente descubiertos en el área geográfica de Barigadu en la zona central de Cerdeña constituyen una nueva aportación para el conocimiento del megalitismo sardo. El estudio de estas estructuras ha permitido también platear ciertas consideraciones acerca de las relaciones entre los monumentos dolménicos y las tumbas en cueva artificial (las denominadas “domus de janas”) que se distribuyen por la misma región. Además las tumbas tipo “domus de janas” son ricas en elementos arquitectónicos que reproducen las estructuras de las cabañas prehistóricas localizadas en la misma área. En relación con esto último, son particularmente interesantes los resultados del estudio medioambiental. El análisis los artefactos de piedra tallada realizados en obsidiana, “el oro negro de la Prehistoria”, encontrados en los yacimientos dolménicos puede proporcionar una vía útil para datar tanto los dólmenes como las “domus de janas” lo que permitirá situarlos a ambos en el mismo contexto cultural. Palabras clave: Barigadu, época prenurágica, tumbas en cuevas artificiales, monumentos dólménicos, análisis territorial.
∗ Dipartimento di Storia, Università di Sassari [email protected]
Links between megalithism and hypogeism in western Mediterranean Europe: a first approach
96
1. Introduzione La regione storico-geografica del Barigadu, ubicata nella parte centrale della Sardegna, occupa una superficie complessiva di 293,94Kmq (Figura 1). In quest’area sono stati individuati finora 138 siti (Loi, cds2) cronologicamente inquadrabili tra la metà del V millennio AC (Neolitico Recente, cultura di Ozieri) e l’età del Bronzo.
Figura 1 - Inquadramento geografico del Barigadu. I siti attribuibili alla fase prenuragica, epoca analizzata in questo studio perché maggiormente rispondente ai suoi specifici interessi, sono in tutto 60 (Loi, cds2). Tra questi è stato possibile individuare almeno 150 tombe ipogeiche del tipo a “domus de janas”, due dolmens, due menhirs, un gruppo di statue-menhirs, 11 stazioni litiche ed un riparo sotto roccia (Figura 2).
Figura 2 – Monumenti preistorici del Barigadu.
Nel presente lavoro l’attenzione si è appuntata in particolare sulle emergenze ipogeiche e megalitiche che, sulla base della loro vicinanza topografica, permettono di avviare un discorso sull’incontro fra ipogeismo e megalitismo in questa parte dell’isola. Nel Barigadu il fenomeno ipogeico si presenta con manifestazioni interessanti soprattutto per quanto concerne i decori simbolici (falsa-porta, protomi e motivi corniformi, etc.) e le rappresentazioni di partiture architettoniche (soffitti decorati, pilastri, lesene, zoccoli, etc.) incisi, scolpiti o dipinti sulle pareti delle sepolture (Depalmas 2000, 835-845). Nel territorio in esame le domus si distribuiscono in prevalenza a gruppi di tre o quattro, mentre si ha un solo esempio di necropoli formata da più di 20 ipogei (Bacco 2000, 971-978). A parte le tombe di Su Angiu-Neoneli (Loi, cds3), distrutte, pare, da incontrollati lavori di cava, di Niu Crobu-Ula Tirso (Taramelli 1935) e di Grugos-Busachi (Bacco 1988, 109), andate sommerse sotto il Lago Omodeo, quelle ancora visibili sono per lo più bicellulari (35,06%) precedute da piccoli ambienti d’ingresso. Lo schema planimetrico, documentabile nel 53,10 % degli ipogei, è spesso a proiezione longitudinale, con padiglione d’accesso, anticella e cella principale, arricchita talvolta da uno o più ampliamenti laterali seriori. Le celle presentano una morfologia varia con piante circolari, sub-circolari, rettangolari, trapezoidali e pareti verticali o concave. Le sepolture megalitiche del Barigadu (Loi, cds3), ubicate rispettivamente nelle località di S. Maria e Nole in agro di Neoneli, rivestono una grande importanza nell’ambito della conoscenza sulla diffusione del megalitismo in Sardegna, giacchè a S di quelle ricadenti nel territorio del comune di Austis, il dolmen e l’allèes couvertes di Perda Longa (Lilliu 2003, 218, 224) – limitrofo a quello di Neoneli – se ne conoscevano solo sei (Cicilloni 1999, 53). I dolmens del Barigadu, entrambi di tipo “semplice”, si diversificano sia nelle dimensioni, che aumentano in quello di Nole, sia in alcune particolarità architettoniche. Non si osservano in essi elementi decorativi o cultuali quali incisioni, coppelle, canalette, etc. In quanto alla cronologia, le sepolture in esame, sulla base delle datazioni proposte per le tombe dolmeniche sarde, potrebbero ascriversi fra gli ultimi tempi del Neolitico e la piena Età del Rame. E’ molto probabile che questi megaliti fossero in relazione con i menhirs di Sa Perda Longa e di S. Angelo, distrutti, purtroppo, in seguito a lavori agricoli alla fine degli anni ‘60 del Novecento. Le statue-menhirs rinvenute ad Allai (Cossu 1992-3) ben si inquadrano nell’ambito del vasto corpus di quelle isolane, risultato di un lungo processo evolutivo alla cui origine stanno i menhirs aniconici. Le statue allaesi sono state individuate tra le strutture del nuraghe Arasseda e intorno ad esso, per un raggio di oltre 100m. I monoliti,
Z. Loi. Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del barigadu (sardegna, italia)
97
che in origine formavano, forse, un allineamento, sono caratterizzati da grandi schemi facciali a “T” o ad ancòra e ad ampi motivi verticali a “ferro di cavallo”, e presentano in posizione ventrale cornici di forma rettangolare o ellissoidale, includenti talvolta superfici lisce o incise da spighe, quadrettature, etc. (Atzeni 1994, 190-191). Per quanto concerne la forma, la Cossu (Cossu 1992-3, 307) ne distingue tre differenti tipologie (statua-menhir di sagoma ogivale e sezione piano convessa di misura medio-grande; statua-menhir su pilastrino stretto, rastremato in alto, di sezione semicilindrica; statua-menhir di modulo miniaturistico), mentre per quanto riguarda la sintassi iconografica si distinguono più schemi. Le statue di Allai trovano stringenti analogie con quelle rinvenute nel contiguo territorio di Samugheo, caratterizzate anch’esse da grandi schemi facciali, “U” rovescia e fregio centrale (Perra 92, 37). 2. I monumenti e l’analisi territoriale Per tentare di comprendere i rapporti intercorsi fra ipogeismo e megalitismo in questa regione, abbiamo circoscritto attorno ai tre siti megalitici individuati - due di origine funeraria (dolmens di S. Maria e Nole) ed uno di origine cultuale (statue-menhirs di Pranu Olisai) -, un’area di 2 km di raggio (Figura 3). L’ampiezza dell’area d’indagine è stata dettata dalla relativa vicinanza tra i diversi monumenti. All’interno di ogni zona teorica sono stati analizzati, oltre alla contiguità topografica tra le diverse testimonianze archeologiche, anche gli aspetti geografici che caratterizzano i territori in cui ricadono i siti e che possono aver influenzato la scelta degli stessi in relazione alle esigenze di sussistenza2. La prima area d’indagine, denominata area A, è stata incentrata attorno al dolmen di S. Maria (Figure 4, 5). La tomba, disposta lungo l’asse SE-NE e con ingresso a SE, ha pianta vagamente trapezoidale. La parete sinistra è costituita da un unico lastrone rozzamente lavorato e rincalzato da pietrame minuto, mentre la parete destra è formata da un lastrone regolarizzato nella faccia interna e sul piano di posa, al quale si affiancano due pietre sovrapposte. Il lastrone di copertura, ancora in situ ma spezzato trasversalmente, presenta forma trapezoidale e profilo arrotondato. Alcune pietre poste attorno al monumento, celate in parte dalla fitta macchia mediterranea, potrebbero far parte del peristalite.
2 La nostra indagine prende spunto dal modello di indagine locazionale noto come Site Catchment Analysis (Cazzella 1989, 111-117).
Figura 3 - Visione d’insieme delle tre aree di indagine: A, B, C.
Figura 4 - Neoneli – Dolmen S. Maria. Pianta. (dis. C. Loi) (1:20).
Links between megalithism and hypogeism in western Mediterranean Europe: a first approach
98
Poco distante è stata rinvenuta una scheggia amorfa di ossidiana, di probabile valore votivo o amuletico. La presenza di tombe romane ed altri resti dimostra che l’area ha avuto una continuità di occupazione che si estende fino all’epoca medievale.
Figura 5 - Neoneli – Dolmen S. Maria. Sezioni. (dis. C. Loi) (1:20). All’interno della zona definita attorno al dolmen di S. Maria ricadono, partendo da N, i seguenti complessi ipogeici: la tomba di Mandras (Loi 2002-3; Zaru 2005), le necropoli di Crabiosu-Istudulè (Zaru 1992; Loi 2002-3) e Puleu, la tomba di Sa Tanca ‘e Sa Marchesa (Loi, cds3) e la necropoli di Iscala Mugheras (Zaru 1992; Loi 2002-3). In relazione con la necropoli di Crabiosu-Istudulè doveva essere l’omonimo riparo sotto roccia. Allo stato attuale delle ricerche non è stata rinvenuta alcuna traccia del menhir di Perda Longa. Il monolite, spezzato e riutilizzato - pare - come materiale costruttivo per i muri di recinzione, era di tipo aniconico, privo cioè di elementi che possono richiamare la figura umana. Di estremo interesse è la Tomba di Mandras. In questo monumento coesistono le rappresentazioni, dipinte, di due tipologie di soffitto: ellittico nell’anticella e ad uno oppure a due spioventi con lati brevi arrotondati nella cella principale. Il particolare di maggior interesse della Tomba di Mandras è costituito tuttavia da un motivo dipinto a “reticolato” interpretabile come l’intelaiatura della pareti laterali della capanna preistorica (Loi, cds2). In Sardegna questo motivo si trova inciso sulle pareti della tomba XI di Sos Furrighesos-Anela e sui ciottoli di Ozieri e di Puisteris-Mogoro (Tanda 1984, 82). G. Tanda riprendendo la comparazione unanimemente accettata fra i ciottoli incisi o dipinti con tale motivo ed i churinga dell’Australia, avanza l’ipotesi che esso, anche quando
non è inciso su un oggetto ma su una parete, almeno in qualche caso, sia un attributo figurativo divino, espressione quindi, di per sé, di una entità soprannaturale (Tanda 1984, 110-111). Poco più a S della domus di Mandras abbiamo il gruppo di quattro tombe di Crabiosu-Istudulè. Si tratta di ipogei di planimetria abbastanza semplice, mono-bicellulari del tipo a forno. Due domus (I, III) presentano, poco sotto la soglia del portello d’ingresso alla cella principale, una fascia orizzontale in rilievo interpretabile, forse, come la rappresentazione di uno zoccolo in muratura (Loi 2002-3). Il riparo sotto roccia di Crabiosu, posto assai vicino all’omonima necropoli, si mostra oggi come un piccolo anfratto naturale. La parete d’ingresso presenta incise, orizzontalmente e per tutto il suo sviluppo, due canalette. La prima di queste, situata in posizione più elevata, si configura ad angolo ottuso molto irregolare, mentre la seconda corre lungo tutta la parete senza soluzione di continuità. Tale fregio potrebbe essere interpretato come la rappresentazione delle falde di un tetto a doppio spiovente (Loi, cds2). All’interno la roccia, dall’andamento irregolare nelle pareti e sul soffitto, appare notevolmente disgregata da processi erosivi. E’ possibile ipotizzare che il riparo sia stato utilizzato come dimora o abbia integrato strutture abitative. Lo suggeriscono la sua vicinanza alle domus de janas ed il fatto che nelle zone centrali dell’Isola sia largamente attestato l’uso di cavità naturali a scopo abitativo e/o di sepoltura. Nei pressi del centro abitato di Neoneli, in direzione S, è situata la necropoli ipogeica di Puleu. Essa è costituita da cinque domus de janas, ma di queste soltanto 3 sono attualmente rilevabili. I monumenti si aprono lungo un costone di trachite ricoperto da una rigogliosa vegetazione. Nella Tomba IV le cornici in rilievo negativo che, generalmente, ornano i portelli d’ingresso alle domus e alle diverse celle, sono ridotte ad un’imitazione grafica, resa con semplici linee incise. La riduzione del rilievo a linea incisa, sarebbe indice di “un gusto nuovo” (Tanda 1984, 21). Verso SO, è la domus di Sa Tanca. La tomba, ampiamente rimaneggiata, si apre alla base di un basso affioramento trachitico. Il monumento, superstite forse di una piccola necropoli, è di tipo pluricellulare. Torna qui il particolare della cornice ridotto a un’imitazione grafica.L’ultimo gruppo di tombe ipogeiche, in località Iscala Mugheras, è costituito da sei ipogei, fra i quali spicca il primo, pluricellulare, con anticella caratterizzata dal soffitto a spiovente unico, oltre che da una riproduzione in rilievo di falso architrave sul portello d’ingresso alla cella principale.
Z. Loi. Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del barigadu (sardegna, italia)
99
Figura 6 – Distribuzione dei siti dell’area A in rapporto all’altimetria e all’idrografia.
Circa la contemporaneità di utilizzo fra i monumenti individuati, la semplicità planimetrica delle domus di Crabiosu suggerisce di attribuirle alle fasi iniziali della cultura di Ozieri, mentre i particolari osservati nella tomba IV di Puleu e Sa Tanca e sui soffitti e sulle pareti della tomba di Mandras - benché, in questo caso, possano anche essere successive al primo e più antico impianto della domus -, ci inducono ad assegnarle a momenti finali della stessa cultura. Il dolmen di S. Maria potrebbe riferirsi allo stesso orizzonte cronologico indicato per codesti monumenti. Passando all’analisi territoriale, l’area in esame è caratterizzata nella parte centrale da un paesaggio collinare con quote comprese fra i 401 e i 500m s.l.m., che aumentano verso la zona orientale (501-600m s.l.m). Caratteristiche differenti presenta invece il settore occidentale, nel quale le quote altimetriche decrescono progressivamente dai 401 ai 300m s.l.m.. Il dolmen di S. Maria è situato sulla sommità di un leggero rilievo ad una quota di 408m s.l.m., in posizione intermedia fra le necropoli di Crabiosu-Istudulè e Puleu: 4 dei 5 complessi ipogeici sono ubicati ad altitudini che rientrano tra i 301 e i 500m e uno fra i 501 e i 600m s.l.m. (Figura 6). Dal punto di vista geologico, gran parte dell’area è occupata da rocce vulcaniche di natura trachitica (86,54%). Brevi fasce di depositi di origine alluvionale si dispongono nell’area centrale e ad O (13,36%). La totalità dei monumenti insiste su superfici a litologia trachitica. La produttività dei suoli, in assenza di studi paleoambientali specifici, è stata ricostruita mediante l’utilizzo delle moderne carte pedologiche (Aru et al, 1991). Le Unità Cartografiche Pedologiche che interessano l’area circolare in esame sono due: Paesaggi delle alluvioni recenti dell’Olocene e Paesaggi delle formazioni effusive
del Cenozoico. Gran parte di questi territori presenta caratteri favorevoli all’impianto di attività agro-pastorali (classi d’uso II, V). L’analisi del rapporto dei diversi monumenti con l’idrografia evidenzia come la maggioranza di essi avesse un corso d’acqua ad una distanza inferiore ai 300m (Figura 6). Le necropoli ipogeiche di Crabiosu-Istudulè, Puleu e Iscala Mugheras e le tombe isolate di Mandras e di Sa Tanca sono state realizzate rispettivamente a 1600m, 1670m, 1900m e 1800m dal dolmen di S. Maria (Figura 7).
Figura 8 – Neoneli – Dolmen Nole (foto C. Loi). La relativa vicinanza topografica fra il dolmen di S. Maria e le sepolture ipogeiche non produsse, in questo territorio, quella commistione architettonica ipogeico-megalitica attestata nel vicino territorio di Abbasanta
Links between megalithism and hypogeism in western Mediterranean Europe: a first approach
100
Figura 7 – Distanza reciproca fra i monumenti individuati all’interno dell’area A. e in altri siti dell’isola (Cicilloni 1999, 65-66). Nessuna delle domus studiate nel presente lavoro presenta cioè, in corrispondenza dell’ingresso, un corridoio megalitico. La totale assenza di torri nuragiche all’interno di questo territorio, in un’area dove era particolarmente elevata la presenza di siti di epoca prenuragica, potrebbe essere stata determinata da un impoverimento dei suoli causato dell’intenso sfruttamento agricolo attuato nelle epoche precedenti. Contemporaneamente alla frequentazione del sito di S. Maria, una piccola comunità si stabilì in località Nole, la cui distanza da esso, pari a 5km, porterebbe ad escludere una relazione diretta. Il dolmen di Nole, orientato verso E-SE, è costituito da un vano di pianta quadrangolare (Figura 8). Sia la parete di destra che quella di sinistra sono costituite ciascuna da una lastra ortostatica unica, sormontata da alcune pietre di rincalzo fra essa e la lastra di copertura. La parete di fondo è costituita da due ortostati affiancati. La tavola di copertura, ancora in situ, consiste in un masso piatto quadrangolare. Il materiale di costruzione è la trachite. Nei pressi del monumento è stata rinvenuta una scheggia amorfa di ossidiana. All’interno dell’area incentrata sul dolmen di Nole, denominata area B, sono stati individuati altri due siti riferibili però ad epoca nuragica: il complesso nuragico Nole ed il nuraghe Olisezzo. Fonti locali ricordano - nelle immediate adiacenze della chiesa campestre di S. Angelo,
situata a circa 800m a O del dolmen -, la presenza di un menhir, anch’esso di tipo aniconico (Loi, cds1). La planimetria del nuraghe Nole non è definibile a causa del cattivo stato di conservazione. A circa 200m a O-SO dell’edificio nuragico si estendeva un ampio villaggio costituito da un numero imprecisabile di capanne di pianta circolare e sub-circolare anche di notevoli dimensioni, obliterate da pietre di crollo e da una fitta macchia mediterranea. In relazione con l’insediamento di Nole/Noccureli dovevano essere due fonti distrutte, pare, in tempi recenti. Non molto distante è il nuraghe Olisezzo. Del monumento, fortemente crollato e ricoperto dalla vegetazione arbustiva, si conserva soltanto un breve tratto di muratura dall’andamento curvilineo per un’altezza massima residua di m2,10 a O con 3 filari. La piccola comunità che eresse il dolmen di Nole aveva operato una scelta differente rispetto alla comunità di S. Maria. Infatti, l’intera area delimitata attorno a questa sepoltura è caratterizzata - entro il raggio di 2km - da un paesaggio di alta collina (701-800m), con quota massima di 842m sul monte Olisezzo (Figura 9). All’estremità settentrionale di questo territorio, in prossimità del santuario campestre di S. Angelo, è presente un vasto pianoro che si estende verso Monte Manicore (694m) e a punta Pranu Cungiau (747m).
Z. Loi. Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del barigadu (sardegna, italia)
101
Figura 9 – Distribuzione dei siti dell’area B in rapporto all’altimetria e all’idrografia.
Figura 10 – Distanza reciproca fra i monumenti individuati all’interno dell’area B. Tutti i monumenti, raggruppati in prevalenza nella parte centrale dell’areale indagato, sorgano su terreni rocciosi, con limitazioni severe all’uso agricolo e maggiormente adatti ad un’economia a carattere pastorale. Non sfugge, tuttavia, il fatto che, sebbene la litologia dominante sia quella granitica, questi monumenti sono stati edificati là dove emergono affioramenti trachitici. L’approvvigionamento idrico era assicurato dalla presenza del Rio S. Angelo, il più importante tra quelli di questo territorio che, essendo alimentato da numerose sorgenti, ha sempre una certa portata anche nel periodo
estivo, con considerevoli aumenti nel periodo invernale (Figura 9). Al centro della zona circolare la disponibilità idrica era assicurata, inoltre, da tre fonti naturali: Funtana Nole, Funtana Perda Modde, Funtana Fritta. I monumenti nuragici sono stati realizzati a 1700 e a 800m dal dolmen di Nole (Figura 10). La vicinanza topografica fra il dolmen di Nole e i nuraghi soppracitati dimostra che il popolamento di questi territori, caratterizzati da buone potenzialità difensive, cominciò in epoca neolitica.
Links between megalithism and hypogeism in western Mediterranean Europe: a first approach
102
La terza area d’indagine, denominata area C, ha come centro il luogo in cui sorgevano le statue stele di Allai. Il complesso megalitico è stato individuato sul bordo del vasto altopiano di Pranu Olisa, 1,5km in linea d’aria a NE di Allai. L’area sacra era costituita da almeno 12 statue-menhirs, individuate, come già detto, fra le rovine del nuraghe Arasseda. Una di esse è stata rinvenuta, in palese contesto di riutilizzo, fra la tessitura muraria dello stesso. Il reimpiego di statue-menhirs in strutture di monumenti nuragici è ampiamente attestato nella letteratura archeologica (Atzeni 1980; Moravetti 1984, 52). L’altezza dei tronconi, tutti in trachite, varia da un minimo di m0,28 ad un massimo di m1,50. Sul prospetto anteriore si evidenziano grandi schemi facciali, motivo ad “U” rovescia e fregio centrale. L’assenza del doppio pugnale e degli antropomorfi capovolti – caratteristici del vicino gruppo sarcidanese - indica forse un diverso utilizzo rituale di questi megaliti (culti agrari?). Nell’ambito dello stesso insediamento si segnalano inoltre tre complessi ipogeici, quattro nuraghi e due tombe di giganti. Vaschette e coppelle di dubbia cronologia si individuano numerose in prossimità del ciglio N del pianoro. Ad una maggiore distanza, al di sotto dell’altopiano, in direzione NO, si segnalano i nuraghi Prunas e Ariolu. L’ipogeo di Arasseda, caratterizzato da un ingresso a pozzetto, monocellulare con volta a forno, si apre su un basso affioramento trachitico ad alcune decine di metri a S del nuraghe omonimo. Di notevole interesse le incisioni che si osservano in prossimità dell’ingresso alla tomba. Sul versante E dell’altura di Pranu sono le sette tombe di Marajana. Di queste particolare attenzione merita senz’altro la tomba I: un ipogeo pluricellulare, che presenta residui di partiture architettoniche scolpite in rilievo alle pareti dell’anticella. Ancora, un’incisione antropomorfa è stata individuata a poca distanza dal luogo in cui sorgevano verosimilmente le statue-menhirs (Cossu 1992-3, 300). Il petroglifo, cronologicamente parallelo alle statue-menhirs, raffigura un personaggio maschile, in piedi con braccia e gambe a U. Il corpo è ottenuto con un unico solco, mentre il sesso è indicato da un piccolo incavo. Il nuraghe Arasseda, con aggiunta frontale bilobata, realizzato in trachite, riutilizza in opera nelle sue strutture interne due tronconi di stele figurate. Il nuraghe Sa Pala ‘e Sa Cresia, a brevissima distanza dal precedente, è un monotorre costruito anch’esso con pietre trachitiche. Tutt’intorno congerie di pietrame sono certo da interpretarsi come i resti di un abitato protrattosi per diverse epoche. Non molto distanti sono i nuraghi Liggiu e Pranu Olisa. Difficile dire, al momento attuale delle ricerche, se una tomba dolmenica avesse preceduto la costruzione delle
due tombe di giganti individuate sul pianoro. Ricordiamo, infatti, che nel vicino territorio di Laconi è documentata la presenza di statue-menhirs presso tombe megalititiche dolmeniche (Atzeni 1980). Il centro della nostra area di indagine si individua, come già detto, sulla sommità di un esteso altopiano a 290m di quota, dal quale si domina verso NO il fondovalle solcato dal Riu Massari e verso E i rilievi del Mandrolisai. I monumenti si distribuiscono, prevalentemente, lungo il bordo del rilievo. La necropoli ipogeica di Marajana si colloca, invece, lungo il versante SE, particolarmente ripido nelle parti alte, con profili più dolci nei tratti medi e bassi. Nella zona sottostante il pianoro, caratterizzata da modesti rialzi, l’altimetria è compresa tra i 101 e i 200m (Figura 11). Significativo il fatto che tutti i monumenti siano edificati sulle formazioni litologiche trachitiche: i suoli che si estendono su queste formazioni sono in genere favorevoli all’impianto di attività agropastorali. All’interno dell’area circolare la disponibilità idrica era assicurata, oltre che dal Riu Massari, dal Rio Narbonis a SO, dal Rio Foroju a SE (Figura 11). La domus di Arasseda e le necropoli ipogeiche di Marajana e di Spina Crebina, sono state realizzate rispettivamente a 100m, 1200m e 1800m dal luogo in cui sorgevano le state-menhirs (Figura 12). 3. Conclusioni Dall’indagine sulla vicinanza e sulla distribuzione geografica dei diversi monumenti presi in esame è possibile trarre alcune considerazioni: - innanzi tutto la notevole concentrazione di grotticelle artificiali contrasta, nel Barigadu, con l’esiguità delle tombe megalitiche. Si deve tuttavia considerare che, come spesso accade in altre parti dell’Isola, le “esigenze” agricole possano aver causato la scomparsa di alcune sepolture dolmeniche e che altre non siano state probabilmente scoperte e quindi censite; - il dolmen di S. Maria si inserisce in un’area in cui s’impone il fenomeno ipogeico (Area A). Il dato parrebbe indicare - se la contemporaneità di utilizzo di domus e dolmen venisse provata da indagini stratigrafiche - la presenza di un gruppo umano promotore del modello epigeico in un’area dov’era particolarmente forte la tradizione ipogeica. Il fatto che, come già detto, non si arrivò ad esiti misti, cioè ipogeico-megalitico, induce a ritenere che queste tradizioni architettoniche abbiano convissuto in parallelo. La notevole concentrazione di siti riscontrata in quest’area sembrerebbe indicare un’occupazione intensiva di questi luoghi per favorevoli elementi geografici-naturali (Figura 13) e l’esistenza di piccoli nuclei abitativi ad economia agropastorale disseminati, forse, a breve distanza l’uno dall’altro;
Z. Loi. Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del barigadu (sardegna, italia)
103
Figura 11 – Distribuzione dei siti dell’area C in rapporto all’altimetria e all’idrografia.
Figura 12 - Distanza reciproca fra i monumenti individuati all’interno dell’area C.
Links between megalithism and hypogeism in western Mediterranean Europe: a first approach
104
Figura 13 – Distribuzione dei siti delle aree A, B e C in rapporto alla geologia e pedologia. - il dolmen di Nole, invece, si situa in un’area in precedenza non interessata dalla presenza di domus de janas (Area B). Questa sepoltura testimonia la presenza di un gruppo umano non numeroso, probabilmente nomade, di estrazione pastorale. Esso pare gravitare verso il territorio di Austis, ove l’architettura dolmenica risulta ben attestata. I dati geografici di quest’area, caratterizzata da un paesaggio di alta collina, portano ad ipotizzare un’economia basata principalmente sull’allevamento (Figura 13). L’assenza di domus de janas è forse legata, al di là degli aspetti socio-economici, alla mancanza di affioramenti rocciosi atti alla loro escavazione; - nei pressi di entrambe le sepolture dolmeniche si segnala la presenza di menhirs aniconici; - il rinvenimento di schegge amorfe di ossidiana sembra testimoniare l’utilizzo dei dolmens in epoca preistorica; - nel caso dell’assembramento dei menhirs, la scelta di un altopiano non è casuale. (Area C). Tale ubicazione è legata al concetto del “luogo alto”, sede della divinità. E’ possibile che la località di Arasseda costituisse un polo di
raccordo territoriale, una sorta di santuario all’aperto che attirava i fedeli che vi si recavano per soddisfare esigenze connesse al sacro. L’analisi pedologica porta ad ipotizzare per quest’area un’economia basata prevalentemente sull’allevamento del bestiame, alla quale si affiancava una attività secondaria basata su limitate pratiche agricole (Figura 13); - i siti megalitici attestati in questa zona, presentano una continuità di vita mentre, in quelle zone maggiormente caratterizzate dalla presenza di tombe ipogeiche fa riscontro un vuoto nelle epoche successive. In conclusione, sulla base della limitatezza quantitativa e geografica del fenomeno epigeico possiamo affermare che l’inserimento di schemi megalitici in quest’area sia stato un fenomeno marginale che non soppiantò rituali e credenze proprie dell’ipogeismo. Tuttavia, solo l’estendersi delle indagini consentirà la piena comprensione delle dinamiche culturali che hanno interessato questa regione in epoca prenuragica.
Z. Loi. Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del barigadu (sardegna, italia)
105
4. References
Atzeni, E. 1994. La statuaria antropomorfa sarda, in La statuaria antropomorfa in Europa dal Neolitico alla romanizzazione, 193-213 (La Spezia-Pontremoli, 27 Aprile-1 Maggio 1988), Sarzana. Atzeni, E. 1980. Menhirs antropomorfi e statue-menhirs della Sardegna. Annali del Museo Civico di La Spezia, II, 1979-80, 9-64. Aru, A., Baldaccini, A. e Pietracaprina, A. 1991. Nota illustrativa alla carta dei suoli della Sardegna, Cagliari. Bacco, G. 1988. Le indagini territoriali al lago Omodeo, V. Santoni-G. Bacco-P.B. Serra, Lo scavo del nuraghe Càndala di Sorradile (Oristano) e le indagini territoriali al Lago Omodeo, Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le Provincie di Cagliari e Oristano, 4.I/1987, 1988, 107-111. Bacco, G. 2000. La necropoli ipogeica di Campumajore–Busachi (OR), in Atti del Congresso Internazionale L’ipogeismo nel Mediterraneo (Sassari-Oristano 23-28 Maggio 1994), vol. II, 971-978. Sassari. Cazzella, A. 1989. Manuale di archeologia. Le società della Preistoria. Bari, Laterza. Cicilloni, R. 1999. Dolmen e allèes couvertes in Sardegna. Analisi e problematiche, Studi Sardi XXXI (1994-1998), 51-110. Cossu, A. M. 1992-3. Nuove statue menhirs ed un inedito petroglifo nel territorio di Allai (Oristano), Studi Sardi XXX (1992-1993), 299-328. Depalmas, A. 2000. Le sepolture ipogee della media valle del Tirso: tipologia, distribuzione ed analisi territoriale, in Atti del Congresso Internazionale L’ipogeismo nel Mediterraneo (Sassari-Oristano 23-28 Maggio 1994), vol. II, 835-845. Sassari. Lilliu, G. 1988. La civiltà dei Sardi dal paleolitico all’età dei nuraghi. Torino. Loi, C. 2002-2003. Emergenze archeologiche nei territori dei comuni di Ardauli, Boroneddu, Neoneli, Tadasuni, Ula Tirso, Tesi di laurea, Università degli studi di Sassari. Loi, C. 2006 (cds1). Modelli di insediamento nel territorio del Barigadu, in Convegno Nazionale Giovani Archeologi. Sassari. Loi, C. 2008 (cds2). Testimonianze Prenuragiche nel Barigadu, in Atti 2° Convegno “Federico Halbherr” per i giovani archeologi. Roma. Loi, C. 2009 (cds3). Testimonianze archeologiche nel territorio del comune di Neoneli. Moravetti, A. 1984. Statue-Menhir in una tomba di giganti del Marghine, Nuovo Bullettino Archeologico Sardo, I, 41-67. Nieddu, M. R. 2003. Monumenti prenuragici sul foglio 207/ III NO (Salto di Lochele), in Studi in Onore di Ercole Contu, 73-81. Sassari. Perra, M. 1992. Statue-menhir in territorio di Samugheo (Oristano), Nuovo Bullettino Archeologico Sardo IV, 17-42. Tanda, G. 1984. Arte e religione della Sardegna preistorica nella necropoli di Sos Furrighesos - Anela (SS), I. Sassari. Taramelli, A. 1935. Edizione Archeologica della Carta d’Italia, Foglio 205 (Capo Mannu), Foglio 206 (Macomer), IGM, Firenze. Zaru, M. 1992. Le domus de janas di Ardauli, in G. Deiana (ed.), I musuleos e le chiese di Ardauli, 125-157. Cagliari. Zaru, M. 2005. Ardauli. Tra archeologia e toponomastica. Quartu Sant’Elena, Edizioni Prestampa.