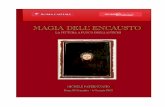Empatia ed Autismo: autenticità di un incontro
Transcript of Empatia ed Autismo: autenticità di un incontro
Empatia ed Autismo: autenticità di un
incontro
Percorso storico-fenomenologico:
esperienza di relazione d’aiuto nell’ambito clinico-metabolico
dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.
i
GIUSEPPE MINNITI
FALACE
IndicePrefazione...................................................................p. 3
Introduzione...............................................................p. 7
Metodologia d’approccio.........................................p. 9
Percorso storico.........................................................p. 12
Esperienza personale...............................................p. 17
Discussione.................................................................p. 28
Conclusioni.................................................................p. 33
Appendice...................................................................p. 38
Postfazione.................................................................p. 53
Nota bibliografica....................................................p. 55
L’autore.......................................................................p. 58
Copyright....................................................................p. 59
ii
Prefazione
In questo libro viene presentato un percorso di counselling, inteso come proces-so relazionale di tipo professionale, che si fonda sull’empatia, ovvero sull’ascol-to, sul supporto e la relazione che coinvolge un counsellor e una coppia, in par-ticolare una famiglia, che sente il bisogno di essere aiutata.
L’approccio di seguito presentato è caratterizzato dall’utilizzo da parte del counsellor di qualità personali, di conoscenze specifiche, nonché di abilità e strategie comunicative, di problem solving e relazionali, finalizzate all’attivazio-ne e alla riorganizzazione delle risorse proprie dell’individuo al fine di rendere possibili scelte e cambiamenti in situazioni percepite come difficili dalla perso-na stessa, o nella ricerca della giusto equilibrio per poter vivere situazioni stres-santi e dolorose.
L’attività di counselling si traduce fondamentalmente in un orientamento all’ascolto e al dialogo dove vitalità, amore, creatività, umorismo, tenerezza, presenza, pazienza e contatto, diventano fattori portanti della relazione di aiu-to.
Questo libro ci offre la possibilità (che definirei molto innovativa nello sce-nario attuale italiano) di vedere applicata l’arte del counselling in un ambito de-licato, come quello dei genitori di persone autistiche.
Prendersi cura da parte del counsellor, vuol dire farsi carico dei vissuti emo-tivi, esistenziali e dei significati che la persona attribuisce alla propria vita e al-la propria storia, tramite la presenza, l’ascolto e il sostegno emotivo, aiutarla a elaborarli al fine di acquisire il maggior grado possibile di autonomia e benesse-re psicologico.
iii
In relazione alla comprensione che abbatte tutte le barriere che separano il counsellor dai singoli elementi della famiglia, ci viene in aiuto una famosa fra-se di Rollo May (Rollo May “L'arte del Counseling” Astrolabio-1991):
“E’ come invitare chi ha viaggiato alla neve e al gelo ad entrare in casa no-stra a sedersi per un’ora davanti al fuoco!”
Questo è lo spirito che anima la relazione d’aiuto esposta nelle pagine che se-guono, ovvero una “considerazione positiva incondizionata” (come amerebbe direbbe Carl .Rogers), che assume la connotazione di rispetto e valorizzazione del singolo genitore, ascoltato in modo non giudicante, anche nel momento in cui la sua azione ed il suo pensiero dovessero essere totalmente differenti dalla percezione del counsellor.
L’autore parte dalla domanda chiave:
“Come affrontare un’esperienza di counselling a genitori di pazienti autisti-ci?”.
Il counsellor familiare, in questo particolare caso, si troverà ad affrontare “non una ma molte versioni a volte differenti del vissuto e del dolore” (afferma l’autore). Ed ecco che si configura, prendendo campo pagina dopo pagina, la novità dell’approccio proposto dal dott. Minniti, ovvero la capacità di accoglie-re ed ascoltare i genitori, in un clima assolutamente non strutturato ma ricco di fiducia, attenzione e cura verso ciò che esprime ogni persona coinvolta nel pro-cesso.
“Fare consulenze metaboliche a genitori di pazienti autistici, lasciando il po-sto all’empatia, in modo tale da comprendere le emozioni che sta vivendo il ge-nitore, vivendole insieme a lui senza al contempo farsi affogare dalle stesse” (G. Minniti).
Con queste parole l’autore ci trasmette un concetto tanto profondo ed inti-mo, quanto magico e avvolgente, un po’ come accade al pianista che riesce a leg-gere non solo lo spartito, ma anche lo spirito e l’emozione che ha animato il compositore mentre lo scriveva, riuscendo infine ad interpretare il brano con un’intensità tale da far vibrare le note non solo nell’orecchio di chi ascolta, ma
iv
nel cuore e nello spirito di chi le ha composte, regalandone le stesse emozioni rivisitate ed arricchite. Tutto ciò permetterà al bravo pianista di vivere empati-camente la sinfonia, senza sostituirsi mai al compositore, emozionandosi pro-fondamente senza per questo essere sommerso o travolto dalle stesse emozioni suscitate.
Con grande maestria l’autore ci guida, nel suo libro dalla metodologia del-l’approccio, al percorso storico che lo ha preceduto, fino all’esperienza persona-le, il tutto in una piacevolissima armonia di storia, idee, e vissuti personali che ci avvolgono e ci trascinano ad una lettura unica e ricca di stimoli ed interroga-tivi.
La relazione d’aiuto così espressa, ci appare come una meravigliosa opportu-nità offerta ai singoli genitori di dare un senso a se stessi ed alla coppia, al loro proprio vissuto ed ai loro profondi sentimenti, in modo tale da apparire com-pletamente a proprio agio nel mondo che li circonda.
Una lettura ricca e piacevole che sono certa appassionerà ogni singolo letto-re, avvolgendolo nel calore e nella percezione di sé e dell’altro.
Simonetta Lumachi
v
“Tutto è sospeso come in attesa.
Non penso più. Sono contento e muto.
Batte il mio cuore al ritmo del mio passo”
Camillo Sbarbaro “Rimanenze” 1955
vi
C A P I T O L O 1
Introduzione
Lo sviluppo della persona umana viene definito come risultato della collabora-zione di suoi due centri basilari: dell’intelletto e dell’affettività, spesso contrap-posti, anche se questa contrapposizione, come ogni categorizzazione in campo psicologico, rivela un carattere troppo rigido e superficiale.
Un’altra contrapposizione che ne risulta riguarda l’attività degli uomini ed è quella della cosiddetta “scienza ufficiale” (medicina, biologia ed affini) ed altre discipline (psicologia, filosofia etc.) genericamente definite “diverse”. La scien-za si concepisce quindi in quanto lo sforzo intellettuale per eccellenza, volto al-la conoscenza delle strutture di un determinato ordine di fenomeni, basato sul metodo il più preciso e sullo studio di cause, di leggi, di effetti delle cose, appli-cato poi -se possibile- a fini concreti. Le discipline “Altre” invece, vengono con-siderate come attività comunicativa soggettiva, ispirata dal bisogno prevalente-mente “interiore” che in una forma strutturata secondo un certo paradigma, esprime il mondo dei sentimenti intimi, dei rapporti umani, delle esperienze esistenziali e delle diverse visioni dell’essere in una prospettiva relativa e sem-pre personale degli autori. Uno dei più significativi aneddoti della storia della filosofia racconta come Diogene, nella piena luce del giorno -armato con una piccola lampada- stava cercando qualcosa in tutti gli angoli, e la sua risposta al-la domanda, quale fosse l’oggetto della sua ricerca fu: cerco l’essere umano. L’uomo è quel mistero che rimane mistero nella luce del giorno e nella luce del-le nostre lampade, l’essere sconosciuto, come diceva Aleis Carrel; il grande abis-
7
so come aveva formulato, con una parola dei salmi, St. Agostino. Le nostre “lampade” di oggi sono molto sofisticate, le scienze umane hanno scoperto nel-la geografia dell’essere umano dei continenti finora sconosciuti e cercano di de-mitilogizzare fino in fondo il mistero umano. Ma col crescere del nostro sapere cresce anche l’abisso ed il suo oscuro imperscrutabile. Tuttavia, cercare che co-sa sia l’uomo, cercare il segreto della nostra propria esistenza ed essenza rima-ne un impulso irresistibile, che appartiene al dinamismo innato della nostra vi-ta. Ecco il perché di questa mia breve introduzione, al tema che andrò a tratta-re, l’EMPATIA.
8
C A P I T O L O 2
Metodologia d’approccio
Io penso che con il parcellizzare del sapere umano, si rischia di trovarsi davanti ad una foresta e vedere solo un singolo albero, o viceversa non accorgersi del-l’intera foresta. In ogni approccio scientifico, quindi diventa prioritario l’ap-proccio olistico. Ecco perché, oggi (confortato da studi eseguiti da insigni scien-ziati (cito per brevità E. Kandel, S. Greenspan) bisogna avere il coraggio di par-lare di studio delle scienze umane sotto ogni specifico profilo, che se condotto con rigore e serietà permette una visone più completa di quanto si sta studian-do.
E’ necessaria da una parte la molteplicità dell’approccio (nel mio caso l’empa-tia) in corrispondenza alle diverse dimensioni dell’essere umano; d’altra parte la prospettiva multidisciplinare non deve concludersi in una frantumazione del sapere, bensì deve rimanere aperta all’esigenza di cogliere l’unità dell’oggetto considerato. E’ evidente che tale unità non è semplicemente il risultato della somma delle acquisizioni dei diversi saperi analitici, né può essere la conclusio-ne di un’operazione eclettica e sincretistica, ma può essere pensata solo a parti-re da un punto di vista globale, capace di mettere in rapporto la questione an-tropologica dell’identità profonda dell’uomo con il significato definitivo e con la verità originaria del mistero dell’esistenza umana. Per evitare qualunque equivoco, spiacevole, mi preme premettere che la ricerca globale e veritativa non ha la pretesa di conoscere né di giudicare tutti gli aspetti particolari del-l’empatia e di conseguenza non interferisce con le letture parziali ed analitiche
9
operate dalla diverse scienze (umane e naturali), ma auspico a me stesso di aprire l’orizzonte del “mio sapere umano” alle dimensioni ed ai significati più profondi dell’uomo, che diventa “persona”, e della realtà intera.
In questo mia dichiarazione d’intenti mi viene in aiuto LA BIBBIA; sono quattro i termini essenziali adoperati nell’Antico Testamento e poi ripresi nel Nuovo: basar, ruah, nefesh, leb, tradotti con sarx, pneuma, psiche`, kardia (dianoia) e dalla volgata latina con: caro, spiritus, anima, cor o mens.
Si tratta di locuzioni diverse che indicano aspetti e componenti differenziate dell’uomo, ma che pur si riferiscono alla totalità del suo essere. Se “basar” espri-me la contiguità dell’uomo con il modo materiale, la sua mortalità e transitorie-tà, “ruah” al contrario proclama la sua differenza dal modo materiale e la sua affinità con un “OLTRE”. “Leb” (mens, kardia) specifica questa diversità come trascendenza di libertà e di ragione, inoltre allude alla sintesi di materia e di spirito, di ragione ed emozione nell’esistenza umana, a questa penetrazione re-ciproca delle dimensioni della realtà che è talmente significativa per la cono-scenza di questa creatura “uomo”. “Nefesh” infine prospetta l’uomo come coin-volto nella storia in quanto porta una responsabilità. Nella polivalenza dei ter-mini, tuttavia, nell’insieme si può osservare che l’uomo è situato su due livelli irriducibili, ma pure indisgiungibili: il livello dell’immanenza, che lo porta ad essere solidale con il mondo materiale, e il livello della transcendenza rispetto all’universo terrestre, che lo porta ad essere in relazione con “L’OLTRE DA SE”... (e ciascuno dia pure il nome che ritenga a questo “OLTRE”… la cosa cer-ta e universalmente condivisa è che “ogni uomo avverte tale bisogno”).
Alla luce di tutto ciò, appare evidente che la ricchezza delle valenze semanti-che dei concetti che descrivono la realtà dell’uomo (e l’empatia è uno di que-sti), mostra la distanza e l’opposizione tra la “concezione olistica della persona” e le riduzioni di tipo razionalistico-cartesiano o monistico-materialista, che semplificano la questione antropologica, riducendo l’uomo a mera realtà orga-nicistica.
10
Invece la rivendicazione del carattere di “infinitezza intenzionale” della per-sona, implica la sua dimensione relazionale costitutiva. E tale dimensione rela-zionale costituisce l’unità della persona come tale, ed il fondamento per ogni punto di contatto con tutte le realtà empiriche ed esperienziali che circondano e costituiscono l’uomo stesso, che s’interroga sul suo essere, alla luce del com-plesso tessuto di relazioni che in lui s’intrecciano, senza confondersi, ma anche senza separarsi radicalmente tra loro. Proprio tale complesso tessuto di relazio-ni che si intrecciano nell’uomo senza intaccarne la sua unità personale, fa si che il suo “sapere” possa essere e restare aperto al progresso delle acquisizioni e ricchezze provenienti dalle forme del sapere umano che indagano sulle dimen-sioni empiriche, storico-sociali e psicologiche della realtà umana, e nello stesso tempo garantisce, contro ogni forma di semplificazione monistica e di divisio-ne dualistica, l’intima unità dell’uomo.
Attraverso, una breve sintesi storica degli studi sull’Empatia, delle sue origi-ni filosofiche-fenomenologiche, citando sommariamente gli studi di Husserl prima e di Edith Stein (sua allieva) successivamente, mi preme arrivare a come oggi tale termine viene inteso. Il tutto applicato ad una mia esperienza lavorati-va di counselling-famigliare per genitori di pazienti autistici.
Questo perché io credo fermamente che la struttura della “persona- umana“ (in qualsiasi ruolo ed ambito ella operi), si fonda essenzialmente sulla catego-ria di relazione e si autentica nella tensione verso -IL PROPRIO PROSSIMO-(paziente, alunno, cliente, etc.) IO penso che l’uomo diventa “SE STESSO” ri-uscendo a scoprire la sua identità più profonda se e nella misura in cui rinun-cia all’autoaffermazione di sé, in una consapevolezza della propria “alterità”, fi-nalizzata solo ed esclusivamente nel cercare il “servizio all’altro da se”, esaltan-done (nel nostro caso di futuri counsellor, con la relazione d’aiuto) la specifica e propria originalità.
11
C A P I T O L O 3
Percorso storico
Si afferma oggi da molte parti e, penso, con indubbio fondamento, che la feno-menologia è la filosofia del nostro tempo. Essa corrisponde effettivamente a quel bisogno tanto avvertito dai nostri contemporanei, di andare alle cose stes-se, di vedere con i propri occhi, e poi di descrivere, con esattezza e fedeltà, la realtà, così come essa veramente ci si manifesta, senza idoli, presupposti o pre-giudizi ideologici. Aspirazione certamente condivisa da tutti i grandi filosofi di ogni tempo, ma particolarmente avvertita nell’attuale momento storico. Come è noto, la Fenomenologia, nel senso moderno e più usato del termine, nasce al-l’inizio del Novecento in Germania per opera di Edmund Husserl, ma raccoglie presto numerosi ed illustri fautori in ogni parte del mondo. Tra essi M. Scheler, H. Conrad-Martius, N. Hartmann, E. Stein, e, più recentemente, M. Hei-dehher, J. P. Sartre, M. Merleau-Ponty, P. Ricoeur, E. Levinas, E. Paci, fino ad arrivare ai nostri giorni con N. Feshbach , J. Strayer e Martin L. Hoffman. L’in-fluenza del metodo fenomenologico è stata ed è perciò tuttora assai grande, an-che in quelle correnti di pensiero, per es. quelle cosiddette <esistenzialistiche>, che non gli sono state del tutto fedeli. Per questo, negli ultimi anni, si sono mol-tiplicati studi, ricerche, congressi, pubblicazioni, società scientifiche. Edmund Husserl (1859-1938) è stato il fondatore della fenomenologia ed uno dei filosofi più influenti del Novecento. Il saggio “Fenomenologia e psicologia”(che Hus-serl scrive tra il 1916 ed il 1917), viene tradotto per la prima volta in italiano, sulla base dell’edizione critica dell’Archivio Husserl di Lovanio. Attraverso il confronto tra lo statuto epistemologico della psicologia e della fenomenologia,
12
il saggio offre una sintetica ed insieme problematica introduzione alla fenome-nologia husserliana: dalla distinzione tra atteggiamento naturale ed atteggia-mento fenomenologico, all’analisi della coscienza come intenzionalità ed attivi-tà istitutrice dei significati e dei valori che costituiscono il mondo umano. Ben-ché l’analisi della coscienza sia centrale anche per la psicologia, Husserl deli-nea lo sviluppo della psicologia descrittiva alla fenomenologia, sottolineando che il percorso della fenomenologia possiede un’autonomia che ne fa “una scienza radicalmente nuova”, che ha di mira l’intuizione dell’essenza, della radi-ce, delle varie regioni dell’esperienza, scandagliata nel duplice versante della soggettività e della oggettività ad essa correlata. La Fenomenologia si delinea, dunque, come scienza pura dei fenomeni, pure idealità, mentre la psicologia è scienza dei fatti, del soggetto empirico con i suoi pensieri, le sue volizioni, i suoi sentimenti. Sarà (come vedremo più avanti) Carl Rogers a dare unicità d’intenti alle due scienze.
Edith Stein (1891-1942), conseguì il dottorato nel 1916 avendo come correla-tore Edmund Husserl. Il tema prescelto, quello dell’EINFUHLUNG (termine tradotto in italiano prima con “entropatia” e poi meglio come “empatia” dal ter-mine inglese “empathy”) era stato esplicitamente trattato da Husserl già dal 1905, ma, in realtà, marginalmente rispetto alle analisi fondamentali che egli andava sviluppando e che confluirono nel 1913 nelle “Idee per una fenomenolo-gia pura ed una filosofia fenomenologica”, rivolte a delineare il ruolo della ricer-ca fenomenologica e la sua capacità critica. Ritengo perciò molto indicativo che fra le molteplicità di temi che già Husserl stava affrontando, da quello della lo-gica a quello dell’etica e del tempo, Edith Stein avesse scelto proprio l’indagine sull’empatia, cioè un particolare vissuto presente nel soggetto umano, e credo che si possa giustificare tale scelta se si osserva che, attraverso esso, ella mo-stra non solo tutta la pregnanza dell’analisi fenomenologica, ma può anche, af-frontare il tema della “persona”, dimostrando fin dalle sue riflessioni giovanili
13
quanto sia grande l’interesse, che diventerà costante nella sua speculazione, per la comprensione dell’essere umano in quanto “Essere”.
Nella Stein si evidenzia lo sforzo di analizzare la vita della coscienza ed isola-re all’interno di essa gli atti che la costituiscono. L’atto dell’empatia assume un particolare valore perché giustifica l’uscita da se stessi, dalla propria singolari-tà, attraverso uno strumento che è già posseduto dal soggetto e che permette di cogliere ciò che accade nell’estraneità senza interferire in essa, rendendosi con-to che è impossibile immedesimarsi fino in fondo nell’ambito che gli/le appar-tiene.
Il merito di Edith Stein è quello di aver gettato le basi dell’analisi del vissuto dell’empatia in modo piano, convincente e si potrebbe dire didatticamente effi-cace, chiarendo a se stessa ed a noi che cosa accade in noi stessi quando incon-triamo un’altra persona e come da questo incontro si possa muovere per com-prendere la sua e nostra costituzione d’essere.
Ritengo indispensabile, per comprendere l’uso attuale del termine empatia nella letteratura psicologica, ed in particolare per comprendere le difficoltà con-nesse alla sua definizione ed al suo studio nella moderna psicologia dello svilup-po, esaminare, se pure brevemente, la storia di questo termine nella psicologi-ca novecentesca.
La capacità di fare propria l’esperienza di un’altra persona era già stata de-scritta ed analizzata da Freud a proposito dell’identificazione isterica. Freud aveva chiarito (1899) che per mezzo di tale tipo di identificazione i pazienti rie-scono ad esprimere nei loro sintomi le esperienze delle altre persone ed a soffri-re ciò che gli altri soffrono. L’identificazione isterica, quindi, non è semplice ed esteriore imitazione, bensì appropriazione profonda, (anche se senza una reale consapevolezza da parte di chi vive tale immedesimazione) di ciò che l’altro vi-ve, sulla base del riconoscimento”inconscio”, di una comune esperienza emoti-
14
va, in tal caso di natura sessuale. L’esperienza di condivisione era quindi ben nota agli psicoterapeuti.
Il termine empathy, che in italiano diverrà empatia, venne coniato da Titche-ner nel 1909, come precedentemente detto, dal termine tedesco Einfuhlung (sentire dentro) ma anche sulla base del termine greco empatheia. Già Lipps (1905) aveva dato una formulazione più psicologica a tale concetto. Egli aveva sottolineato che il piacere estetico consiste sì nel godere di un oggetto esterno, ma non risiede nell’oggetto, bensì nel soggetto stesso. Urge sottolineare comun-que che la definizione di Lipps, sembra più vicina a quello che oggi viene defini-to contagio emotivo, e non empatia cognitivamente mediata. Dalla seconda me-tà del Novecento in poi, l’attenzione, si sposta grazie a Carl Rogers (1959; 1975) dalla condivisione dei vissuti altrui, (caratteristica ad es. dell’identificazione isterica), alla relazione tra il terapeuta -e/o counsellor ed il cliente, ed al ruolo svolto dall’empatia in tale relazione. Rogers, definitivamente, considererà l’em-patia una modalità indispensabile nella “relazione d’aiuto”, la quale (l’empatia) consente di entrare nel modo di un’altra persona senza giudicarla.
Anche Kohut (1959-1984) ha posto l’empatia al centro della relazione tera-peutica, considerandola come la modalità attraverso la quale il terapeuta e/o counsellor accede al mondo psicologico del paziente. Empatia ed introspezione sono per questo autore gli aspetti essenziali dell’osservazione psicoanalitica: senza empatia si registrano solo gli aspetti fisici di un movimento o di un’azio-ne, ma non se ne può comprendere il significato psicologico. Più in generale, l’empatia è per questo autore una capacità innata che permette a tutte le perso-ne umane di comprendere gli stati psicologici degli altri; essa è perciò diversa sia dalla simpatia sia dalla compassione o dall’intuizione. Kohut (1971) ha sotto-lineato anche la funzione dell’empatia nel creare il legame tra le persone; si trat-ta di un tema che è stato ripreso dalla recente ricerca psicologica, in particolare nello studio della relazione madre-bambino. In questi ultimi decenni i ricerca-tori più attenti hanno cercato, di ricomporre un quadro teorico che rendesse ra-
15
gione della complessità del fenomeno, delle sue diverse modalità di espressio-ne, dei processi cognitivi ed emotivi che lo mediano.
16
C A P I T O L O 4
Esperienza personale e metodologia di studio
E’ possibile oggi tentare di delineare un modello di empatia che ne spieghi la complessità e le sue modificazioni lungo lo sviluppo. E’ quello che cercherò di esporre da qui in seguito, con applicazione specifica e fattiva nell’ambito della mia professione. Ossia di come, fare consulenze metaboliche a genitori di pa-zienti autistici, abbia il suo goal vincente se in tale “relazione d’aiuto”, l’empa-tia trova il suo giusto spazio. A tal proposito, brevemente, in seguito esporrò an-che aspetti fenomenologici dell’autismo.
Molti vissuti che danno sapore e rendono più intensa la nostra vita di tutti i giorni, colorandola di sfumature alle volte appena percepibili, altre volte così decise da rendere indimenticabili certi attimi, sono esperienze di empatia. Pro-vare empatia per qualcuno, ritengo, significa comprendere le emozioni che sta vivendo e viverle a propria volta senza lasciarsi allagare da esse, capendo le sue ragioni e le sue intenzioni; vuol dire creare nel proprio mondo interiore uno spazio su misura, dove sì riconosciamo le nostre di emozioni, ma siamo dispo-nibili ad accogliere il mondo dell’altro senza reciproci “inquinamenti”. Allo stes-so modo sentire che qualcuno prova empatia per noi vuol dire sentirsi capiti, accolti, non più soli. Ed ecco che, credo esistono dei buoni motivi per studiare l’empatia ed imparare a conoscere il più possibile come nasce, come evolve e co-me media i nostri rapporti con gli altri.
Lo studio dell’empatia, abbiamo visto, ha interessato diverse aree della psi-cologia (evolutiva, sociale, clinica, dinamica, del lavoro). Provare empatia signi-
17
fica mettersi quindi “nei panni degli altri” e condividerne lo stato emotivo in maniera vicaria, cioè provare un’emozione uguale o simile a quella dell’altro, con la consapevolezza che la causa del proprio vissuto è l’emozione dell’altro. L’empatia è una capacità fondamentale per la costruzione di relazioni interper-sonali positive e la promozione di comportamenti prosociali.
Essere empatici favorisce la comunicazione e gli scambi sociali, incoraggia l’accoglienza della diversità, facilita la cooperazione nell'ambiente lavorativo, regola il flusso delle emozioni negative e delle condotte aggressive. Secondo Hoffman (2000), con tutta probabilità lo studioso attuale più autorevole sull’ar-gomento, l’empatia può essere definita in termini funzionali (cioè orientati ad esplicitare i processi sottostanti alle reazioni empatiche) come <la scintilla che fa scaturire la preoccupazione umana per gli altri, la colla che rende possibile la vita sociale>, mentre in termini fenomenologici (cioè volti a descrivere un feno-meno nel suo manifestarsi) consiste in <una risposta affettiva più appropriata alla situazione di un altro che alla propria>.
Provare empatia non significa sperimentare esattamente quello che l’altro vive, ma comprendere e condividere in modo vicario l’emozione che lui prova. E’ importante sottolineare come la capacità empatica va distinta da altre espe-rienze affettive che per certi versi sono ad essa simili: la simpatia, il disagio per-sonale, il contagio emotivo. Nel tentativo di “concetto olistico di persona”, a cui facevo riferimento all’inizio, mi sembra opportuno, nel parlare d’empatia, non dimenticare i principali studi dei neuroscienzati che hanno indagato i legami tra l’empatia ed i meccanismi neurofisiologici sottostanti. Ritengo che, parten-do da queste recenti ricerche, che identificano quelle che possono essere consi-derate le fondamenta anatomofisiologiche del sentire empatico, acquistano un criterio maggiormente scientifico (nel senso di accettazione maggiore di tutta la comunità scientifica) anche quegli studi di natura prettamente psicologica, i quali a loro volta approcciano l’empatia in una prospettiva multidimensionale
18
(olistica), non limitandosi, dunque, a descriverla in termini esclusivamente co-gnitivi o affettivi.
I contributi dei neuroscienzati che, in anni recenti, hanno cercato di indivi-duare le basi neurofisiologiche dell’empatia, oltre che rappresentare una nuova frontiera sull’argomento, sono diventati un tassello rilevante per ricostruire le prime tappe dello sviluppo filogenetico (che attiene, cioè, alla ricostruzione del-l’evoluzione degli organismi viventi dai primordi ad oggi) ed ontogenetico (che riguarda, cioè, l’insieme dei fenomeni che portano allo sviluppo di un organi-smo, dalla cellula uovo fino all’individuo adulto) della funzione.
Date le somiglianze genotipiche (che si riferiscono, cioè, alle caratteristiche tipiche di un organismo ereditate geneticamente) e fenotipiche (che attengono, cioè al complesso dei caratteri morfologici e funzionali di un organismo, risul-tanti dall’interazione del suo genotipo con l’ambiente) tra i primati e la specie umana, alcuni neuroscienziati hanno indagato i substrati neurali delle funzioni psichiche nei primi, per poi estendere sperimentazioni e risultati anche agli uo-mini. Seguendo questa procedura, circa 15 anni fa, un gruppo di ricerca del Di-partimento di Neuroscienze dell’Università di Parma, ha intrapreso la prima di una lunga serie di sperimentazioni sul funzionamento cerebrale dei macachi, (Gallese, Keysers, Rizzolatti). Il team di ricercatori individuò nel cervello di questi primati una particolare classe di neuroni premotori, situati in un’area chiamata F5 (corrispondente alla corteccia premotoria ventromediale dei maca-chi) che si attivano non solo quando le scimmie eseguono una specifica azione (come ad esempio afferrare un oggetto), ma anche quando esse osservano un altro individuo (conspecifico od umano) compiere quella stessa azione. Gli au-tori hanno battezzato questo tipo di neuroni “i neuroni specchio” (mirror neu-rons).
Il nucleo centrale di questa scoperta starebbe nel fatto che nel momento in cui si è testimoni di un’azione, si mette in moto quello stesso sistema neurale che si attiva mentre la si esegue; l’osservatore, quindi, comprenderebbe le azio-
19
ni degli altri perché le “mima” dentro di sé, e automaticamente le esperisce. Ul-teriori studi, utilizzando un range eterogeneo di strumenti e di metodologie di ricerca, hanno messo in luce che anche negli esseri umani esiste un sistema di neuroni specchio, che coinvolge aree cerebrali omologhe a quelle che si attiva-no nei primati. Più precisamente, il “sistema dei neuroni specchio” (mirror neu-rons system) è formato da una rete neurale corticale che coinvolge: la parte ro-strale del lobo parietale inferiore, la sezione caudale del giro frontale inferiore e la parte ad essa adiacente della corteccia premotoria.
Una volta dimostrato che i neuroni specchio sono coinvolti nella compren-sione delle azioni sociali, i ricercatori hanno iniziato a chiedersi se fossero im-plicati anche nelle relazioni sociali, in particolare nella capacità di comprensio-ne e condivisione degli stati emotivi altrui. Per rispondere a questo quesito, il gruppo di ricerca dell’Università di Parma, in alcuni studi recenti, ha verificato se osservare una persona mentre sperimenta disgusto o dolore fa si che si atti-vano dei neuroni specchio nell’osservatore. Così, l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata nell’area corticale detta insula, la cui parte anteriore destra è respon-sabile (neuropsicologicamente) del disgusto. A questo proposito, Rizzolatti et. altri, hanno rilevato, grazie a delle neuroimmagini (FMRI: Functional Magne-tic Resonance Imaging), che sia quando le persone annusano odori nauseabon-di, sia quando guardano un filmato il cui protagonista vive una situazione di di-sgusto ed ha un’espressione conseguente si attivano: la parte anteriore dell’in-sula, la corteccia cingolata anteriore (coinvolta neuropsicologicamente nel-l’espressione delle emozioni), i gangli della base (associati al controllo motorio delle azioni). Ciò vuol dire che, quando si assiste all’espressione di disgusto di un altro, si attivano le stesse reti neurali di quando si sperimenta in prima per-sona la medesima emozione. Congruamente con tali risultati, altri ricercatori (Singer et. altri) hanno trovato che le stesse strutture cerebrali che mediano l’esperienza e la percezione di disgusto sono implicate anche nell’empatia per il dolore, ed addirittura al crescere dell’emozione provata, i neuroni specchio mo-
20
strano livelli di attivazioni maggiori. Allo stato delle cose va anche detto, per onestà intellettuale, che tale meccanismo può solo spiegare solo un livello basi-lare che sottostà alla componente affettiva dell’esperienza empatica.
La strada da percorrere è ancora lunga e tale ambito di studi ha il merito di aprire nuovi interrogativi rispetto ad es. se nel vivere emozioni positive si atti-vano le stesse aree che si attivano vivendo emozioni negative; non si conosce bene come questi livelli di attivazione interagiscono con i più complessi proces-si di attribuzione cognitiva (ad es. il role taking), coinvolti nelle forme più evo-lute di empatia. Infine, i neuroni specchio sono coinvolti allo stesso modo nella condivisione delle cosiddette “emozioni sociali” (vergogna, gelosia etc.) in cui aspetti culturali ed educativi giocano un ruolo particolarmente rilevante? Ed ec-co che ritorniamo… agli aspetti “olistici” della PERSONA.
Dal punto di vista più propriamente psicologico, da tempi relativamente re-centi c’è una lunga e consolidata tradizione di ricerca che ha sistematicamente elaborato dei modelli per descrivere il funzionamento e lo sviluppo dei processi empatici.
Il primo modello multidimensionale, fra quelli più recenti, di empatia è do-vuto a Norma Feshbach. Il merito di questa autrice consiste nell’aver sviluppa-to per la prima volta nella letteratura psicologica, un modello sistematico che, superando la visione dell’empatia come un’abilità monolitica, le attribuisce un carattere multidimensionale. Processi cognitivi ed affettivi non sono contrappo-sti o giustapposti, ma si integrano, concorrendo entrambi alla definizione del “modello empatico”.
Feshbach elabora il primo strumento per rilevare appositamente la responsi-vità empatica, il FASTE (Feshbach Affective Situation Test for Empathy), che riflette gli assunti di base del suo modello teorico. L’autrice nelle sue ricerche, ha dedicato una particolare attenzione a tre aspetti: 1) i risvolti sociali dell’em-patia, (osservando se essa fosse in grado di migliorare i rapporti interpersonali,
21
inibendo l’aggressività e promuovendo il comportamento prosociale), 2) gli sforzi per misurare adeguatamente il modello empatico, 3) il tentativo di elabo-rare programmi specifici per incrementare le capacità empatiche. I pregi di tali ricerche consistono nel cercare di dare una definizione rigorosa dell’empatia, sia come variabile teorica, sia come variabile operazionale, affiancando agli aspetti affettivi anche quelli cognitivi, come il role taking. Il limite di tale lavo-ro consiste nell’essere eccessivamente restrittivo nella definizione, poiché esclu-de dal “modello proposto” tutte le risposte affettive vicarie non identiche a quel-le osservate. Altresì nel lavoro della Feshbach, pur avendo un carattere multidi-mensionale, la concezione di empatia tradisce un predominio della cognizione sull’affettività, essendo quest’ultima subordinata a due abilità cognitive prope-deutiche. Il modello non spiega infatti forme di condivisione affettiva rudimen-tali che compaiono nei primi anni di vita e che coinvolgono processi cognitivi più semplici del role taking, (mi riferisco a vari studi di “social referencing”, qui non contestuali).
Notevoli, sono anche gli studi di Martin L. Hoffman, che ha tracciato le tap-pe fondamentali del suo modello intorno agli anni ottanta del Novecento, ma in anni successivi, ne ha rivisto alcuni assunti fino a giungere alla versione più recente del 2001. Hoffman, rispetto a Feshback, è meno restrittivo nel definire i comportamenti empatici. Con “empatia”, infatti non si riferisce solo al verifi-carsi di un’esatta corrispondenza tra i propri sentimenti e quelli dell’altro. Piut-tosto, ritiene che con tale termine si possa definire quell’insieme di processi che accompagnano la percezione dello stato emotivo di chi si ha di fronte e che suscitano, nel soggetto, una risposta affettiva più appropriata alla situazione in cui si trova l’altro che alla propria, intendendo con questo quasi un vissuto più consono a quello dell’altro che al proprio. Ecco che quindi l’autore elabora un modello a tre componenti: affettiva, cognitiva e motivazionale. L’aggiunta del-l’”effetto motivante”, secondo Hoffmann, dipende dal fatto, che condividere l’emozione dell’altro, soccorrendolo ad esempio, e quindi alleviando la sua sof-
22
ferenza, fa provare a chi aiuta uno stato di benessere; viceversa, la scelta di non confortare l’altro porterebbe con sé uno spiacevole senso di colpa.
Il collegamento tra l’empatia ed il comportamento prosociale è centrale nel modello dell’autore, al punto che egli inserisce l’abilità empatica nel quadro più complesso dello sviluppo morale. In definitiva, l’empatia con Hoffman di-venta un’abilità che evolve, che cambia forma, che si differenzia progressiva-mente, perdendo la dimensione monolitica che Feshback e gli autori preceden-ti le avevano attribuito. In altre parole laddove Feshback concettualizza un’uni-ca empatia mediata da processi cognitivi complessi, Hoffman trova spazio per diversi tipi di empatia, che mutano e si fanno più complessi via via che i proces-si cognitivi che la mediano si evolvono. Per la prima volta, l’empatia e’inserita appieno in un’ottica di sviluppo.
La critica che si può muovere ad Hoffman, è quella di essersi frequentemen-te limitato ad una “meta riflessione” su dati empirici provenienti da altri ricer-catori, senza averne sottoposto a verifica le proprie assunzioni teoriche attraver-so esperimenti appositamente ideati. Sorvolando su altri studi, che hanno rical-cato i modelli fin qui proposti, resta utile ricordare gli studi di Bischof-Kohler per il quale il livello evoluzionistico di Hoffman diventa il punto di partenza per approfondire lo sviluppo della funzione empatica nell’uomo. Egli ritiene che l’empatia sia definibile da un punto di vista fenomenologico e da un punto di vista funzionale. In una prospettiva fenomenologica l’empatia è descritta co-me l’esperienza attraverso cui si comprende lo stato emotivo di un altro condi-videndone l’emozione, ma restando consapevoli che tale emozione, pur condivi-sa, appartiene all’altro. In una prospettiva funzionale è invece necessario speci-ficare quanto segue: vi sono due pattern di stimoli che elicitano empatia, il com-portamento espressivo dell’altro (espressioni facciali, postura); la situazione dell’altro (le caratteristiche specifiche della situazione che l’individuo sta viven-do, mentre sperimenta una particolare emozione. Nonché, sempre nella pro-spettiva funzionale, vi sono diversi tipi di meccanismi intraorganismici (che
23
cioè entrano in gioco nelle dinamiche interne dell’individuo) che variano in re-lazione alla componente che, di volta in volta viene attivata. Le componenti pos-sibili possono essere: quella affettiva, (la mia partecipazione emotiva al vissu-to dell’altro) quella sociocognitiva, che si attiva quando si tenta di analizza-re la corrispondenza tra l’espressione dell’osservato e l’emozione che, in quella situazione, egli sta provando. In tale processo risulta importante l’abilità di og-gettivazione del sé, ossia la capacità di considerare sé e l’altro come entità di-stinte. Ultima, la componente motivazionale, orientata all’attuazione di com-portamenti di aiuto volti ad attenuare l’emozione spiacevole sperimentata dal-l’altro e, perciò, strettamente legata al comportamento prosociale. E’ bene ag-giungere che nel momento in cui si percepisce lo stato emotivo dell’altro, la scelta di propendere per un comportamento od un altro, è mediata anche da due “sistemi di controllo”, Il sistema di giudizio, ed il sistema di regolazione del-le emozioni: imparando a conoscersi (oggettivazione del se) si riesce sempre più a migliorare il proprio insight e riuscire ad essere maggiormente consapevo-li rispetto a tali sistemi.
Finalmente, sembra essere tutti d’accordo (neuroscienziati, psicologi, filoso-fi e perché no anche counsellor!) che l’empatia è un’esperienza complessa e multidimensionale, in cui si condivide affettivamente l’emozione che l’altro sta vivendo ed in cui si mettono in gioco forme di mediazione cognitiva, progressi-vamente più elaborate, che permettono di comprendere in modo sempre più profondo, il punto di vista di chi si ha di fronte. Lo svolgersi di questo processo è un percorso che procede per tappe e che è costellato di scambi relazionali con altri significativi. Sintetizzando sono tre gli aspetti che risultano fondamentali nell’empatia: la dimensione affettiva, la dimensione cognitiva ed il fatto che es-sa implichi la relazione con gli altri, entrando nel loro mondo e coinvolgendolo nel proprio.
Da questo assunto, si può immaginare quanto questo diventa arduo e diffici-le in una situazione di sviluppo atipico qual’è quello autistico. E quanto questa
24
“sindrome multifattoriale” si rifletta in ambito familiare, in senso sociale più stretto, ed ambientale in senso socialmente più ampio con conseguenze facil-mente intuibili.
Il termine autismo identifica una disabilità permanente complessa, di natu-ra neurobiologica, con esordio nei primi tre anni di vita.
Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative:
- alla comunicazione,
- all'interazione sociale reciproca,
- al repertorio di interessi/attività (selettivi e ripetitivi).
Le anomalie comportano una significativa compromissione dello sviluppo delle funzioni mentali con la conseguenza di una grave disabilità che può assu-mere espressività variabile lungo il ciclo di vita.
Di fatto l'autismo rappresenta una condizione specifica all'interno di uno spettro di disturbi, definiti disturbi dello spettro autistico o disturbi pervasivi dello sviluppo (DSM IV-TR).
Lo Spettro Autistico è un’entità eterogenea a genesi multifattoriale; l’elemen-to essenziale comune è il “core autistico” (disturbo nell’interazione sociale con tendenza all’isolamento, anomalie comportamentali con interessi selettivi atipi-ci e con stereotipie) che si può riscontrare in contesti clinici molto diversi fra lo-ro.
L’incidenza è di 2-5 casi/anno 10. 000 soggetti , la prevalenza è di 4-10 casi (in alcune casistiche fino a 21) su 10.000 nati vivi ed il rapporto maschi/femmi-ne è di 5:1. Per definizione l’esordio della Disturbo Autistico si pone quindi pri-ma dei 3 anni di età anche se non raramente si giunge alla diagnosi con grave ritardo rispetto a questo termine temporale.
25
La compromissione dell’interazione sociale reciproca è quali/quantitativa e la gravità varia di concerto con l’età del bambino e con il suo grado di sviluppo di cui il Q.I. è la condizione determinante. Rispetto alla prognosi, è da intender-si prognosi psicosociale (quoad valitudinem) ed al momento non è soddisfacen-te. Solo il 10% raggiunge un buon grado di autonomia ed è in grado di svolgere un lavoro pur mantenendo “bizzarrie comportamentali”. Brevemente, è utile ag-giungere che in merito alla neurobiologia dell’autismo, gli studi neuropatologi-ci, neurofisiologici , biochimici-metabolici, genetici e le tecniche di neuroima-ging hanno permesso di reinterpretare le cause sottese a tale sindrome, ricono-scendogli una componente multifattoriale che merita in “OGNI SUO ASPET-TO” un approccio olistico nel pieno rispetto del paziente e dei suoi famigliari. Detto ciò, ritorno nell’ambito di nostro interesse.
Sottolineo quindi che la difficoltà principale dei pazienti autistici sta nella compromissione grave e perdurante dell’interazione sociale. In termini più con-creti, questi pazienti manifestano anomalie in diversi comportamenti non ver-bali che regolano la comunicazione con gli altri (ad esempio evitano lo sguardo diretto, sono poco espressivi nel volto, rigidi nelle posture ecc.). Inoltre, hanno grosse difficoltà ad instaurare relazioni adeguate con i compagni; i più piccoli possono avere scarso o nessun interesse nel fare amicizia, mentre quelli più grandi possono essere interessati all’amicizia ma incapaci di comprendere le convenzioni che regolano l’interazione sociale. Oltre a ciò difficilmente i sogget-ti autistici cercano spontaneamente di condividere gioie ed obiettivi con gli al-tri (per esempio non partecipano attivamente a semplici giochi sociali, prefe-rendo attività solitarie e coinvolgendo gli altri solo come aiutanti “meccanici”). A questa grossa difficoltà relazionale spesso si aggiungono disturbi del linguag-gio e modalità di comportamento ripetitive e stereotipate.
Molti studi mettono in luce come i soggetti autistici manifestano difficoltà in una grande varietà di compiti che attengono alla capacità di comprensione dei vissuti degli altri. Essi, infatti, faticano enormemente a riconoscere e condi-
26
videre le emozioni di chi gli sta accanto e non riescono a capire chiaramente il significato dei termini affettivi. Inoltre, è difficoltosa anche la comprensione dei contesti appropriati in cui esprimono le varie emozioni ed il riconoscimen-to di come le espressioni facciali, vocali e gestuali sono legate tra loro e concor-rono ad esprimere una particolare emozione. I pazienti autistici falliscono an-che nei compiti di social referencing per orientarsi di fronte a stimoli inconsue-ti. Il disagio che i pazienti autistici provano quando devono interagire con gli altri si ripercuote nella loro prestazione in situazioni in cui si chiede loro di em-patizzare in situazioni vicine all’esperienza reale. Tuttavia, se si richiede a pa-zienti autistici “ad alto funzionamento” (Q. I. >70), di riflettere sul vissuto di una persona con cui non stanno interagendo (come avviene quando guardano un filmato), essi mostrano di essere in grado di empatizzare con il vissuto del-l’altro. Ciò supporta la tesi che, pur in una situazione di patologia (l’autismo) , il grado d’empatia del soggetto varia in funzione di quanto la sua componente cognitiva moduli la componente emozionale. Singolare, come nei pazienti con S. di Down, avvenga esattamente il contrario e spesso essi hanno “performance empatiche” empiricamente superiori.
27
C A P I T O L O 5
Discussione
Come affrontare quindi un’esperienza di counselling a genitori di pazienti auti-stici?
Presuntuosamente, ma direi anche realisticamente, Carl Rogers e gli studi di counselling centrato sulla persona hanno fatto la differenza.
Alla luce della mia esperienza, vorrei sottolinearla, in parte con le parole di Rogers, ma anche con uno scritto di Antonio M. Ferreri (psicologo e psicotera-peuta) che non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, ma i cui scritti ho ampiamente apprezzato. Nello specifico: “I.A.C.P. e la terapia familiare cen-trata sul cliente, pag. 68-72”. Fedelmente, anche se sommariamente, riporto:
Rogers non esitava a definire l’empatia come <un modo di essere tutt’altro che apprezzato> (1980). Eppure <per ironia della sorte è diventata un concetto co-sì accettato in psicoterapia che pochi ne apprezzano le sottigliezze, le sfumatu-re ed il potere (Gaylin, 1989, p. 272).
Nella relazione d’aiuto la comprensione empatica comporta una sfida tutta peculiare di questo contesto: un counsellor, infatti deve riuscire ad essere em-patico nei confronti delle singole persone senza perdere un senso di empatia per la famiglia nel suo intero. Si tratta di vivere, quindi, la sfida del “parados-so” che Boszormenyi-Nagy e Ulrich (1981) definiscono “parzialità multidirezio-nale” (multi-directional partiality): <Verso i partecipanti, il counsellor non adotta un atteggiamento di contemplazione imparziale di tutti gli interessi in
28
gioco. Il counsellor è multidirezionalmente parziale, per esempio offrendo em-patia, appoggio ed ascolto ad una persona, e poi subito dopo all’avversario di quella persona>. (Boszormenyi-Nagy ed Ulrich, 1981-p. 178) . E’ assolutamente estraneo a questo contesto il concetto di “neutralità”, che d’altra parte non ha alcun senso neppure nel counselling individuale centrato sul cliente; infatti il counsellor vive e comunica la sua partecipazione calorosa al mondo interiore del cliente. Al contrario di quanto avviene nel counselling individuale, quindi, il counsellor familiare si trova ad affrontare non una, ma molte versioni -spes-so molto diverse e talvolta in aperta contraddizione reciproca- dell’esperienza personale e sociale dei diversi componenti della famiglia: <come e a che punto rispondere empaticamente a queste storie è complesso, poiché ci sono molte prospettive da cui trarre significato come ascoltatore (Anderson, 1989, p. 299). E’ un cambiamento dall’ “io” al “noi”: un cambiamento di schema, un movimen-to di uscita dallo schema di riferimento del sé individuale verso uno schema di riferimento di relazione. Nel cambiare schema di riferimento, cerco di restare sintonizzato con ciò che viene detto ed espresso, ma muovendo ciò che viene detto ed espresso verso un contesto del sé e di relazioni sociali. I cambiamenti di schema non sono interpretazioni od osservazioni del processo di coppia o fa-miglia. Sono invece responsi empatici alla individualità e mutualità percepita della vita dei miei clienti> (Anderson, 1989, pp. 302-302) .
Il valore dell’empatia nella relazione d’aiuto è legato al suo potere di promuove-re la comprensione di sé e di predisporre il cambiamento autodiretto.
Rogers indica almeno tre ragioni che giustificano l’importanza dell’atteggia-mento empatico: (“Un modo di essere. I più recenti pensieri dell’autore su una concezione di vita centrata-sulla persona”, Martinelli, Firenze 1983):
- la qualità non giudicante ed accettante del clima empatico permette alle persone di assumere un atteggiamento valorizzante e che si prende cura di sé;
29
- essere ascoltati da qualcuno che comprende, rende possibile alle persone di ascoltare con più attenzione se stesse, con una maggiore empatia verso il lo-ro esperire più autentico, verso i loro significati, altresì, vagamente percepiti;
- la maggiore comprensione e valutazione di sé ad opera degli individui apre loro aspetti nuovi dell’esperienza che diventano parti di un concetto di sé più accuratamente fondato.
Naturalmente, come le altre abilità della relazione efficace, l’empatia, non è riconducibile esclusivamente ad una qualche forma di attitudine congenita alla comprensione dell’altro; essa, anzi, è qualcosa che può essere sviluppata trami-te formazione ed esperienza di addestramento. Ogni persona può essere aiuta-ta a diventare empatica… questa qualità sottile, elusiva… non è qualcosa di “in-nato”; anzi, può essere appresa, e appresa più rapidamente in un clima empati-co”. A tal proposito ecco il pensiero di Rogers: “Dovremmo scegliere persone piene di calore, spontanee, autentiche, comprensive, e non giudicanti. Dovrem-mo anche cercare di impostare il programma formativo di questi soggetti in modo da far loro via via sperimentare l’empatia, l’interesse per gli altri, e da rendere loro più facile essere se stessi, essere autentici. In questo training do-vremo puntare più sull’esperienza interpersonale che non sull’apprendimento intellettuale” (La terapia Centrata sul Cliente, Martinelli, Firenze1970, pag.124).
Rogers, rivendica alle relazioni d’aiuto, anche nei contesti professionalizzan-ti, lo statuto di expertise, accanto a quello -ineliminabile ma insufficiente- della conoscenza. E in questo senso le sue posizioni, minacciando di destrutturare un sistema di potere incentrato sulla detenzione e sulla trasmissione del sape-re, devono essere apparse a più di qualcuno motivo di inquietitudine e di timo-re: “Le idee di Rogers spaventano coloro la cui identità professionale risiede prevalentemente nella loro conoscenza psicologica e nella loro capacità di incar-nare il ruolo degli esperti” (Thorne, Carl Rogers, cit, p.65).
30
Ritengo, quindi, che il professionista rogersiano, infatti è “esperto” nel sen-so più proprio del termine, in quanto pronto a trarre dall’esperienza un sapere situato, concreto, non dogmatico, aperto ed efficace. Ed è qui la vera novità, nel-l’approccio "veramente nuovo" anche se non necessariamente nelle sue idee che hanno antiche radici (C.Rogers-“Potere personale. La forza interiore ed il suo effetto rivoluzionario”, Astrolabio, Roma 1978).
Alla luce di questo percorso nei miei incontri, settimanali, con i genitori di pazienti autistici, ho acquisito la tendenza a dar l’avvio alla “relazione”, in modo assolutamente non strutturato, esprimendo la mia fiducia in loro, così ri-esco a essere sciolto e rilassato fin dal primo momento. Ascolto con tutta l’at-tenzione, la cura e la sensibilità, che mi sono possibili, ogni persona che espri-me se stesso. Ascolto sempre, si tratti di uno sfogo superficiale oppure significa-tivo. Io credo che valga sempre la pena di ascoltare e cercare di capire una per-sona che parla; ne consegue che “egli” ha valore per il fatto d’avere espresso qualcosa. Mi concentro su chi in quel momento mi sta parlando e senza dubbio mi interesso assai meno ai particolari del suo litigio con il figlio, delle sue diffi-coltà -concrete- nel gestirlo, del suo eventuale disappunto provocato da quanto io gli devo professionalmente e clinicamente comunicare (alterazioni biochimi-che, allergie, intolleranze alimentari… ect.), puntando fortemente ed empatica-mente al significato che queste esperienze hanno per lui ora, ed ai sentimenti ed emozioni che esse destano in lui.
E’ a questi sentimenti, a queste emozioni che cerco di modularmi, nella ma-niera più rogersiana che mi è possibile, congruentemente, empaticamente, con una accettazione piena ed incondizionata, desiderando pienamente e vivamen-te di rendere l’atmosfera psicologicamente sicura per chi in quel momento in-terloquisce con me. Voglio fargli sentire, sin da principio che, se assume il ri-schio di dire qualcosa di molto personale o assurdo o ostile o finanche cinico, io ci “sono” nell’ascoltarlo attentamente, in quanto in ciò che egli dice c’è un’au-tentica espressione di se stesso. In tutto questo mi rendo perfettamente conto
31
che non è possibile salvaguardare l’esperienza di chi “mi si affida”, dal dolore, generato ogni giorno dalla maggiore o minore consapevolezza che deriva dal “sapere un figlio malato”. Tuttavia cerco di trasmettergli, che qualunque cosa accada a lui o in lui, sarò -empaticamente- con lui, nei momenti di dolore o di gioia, o in quella combinazione delle due cose che è un così frequente segno di crescita. Penso di riuscire, di solito, a sentire quando un genitore è spaventato od offeso, ed è proprio in questi momenti che gli faccio capire con qualche cen-no, verbale o no, di percepire questa sua situazione e d’essere al suo fianco, sen-za sostituirmi a lui, mentre vive quell’offesa e quella paura.
Ammetto che bisogna dotarsi anche di una gran pazienza.
32
C A P I T O L O 6
Conclusioni
Spero di riuscire ad esprimere bene cosa intendo con ciò. Io credo fermamente che se c’è una cosa che ho imparato e reimparato negli ultimi anni, è che alla fi-ne si è ricompensati accettando ogni genitore esattamente com’è. In questo è compreso che, se una persona desidera restare “psicologicamente ai margini”, non forzo mai la mano. Ho imparato ad accettare i momenti, più o meno per me lunghi, di silenzio o di mutismo, facendo bene attenzione che essi non deri-vano da un dolore o da una resistenza precedentemente non espressa. Sto im-parando ad essere sempre più libero di far “uso” dei miei sentimenti, delle mie emozioni così come li provo in un dato momento, posso dire così, di provare -quasi sempre- un interesse autentico ed attuale per il mio interlocutore. Mi è difficile dire perché accada, (o forse intellettualizzerei troppo la faccenda), è semplicemente un fatto. Voglio esprimere allo stesso modo (empatico e con-gruente) tanto i sentimenti ed emozioni positivi ed amabili, quanto quelli nega-tivi o frustrati o rabbiosi. Comprendo che ciò può comportare un certo rischio, anche se con esiti positivi. Mi sembra di agire per il meglio, nelle mie “relazioni d’aiuto sanitario” (ammetto che il termine e’infelice, mi suona come un ibrido …), quando i “miei” sentimenti, le mie emozioni -positivi o negativi- sono in in-terazione immediata con quelli di chi mi sta di fronte. Per me vuol dire che stia-mo comunicando ad un livello profondo di “significato personale”. E’ il punto più vicino ad un rapporto “IO-TU” che mi riesca di raggiungere, senza inquina-menti emozionali. In sostanza, l’empatia ci consente di “sentire l’ira, la paura, il turbamento del cliente, come se fossero nostri, senza però aggiungervi la no-
33
stra ira, la nostra paura, il nostro turbamento”, (Carl Rogers- “Un modo d’esse-re. I più recenti pensieri dell’autore su una concezione di vita centrata -sulla persona”-, Martinelli, Firenze, 1983, p.121). Si tratta di una particolare forma di decentramento cognitivo ed emotivo, che permette di “essere presso l’altro senza essere l’altro e senza cessare di essere se stessi” (De Peretti, Presence de Carl Rogers, cit., p.215), e di coglierne i vissuti riducendo al minimo il rischio di sovrapporvi la propria esperienza pregressa o le proprie valutazioni. Essere empatici, insomma, significa entrare nel mondo percettivo dell’altro e trovarci-si completamente di casa. Comporta una sensibilità, istante dopo istante, verso i mutevoli significati percepiti che fluiscono in quest’altra persona (Carl Ro-gers- “Un modo di essere”. I più recenti pensieri dell’autore su una concezione di vita centrata sulla persona”, Martinelli, Firenze 1983, p.122). La capacità em-patica, soprattutto grazie al contributo offerto dall’approccio centrato sulla per-sona, è oggi ampiamente accreditata come competenza fondamentale e stru-mento chiave nella relazione di cura, per il suo valore terapeutico ed educativo. In “La terapia centrata sul cliente”, Carl Rogers scrive che: Quando il counsel-lor ha chiaro il mondo del cliente tanto da potercisi muovere liberamente, allo-ra può, sia comunicare al cliente la sua comprensione di ciò che è noto a lui, sia aiutare il cliente a dare a certe esperienze dei significati di cui il cliente stesso è scarsamente consapevole. E’ questa specie di empatia profondamente sensibile che è importante per rendere capace una persona di avvicinarsi a se stessa, di imparare, di modificarsi e di evolvere. (cit.pp47-51)”
La comprensione empatica facilita la crescita ed il cambiamento nella misu-ra in cui riesce a polarizzare l’attenzione del soggetto sulla sua esperienza pro-fonda, incoraggia il processo di auto esplorazione, aumenta il grado di com-prensione di sé e del significato della propria situazione esistenziale ed infine svela alcune direzioni di senso possibili per intraprendere una trasformazione. In “Terapia Centrata sul Cliente”, Rogers parla di un linguaggio -accordato- (at-tuned) a quello del cliente, cioè un modo di interagire a livello comunicativo
34
che privilegia alle consuete risposte indagatrici, estimative, rassicuranti,inter-pretative etc., la tipologia delle risposte “comprensive”, capaci di cogliere il “sentimento dominante” e rimandarlo all’interlocutore affinché ne prende co-scienza e sia indotto all’autoesplorazione ed all’autoaccettazione,autentica pre-messa e motore del cambiamento.
Rogers in -Psicoterapia e relazioni umane- (Rogers-Kinget) individua e di-stingue tre tipi di “risposta-riflesso”:
-la reiterazione semplice (recognition of feeling), che consiste nel ripetere le espressioni più significative del cliente e riproporle nella comunicazione senza mutarle: tale risposta consente di rassicurare l’interlocutore circa il fatto di es-sere stato ascoltato effettivamente e compreso correttamente, lo sollecita a con-tinuare, gli permette anche di correggersi o esplicitare meglio i propri vissuti, e spesso (dal momento che il counsellor, nel ripetere sceglie le frasi più ricorren-ti o significative oppure tenta di riassumere ciò che è stato detto magari in ma-niera confusa e convulsa) gli offre l’occasione per operare una prima compren-sione di sé, riordinando l’esperienza;
- Il riflesso del sentimento (reflection of feeling) costituisce il riflesso vero e proprio, mediante il quale il counsellor cerca di connettere le emozioni manife-state nella comunicazione ai significati che vengano espressi: in tal modo il cliente può iniziare a dare un nome ai propri sentimenti ed a esplorarne le ra-gioni o le inconsistenze;
- La delucidazione (clarification), adoperata solo raramente da Rogers in quanto contenente un rischio di valutazione, consiste nel tentativo (da espri-mersi sempre in modo ipotetico o come suggestione o parere personale da sot-toporre al giudizio ultimo del cliente) di correlare emozioni e significati con aspetti dell’esperienza di cui il cliente non è pienamente consapevole e che pa-re di poter intuire o dedurre implicitamente da ciò che è stato comunicato spes-so in modo frammentario.
35
Ed è così che, alla fine del mio percorso biennale I. A. C. P., posso dire che come counsellor, mi riconosco nell’approccio centrato sulla persona. Tuttavia, (anche se è pleonastico sottolinearlo) questa adesione teoretica, metodologica e valoriale non implica una chiusura a concetti, teorie e modelli di intervento elaborati in altre prospettive. Come S. Paolo (mi si scusi per la megalomania) parafrasando, mi dico: “Tutto prova, ritieni ciò che buono!” Per me e per l’altro da me.
In conclusione, mi preme dire quanto segue.
L’empatia è il fenomeno del nostro entrare quotidianamente in rapporto con altri cogliendo la loro individualità di persone, dotate di corpo e di psiche, di emozioni, di motivazioni, di valori, di una vita sociale, spirituale. Essa, quin-di, invita a concentrare l’attenzione sulle dimensioni dell’esperienza il cui sche-ma è il movimento, il passaggio costante e reciproco dall’esterno all’interno, da sé agli altri, dai momenti sensoriali -vitali legati al corpo ed al mondo fisico -na-turale- e che si riversano sulle emozioni, sulla volontà e sull’agire- al raccogli-mento in ciò che può assumere valore assoluto.
Per questa ragione è necessario distinguere l’empatia dal semplice sentire-con (Mit-fuhlen) o dall’immedesimazione (Eins-fuhlen); non si tratta, infatti, di accompagnare con il proprio sentire il sentire altrui, provando simpatia o an-tipatia -tali atteggiamenti possono verificarsi, ma presuppongono già l’empa-tia- né di poter vivere con le stesse modalità, ciò che l’altro vive. Certamente ed in primo luogo, ci si muove dalla constatazione che si riconosce l’altro come in-dividuo-persona, non solo come “oggetto” fra gli altri del mondo fisico come “corpo” (Korper) fra i corpi, ma come soggetto vivente e senziente (Leib), indi-viduo psico-fisico; in secondo luogo la specificità del vissuto dell’empatia emer-ge nel confronto, ad esempio con il ricordo o la fantasia, infatti l’empatia si di-stingue perché non c’è la ripresentazione di un mio stato d’animo, ma di uno stato d’animo vissuto da un’altra persona, è ciò che è da essa espresso .
36
Ed è così che l’atto dell’empatia assume un particolare valore perché giustifi-ca l’uscita da se stessi, dalla propria singolarità, attraverso uno strumento che (come ha sempre sostenuto Rogers) è già posseduto dal soggetto e che permet-te di cogliere ciò che accade nell’estraneità senza interferire in essa. La pienez-za e l’apertura all’ESSERE, connotona così l’empatia entro il recinto della re-sponsabilità, dell’interesse, (l’*I CARE* dei ragazzi di Barbiana di don Milani), del più autentico farsi carico, del più libero condividere. L’altro “mi e’entrato nello sguardo” ed in questo specifico incontro, che è esperienza immediata, pos-so vivere valori che a lui appartengono e portare a scoprimento <<strati>> del-la mia persona cui ancora non ero pervenuto. E, per la caratteristica propria del “sentirsi accompagnati” che risiede nell’esperienza empatica, ciò che avvie-ne secondo la cifra della conoscenza, ma anche secondo quella dell’amore, per sé e per gli altri. Per essere in grado di cogliere nella mia esperienza vissuta non originaria l’altrui esperienza vissuta originaria è indispensabile attribuire valore all’altro proprio perché tale. E per far ciò è indispensabile che:
1. La presenza dell’io soggetto presupponga la coscienza di sé come persona unica ed originale.
2. L’atto del “cogliere” indica apertura nei confronti dell’altro da me
3. Il riferimento all’esperienza estranea vissuta, si traduce in accettazione del fatto che ci sia qualcosa di altrettanto originale ed importante di cioè che ag-gettivo come “mio” e che l’altro, l’estraneo, esiste e permane non in rapporto a me.
4. Percepire e vivere questa esperienza estranea, vissuta “come se” fosse mia indica la consapevolezza che mia non è, ed io permango come soggetto, di fron-te ad un altro soggetto.
Ebbene: coscienza di sé, stabilità, equilibrio, ascolto, gratuità, oblatività, com-passione, senso del limite sono caratteristiche per le quali la persona si fa capace di empatizzare. Il volerlo essere, dipende molto da noi stessi.
37
C A P I T O L O 7
Appendice
L’uomo è quel mistero che rimane tale, nella luce del giorno e nella luce delle nostre lampade, l’essere sconosciuto, come diceva Aleis Carrel; il grande abisso come aveva formulato, con una parola dei salmi, St. Agostino.
Le nostre lampade di oggi sono molto sofisticate, le scienze umane hanno scoperto nella geografia dell’essere umano dei continenti finora sconosciuti e cercano di illuminare fino in fondo il mistero umano.
Ma col crescere del nostro sapere cresce anche l’abisso ed il suo oscuro im-perscrutabile.
Tuttavia, cercare che cosa sia l’uomo, cercare il segreto della propria esisten-za ed essenza rimane un impulso irresistibile che appartiene al dinamismo in-nato della nostra vita.
Ecco il perché di questa mia breve introduzione al tema che andrò a tratta-re.
Mi preme sottolineare che la ricerca non ha la pretesa di conoscere né di giu-dicare tutti gli aspetti particolari dell’empatia e di conseguenza non interferisce con le letture parziali ed analitiche operate dalla diverse scienze (umane e natu-rali), ma auspico a me stesso di aprire l’orizzonte del mio sapere umano alle di-mensioni ed ai significati più profondi dell’uomo che diventa persona.
Attraverso una breve sintesi storica degli studi sull’empatia, delle sue origini filosofiche-fenomenologiche citando sommariamente gli studi di Husserl pri-
38
ma e di Edith Stein (sua allieva) successivamente, mi preme arrivare a come og-gi tale termine viene inteso. Il tutto applicato ad una mia esperienza lavorativa di counselling-famigliare per genitori di pazienti autistici.
Vorrei innanzitutto condividere la mia visione d’empatia frutto della mia esperienza di persona.
Edmund Husserl (1859-1938) è stato il fondatore della fenomenologia ed uno dei filosofi più influenti del Novecento.
Il saggio -Fenomenologia e psicologia- (che Husserl scrive tra il 1916 ed il 1917) viene tradotto per la prima volta in italiano sulla base dell’edizione criti-ca dell’Archivio Husserl di Lovanio.
Edith Stein (1891-1942), conseguì il dottorato nel 1916 avendo come correla-tore Edmund Husserl.
Il tema prescelto, quello dell’EINFUHLUNG (termine tradotto in italiano prima con enteropatia e poi meglio come empatia dal termine inglese em-pathy) era stato esplicitamente trattato da Husserl già dal 1905, ma, in realtà, marginalmente rispetto alle analisi fondamentali che egli andava sviluppando e che confluirono nel 1913 nelle “Idee per una fenomenologia pura ed una filo-sofia fenomenologica”, rivolte a delineare il ruolo della ricerca fenomenologica e la sua capacità critica.
Nella Stein l’atto dell’empatia assume un particolare valore perché giustifica l’uscita
- da se stessi,
- dalla propria singolarità,
attraverso uno strumento che è già posseduto dal soggetto e che permette di cogliere ciò che accade nell’estraneità senza interferire in essa, rendendosi con-
39
to che è impossibile immedesimarsi fino in fondo nell’ambito che gli/le appar-tiene.
Ritengo indispensabile per comprendere l’uso attuale del termine empatia nella letteratura psicologica ed in particolare per comprendere le difficoltà con-nesse alla sua definizione ed al suo studio nella moderna psicologia dello svilup-po esaminare, se pure brevemente, la storia di questo termine nella psicologi-ca novecentesca.
La capacità di fare propria l’esperienza di un’altra persona era già stata de-scritta ed analizzata da Freud a proposito dell’identificazione isterica.
Già Lipps (1905) aveva dato una formulazione più psicologica a tale concet-to.
Il termine empathy che in italiano diverrà empatia venne coniato da Titche-ner nel 1909 come precedentemente detto dal termine tedesco Einfuhlung (sen-tire dentro) ma anche sulla base del termine greco empatheia.
Dalla seconda metà del Novecento in poi, l’attenzione si sposta grazie a Carl Rogers (1959; 1975) dalla condivisione dei vissuti altrui, alla relazione tra il te-rapeuta e/o counsellor ed il cliente, ed al ruolo svolto dall’empatia in tale rela-zione.
Rogers, la quale (l’empatia) consente di entrare nel modo di un’altra perso-na senza giudicarla.
In questi ultimi decenni i ricercatori più attenti hanno cercato di ricomporre un quadro teorico che rendesse ragione della complessità del fenomeno delle sue diverse modalità di espressione dei processi cognitivi ed emotivi che lo me-diano.
Il primo modello multidimensionale fra quelli più recenti è dovuto a Norma Feshbach.
40
Il merito di questa autrice consiste nell’aver sviluppato per la prima volta nella letteratura psicologica, un modello sistematico che, supera la visione del-l’empatia come un’abilità monolitica.
I processi cognitivi ed affettivi non sono contrapposti o giustapposti, ma si integrano concorrendo entrambi alla definizione del modello empatico.
Feshbach elabora il primo strumento per rilevare appositamente la responsi-vità empatica: il FASTE (Feshbach Affective Situation Test for Empathy) che riflette gli assunti di base del suo modello teorico.
Il limite di tale lavoro consiste nell’essere eccessivamente restrittivo nella de-finizione poiché esclude, dal modello proposto, tutte le risposte affettive vicarie n o n i d e n t i c h e a q u e l l e o s s e r v a t e . Notevoli sono anche gli studi di Martin L. Hoffman (2001) che elabora un mo-dello a tre componenti: affettiva, cognitiva e motivazionale.
Il collegamento tra l’empatia ed il comportamento prosociale è centrale nel modello dell’autore al punto che egli inserisce l’abilità empatica nel quadro più complesso dello sviluppo morale.
In definitiva, l’empatia con Hoffman diventa un’abilità che evolve, che cam-bia forma, che si differenzia progressivamente, perdendo la dimensione monoli-tica che Feshback e gli autori precedenti le avevano attribuito.
Per la prima volta, l’empatia è inserita appieno in un’ottica di sviluppo.
La critica che si può muovere ad Hoffman è quella di essersi frequentemen-te limitato ad una meta riflessione su dati empirici provenienti da altri ricerca-tori, senza averne sottoposto a verifica le proprie assunzioni teoriche attraverso esperimenti appositamente ideati.
41
Finalmente, sembra essere tutti d’accordo: counsellor, neuroscienziati, psi-cologi, filosofi, psichiatri, psicoterapeuti… e la lista potrebbe continuare!
Sintetizzando sono tre gli aspetti che risultano fondamentali nell’empatia: la dimensione emozionale, la dimensione cognitiva ed il fatto che essa implichi la relazione con gli altri, entrando nel loro mondo e coinvolgendolo nel proprio. Da questo assunto si può immaginare quanto questo diventa arduo e difficile in una situazione di sviluppo atipico quale è quello autistico nello specifico, comprensivo nei disturbi generalizzati dello sviluppo.
E quanto questa sindrome multifattoriale si rifletta in ambito familiare, in senso sociale più stretto, ed ambientale in senso socialmente più ampio con conseguenze facilmente intuibili. E’ quello che cercherò di esporre da qui in se-guito, con applicazione specifica e fattiva nell’ambito della mia professione.
Ossia di come fare consulenze metaboliche a genitori di pazienti autistici ab-bia il suo goal vincente se in tale relazione d’aiuto l’empatia trova il suo giusto spazio.
Sottolineo quindi che la difficoltà principale dei pazienti autistici sta nella compromissione grave e perdurante dell’interazione sociale.
A questa grossa difficoltà relazionale spesso si aggiungono disturbi del lin-guaggio e modalità di comportamento ripetitive e stereotipate. Tuttavia, se si richiede a pazienti autistici ad alto funzionamento (Q. I. >70), di riflettere sul vissuto di una persona con cui non stanno interagendo (come avviene quando guardano un filmato), essi mostrano di essere in grado di empatizzare con il vis-suto dell’altro.
Ciò supporta la tesi che, pur in una situazione di patologia (l’autismo), il grado d’empatia del soggetto varia in funzione di quanto la sua componente co-gnitiva moduli la componente emozionale.
42
Singolare come nei pazienti con S. di Down, avvenga esattamente il contra-rio e spesso essi hanno performance empatiche empiricamente superiori. Co-me affrontare quindi un’esperienza di counselling a genitori di pazienti autisti-ci?
Presuntuosamente, ma direi anche realisticamente, Carl Rogers e gli studi di counselling centrato sulla persona prima e successivamente, gli approfondi-menti miei personali sugli scritti di Edith Stein, hanno fatto la differenza, por-tandomi addirittura (ecco perché la presunzione!) ad elaborare un mia singola-re teoria in merito all’empatia, che in sé reca una nuova modalità d’approccio e relazione cliente-counsellor.
Empatia, secondo la definizione iniziale di Edith Stein, designa un genere di atti, nei quali si coglie l'esperienza vissuta altrui. Usa inoltre questo concetto per determinati atti percettivi particolarmente in relazione ad altre persone.
Edith Stein chiama con Max Scheler l'atto dell'empatia nella propria espe-rienza percezione interiore.
Secondo Edith, cogliere e descrivere a grandi linee il processo interiore con-creto, mediante il quale avviene tale empatizzare in un'altra persona, deve esse-re il nostro primo compito. In primo luogo, Edith cerca di affrontare questo compito distinguendo l'atto dell'empatizzare da atti conoscitivi simili, che pari-menti hanno per oggetto l'esperienza vissuta soggettiva di un altro: dalla perce-zione esterna, dal sapere di vissuti estranei, dal co-sentire (Mitfühlen) e dal-l'uni-sentire (Einsfühlen).
Percezione esterna, secondo Edith Stein, è un titolo di atti nei quali l'essere viene a me come entità corporale.
In questo modo posso, come dimostrato dall'esempio del dolore che coglie un altro, percepire l'esplosione dolorosa di colui che soffre.
L’empatia ha però come oggetto lo stesso dolore.
43
Similmente avviene per il sapere dei vissuti estranei: in questo caso, median-te la comunicazione dell'altro, io vengo a sapere del suo dolore; ma il dolore stesso mi resta ancora estraneo, è per me un sapere vuoto basato su una comu-nicazione, ma non mi è dato per esperienza. L'empatizzare è molto distinto an-che dal cosentire (Mitfühlen).
In questo caso, Edith sceglie l'esempio della gioia di uno studente per aver superato un esame: nel cosentire mi immetto nell'avvenimento del buon esito dell'esame, e quindi in quello per cui egli (cioè il compagno di studi) gioisce; io gioisco con lui per questo evento.
Empatia al contrario significa percepire la stessa gioia che lo studente ha in sé: nell'empatizzare, colgo la sua gioia e ciò facendo mi traspongo in essa. Pari-menti, l'empatizzare (Einfühlen) e l'unisentire (Einsfühlen) sono due atti diver-si.
Quando godo di uno stesso avvenimento o di uno stesso oggetto di cui un al-tro gode, questo mi può condurre al fatto che non più solo io e lui, ma noi go-diamo, noi ci uni-sentiamo nella gioia dello stesso oggetto.
Ma anche questo è un processo nel quale l'atto conoscitivo è indirizzato al-l'oggetto comune della gioia, ma non alla stessa gioia dell'altro.
Quindi non è mediante l'unisentire che facciamo esperienza vitale degli al-tri, ma mediante l'empatizzare, in quanto solo mediante l'empatia l'unisentire e l'arricchimento della propria esperienza vitale diviene possibile o può divenir-lo. Come avviene l'empatia? Cosa si percepisce mediante l'empatia?
Nel campo dell'esperienza dei propri vissuti, che in base alla costituzione corporea dell'essere umano sta sempre naturalmente in relazione con l'espe-rienza vitale psicofisica, si apre ora al soggetto empatizzante un nuovo regno di oggetti: il mondo dei valori. Ma mi viene incontro anche e soprattutto l'essere umano stesso nel suo valore peculiare.
44
L'empatia conduce ad una sensazione di valore (Wertfühlen) nella quale ci è data la persona dell'altro.
Edith scrive come negli atti propri originari si costituisce la propria perso-na, così negli atti vissuti empaticamente si costituisce l'altra persona.
È in definitiva lo stesso altro, che attraverso l'empatia viene percepito. Allo-ra non dobbiamo temere, in questo contesto pur all'interno del sobrio linguag-gio dell'analisi scientifica di parlare di questo atto dell'empatia come di un atto di amore in solo atto si compie un afferrare, ossia un intendere del valore della persona. Ecco quindi che, nella relazione d’aiuto, nello specifico a genitori di pazienti autistici, la comprensione empatica comporta una sfida tutta peculia-re di questo contesto: un counsellor, infatti deve riuscire ad essere empatico nei confronti delle singole persone senza perdere un senso di empatia per la fa-miglia nel suo intero.
E’ assolutamente estraneo a questo contesto il concetto di neutralità, che d’altra parte non ha alcun senso neppure nel counselling individuale centrato sul cliente; infatti il counsellor vive e comunica la sua partecipazione calorosa al mondo interiore del cliente.
Al contrario di quanto avviene nel counselling individuale, quindi, il counsel-lor familiare si trova ad affrontare non una, ma molte versioni-spesso molto di-verse e talvolta in aperta contraddizione reciproca-dell’esperienza personale e sociale dei diversi componenti della famiglia.
La qualità non giudicante ed accettante del clima empatico permette alle persone di assumere un atteggiamento valorizzante e che si prende cura di sè; essere ascoltati da qualcuno che comprende, rende possibile alle persone di ascoltare con più attenzione se stesse, con una maggiore empatia verso il loro esperire più autentico, verso i loro significati, altresì, vagamente percepiti; la maggiore comprensione e valutazione di sè ad opera del lavoro di counselling apre loro aspetti nuovi dell’esperienza che diventano parti integranti. Ritengo,
45
quindi, che il professionista rogersiano, infatti è esperto nel senso più proprio del termine, in quanto pronto a trarre dall’esperienza un sapere situato, concre-to, non dogmatico, aperto ed efficace.
Ed è qui la vera novità, nell’approccio veramente nuovo anche se non neces-sariamente nelle sue idee che hanno antiche radici (C.Rogers, Potere persona-le. La forza interiore ed il suo effetto rivoluzionario, Astrolabio, Roma 1978).
I genitori hanno il ruolo essenziale di favorire lo sviluppo del bambino, in se-no alla famiglia: in altre parole, di educarlo.
Sebbene si tratti di una missione comune a tutte le famiglie, è vero che le dif-ficoltà date dall’autismo, sovente incomprensibili per molti genitori e che impli-cano bisogni molteplici e su di un lungo periodo, pervadono i genitori e richie-dono loro nuove conoscenze alle quali non sono state fin là confrontate.
Queste difficoltà educative portano spesso i genitori a restringere i loro con-tatti naturali (famigliari, di vicinato o di amicizie), quando al contrario sarebbe proprio - nel mantenimento e - nello sviluppo di tali relazioni che i genitori tro-verebbero una parte dell’aiuto necessario.
I due genitori devono pure trovare il loro posto, non solamente in termini di equilibrio tra la professione (nella quale alcuni padri si rifugiano), la vita fami-gliare con le implicazioni supplementari derivanti dall’handicap, e il benessere personale (in termini di hobby, d’implicazione sociale, di realizzazione persona-le, ma anche in termini di condivisione di compiti ed attività fra il padre e la madre). Infine, il gruppo famigliare deve potersi integrare nella vita sociale, la vita del quartiere, della città, del comune.
E’ la funzione sociale.
La famiglia dovrà imparare a sopportare lo sguardo degli altri, in particolare dei vicini, e a non esitare nel richiedere aiuto.
46
Esistono infatti numerose risorse invisibili che bisogna essere capaci a risve-gliare.
Quale accompagnamento proporre ai genitori?
Un accompagnamento per facilitare lo sviluppo del bambino.
Alla luce di questo percorso nei miei incontri settimanali, con i genitori di pazienti autistici, ho acquisito la tendenza a dar l’avvio alla relazione in modo assolutamente non strutturato, esprimendo la mia fiducia in loro, così riesco a essere sciolto e rilassato fin dal primo momento.
Ascolto con tutta l’attenzione, la cura e la sensibilità, che mi sono possibili, ogni persona che esprime se stessa.
Ascolto sempre, si tratti di uno sfogo superficiale oppure significativo.
Io credo che valga sempre la pena di ascoltare e cercare di capire una perso-na che parla; ne consegue che egli ha valore per il fatto d’avere espresso qualco-sa.
Mi concentro su chi in quel momento mi sta parlando e senza dubbio mi in-teresso assai meno ai particolari del suo litigio con il figlio, delle sue difficoltà concrete nel gestirlo, del suo eventuale disappunto provocato da quanto io gli devo professionalmente e clinicamente comunicare (alterazioni biochimiche, allergie, intolleranze alimentari…. etc.), puntando fortemente ed empaticamen-te al significato che queste esperienze hanno per lui ora, ed ai sentimenti ed emozioni che esse destano in lui.
E’ a questi sentimenti, a queste emozioni che cerco di modularmi, nella ma-niera più rogersiana che mi è possibile, congruentemente, empaticamente, con una accettazione piena ed incondizionata, desiderando pienamente e vivamen-te di rendere l’atmosfera psicologicamente sicura per chi in quel momento in-terloquisce con me.
47
Voglio fargli sentire, sin da principio che, se assume il rischio di dire qualco-sa di molto personale o assurdo o ostile o finanche cinico, io ci sono nell’ascol-tarlo attentamente, in quanto in ciò che egli dice c’è un’autentica espressione di se stesso.
In tutto questo mi rendo perfettamente conto che non è possibile salvaguar-dare l’esperienza di chi mi si affida, dal dolore, generato ogni giorno dalla mag-giore o minore consapevolezza che deriva dal sapere un figlio malato.
Tuttavia cerco di trasmettergli, che qualunque cosa accada a lui o in lui, sa-rò empaticamente con lui, nei momenti di dolore o di gioia, o in quella combi-nazione delle due cose che è un così frequente segno di crescita… e spesso non ce ne accorgiamo neppure!!!
In questo è compreso che, se una persona desidera restare psicologicamente ai margini, non forzo mai la mano. Ho imparato ad accettare i momenti, più o meno per me lunghi, di silenzio o di mutismo, facendo bene attenzione che es-si non derivano da un dolore o da una resistenza precedentemente non espres-sa.
Ho imparato ad essere sempre più libero di far uso dei miei sentimenti, del-le mie emozioni così come li provo in un dato momento.
Posso dire così, di provare -quasi sempre- un interesse autentico ed attuale (il qui ed ora!) per il mio interlocutore.
Si tratta di una particolare forma di decentramento cognitivo ed emotivo, che permette di “essere presso l’altro senza essere l’altro e senza cessare di esse-re se stessi” (De Peretti, Presence de Carl Rogers, cit., p. 215)
Essere empatici, insomma, significa entrare nel mondo percettivo dell’altro e trovarcisi completamente di casa.
Comporta una sensibilità, istante dopo istante,verso i mutevoli significati percepiti che fluiscono in quest’altra persona (Carl Rogers, Un modo di essere).
48
Empatizzando, io “CI SONO” dietro le sue e mie parole, dietro le sue e mie azioni, ma sempre la stessa persona che parla ed agisce. (CONGRUENZA)
Solo empatizzando, mi porto veramente alla sua altezza.
Ciò che ci è dato immediatamente dall’esperienza sono, per esempio, realtà colorate ed estese, sentimenti di gioia e di dolore, etc…
Riflettendo su questi dati dell’esperienza immediata, percepisco che vi è tra essi una differenza profonda: alcuni si identificano con me, sono miei in modo da poter dire: io sono adirato, io sono lieto; sono miei modi di essere; altri, al contrario, pur essendo miei, non si identificano con me, io non sono la cosa co-lorata che vedo. Il vedere è mio, ma la cosa colorata è altro da me. E’ importan-te sottolineare come all’interno di un rapporto empatico autentico non vi siano un emittente e un ascoltatore empatico definiti in modo rigido ma che questi r u o l i s i a n o i n t e r s c a m b i a b i l i t r a i d u e i n t e r l o c u t o r i .L’empatia, l’Einfühlung, è uno strumento naturale, immediato, tipicamente umano attraverso cui si riesce a cogliere ed a comprendere gli altri esseri uma-ni, i loro vissuti, i loro stati d’animo, i loro sentimenti.
Non è una pratica che si apprende o si applica quanto ve ne sia bisogno, ma è connaturato all’essere umano.
L’esperienza dell’altro è fondamentale anche sotto un altro aspetto, perché attraverso essa comprendo analogicamente la mia e viceversa, comprendo l’al-tro attraverso l’esperienza che ho di me stesso. Ed è proprio in questo scambio reciproco di esperienze e di relazioni umane che si comprende in modo pieno l ’ u n i v e r s o p e r s o n a u m a n a .L’empatia è anche un sentire che implica un rivivere in cui un ricordo, nel ma-re della nostra memoria, ci colpisce col vissuto di un’altra/o che ci contagia in quanto ci trova recettivi e vulnerabili. Proprio perché affiora in noi attraverso il rapporto con un’altra/o quel vissuto nostro ci induce a rivolgerci all’altra/o con una nuova attenzione, e nel farci scoprire qualcosa di inaspettato di noi stessi,
49
c i f a g u a r d a r e l ’ a l t r a / o a l p a r i d i u n a r e a l t à d a s c o p r i r e .D’altro canto quante volte una parola che ci colpisce nel profondo, uno sguardo che scava nell’abisso del nostro silenzio, l’eloquenza di un profumo che evoca il ricordo di un vissuto, rimettono in circolo nuove emozioni e rinnovate relazio-ni, dove lo sguardo verso l’altro riparte con l’entusiasmo di una nuova scoper-ta. L’empatia è allora un continuo movimento, un farsi che nasce da un iniziale legame indifferenziato tra gli esseri, integrando l’universale ed il particolare, ed è dunque un’esperienza trasformatrice, sicuramente difficile e precaria, come anche lo sono tutte le relazioni. Ma l’empatia è come un fiume carsico; ora riaf-fiorante, ora inabissato, tale da costituire un legame di comprensione immedia-ta che spesso sboccia all’improvviso e all’istante, seguendo le suggestive parole di J. Conrad in Cuore di tenebra:
“V’era fra noi […] il legame del mare, quel legame non soltanto teneva uniti i nostri cuori nel lunghi periodi di separazione, ma aveva anche l’effetto di ren-derci tolleranti a vicenda delle nostre storie, e persino delle nostre convinzio-ni”.
Concludo prendendo a prestito una frase di Einstein “La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero; è la fonte di ogni vera arte e di ogni vera scienza. Essere che non conosce questa emozione, che è incapace di fermarsi per lo stupore e restare avvolto dal timore reverenziale, è come un morto”.
50
51
PERSONA
Io dove sono? Io perché sono?Io cosa sono?
Conosco il luogo che abito, la mia ca-sa e la sento mia?
Qual è il fine dei miei vissuti, della mia quotidianità, del mio essere?
Conosco me stesso e chi voglio ospita-
re?
EMPATIA DI STATO
EMPATIA DI PROCESSO
Figura 1
Il soggetto PERSONA è da intendere sia per il cliente che per i counsellor professionisti dotati entrambi (con insight diversi) di empatia di stato e di empatia di processo.
52
CLIENTECOUNSELLOR
PROFESSIONISTA
EMPATIA DI STATO
EMPATIA DI PROCESSO
EMPATIA DI STATO
EMPATIA DI PROCESSO
EMPATIA DI RELAZIONE
.... dimensione di incontro ossia... quella dell’interiorità
?
Figura 2
Esempio di efficace relazione d’aiuto
P O S T FA Z I O N E
Postfazione
Accostandomi alla lettura di questo scritto e conoscendo il cammino professio-nale di chi scrive, la prima sensazione è quella di trovarsi di fronte ad un auto-re, consapevole della complessità dell’argomento, competente.
Il suo approccio non perde mai il rigore scientifico che lo caratterizza, non cede mai alla tentazione dell’emotività e/o del sentimentalismo, ma è sostenu-to da una rigorosa ricerca scientifica/filosofica che non perde di vista il conte-sto applicativo. Nell’esperienza effettuata di relazione d’aiuto con genitori di persone con Disturbi Pervasivi dello Spettro Autistico si evince infatti l’attenzio-ne alle necessità di conoscenza in merito alle complesse caratteristiche metabo-liche dei loro figli, che non si disgiunge dal rispetto dei loro vissuti e delle loro sofferenze connessi ad una “diagnosi” con la quale devono fare i conti quotidia-namente.
E’ presente inoltre una sensibilità associata ad una chiarezza metodologica che fa dell’empatia nei confronti di queste persone “un’esperienza complessa e multidimensionale, in cui si condivide affettivamente l’emozione che l’altro sta vivendo ed in cui si mettono in gioco forme di mediazione cognitiva, pro-gressivamente più elaborate, che permettono di comprendere in modo sem-pre più profondo, il punto di vista di chi si ha di fronte”.
L’autore inoltre condivide chiaramente un modello multidimensionale di empatia, quindi un modello sistematico che considera i processi cognitivi ed af-fettivi non contrapposti o disgiunti, ma che si integrano, concorrendo entrambi indissolubilmente all’unicità della persona.
53
Infine questo contributo rappresenta un tassello significativo della più am-pia presa in carico del soggetto con Disturbi dello Spettro Autistico e dei suoi familiari che implica una visione multidisciplinare che deve coglierne, mante-nendo l’unità del soggetto ed evitandone quindi la frantumazione, i punti debo-li e quelli forti, le competenze emergenti e quelle ancora non presenti, le neces-sità a livello cognitivo, emotivo, comunicativo, comportamentale, ancorati al contesto in cui è calato.
I trattamenti abilitativi/riabilitativi basati su ipotesi coerenti con i dati e i modelli emergenti dalle neuroscienze, distinti sulla base dei meccanismi neuro-psicologici e neurobiologici su cui devono operare connessi sia allo specifico profilo di aree di forza e di debolezza individuale, sia al momento del ciclo vita-le che ne caratterizza la peculiare fase di sviluppo, non possono prescindere da un coinvolgimento attivo dei genitori nel più ampio processo di intervento, ma devono anche prevedere una relazione d’aiuto, un lavoro “empatico” che può promuovere la comprensione di sé e predisporre un cambiamento autodiret-to.
La strada da percorrere sicuramente è ancora lunga e tanti sono ancora gli interrogativi, tuttavia tali scritti, così come le ricerche che sono alla base dei modelli per descrivere sistematicamente il funzionamento e lo sviluppo dei pro-cessi empatici hanno il merito di contribuire alla comprensione “scientifica” del funzionamento emotivo integrato al funzionamento cognitivo.
In conclusione questo scritto è il sedimento di un lungo percorso teorico/ap-plicativo ricco, autenticamente vissuto. È un cammino in divenire che, sono cer-ta, non mancherà di donarci altri frutti preziosi.
Francesca Maria Battaglia
54
Nota bibliografica
Alessandrini Marcone, G. (1980). Significato attuale dell’approccio centrato sulla persona nelle opere di Carl Rogers. Annali dell’Istituto di Pedagogia, 2, 79-95.
Banfi, A. (1961). La problematicità dell’educazione ed il pensiero pedagogi-co. Firenze: La Nuova Italia.
Beglinger, L. J. & Smith, T. (2001). A review of subtyping in autism and pro-posed dimensional classification model. Journal of Autism Develeopment Di-sorder, 8; 411-422
Besoli, S. & Guidetti, L. (a cura di). (2000). Il realismo fenomenologico. Sul-la filosofia dei circoli di Monaco e Gottinga. Macerata: Quodlibet.
Bettinelli, C. (1976). Il pensiero di Edith Stein. Milano: Vita e Pensiero.
Boella, L. & Buttarelli, A. (2000). Per amore di altro. L’empatia a partire da Edith Stein. Milano: Raffaello Cortina.
Bonino, S., Lo Coco. A. & Tani, F. (1998). Empatia: i processi di condivisio-ne delle emozioni. Firenze: Giunti.
Bosio, F. (1962). Psicologia e logica nella fenomenologia di Husserl. "Aut-aut", 68, 131-154.
Costa, V., Franzini. E. & Spinicci, P. (2002). La fenomenologia. Torino: Ei-naudi.
Damasio, A. R. (1995). L’errore di Cartesio: emozione, ragione e cervello umano. Milano: Adelphi.
lv
Feshbach, N. D., et al. (1968). Empathy in Six and Seven years old. Child De-velopment, 39, 133-45.
Fortuna, F. & Tiberio, A. (1999). Il mondo dell’empatia. Campi di applica-zione. Milano: Franco Angeli.
Galimberti, U. (1997). Dizionario di psicologia. Torino: Utet.
Gallese, V., Keysers, C. & Rizzolatti, G. (2004). A Uniflying View of the Basis of Social Cognition. Trends in Cognitive Sciences, vol.8, n.9, 396-403.
Gilson, E. (1993). Le costanti dell’essere, trad. it., Roma: Massimo.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam books.
Guitton, J. (1985). Il lavoro intellettuale. Roma: Edizioni Paoline,
Husserl, E. (1965). Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fe-nomenologicamente fondata, trad. it. Torino: Einaudi.
Janine, A., Lamb, L. et al. (2000). Autism: recent molecular genetic advan-ces. Human molecular genetics, Vol.9, n.6-rw
Kohut, H. (1984). Introspection, Empathy, and the Semicircle of Mental Health. In J. Lichtenberg, M. Bornstein, D. Silver (ed), Empathy, vol.1 (pp.81-100). Hillsdale (NJ): Erlbaum.
Levinas, E. (1980). Totalità ed infinito, trad.it. Milano: Jaca Book.
Maslow, A. H. (1971). Verso una psicologia dell’essere. Roma: Astrolabio.
Mucchielli, R. (1996). Apprendere il counseling. Manuale di autoformazio-ne al colloquio di aiuto. Trento: Erickson.
Paci, E. (1963). La psicologia fenomenologica e la fondazione della psicolo-gia come scienza. Aut-aut, 74, 7-9.
Rogers, C. (1975). Empathic: An Unappreciated Way of Being. The counse-ling Psychologist, 2, 2-10.
Rogers, C. (1976). I gruppi d’incontro. Roma: Astrolabio.
Rogers, C. (1978). Potere personale. La forza interiore e il suo effetto rivolu-zionario. Roma: Astrolabio.
lvi
Thorne, B. & Lambers, E. (ed). (1998). Person-centered Therapy. An Euro-pean Perspective. London: Sage Publications.
lvii
L’autore
Giuseppe Minniti
Ricercatore
I.R.C.C.S.G Gaslini Università di Genova
D.I.N.O.G.M.I Lab-Errori Congeniti Metabolismo
Professional Counselor - Orientamento Rogersiano
C.C.P.C. Assocounseling - Milano
e-mail :[email protected]
Tel.010-5636406
Fax:010-3773210
lviii
Copyright
Empatia ed Autismo: autenticità di un incontro
Giuseppe Minniti
© 2012 Falace, Genova. Tutti i diritti riservati.Vietata la riproduzione. Questo libro contiene materiale protetto da Copyright. Non si può modificare, pubblicare, tra-
smettere, partecipare al trasferimento o alla vendita di questi contenuti, né creare opere derivate.
lix
eBook ISBN: 9788898204113
Immagine di copertina © Boyan Dimitrov - Fotolia.com




























































!['JNCLASSIF]ED - DTIC](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323a138be5419ea700eb098/jnclassifed-dtic.jpg)