Gli Stati Uniti e Achille Lauro negli anni Cinquanta. Storia di un incontro impossibile
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Gli Stati Uniti e Achille Lauro negli anni Cinquanta. Storia di un incontro impossibile
����������������� ����� ���������
Le Lettere
ontemporaneatoria
B I M E S T R A L E D I S T U D I S T O R I C I E P O L I T I C I S U L L ’ E T À C O N T E M P O R A N E A
Direttore
Francesco Perfetti
Comitato scientifico
Giuseppe Are †, Università di PisaGiuseppe Bedeschi, Università di Roma La SapienzaAlain Besançon, Institut de FranceMauro Canali, Università di CamerinoPierre Chaunu †, Institut de FranceDino Cofrancesco, Università di GenovaAntonio Costa Pinto, I.S.C.T.I., LisboaOlivier Dard, Université Paul Verlain-MetzDavid D. Dilks, The University of HullSpencer M. Di Scala, University of Massachusetts, BostonAntonio Donno, Università di LecceManuel Espadas Burgos, C.S.I.C., MadridFrançois Fejtö †, Institut des Études Politiques, ParisStephen Fisher-Galati, University of Colorado at BoulderGiuseppe Galasso, Università di Napoli Federico IIMichael A. Ledeen, American Enterprise Institute, WashingtonRudolf Lill, Universität KarlsruheJuan J. Linz, Yale University, New HavenLuigi Lotti, Università di FirenzeRaimondo Luraghi, Università di GenovaEdward N. Luttwak, C.S.I.S., WashingtonNicola Matteucci †, Università di BolognaValeri Mikhailenko, Università degli Urali, EkaterinburgSergio Minerbi, Università di GerusalemmeDidier Musiedlak, Université Paris Ouest Nanterre La DéfensePaolo Nello, Università di PisaErnst Nolte, Freie Universität, BerlinGiuseppe Parlato, Libera Università S. Pio V, RomaFrancesco Perfetti, LUISS Guido Carli, RomaGuido Pescosolido, Università di Roma La SapienzaGiorgio Petracchi, Università di UdineRichard Pipes, Harvard University, Cambridge, Mass.René Rémond †, Institut de FranceSergio Romano, Università Bocconi, MilanoHagen Schulze, Freie Universität, BerlinMaurizio Serra, LUISS Guido Carli, Ministero degli Affari Esteri, RomaJean Tulard, Institut de FranceEugen Weber †, University of California, Los Angeles
CSnnCS��������
Nuova Storia ContemporaneaDirezione: via Monte delle Gioie, 24 - 00199 Roma
Redazione e ammin.: Casa editrice Le Lettere, Piazza dei Nerli 8 - tel. 055.2342710; fax 055.2346010 - 50124 Firenze
LETTERE
ANNO XV - NUMERO 4 LUGLIO-AGOSTO 2011
SAGGI
5
RICERCHE
NOTE E DISCUSSIONI
Francesco PerfettiAlle origini dell’egemoniaIdeologie e culturedell’Italia repubblicana 5
George-Henri SoutouL’Intelligence francesee l’Europa dell’EstI servizi di informazione tra laQuarta e la Quinta Repubblica 15
Massimiliano TenconiIl mondo cattolico e la politicasociale del fascismo 33
Federico RobbeGli Stati Uniti e Achille Lauronegli anni CinquantaStoria di un incontro impossibile 45
Fabio FattoreI corrispondenti di guerra italianie la campagna di Russia 73
Riccardo FacchiniLiberali, socialisti, martiriGli eretici medievali traOttocento e Novecento 95
RECENSIONI
Maurizio SerraLa Francia di Vichye il collaborazionismo 113
Alessandro OrsiniFilippo Turatie la cultura politica dei riformistiUn’analisi comparata (1898-1921) 135
Matematici al Senatoda Silvio Maracchia 163
Gabriel de Broglie, La monarchiede Juillet 1830-1848di Maurizio Serra 165
Rivista bimestrale anno XV - n. 4 - luglio-agosto 2011
Direttore responsabile: Francesco PerfettiSegretaria di Redazione: Serena SettesoldiImpaginazione: Stefano Rolle
Direzione:Via Monte delle Gioie, 24 - 00199 Roma
Redazione e Amministrazione:Casa Editrice Le Lettere srlPiazza dei Nerli, 8 - 50124 Firenzetel. 055.2342710 - fax 055.2346010e-mail: [email protected] - www.lelettere.it
Abbonamenti e arretrati:LICOSALibreria Commissionaria SansoniVia duca di Calabria, 1/1 - 50125 Firenzetel. 055.64831 - fax 055.641257e-mail: [email protected] - www.licosa.comc/c postale 343509
Abbonamento annuale (6 numeri):ITALIA � 63,00ESTERO � 120,00Abbonamento onorario � 108,00Abbonamento sostenitore � 516,00Arretrati � 16,00
Distribuzione nazionale nelle edicole:Messaggerie periodici SpA - Via G. Carcano, 32 - 20141 Milanotel. 02.895921 - fax 02.89504932
Autorizzazione Tribunale di Firenze n° 5081 del 14/07/2001
La pubblicazione dei contributi è subordinata al giudizio favorevole di referees.La responsabilità dei contenuti degli scritti appartiene agli autori.Articoli, fotografie e manoscritti non si restituiscono anche se non pubblicati.La Redazione non assume responsabilità per la loro perdita.L’editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibilecomunicare.
La corrispondenza va inviata a:Casa Editrice Le LetterePiazza dei Nerli, 8 - 50124 FirenzeCopyright © 2011: Casa Editrice Le Lettere srl - Firenze
Finito di stampare nel mese di settembre 2011 presso la Tipografia ABC - Sesto Fiorentino (FI)
In copertina:
45
intreccio tra politica interna e politica internazionale resta “uno deinodi irrisolti della storia italiana del dopoguerra”1. La questione èancora più evidente se si considera il rapporto tra Stati Uniti e destraitaliana2, dove alla carenza di opere di respiro internazionale si è som-mata la reticenza nostrana – vinta non da molto – a studiare le destre3.
Negli anni della Guerra fredda la storiografia italiana si è concentrata sui partitiche facevano riferimento ai due blocchi. La destra è stata sostanzialmente ridottaal neofascismo e ad una serie di battaglie di retroguardia, tanto da essere conside-rata a dir poco marginale. Nel periodo compreso tra gli anni Sessanta e gli anniOttanta il risultato è stato un insieme di lavori poco solidi e non privi di asprezzeideologiche che, se non altro, hanno avuto il merito di richiamare l’attenzionesugli “esclusi”4.
A partire dagli anni Novanta la storiografia ha corretto, in parte, i giudizi assaiimprecisi dei decenni precedenti5. È emersa la componente “impolitica”, ben pre-sente nella società ma critica verso i suoi terminali politico-partitici di riferimen-to, ed è stata messa in luce la complessità della destra politica: non più solo neo-fascista ma anche monarchica6. Tuttavia, a causa della loro parabola discendente e
Gli Stati Uniti e Achille Lauronegli anni Cinquanta
di Federico Robbe
CSnnCS����
Storia di un incontro impossibile
L’
1 L. NUTI, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra. Importanza e limiti della presenza americana in Italia,Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. VIII-X.
2 La letteratura sul tema si limita al volume di Deborah Kisatsky del 2005 in cui – a dispetto dell’am-bizioso titolo – la ricerca si è concentrata sulla destra tedesca, quasi ignorando l’Italia: D. KISATSKY, TheUnited States and the European right, 1945-1955, Ohio State University, 2005. Per qualche cenno sull’Ita-lia, ossia sul Msi, si veda la conclusione, in particolare pp. 110-124. Inoltre l’autrice ignora, ad esempio,i preziosi lavori prodotti dalla storiografia italiana, a partire dagli anni Novanta, sia sul rapporto Usa-Italiain generale che sulla destra.
3 Si vedano in proposito le convincenti osservazioni di G. PARLATO, Fascisti senza Mussolini. Le originidel neofascismo in Italia, 1943-1948, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 29-35.
4 Tra le prime riflessioni ricordiamo A. DEL BOCA-M. GIOVANA, I “figli del sole”. Mezzo secolo di nazi-fascismo nel mondo, Milano, Feltrinelli, 1965; P. ROSENBAUM, Il nuovo fascismo. Da Salò ad Almirante.Storia del Msi, Milano, Feltrinelli, 1975; P.G. MURGIA, Il vento del nord. Storia e cronaca del fascismo dopola Resistenza (1945-1950), Milano, Sugarco, 1975; P.G. MURGIA, Ritorneremo! Storia e cronaca del fasci-smo dopo la Resistenza (1950-1953), Milano, Sugarco, 1976.
5 Si vedano soprattutto N. BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica,Roma, Donzelli, 1994; R. CHIARINI, Destra italiana. Dall’Unità d’Italia a Alleanza Nazionale, Venezia,Marsilio, 1995; S. SETTA, La Destra nell’Italia del dopoguerra, Roma-Bari, Laterza, 1995; M. REVELLI, Ladestra nazionale. Un manuale per capire, un saggio per riflettere, Milano, Il Saggiatore, 1996; P. IGNAZI, Ilpolo escluso. Profilo del Movimento Sociale Italiano, Bologna, il Mulino, 1998 [I ed. 1989]; G. PARLATO,Fascisti senza Mussolini, cit.
6 Si vedano R. CHIARINI, Destra italiana, cit., pp. 64-65, 76-77; C. BALDASSINI, L’ombra di Mussolini.L’Italia moderata e la memoria del fascismo (1945-1960), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
46 n. 4/2011 CSn
dell’anacronistica battaglia istituzionale, l’attenzione alle formazioni fedeli allaCorona è stata piuttosto scarsa7.
Ancor meno approfondito è stato l’inquadramento dei contatti e dei margini dimanovra della destra dal punto di vista internazionale. Mentre non mancano ra-gionati studi sulla politica estera missina, i monarchici, pur essendo stati per gliStati Uniti un interlocutore e, per un breve periodo, perfino un potenziale alleatosono stati quasi ignorati8.
Più vivo, recentemente, è stato il dibattito attorno alla figura di Achille Lauro,sia per l’attualità del “laurismo” che per i legami, veri o presunti, con il qualunqui-smo di Giannini9.
In un tale quadro di studi, piuttosto disorganico e in continua evoluzione, que-sto saggio ha l’obiettivo di ricostruire il rapporto tra i diversi centri decisionaliamericani – in primis ambasciata e Dipartimento di Stato – e Achille Lauro neglianni Cinquanta. L’analisi, naturalmente, non potrà prescindere dai tanti partiti emovimenti di destra (soprattutto monarchica), le cui vicende si sono ripetuta-mente intrecciate con quelle del Comandante.
Certo è che il decennio si era aperto il boom delle destre alle amministrative del’51-’52 e con un brusco calo della Dc. Qualche anno dopo il ministro dell’Inter-no Fernando Tambroni avrebbe sciolto il consiglio comunale di Napoli, trasfor-mato nel frattempo in vero e proprio feudo personale dall’armatore. Tra i dueeventi ci furono gli infiniti litigi con Covelli, il tentativo di costruire una forma-zione di destra nazionale non monarchica, la fondazione del Partito monarchicopopolare e le trattative per unire tutti i partiti d’ordine nella “grande destra”.
In tutti questi processi Lauro cercò – a volte sfacciatamente, altre pragmatica-mente – il beneplacito degli Stati Uniti.
A loro volta, gli americani non potevano che essere incuriositi dal “fenomeno”Lauro, dalla sua macchina elettorale, dai suoi metodi “neoborbonici” eppure cosìefficaci, dalla sua storia di self made man. Ma erano soprattutto curiosi di capirese e come quel rozzo imprenditore potesse essere utile a contenere il comuni-smo. Era questo, in sintesi, il filo conduttore dei dispacci dell’ambasciata e diWashington.
7 Tra i lavori basati su fonti d’archivio segnaliamo D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico in Italia dal1946 al 1954, Napoli, Loffredo editore, 1980; A. Ungari, In nome del Re. I monarchici italiani dal 1943al 1948, Le Lettere, Firenze, 2004. Per un quadro sintetico si vedano G. CHIANESE, I monarchici nellaRepubblica, in M. RIDOLFI (a cura di), Almanacco della Repubblica. Storia d’Italia attraverso le tradizioni,le istituzioni e le simbologie repubblicane, Bruno Milano, Mondadori, 2003, pp. 262-272 e A. UNGARI, Imonarchici, in G. NICOLOSI (a cura di), I partiti politici nell’Italia repubblicana, Soveria Mannelli, Rubbet-tino, 2006, pp. 381-429.
8 P. NEGLIE, Il Movimento Sociale Italiano tra terzaforzismo e atlantismo, «Storia contemporanea», a. XXV,n. 6, dicembre 1994; S. FINOTTI, Difesa occidentale e Patto Atlantico: la scelta internazionale del Msi (1948-1952), «Storia delle relazioni internazionali», a. VI, n. 1, 1988; R. CHIARINI, «Sacro egoismo» e «missionecivilizzatrice». La politica estera del Msi dalla fondazione alla metà degli anni Cinquanta, «Storia contem-poranea», a. XXI, n. 3, giugno 1990. Sui monarchici qualche cenno in R. CHIARINI, Atlantismo, america-nismo, europeismo e destra italiana, in P. CRAVERI-G. QUAGLIARIELLO (a cura di), Atlantismo ed europei-smo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 507-508.
9 Su Lauro e Giannini si segnalano una serie di biografie di taglio giornalistico: P. ZULLINO, Il coman-dante. La vita inimitabile di Achille Lauro, Milano, Sugarco, 1976; A. DELLA RAGIONE, Achille Lauro superstar: la vita, l’impero, la leggenda, Napoli, Guida, 2003; C.M. LOMARTIRE, Il qualunquista. Guglielmo Gian-nini e l’antipolitica, Milano, Mondadori, 2008; C.M. LOMARTIRE, ’O Comandante. Vita di Achille Lauro,Milano, Mondadori, 2009.
47
Agli albori della Repubblica: i monarchici italiani visti dagli Usa
Dopo l’insuccesso del referendum istituzionale i monarchici si posero subito ilproblema dell’impegno politico10. Un impegno che, da un lato, doveva per defi-nizione essere super partes e, dall’altro, si scontrava con un sistema che proprioalle formazioni partitiche – più che allo Stato – dava centralità.
Diverse furono le difficoltà organizzative dei fedeli alla Corona negli anni suc-cessivi al ’46. Il Partito democratico italiano di Enzo Selvaggi si sciolse. L’Unionemonarchica italiana (Umi) era ritenuta dal presidente Tullio Benedetti e dall’exministro della Real Casa Falcone Lucifero lo strumento più indicato per radunaregli italiani di fede monarchica, ma avrebbe dimostrato tutti i suoi limiti program-matici e il suo scarso appeal. A ridimensionare le aspirazioni dell’Umi contribuìpoi la nascita di tre partiti monarchici con orientamenti diversi: il Partito nazio-nale monarchico (Pnm), il Partito nazionale cristiano (Pnc) e il Partito nazionaledel lavoro (Pnl). Se il primo aveva avuto il merito di qualificarsi come monarchi-co – implicitamente superando e delegittimando gli altri due – il Pnc era il piùvicino alla Dc come sensibilità culturale e il Pnl poteva vantare un programmasociale di sicuro impatto nell’Italia del dopoguerra11.
Dei tre, quello che dimostrò maggiore lungimiranza fu il Pnm, il cui segretarioera Alfredo Covelli. Gli obiettivi della nuova formazione erano “trasformare ilsentimento monarchico presente nella Nazione in una forza politica unitaria;allargare il consenso di più vasti strati dell’opinione pubblica collegando il moti-vo istituzionale alla capacità di risolvere i problemi della società italiana; una voltarafforzata la presenza monarchica, chiedere e ottenere un nuovo referendum oqualsiasi altra forma di revisione costituzionale dei risultati del giugno 1946”12.Covelli ebbe il merito di appellarsi esplicitamente agli 11 milioni di elettori mo-narchici tramite una netta presa di posizione sulla questione istituzionale. È utilericordare che la sua posizione non era condivisa da altri, dubbiosi sulla presenzadi un solo partito monarchico orientato a destra13.
Con l’esclusione delle sinistre dal governo nel ’47, si presentò l’occasione per ilcoinvolgimento di Achille Lauro in area monarchica. Il Comandante, da influen-te finanziatore dell’Uomo qualunque (Uq), riuscì infatti a prevenire il voto disfiducia dei qualunquisti al governo De Gasperi. Solo Giannini votò a favore e
10 D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico in Italia dal 1946 al 1954, Napoli, Loffredo editore, 1980,p. 18. Per una difesa di parte monarchica sull’esito del referendum si veda F. MALNATI, La grande frode.Come l’Italia fu fatta Repubblica, Foggia, Bastogi, 1997.
11 Sulla nascita e le distinzioni fra i tre partiti si veda A. UNGARI, I monarchici, cit., pp. 381-394;L.F. BENEDETTINI, Lo schieramento delle forze monarchiche, «La Voce Monarchica», 26 ottobre 1946.Sulla crisi e sulla riorganizzazione dell’Umi soprattutto D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit.,pp. 31-37.
12 D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit., p. 27.13 Si veda in proposito quanto scriveva Guglielmi, che avrebbe preferito un raggruppamento monarchi-
co di centro-sinistra, perché i monarchici di centro-destra avevano trovato i loro riferimenti in Dc, Pli oUq: “Il sistema partitocratrico ha imposto ai monarchici la necessità di difendere il loro ideale impegnan-dosi in prima persona nelle battaglie elettorali. Ecco perché in questa situazione di necessità sarebbe au-spicabile lo sviluppo di tre partiti monarchici: uno di destra, uno di centro e uno di sinistra, conciliandoin tal modo il principio ideale della funzione della monarchia con le necessità contingenti della lottapolitica; invece la realtà è ben diversa, datoché il Partito nazionale cattolico non era neppure nato e ilPartito nazionale del lavoro appare decisamente in difficoltà ad appena un anno dalla sua costituzione”,N. GUGLIELMI, Fusione dei partiti monarchici, «La Voce Monarchica», 3 ottobre 1947, in D. DE NAPOLI,Il movimento monarchico, cit., pp. 30-31.
48 n. 4/2011 CSn
l’esecutivo si salvò14. Era l’ultimo atto del legame di Lauro con l’Uq ed era ancheun’ottima base di partenza per raccogliere i voti dei “senza partito”, cioè l’eletto-rato deluso da Giannini, drenando “lo slittamento a sinistra di vaste fasce delsottoproletariato urbano di Napoli”. Si trattava – ha scritto Zullino – di “un’areadi opinione ancora allo stato gassoso e magmatico, anarcoide e monarcoide, igno-rante e misoneista, superstiziosa e mangiapreti, post-fascista senza mai essere stataneppure fascista”15.
L’adesione dell’armatore al Pnm in occasione delle elezioni politiche del ’48consentì al partito di sopravvivere dopo gli sforzi degli anni precedenti. Tuttavia,il suo ingresso suscitò un’invidia mista a sospetto nel segretario Covelli.
All’origine del dissidio tra i due, che avrebbe segnato il decennio successivo,c’era una differente concezione del partito. Lauro lo concepiva come una sorta diviatico per raggiungere il potere, anche a costo di stemperarne l’identità monar-chica. Covelli, invece, anteponeva a tutto la battaglia per il ritorno della Corona.E non è da trascurare l’apertura dell’armatore nei confronti di De Gasperi, anchealla luce della manovra – decisiva per salvare il governo – di pochi mesi prima. Dalsegretario del Pnm non sarebbero mai giunti segnali di collaborazione, probabil-mente perché Covelli puntava a condizionare la Dc da destra in maniera fin trop-po forte. Nel clima post-elettorale, pur essendo comparse le prime divergenze tragli anticomunisti di diversa estrazione, un atteggiamento del genere era sostan-zialmente utopico.
Certo è che i personalismi avrebbero dominato l’evoluzione della destra mo-narchica in Italia. Tra i primi a intravedere i rischi del “laurismo” ci fu GioacchinoVolpe. Ecco quanto scrisse a Covelli nel luglio 1949:
Chi vuole mettere in dubbio le benemerenze e le capacità del comm. Lauro? Di uominicome lui, gran fortuna per un paese ne avesse cento! Ma veder cumulate nella stessa per-sona le qualità e le attività di un capo di partito, finanziatore del medesimo (e non occul-to finanziatore, ma palesissimo, direi ufficiale finanziatore, con tutti i segni di riconosci-mento di tal qualità) e grande uomo d’affari mi fece una certa impressione. [...] Ma sem-bra che questo cumulo, questa identificazione di capo politico e finanziatore non sia sen-za qualche pericolo per il partito, per la sua dignità, il suo credito, la causa che esso pro-pugna. Tanto più che il comm. Lauro non è uomo che non voglia esercitare tutti i dirittiche gli vengono dall’ufficio16.
In politica estera i monarchici erano sostanzialmente privi di un’ideologia diriferimento. Esaltando il principio di nazionalità senza ricadere nel “concettofascista di nazione”, ambivano ad “intercettare i sentimenti dei monarchici a pre-scindere dalla scelta di schieramento politico”17. Tuttavia, non facevano misterodelle loro simpatie atlantiche. Era una differenza sostanziale rispetto ai missini,per ovvi motivi segnati dal recente conflitto mondiale.
14 Sulla vicenda e sul contributo decisivo di Piccioni e Costa nel coinvolgere l’armatore napoletano sivedano P. ZULLINO, Il comandante, cit., pp. 43-57; A. Lauro, La mia vita. La mia battaglia. Editrice Sud,Napoli, 1958, pp. 62-66.
15 P. ZULLINO, Il comandante, cit., p. 57.16 D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit., pp. 59-60. Utili considerazioni anche in P. ZULLINO,
Il comandante, cit., pp. 59-61.17 G. PARLATO, La cultura internazionale della destra tra isolamento e atlantismo (1946-1954), in G.
PETRACCHI (a cura di), Uomini e nazioni. Cultura e politica estera nell’Italia del Novecento, Udine, Gaspa-ri editore, 2005, p. 137.
49
A conferma dell’interesse crescente verso gli Stati Uniti, basti citare il com-mento di Siciliani, segretario dell’Umi, dopo le elezioni politiche: “dall’internonon riusciremo mai a far nulla: solo il Vaticano e l’America potranno in un certopunto giocare la carta monarchica per l’Italia. È bene parlarsi chiaro”18. Nei mo-narchici, l’ancoraggio a referenti internazionali era un segnale evidente sia dellamancanza di un progetto politico concreto che della necessità – quasi un’osses-sione per Lauro – di ottenere l’appoggio degli Stati Uniti.
I diversi centri decisionali americani, però, erano piuttosto diffidenti nei con-fronti del Partito nazionale monarchico. I più attivi informatori del governo Usaerano l’ambasciata, con a capo James Dunn fino al ’52, e il Dipartimento di Stato.La posizione di Lauro e Covelli nei confronti del Patto Atlantico – a cui l’Italiaaveva aderito nel 1949 – e la possibile formazione della “grande destra” erano itemi dominanti nei resoconti americani.
L’atlantismo del partito monarchico, per quanto generico, era riconosciuto daifunzionari Usa. Qualche sospetto generava, invece, il supporto dei grandi pro-prietari terrieri e dei notabili del Sud, giudicati ostacoli al processo di moderniz-zazione e alla politica della produttività. Qualsiasi mutamento di forza dei gruppimonarchici andava monitorato con attenzione in vista della tornata elettoraleamministrativa e di una eventuale alleanza con la Dc. Una mossa di questo tipoavrebbe contributo a polarizzare il sistema politico e a minare il consenso – già indiminuzione dopo l’exploit del ’48 – del partito di De Gasperi. In più, avrebbeallontanato repubblicani e socialdemocratici, aumentando così le chances di so-cialisti e comunisti di attrarre i voti di protesta19.
Il secondo aspetto ben presente nelle relazioni sulla destra italiana di questi anniera l’ipotesi di creare un’unica forza politica composta da missini, monarchici eliberali. Principale artefice della tentata unificazione delle forze di destra fu ilpartito di Lauro e Covelli. Il presupposto era la presenza diffusa di un’Italia chevoleva superare lo spirito della guerra civile, che intendeva “conciliare le richiestedelle masse operaie e contadine con la salvaguardia dei supremi interessi dellaNazione”20. Era un’Italia che non si riconosceva né nel Pci né nella Dc e che, allaricerca di alternative, avrebbe approvato l’esistenza di una “terza forza” nel pano-rama politico. L’appello dei promotori dell’iniziativa era rivolto a quelli che vota-vano Dc senza grande convinzione, coscienti di accordare il voto al male minore.
Inoltre, proprio a partire dal 1950, in coincidenza della guerra di Corea e dellastabilizzazione del regime di Mao, anche molti rappresentanti del mondo indu-striale cominciarono a temere una crescita esponenziale del comunismo, e a pen-sare ad una destra che potesse fungere da contrappeso o interloquire con la Dc21.
I vertici missini, spinti sostanzialmente dall’opportunismo, decisero di aderi-re alla proposta di “grande destra” lanciata dai monarchici. Il gruppo di RussoPerez, Ezio Maria Gray, gli ex fascisti non ostili alla Corona e i “notabili del
18 Lettera di Benedetto Siciliani a Carlo De Blasio, Roma, 12 febbraio 1949, cit. in Udine,, Il movimentomonarchico, cit., p. 71.
19 Monarchist groups and possibile alliance with Christian Democrats, L. Thompson Jr. to the Depart-ment of State, January 15, 1952, National Archives and Records Administration, College Park, Maryland(d’ora in poi NARA), Record Group (d’ora in poi RG) 84, Box 75, f. 350 – Italy Monarchist party clas-sified and unclassified, 1950-52.
20 D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit., p. 99.21 Si veda A. UNGARI, Il rifiuto della “grande destra”. Malagodi e gli “altri” oppositori del centro sinistra,
«Nuova Storia Contemporanea», a. X, n. 4, luglio-agosto 2006, pp. 50-51.
50 n. 4/2011 CSn
Sud”22 erano propensi al dialogo col Pnm, a differenza della corrente più intran-sigente legata all’esperienza e ai principi della Rsi.
Alcuni quotidiani sostennero con forza l’ipotesi di un gruppo di opposizionenazionale: “Il Giornale d’Italia”, “La Voce Repubblicana” e “Il Tempo”. Proprioil giornale di Angiolillo scriveva della presenza palpabile nel Paese di un “diffusis-simo stato d’animo d’attesa verso qualcosa di nuovo” in cui potevano “confluireed armonizzarsi tutte le istanze d’ordine spirituale, storico, nazionale e sociale”23
di alcuni partiti e movimenti di opinione come il Pli, il Pnm e il Msi. Ad ognimodo, sui tempi e sulle modalità di formazione regnava l’incertezza24.
Tali movimenti vennero seguiti con grande interesse dall’ambasciata americana.Al centro dell’attenzione furono, in particolare, i finanziamenti. Il Minister Coun-selor Homer Byington Jr, così commentava: “i tre partiti di destra sembrano averacquisito nuove risorse, e la domanda fondamentale è se e fino che punto gli in-teressi economici si stanno spostando verso di loro, abbandonando la Dc”25. Ri-maneva aperta la domanda su eventuali – e sostanziali – defezioni di importantigruppi che avrebbero potuto allontanarsi dal partito di De Gasperi26.
Il progetto di “grande destra” sarebbe naufragato nei mesi successivi a causa deicontinui scontri e del veto liberale. Il Pli era favorevole al quadripartito e la stra-tegia del biennio 1950-51 aveva lo scopo di rafforzare il potere contrattuale nel-l’ambito del centrismo degasperiano27. Il mancato sbocco del fronte nazionalevenne accolto positivamente, proprio perché fugava – almeno per il momento –i dubbi che la corrente di destra della Dc e i comitati di civici di Gedda potesseroabbandonare il partito per fondare un nuovo soggetto politico.
Due test elettorali importanti
Le elezioni amministrative del 1951-52 sono state un banco di prova per tuttele forze politiche italiane. In primo luogo perché si trattava del primo test eletto-rale che dovettero affrontare i partiti di centro, e la Dc in particolare, dopo lanetta vittoria del 1948. In secondo luogo perché potevano essere considerate unasorta di “prova generale” prima delle elezioni politiche del 1953, altro banco diprova decisivo. Il voto locale, in qualche misura, sarebbe stato uno specchio dellasituazione nazionale, esprimendone gli umori, le insofferenze e i nervi scoperti.
Nella primavera del 1951 era chiamata al voto solo l’Italia centro-settentriona-le, dove le destre avevano una scarsa consistenza28. Il sistema elettorale prevede-
22 Si veda P. ROSENBAUM, Il nuovo fascismo, cit., p. 197.23 «Il Tempo», 18 marzo 1950, cit. in D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit., p. 100.24 G. PARDINI, Fascisti in democrazia. Uomini, idee, giornali (1946-1958), Firenze, Le Lettere, 2008, pp.
53-55. L’autore scrive di “contorni programmatici ancora confusi”, p. 54.25 Discussions of possibility of alignment of Liberal, Msi and National Monarchist parties, H.M. Byington
(Minister Counselor, Embassy) to the Department of State, March 7, 1950, NARA, RG 59, C-3, Box 1,765.00/3-750.
26 Discussions of possibility, cit., p. 3.27 G. ORSINA, Il partito liberale nell’Italia repubblicana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 20.28 Sui motivi dello scaglionamento in due tornate non c’è accordo tra gli storici. Da parte monarchica,
si è sottolineato il tentativo di influenzare l’esito delle successive elezioni nelle “roccaforti monarchichedel Meridione”, si veda D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit., p. 110. Secondo altri, tuttavia, nonsi possono trascurare “i tempi di approvazione della revisione delle circoscrizioni elettorali”, al di là dellemotivazioni politiche dei partiti di governo contrarie ad un voto contestuale di Nord e Sud, si veda G. BAGETBOZZO, Il partito cristiano al potere. La Dc di De Gasperi e di Dossetti, Firenze, Vallecchi, 1974, p. 24.
51
va, per i comuni con più di 10.000 abitanti, la possibilità di presentare liste “ap-parentate”. Concorrevano, in altri termini, non singoli partiti ma liste. E la coa-lizione di maggioranza relativa si sarebbe aggiudicata i due terzi dei seggi29.
Nei primi due mesi del 1952 non erano ancora ben definite le alleanze. In par-ticolare, non era chiaro se i monarchici si sarebbero presentati con l’altra forza didestra, il Msi, oppure – ipotesi meno probabile – con la Democrazia cristiana.Secondo gli osservatori americani la situazione era di difficile interpretazione,tanto da essere definita “fluida, confusa e non molto promettente”30.
A partire da gennaio la Dc, tramite Gonella, aveva cominciato a trattare colpartito monarchico31, registrando subito la netta ostilità del Psdi32 all’idea. Tutta-via, elementi in vista del partito democristiano, come il vice-segretario Ravaioli,lasciavano aperta la porta ai monarchici, soprattutto in virtù del radicamento delpartito al Sud e della possibilità di sottrarre voti al blocco social-comunista33.
Il partito di De Gasperi, insomma, era ingabbiato in una situazione non facile:non era stato abbastanza “di sinistra” per attrarre il voto delle classi popolari econtemporaneamente si era inimicato gli elementi conservatori, all’interno e al-l’esterno del partito, grazie a “certe politiche sociali e al tough talking contro ladestra da parte del governo”34.
Alle prospettive di centro-destra i funzionari di via Veneto non diedero maimolto credito, considerandole puramente strumentali. Thompson scriveva, in-fatti, che le relazioni Dc-Pnm venivano presentate ai partiti laici per mantenerecompatta la coalizione, e non per segnalare un effettivo spostamento del baricen-tro. Nonostante influenti personalità, si pensi a Gedda e ai gesuiti, non fosserocontrari all’alleanza, sembrava che “solo in una situazione senza speranza DeGasperi avrebbe accettato questo accordo”35.
Intanto, crescevano le richieste avanzate dai monarchici in cambio di un loroeventuale appoggio. In un’intervista Lauro chiese l’inclusione del Msi nelle listepresentate in alcune località. Covelli sottolineava gli obiettivi politici del Pnm enon nascondeva di puntare ad incarichi di governo e ad una futura alleanza invista delle elezioni del 1953. Da parte monarchica, quindi, esisteva una disponi-
29 M.S. PIRETTI, La legge truffa. Il fallimento dell’ingegneria politica, Bologna, il Mulino, 2003, p. 24.30 Preparations for Provincial, Municipal Elections, L.E. Thompson Jr. to the Department of State, Fe-
bruary 19, 1952, NARA, RG 59, C-3, Box 2, 765.00/2-1952.31 S. SETTA, La Destra nell’Italia del dopoguerra, cit., p. 25; F. MALGERI, La stagione del centrismo. Poli-
tica e società nell’Italia del secondo dopoguerra, 1945-1960, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, p. 124.32 The May 25 elections – Negotiations and alliances of democratic parties, L.E. Thompson Jr. (Minister
Counselor, Embassy) to the Department of State, May 6, 1952, NARA, RG 59, C-3, Box 3, 765.00/5-652.33 Dal memorandum del 1° aprile 1952, in cui dopo aver affermato la possibilità di alleanza Dc-Pnm,
Ravaioli disse che i partiti minori non potevano obiettare perché non avevano «nulla da offrire al Sud» edespresse preoccupazione sul fermento dei Comitati Civici. Si veda Conversation on April 1st with Avv.Domenico Ravaioli, vice-secretary, Christian Democratic Party, Davis to O. Horsey, April 1, 1952, NARA,RG 59, Records of the Office of Western European Affairs, Office of the Italian and Austrian Affairs,1949-1953, Lot File 54D541, Box 8, f. Italy – 220.01 Christian Democrats. Ravaioli fu uno dei primi apensare alla possibilità di istituire un sistema maggioritario per arginare le ali estreme, G. QUAGLIARIEL-LO, La legge elettorale del 1953, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 34-35.
34 Monarchist groups and their possible alliance with Christian Democrats, L.E. Thompson Jr., (MinisterCounselor, Embassy) to the Department of State, January 15, 1952, NARA, RG 84, Box 75, f. 350 Italy– Monarchist party, classified and unclassified, 1950-52.
35 Preparations for Provincial, Municipal Elections, L.E. Thompson Jr. (Minister Counselor, Embassy)to the Department of State, February 19, 1952, NARA, RG 59, C-3, Box 2, 765.00/2-1952. Da segnalareil tentativo, poi fallito, di coinvolgere Longanesi per sponsorizzare la destra laurina al Nord, in particolarea Milano, si veda R. LIUCCI, L’Italia borghese di Longanesi. Giornalismo politica e costume nell’Italia deglianni ’50, Venezia, Marsilio, 2002, pp. 112-113.
52 n. 4/2011 CSn
bilità a collaborare. Ma dopo mesi in cui dominò il “reciproco scambio di inviti edi pressioni, di minacce e di lusinghe”, Achille Lauro ruppe ogni possibilità ditrattativa con un articolo dal titolo piuttosto esaustivo: L’intesa Pnm-Msi non sipuò infrangere36. Comunque, si registrarono sporadici casi di alleanze tra Dc, Pnme Msi al centro-Sud e in Sardegna37.
La situazione italiana non faceva ben sperare gli americani, tanto che un arretra-mento del quadripartito era ampiamente previsto. Oltre a notare il fatto che laDc, “partito di centro poco dinamico”, avesse senza dubbio perso popolarità,all’ambasciata evidenziavano i tanti limiti dal punto di vista dell’informazione edella propaganda. Si pensi alla scarsa attività dei partiti di governo per intercettareil voto di protesta, che con ogni probabilità sarebbe andato a vantaggio dei social-comunisti e del blocco di destra, così come, in generale, avrebbe prevalso la de-lusione per una campagna elettorale poco vigorosa38.
Analizzando l’esito delle elezioni, si può dire che i timori statunitensi fosseroin buona parte fondati. Il vero e proprio tracollo che subì il partito di De Gasperiandò soprattutto a vantaggio della destra monarchica e missina nel Meridione. Ilblocco delle forze nazionali riuscì ad ottenere la maggioranza a Napoli (dove fueletto sindaco Achille Lauro con 117.000 preferenze), Avellino, Bari, Benevento(con un sindaco missino), Salerno e Foggia (governata in precedenza da un’am-ministrazione di sinistra).
Gli avversari di Lauro ricondussero l’elevato numero di preferenze dell’armato-re ai suoi metodi poco ortodossi. Ma non sono da sottovalutare il suo fiuto po-litico e la sua abilità di accreditarsi come uomo nuovo: “l’uomo d’affari che si èaffermato nella vita grazie alle sue capacità imprenditoriali, [...] disposto a met-tersi al servizio della città”39.
L’affermazione clamorosa di Achille Lauro sorprese sia l’ambasciata romana chei vari centri decisionali di Washington. Una delle prime mosse del nuovo sindacofu addirittura quella di inviare un telegramma a Truman, inaugurando così unaserie di tentativi volti ad ottenere il plauso degli Stati Uniti. Scriveva Lauro: “Noimonarchici abbiamo sempre sentito la necessità di una profonda amicizia fra l’Ita-lia e l’America sul terreno delle esigenze dei due popoli e della stessa collabora-zione per salvare la civiltà occidentale dai pericoli che la minacciano. [...] Vogliodire al Popolo Americano che l’Italia dei monarchici ha per Esso la più viva sim-patia e segue col maggior interesse gli sforzi che Esso e il Suo presidente fannoper assicurare la pace nel mondo”40.
Da parte dell’amministrazione Usa non ci fu alcuna risposta alle richieste di
36 A. UNGARI, I monarchici, cit., pp. 422-424. L’articolo di Lauro, in gran parte riportato dall’autore, fupubblicato su «Il Giornale d’Italia», 6 aprile 1952.
37 De Gasperi, con lo pseudonimo “Quidam de populo” aveva scritto un articolo su «Il Popolo» del 7aprile 1952 rifiutando ogni legame con la destra, tuttavia in alcune città di Lazio, Campania, Puglia, Ca-labria, Basilicata e Sardegna ci furono alleanze, si veda M.S. PIRETTI, La legge truffa, cit., p. 27.
38 Per un esempio evidente del rammarico americano poco prima delle elezioni e per un elenco di pub-blicazioni e film propagandistici, tra cui Come i comunisti ingannano i contadini (148.700 copie), Comesi vive in Russia (500.000 copie) e La valle del terrore (648.000 copie) si veda Usis/Msa Activities in con-nection with italian local elections, Foreign Service Despatch 2765, Embassy to the Department of State,May 23, 1952, NARA, RG 84, Box 74, f. 350 – Italy elections (confidential) 1950-52, da cui è tratta lacitazione “the Christian Democratic Party, being a center party, is somewhat lacking in dynamism”.
39 D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit., p. 155; P. ALLUM, Potere e società a Napoli nel dopo-guerra, Torino, Einaudi, 1975, p. 354.
40 Per il testo integrale del messaggio si vedano «Roma», 28 maggio 1952 e «Il Messaggero», 29 maggio1952.
53
contatto. Era soprattutto l’ambasciata ad essere scettica sulle possibilità che po-tevano aprirsi nel rapporto con il Comandante. Lo stesso ambasciatore sconsi-gliava al Dipartimento di Stato qualsiasi accenno che incoraggiasse la distinzionetra Pnm e Msi. Intanto perché una presa di posizione sui monarchici avrebbecomplicato sia i rapporti col Pri che i dilemmi di De Gasperi sull’apertura a de-stra. Qualsiasi affermazione da parte degli Usa sarebbe stata distorta “dai partitie dalle fazioni interne ai partiti per i loro scopi”. Poi – secondo elemento – i com-menti potevano essere interpretati come “reazione alle elezioni” piuttosto che“chiarificazioni di principi”. C’era, in questo senso, il timore di critiche per gliinteressi americani nella zona, ovvero la base Nato di Napoli.
Pur tenendo conto che, in generale, l’apertura a destra fosse assai rischiosa,Bunker notava che i partiti minori di centro diventavano “sempre più piccoli”41,quindi una loro esclusione dalla compagine governativa avrebbe potuto non esse-re decisiva. Si sottolineavano poi le continue frizioni all’interno del blocco Pnm-Msi e il ruolo potenzialmente decisivo del Re Umberto II nel rompere l’alleanzae facilitare l’accordo tra democristiani e monarchici. Anche dai servizi segretiamericani venivano riportati segnali in questa direzione.42
D’altra parte, non erano pochi i fattori che sconsigliavano una strada del gene-re. Al Nord il peso di Psdi e Pri era decisamente maggiore che al Sud, dove si eraappena votato. Un governo di centro-destra o di destra, inoltre, avrebbe proba-bilmente intrapreso azioni contro i comunisti ma non avrebbe risolto i problemistrutturali, data la sua scarsa propensione alla politica della produttività, assai caraagli americani. Infine, l’Italia sarebbe diventata sempre più nazionalistica sull’on-da dell’irrisolta questione di Trieste43. Insomma, dopo aver chiuso i conti delleamministrative, si apriva senza soluzione di continuità la campagna per le elezio-ni – assai più sentite – del 1953.
A rendere la scadenza particolarmente importante furono il progressivo decli-no dei partiti di centro, la situazione internazionale assai diversa da quella di cin-que anni prima, l’incognita della destra, la generale indifferenza degli italiani esoprattutto la nuova legge elettorale maggioritaria, etichettata dalle opposizioni“legge truffa”44.
41 Telegram 5201, E. Bunker (Ambassador in Italy) to the Secretary of State, May 28, 1952, NARA, RG84, Box 74, f. 350 – Italy elections (confidential) 1950-52.
42 Current Intelligence Digest, Office of current Intelligence, CIA, June 17, 1952, CIA-RDP79T01146A001000250001-4, NARA, Cia Records Search Tool (d’ora in poi CREST).
43 Current Policies of the Government of the United States of America Relating to the NationalSecurity, Volume I, Geographical Area Policies, Part VI, Europe – Italy, NSC, November 1, 1952, De-classified Documents Reference System (d’ora in poi DDRS), http://galenet.galegroup.com/servlet/DDRS;jsessionid=9346770EA6A8459FE7D45D6BB6E44ECC?vrsn=1.0&slb=FT&locID=milano&srchtp=basic&c=8&ste=4&txb=italian+social+movement&sortType=RevChron.
44 Sulla legge del 1953 i due studi principali, di orientamento assai diverso, sono M.S. PIRETTI, La leggetruffa, cit. e G. QUAGLIARIELLO, La legge elettorale del 1953, cit. Si vedano anche F. ORLANDO, Ma non fuuna legge truffa, Roma, Cinque Lune, 1989; C. RODOTÀ, Storia della legge truffa, Roma, Edizioni Associa-te, 1992; P. CRAVERI, De Gasperi e la legge elettorale del 1953, «Quaderni fiorentini», n. 19, 1990; M. DELPERO, Stati Uniti e “legge truffa”, «Contemporanea», a. VI, n. 3, luglio 2003. Sulla precisa “paternità”dell’espressione non c’è accordo tra gli storici: si cita generalmente l’opposizione di sinistra. Nenni, neisuoi diari, fa risalire a Stalin lo slogan politico. Dopo aver esposto al leader sovietico la “manipolazionedel sistema elettorale”, Stalin, “ridendo sotto i baffi” commentava: “una makinatzia [truffa]”. Si vedano P.NENNI, Tempo di guerra fredda. Diari 1943-1956, Milano, Sugarco, 1981, p. 537; V. ZASLAVSKY, Lo stalini-smo e la sinistra italiana. Dal mito dell’Urss alla fine del comunismo 1945-1991, Milano, Mondadori, 2004,p. 178. Manca, a nostro avviso, uno studio ragionato su come si è tramandato e, in una certa misura,cristallizzato negli anni il concetto di “legge truffa” associato alla riforma elettorale maggioritaria del 1953.
54 n. 4/2011 CSn
Un personaggio-chiave per comprendere l’Italia del tempo è l’ambasciatriceamericana Clare Boothe Luce, giunta a Roma nel marzo ’53. Figura complessa etroppo spesso liquidata con leggerezza dalla storiografia americana e italiana45,Mrs. Luce – classe 1903 – è stata parlamentare, affermata giornalista e commedio-grafa. Dopo aver lavorato in Europa come reporter al fronte, fu eletta la primavolta al Congresso nel 1942. In seguito alla tragica morte della figlia diciannoven-ne Ann, avuta dal precedente matrimonio con l’imprenditore George Brokaw,attraversò un periodo di crisi esistenziale e religiosa, che sfociò nella conversionealla religione cattolica nel 1946. Tale momento fu contraddistinto dall’amiciziacol vescovo Fulton J. Sheen.
Intanto, nel 1935, aveva sposato uno degli uomini più potenti e influenti d’Ame-rica: il magnate dell’editoria Henry Luce46. In occasione delle elezioni presiden-ziali del 1952 il contributo di Luce e di giornali come “Time” e “Life” giocaronoun ruolo determinante nella vittoria di Eisenhower. Durante la campagna eletto-rale, peraltro, si era distinta anche la moglie Clare con numerosi discorsi e inter-venti a favore Ike su tematiche internazionali e sui pericoli del comunismo47.
È prassi consolidata, nel sistema politico americano, la nomina di nuovi amba-sciatori dopo le elezioni presidenziali48. Per la prestigiosa sede romana di via Ve-neto la scelta cadde su Clare Boothe Luce. La nomina suscitò immediatamenteun aspro dibattito tanto negli Usa quanto in Italia, polarizzando favorevoli econtrari. Donna, cattolica, moglie di un importante editore e anticomunista con-vinta. Erano essenzialmente questi i motivi che suscitarono perplessità tra i fun-zionari del Dipartimento di Stato, nei circoli protestanti e in Italia.
La nuova responsabile dell’ambasciata si distinse subito per un acceso antico-munismo. Ciò divenne chiaro grazie alla questione di Trieste e alla pertinacia concui poneva i problemi italiani all’attenzione di Eisenhower e del suo assistentespeciale per la guerra psicologica C.D. Jackson. Già nel gennaio 1953, la Luceaveva definito la questione giuliana “cruciale” in un colloquio con il Segretario diStato, John Foster Dulles. Pensava, comunque, che il ritorno della città avrebbesfortunatamente risolto “solo alcuni dei veri problemi dell’Italia”49.
Non di rado, l’attività di Clare Boothe Luce a Roma è stata ridotta alla crociatacontro il comunismo e all’interventismo negli affari di un altro Paese50. In questosenso, il discorso della Luce a ridosso del voto, nel quale parlò di “gravi conse-guenze” in caso di vittoria degli estremismi, certo non giovò alla sua popolarità51.
45 I primi seri studi sulla permanenza all’ambasciata di Mrs. Luce sono A. BROGI, L’Italia e l’egemoniaamericana nel Mediterraneo, Firenze, La Nuova Italia, 1996, pp. 67-104, 149-169; L. NUTI, Gli Stati Unitie l’apertura a sinistra. Importanza e limiti della presenza americana in Italia, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp.5-105; M. DEL PERO, L’alleato scomodo. Gli Usa e la Dc negli anni del centrismo(1948-1955), Roma,Carocci, 2001, pp. 178-274.
46 Sulla figura di Henry Luce si veda A. BRINKLEY, The Publisher. Henry Luce and his american century,Knopf, 2010.
47 Si vedano, a titolo di esempio, alcune lettere precedenti al voto: D.D. Eisenhower to C.B. Luce, July26, 1952; September 3, 1952; October 3, 1952, Library of Congress, Manuscript Division, WashingtonD.C., Clare Boothe Luce Papers, (d’ora in poi LOC, CBLP) Box 193, f. 12 Ea-Ei 1952.
48 E. ORTONA, Anni d’America. La diplomazia 1953-1961, Bologna, il Mulino, 1986, p. 220.49 Wednesday, January 28, 1953, LOC, CBLP, Box 56, f. 10, Diaries, 1953.50 Si vedano, per esempio, E. SANTARELLI, Storia critica della repubblica. L’Italia dal 1945 al 1994, Mila-
no, Feltrinelli, 1996, p. 103; P. GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 2006, pp.190 e 258.
51 M. DEL PERO, Gli Stati Uniti e la «guerra psicologica» in Italia (1948-56), «Studi Storici», a. XXXIX,n. 4, ottobre-dicembre 1998, p. 977. Per il testo integrale del discorso in lingua originale si veda LOC,
55
Al di là dell’episodio, la posizione degli Stati Uniti di fronte alla scadenza elet-torale del 7 giugno 1953 era piuttosto diversificata. I funzionari del Dipartimentodi Stato e dell’ambasciata confidavano in un positivo esito delle elezioni. Piùpessimisti, invece, erano i rapporti provenienti dalla Cia e dai consolati, che sidistinsero per una posizione critica nei confronti delle forze di governo.
A pochi giorni dal voto, Byington, dell’Office of Western European Affairs,scriveva che la destra rimaneva il “grande punto di domanda”. In caso di nonraggiungimento del premio di maggioranza, la prima ipotesi era l’allargamento aimonarchici, la seconda un’apertura a sinistra includendo il Psi (soluzione definita“altamente improbabile”) e la terza una nuova chiamata alle urne52.
Simili erano le impressioni dell’ambasciata. In un memorandum di conversazio-ne tra Bunker e Gedda l’ambasciatore prospettava una vittoria della Dc e dei suoialleati, seppure non di larga misura53. Le alternative in caso di sconfitta, sempresecondo i funzionari di via Veneto, erano piuttosto confuse. Da destra le pressio-ni sarebbero state “potenti” ed era ancora da capire se l’apertura ai monarchici“avrebbe fermato la disintegrazione della vita politica italiana o condotto ad estre-mismi di destra o sinistra”54.
A differenza di quelli provenienti da altri centri decisionali, i rapporti dellaCentral Intelligence Agency furono particolarmente foschi. Gli analisti dell’In-telligence Advisory Committee ritenevano che un allargamento ai monarchici fos-se in qualche modo impossibile da rimandare, viste la pericolosità della sinistra el’endemica instabilità in caso di non raggiungimento del premio55.
Anche dai consolati non arrivarono previsioni ottimiste. Il raggiungimentodella maggioranza era “molto in dubbio, se non improbabile”, e la sottile vittoriadella coalizione alle elezioni amministrative, con ogni probabilità, sarebbe statadistrutta56.
Insomma, nelle analisi era chiara la preoccupazione per la destra. Non eranotanto i missini a suscitare apprensione quanto il Pnm, che aveva un alto potenzia-le di crescita grazie alla distanza dai neofascisti. D’altra parte, il ruolo e i progettidi Lauro erano un’arma a doppio taglio. Se la presenza del Comandante avevaavuto il merito di conquistare il sottoproletariato e i delusi dalle politiche gover-native, il partito faticava a trasformarsi da partito regionale, limitato al Sud, a forzanazionale, capace di operare come “terza forza”. Gli industriali settentrionali,
CBLP, Box 686, f. 4, May 28, 1953. Sulle varie reazioni della stampa italiana si vedano Wide press commentson Ambassador Luce’s speech, Italian press highlights n. 229, prepared by Mutual Security Agency andUnited States Information Service, May 30-31, June 1, 1953, Dwight D. Eisenhower Library, Abilene,Kansas (d’ora in poi DDEL), John Foster Dulles Papers (d’ora in poi JFD Papers), 1951-59, Generalcorrespondence and memoranda series, Box 2, f. Strictly confidential – L (4).
52 Italian election round-up, H. Byington (Office of Western European Affairs) to L. Merchant (Assi-stant Secretary of State for European Affairs), June 5, 1953, NARA, RG 59, Subject files relating to Ita-lian Affairs, 1944-1956, Lot File 58D357, Box 13, f. 233 Elections (national) 1953.
53 Si veda Church support for the center coalition, F.T. Williamson (Counselor for Political Affairs, Em-bassy) to the Department of State, May 12, 1953, NARA, RG 59, C-3, Box 4, 765.00/5-1253. Sul soste-gno della Chiesa cattolica alla coalizione centrista si veda anche The election issues, F.T. Williamson (Coun-selor for Political Affairs, Embassy) to the Department of State, May 21, 1953, 765.00/5-2153, NARA,RG 59, Subject files relating to Italian Affairs, 1944-1956, Lot File 58D357, Box 13, f. 233 Elections(national) 1953.
54 Possibilities if center is defeated, F.T. Williamson (Counselor for Political Affairs, Embassy) to theDepartment of State, June 3, 1953, NARA, RG 59, C-3, Box 4, 765.00/6-353.
55 Probable developments in Italy, National Intelligence Estimate, CIA, March 31, 1953, www.foia.cia.gov.56 Consulates estimates on the election outcome, F.T. Williamson (Counselor for Political Affairs, Embas-
sy) to the Department of State, May 27, 1953, NARA, RG 59, C-3, Box 4, 765.00/5-2753.
56 n. 4/2011 CSn
infatti, avevano risposto in modo tutt’altro che entusiasta alle proposte di Lau-ro57. Il rilancio della politica nazionalista venne associato all’esperienza fascista,depotenziando l’iniziativa. Fra i monarchici del Nord aveva suscitato una certarepulsione la presenza di personaggi come Dino Alfieri e Vito Mussolini. In più,la vicinanza di Confindustria ai liberali e alla Dc, oltre ai dissidi col presidente (earmatore) Costa58, affossarono il progetto di Lauro.
L’esito elettorale sorprese e indispettì gli Stati Uniti. Il consenso alla Dc scesedi poco meno di 10 punti percentuali, e anche i suoi alleati persero voti a vantag-gio di destra e sinistra. Circa il 13% dei voti andò a missini e monarchici59, mentresocialisti e comunisti raggiunsero il 35%. Va considerato che non sono pochi idubbi sul computo dei voti60.
Principale conseguenza delle elezioni del 1953 fu che il centrismo divenne for-mula di sopravvivenza e favorì la prassi del “governo ai margini”61. In tale conte-sto, l’ipotesi di una legittimazione della destra non era ben vista dagli osservatoriamericani e obbligava a tener conto delle possibili conseguenze negative per lastabilità dell’Italia. Assai diffuso era il timore che un governo composto da Dc emonarchici provocasse agitazioni, anche perché – si legge in un rapporto dellaCia – apriva “quasi inevitabilmente” la strada all’ingresso dei neofascisti62.
La formazione del governo fu piuttosto travagliata. Con la mancata fiducia delladestra a De Gasperi, che ne aveva esplicitamente sollecitato l’appoggio in parla-mento, la possibilità di uscire dal ghetto veniva ancora una volta rimandata. Allachiusura prevedibile dei missini si era accompagnato il rifiuto di Covelli e quello– più sofferto – di Lauro63.
Complicò la situazione la nomina del democristiano Giuseppe Pella a capo delGoverno. Appartenente alla stessa scuola economica liberista di Einaudi, Pella si
57 Si veda S. COLARIZI, Storia del novecento italiano, Milano, Rizzoli, 2000, p. 348.58 D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit., p. 125. Si veda l’articolo di Leo Wollemborg sul
«Washington Post», 9 maggio 1953, riportato interamente in P. ZULLINO, Il comandante, cit., pp. 65-69.59 Camera dei Deputati: 6,8% Pnm e 5,8% Msi; Senato: 6,5% Pnm e 6% Msi.60 Tra i voti non validi, l’alto numero di schede nulle rispetto alle bianche si verificò in maniera impo-
nente (66,9%) alla Camera – dove era in gioco il premio di maggioranza – e assai meno (46,9%) al Senato,si veda G. QUAGLIARIELLO, La legge elettorale del 1953, cit., p. 130. Da segnalare poi quanto affermò Vin-cenzo Longi, funzionario della Camera in quegli anni. Intervistato sul tema diversi anni dopo, Longi disseche “delle circa 800.000 schede contestate, moltissime erano più che valide e che quindi il quorum del 50per cento più uno si sarebbe abbondantemente superato”, G. LOQUENZI, Longi, molte schede erano vali-dissime, «Ideazione», a. II, n. 5, settembre-ottobre 1995, pp. 186-189. Di diverso avviso è Maria SerenaPiretti, che ricorda – tra le altre cose – il basso numero di schede nulle in regioni “rosse”, M.S. Piretti, Lalegge truffa, cit., pp. 177-184.
61 G. DI PALMA, Risposte parlamentari alla crisi di regime: un problema di istituzionalizzazione, in L.GRAZIANO-S. TARROW (a cura di), La crisi italiana, Torino, Einaudi, 1979, vol. II, pp. 367-422. Si veda lalucida analisi di P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico (1945-1996),Bologna, il Mulino, 1997, pp. 271-272.
62 Current Intelligence Weekly, Office of Current Intelligence, CIA, July 3, 1953, CIA-RDP79-00927A000100050001-7, NARA, CREST.
63 Sulla posizione missina in quell’occasione si veda G. ROBERTI, L’opposizione di destra in Italia (1946-1976), Napoli, Gallina Ed., 1988, pp. 63-69. Per i monarchici D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico inItalia, cit., pp. 184-185; A. LAURO, La mia vita. La mia battaglia, cit., pp. 70-72. Andreotti ha ricordatoche il 6 luglio, in seguito all’esortazione di De Gasperi rivolta ai monarchici “Non vi domandiamo diseppellire le vostre riserve ma di spostarle nel tempo”, Covelli avrebbe detto di voler votare contro (nean-che “benevola attesa”) di fronte al quadripartito, mentre Lauro avrebbe affermato “Poi vedremo. Lascia-mo che le cose si sviluppino”. Ma il 23 luglio l’armatore – negando la fiducia al governo – diceva ai suoi“Ma dove sta tutta questa grandezza di De Gasperi? Ha settant’anni e non ha una lira”, per poi tornarepiù possibilista il 2 agosto, G. ANDREOTTI, 1953. Fu legge truffa?, Milano, Rizzoli, 2006 cit., pp. 126-127,166 e 182.
57
era fatto apprezzare come ministro del Bilancio. Grazie allo spiccato e decisonazionalismo in politica estera, godeva del consenso di larga parte dell’opinionepubblica. Il suo era un governo amato dalla società più che dalla politica. E iltentativo di presentarsi come “uomo forte” “sembrava dovesse caratterizzare l’in-tera seconda legislatura”64. Addirittura, il leader della Coldiretti Bonomi a collo-quio con un funzionario americano nel ’54, disse che “a un certo punto Pella erapiù popolare di Mussolini” ma non aveva alcun sostegno all’interno del partito65.
Pur approvando genericamente le maniere forti dell’esecutivo, la destra monar-chica presentava due giudizi difformi, espressi dai due principali interpreti delpartito di Stella e Corona: Alfredo Covelli e Achille Lauro. Per il segretario delPnm, il governo in carica rappresentava una grande novità e una possibile evolu-zione dal centrismo al centro-destra, isolando ancora di più le sinistre. Secondol’armatore napoletano, invece, Pella era un esponente “atipico della Dc, fuori dallecorrenti, destinato perciò ad essere fagocitato dal partito”66. Quindi bisognavaancora puntare su De Gasperi. I semi della scissione erano, in qualche misura, giàpresenti dopo le elezioni del ’53.
Uno dei principali problemi che dovette affrontare il partito monarchico era dinatura finanziaria, visto che dipendeva interamente dall’imprenditore sicilianoAletti e da Lauro. D’altronde, l’endemica mancanza di fondi e la grande popolari-tà di Lauro imponevano di evitare dolorosi divorzi. Questo era vero – in particolareper Covelli – durante il governo Pella, che godeva del consenso monarchico67.
All’inizio del 1954 Pella tentò un rimpasto governativo, sostituendo il ministrodell’Agricoltura Salomone, troppo propenso a politiche riformatrici, con Aldi-sio, più gradito al Pnm. Il progetto, però, fu bloccato dagli stessi democristiani einnescò una crisi di governo che portò alla caduta del governo68. L’episodio chiarìulteriormente la natura “personalistica” del monocolore retto dal politico bielle-se, che mal sopportava i “vincoli soffocanti” della Dc69. Si chiudeva così una pa-rentesi nazionalistica che aveva avuto il pregio di porre Trieste all’attenzione deglianglo-americani, ma che non ebbe mai il deciso sostegno del partito.
Incomprensioni reciproche
I primi mesi del ’54 furono segnati dalle difficoltà di avviare un esecutivo stabi-le. Dopo il “fuoco amico” della Dc e il fallimentare tentativo di Fanfani, le previ-
64 R. LIUCCI, L’Italia borghese di Longanesi, cit., p. 117. Gabriella Fanello Marcucci ha scritto, in manie-ra forse azzardata, che Pella godeva di un consenso che “De Gasperi, pur nella sua autorevolezza, non erariuscito a raccogliere”, G. FANELLO MARCUCCI, Giuseppe Pella. Un liberista cristiano, Soveria Mannelli,Rubbettino, 2007, p. 171.
65 Paolo Bonomi’s political views, Paolo Bonomi (President of the Coltivatori diretti), V. Sullam (Mr.Bonomi’s representative in Washington), T. Fina (Division of Research for Western Europe, Departmentof State), September 3, 1954, NARA, RG 59, Subject files relating Italian Affairs, 1944-56, Lot File58D357, Box 16, f. 221 Civic Committees 1954.
66 D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit., p. 195.67 National Monarchist Party (PNM): Lauro-Covelli controversy and future prospects, F.T. Williamson
(Counselor of Embassy) to the Department of State, October 9, 1953, NARA, RG 59, C-3, Box 4, 765.00/10-953.
68 Si veda S. SETTA, La Destra nell’Italia del dopoguerra, cit., p. 31; G. ANDREOTTI, De Gasperi e il suo tempo,Milano, Mondadori, 1956, p. 390; G. FANELLO MARCUCCI, Giuseppe Pella, cit., p. 216. L’autrice riporta cheil nome di Aldisio “leader e fondatore della Dc siciliana” sarebbe stato consigliato da don Luigi Sturzo.
69 G. FANELLO MARCUCCI, Giuseppe Pella, cit., p. 217.
58 n. 4/2011 CSn
sioni americane si fecero sempre più cupe70. Con l’indebolimento della Dc au-mentarono i dubbi dell’ambasciata sulla capacità di far fronte al comunismo. Inquesto senso, un tassello importante per ricostruire le convulse settimane cheportarono all’esecutivo Scelba, è dato dai memoranda tra Clare Boothe Luce eAchille Lauro.
La proposta del Comandante – che mise in luce le lotte interne al Pnm e i diver-si progetti dei due leader – provocò anche l’interesse di De Gasperi. In un primomomento l’armatore testò la possibilità di allearsi con la Dc. Tuttavia, rilevò su-bito la sostanziale avversione dell’elettorato settentrionale, a cui bisognava dimo-strare “l’ineluttabilità della mossa e presentarla [...] come una tesi da doversicoltivare con letizia”71. Inoltre, la forte presenza della sinistra democristiana, piùradicata al Nord che al Sud, rendeva improbabile l’ipotesi di un’apertura a destra.Come già era successo in occasione delle elezioni politiche l’anno precedente, ileader democristiani tentennarono di fronte all’accordo col partito di Stella eCorona, sia per la reazione dell’elettorato che per l’ostilità di larga parte del mondoindustriale.
Il sindaco di Napoli cercò, quindi, l’appoggio dell’ambasciata per promuoverela nascita di un partito trasversale, possibilmente con una sigla meno compro-mettente di Pnm e con l’aggettivo “democratico”. La notizia era stata diffusadall’”Avanti!”72 e si riferiva a un nascente “gruppo armatoriale”. Inoltre, Beniami-no Degni, esponente della Dc partenopea, aveva assicurato a Lauro un colloquiocon De Gasperi per porre le basi della costituzione del nuovo partito. Tale forma-zione politica sarebbe stata favorevole ad un’alleanza coi democristiani, che avreb-bero – a loro volta – alimentato le voci di una dissidenza interna per accelerarnela nascita73. Anche dall’ambasciatrice non mancarono segnali in questo senso,malgrado altri esponenti del Pnm, lontani da Lauro, avessero smentito categori-camente74.
Incontrando Mrs. Luce, l’armatore confermò la sua avversione al quadripartito,ritenuto debole e instabile. Solo una coalizione di tutti i partiti d’ordine avrebbepotuto salvare il governo. Di fronte alla questione del probabile abbandono diPsdi e Pri, Lauro rimandava ad un successivo incontro l’esposizione di un pianopiù dettagliato sulle modalità di azione e su “cosa gli Stati Uniti avrebbero potutofare per aiutarci”75. Al consolato di Napoli, intanto, si percepiva la diffusa attesadi cambiamento nella scena politica nazionale. Due erano le possibilità: un’alle-anza della Dc coi monarchici, che avrebbero sostituito i socialdemocratici, oppu-re la creazione di un nuovo partito di destra, senza riferimenti “irrealistici” alla
70 Si vedano A. TARCHIANI, Tormenti di un ambasciatore. L’anno conclusivo di Washington 1954, SoveriaMannelli, Rubbettino, 2006, pp. 34-45; Si veda anche L.J. WOLLEMBORG, Stelle, strisce e tricolore. Trent’an-ni di vicende politiche fra Roma e Washington, Milano, Mondadori, 1983, p. 20.
71 G. ANDREOTTI, De Gasperi e il suo tempo, cit., p. 578.72 F. GERARDI, Si accentua in tutto il Paese l’impopolarità del governo, «Avanti!», 23 febbraio 1954.73 D. DE NAPOLI, Il movimento monarchico, cit., pp. 198-199.74 Edoardo Stolfi, rispetto alle voci di un nuovo movimento, parlava di “manovre tattiche di altri partiti
contro il Pnm”, si veda Monarchist Party (PNM) devolpments, F.T. Williamson (Counselor for PoliticalAffairs, Embassy) to the Department of State, February 19, 1954, NARA, RG 59, C-3, Box 5, 765.00/2-1954.
75 Memorandum of conversation, C.B. Luce, A. Lauro, A. Nester (American Consul general in Naples),J. Miner (American Naval Attachè to Rome), C. Rinaldi (Assistant Public Affairs Officer in Naples),March 1, 1954, inoltrato a Miller (Cia) nel giugno 1954, LOC, CBLP, Box 633, f. 7 Memoranda inter-office Apr-Jun 1954.
59
monarchia, chiamato “Movimento democratico italiano” o “Movimento nazio-nalista italiano”. Tale raggruppamento avrebbe dovuto intercettare i consensi ditutti i partiti anticomunisti e avere il supporto attivo della Chiesa76.
L’incontro tra Lauro e l’ambasciatrice si ripeté pochi giorni dopo. Ne risultòuna comunanza di vedute sulla necessità che gli industriali prendessero coscienzadel pericolo comunista. Era una questione assai cara alla Luce, che si stava impe-gnando per responsabilizzare gli italiani, e in particolare gli imprenditori, di fron-te all’avanzata delle sinistre. Clare Luce notava, poi, che “per gli stranieri era moltodifficile capire perché i due terzi dell’Italia – non comunisti – non riuscissero amettersi insieme per formare un governo stabile”. E non nascondeva che la situa-zione del comunismo era tale che “uomini come lui erano obbligati a fare qualco-sa sul piano politico nazionale”. Di qui l’idea di Lauro: creare un nuovo movi-mento-partito in grado di attrarre l’elettorato anticomunista e cavalcare i malu-mori del Paese. Bastavano dieci self made men (“gli elettori sono impressionatidalle figure energiche e capaci”). Ed erano disponibili già 5 miliardi – recuperatitra alcuni industriali del Nord – e 50 milioni messi a disposizione da lui. Il movi-mento poteva essere organizzato già in aprile, per essere pronto in autunno epreparare il terreno in caso del temuto ritorno alle urne.
Da parte sua, la Luce pose l’accento sul simbolo. Era necessario un simbolo cheevocasse qualcosa “anche per gli analfabeti”. Stando a quanto riportato nel me-morandum, si capisce l’accento posto dall’ambasciatrice sul simbolo più che suiprogrammi. Una tale insistenza – in assenza di finanziamenti e di un’idea chiara– stupì Lauro77. Si tratta di un esempio paradigmatico della diversa ottica con cuii due leggevano la competizione politica. Clare Boothe Luce era giornalista ecommediografa, perdipiù profondamente influenzata dal sodalizio umano e pro-fessionale con Henry Luce. Era stato proprio il marito l’inventore delle primeriviste incentrate sulle immagini più che sul testo. Il simbolo, quindi, non potevaessere un dettaglio.
Il sindaco di Napoli, invece, aveva sempre praticato uno stile tutto diverso.All’origine delle sue 130.000 preferenze del 1952 c’era, in parte, il fascino dellamonarchia. Ma non si può trascurare l’indubbia attrattiva esercitata dai modi gros-solani, diretti ed efficaci del personaggio. Achille Lauro, ha notato Montanelli, fu“un sindaco padrone e padrino, efficiente e clientelare, prodigo e bizzarro, igno-rante e geniale, inviso all’intelligenza e adorato dalla plebe. La sua ideologia mo-narchica era appicicaticcia, il suo impegno fasullo. [...] Era un guappo orgoglioso,un capopopolo che impose più di una volta Napoli a Roma, e che trasgredì più diuna volta le regole imposte da Roma”78.
Non è chiaro in che misura il Partito monarchico popolare, fondato nel giugno’54, fosse la combinazione di lotte personali, sollecitazioni americane e pressionidemocristiane. Comunque, è ragionevole ipotizzare l’influenza di Clare BootheLuce, che lasciò la porta socchiusa davanti all’eventuale nascita del soggetto de-scritto da Lauro.
Al di là dei personalismi e degli interessi imprenditoriali dell’armatore, all’ori-gine della scissione c’era una differenza piuttosto marcata nella concezione del
76 Certain political opinions in Naples, H.C. Reed (American Consul, Naples) to the Department ofState and Embassy, March 4, 1954, NARA, RG 59, C-3, Box 5, 765.00/3-454.
77 Memorandum of conversation, C.B. Luce, A. Lauro, J. Engle (Third Secretary of Embassy), March 11,1954, NARA, RG 59, C-3, Box 5, 765.00/3-3154.
78 I. MONTANELLI-M. CERVI, L’Italia del miracolo, Milano, Rizzoli, 2005, pp. 121-123.
60 n. 4/2011 CSn
partito. È utile, poi, tenere presente le pressioni della Dc nella formazione di unnuovo partito monarchico. Lauro, così, avrebbe rinunciato ad un ruolo nazionaleper concentrarsi in Campania. Grazie a speciali provvedimenti varati dall’esecu-tivo sui cantieri navali, il Comandante poté salvaguardare i propri interessi. Avevaformato un partito che ridimensionava il peso contrattuale dei monarchici inParlamento e rafforzava implicitamente il governo Scelba79.
Com’era prevedibile, la scissione venne ampiamente commentata dagli osserva-tori americani. Il nuovo partito fu accolto positivamente, seppur con la dovutacautela. L’ambasciata continuava a preferire il quadripartito ad altre combinazioniche prevedessero l’inclusione del Pmp al posto di uno dei partiti laici. In più, inun momento così delicato, destavano più di qualche perplessità gli apprezzamen-ti di Lauro ai neofascisti del Msi. Certo il Pnm ne uscì seriamente danneggiato:Covelli aveva fallito nei suoi tentativi di creare un partito determinante per gliequilibri nazionali. La separazione accelerò la graduale e inesorabile perdita diprestigio iniziata con la mancata fiducia a Fanfani e Scelba. Si poteva pensare diconsigliare l’inclusione di Lauro ma era sicuramente preferibile tentare ulterioripressioni sui monarchici di Covelli per farli confluire nella Dc e sfruttare la gene-rale disarticolazione della destra italiana80. L’ipotesi di una pressione democristia-na sull’armatore napoletano – esagerando un po’ l’intervento di De Gasperi –apparve subito nei dispacci dei funzionari americani:
Lauro è stato quasi certamente aiutato da De Gasperi e da altri democristiani che vole-vano spaccare il Pnm. È stato in contatto con De Gasperi e con i potenti sponsor coin-volti probabilmente nella decisione di Lauro di lasciare il Pnm. Il governo centrale ha unpeso decisivo nelle questioni, specialmente i sussidi, riguardanti la marina mercantile (l’ori-gine della fortuna di Lauro) così come ce l’ha nel controllo delle istituzioni bancarie na-poletane, nei giornali, ecc. [...] In ogni caso, sembra chiaro che Lauro abbia deciso che ungoverno Dc-Pnm non fosse probabile nell’immediato futuro. Le questioni ideologiche,come la Ced o la Nato, non furono probabilmente ciò che determinò la sua azione, maservirono come giustificazione per una mossa che appare utile solo ed esclusivamente adAchille Lauro81.
La separazione venne interpretata, principalmente, come una manovra della Dce coincise con la fine della breve stagione in cui si discusse l’apertura a destra.Con la scissione la politica degli Stati Uniti nei confronti dei monarchici assunsetoni più pragmatici. Da uno scambio di lettere tra Jones, direttore del Bureau forEuropean Affairs del Dipartimento di Stato e il Minister Counselor dell’ambascia-ta Durbrow notiamo la vicinanza dei due nel “coltivare” i rapporti coi monarchi-ci, in modo da facilitare la loro cooperazione con il governo. Tutto ciò andavafatto senza venir meno alla fiducia nella coalizione guidata da Scelba. Sotto certe
79 A. BALDONI, La destra in Italia 1945-1969, Roma, Pantheon, 2000, p. 395; M.G. ROSSI, Il governoScelba tra crisi del centrismo e ritorno anticomunista, «Italia contemporanea», n. 197, dicembre 1994, p. 795;S. COLARIZI, Storia del novecento italiano, cit., pp. 348-349.
80 Telegram 3957, Embassy to the Secretary of State, June 4, 1954, NARA, RG 59, C-3, Box 5; Monar-chist split strenghtens Scelba, June 10, 1954, NARA, RG 59, Subject files relating to Italian Affairs, 1944-1956, Lot File 58D357, Box 19, f. 220.10 Pmp 1954; C.W. Gray (American Consul General) to the Of-ficer in charge (American Consulate), June 10, 1954, NARA, RG 84, CBL, Box 7, f. Staff meetings – Amb.
81 An estimate of the impact of the Lauro Monarchist Party – Pmp, A. Mayio (Division of Research forWestern Europe) to R. Freund (Western Europe), June 4, 1954, NARA, RG 59, C-3, Box 5, 765.00/6-454. Cenni sui contatti tra De Gasperi e Lauro per dividere il voto monarchico sono presenti in C.B. Luceto A. Dulles (Director, CIA), March 12, 1954, LOC, CBLP, Box 611, f. 3 Do-Du 1954.
61
condizioni – osservava Durbrow – tali contatti potevano essere molto utili per fa-vorire l’atteggiamento dei monarchici su questioni vitali per l’interesse americano82.
Il governo Scelba, secondo gli alti funzionari di via Veneto, “stava facendo unbuon lavoro” e non c’era motivo di “minare il centro”. Anzi, l’esecutivo guidatodal politico siciliano meritava la non ostilità delle forze democratiche di destra, amaggior ragione nel Mezzogiorno dove il comunismo stava mietendo sempre piùconsensi. E il Pmp tornava utile, sia secondo gli Usa che secondo la Dc, per fre-nare la crescita dei socialcomunisti83.
Lo stesso Lauro, peraltro, si era reso conto dell’arretratezza del suo elettoratoe delle enormi difficoltà che avrebbe incontrato nel proporre un nuovo soggettopolitico senza riferimenti alla monarchia. Così, il Pmp da momento transitoriodivenne forza locale utile, in larga misura, a salvaguardare gli interessi dell’arma-tore napoletano, ma adatta anche a contenere il comunismo al Sud. Cosa apprez-zata dagli americani84 e per nulla scontata, visto che un partito genericamente didestra e senza riferimenti alla Corona non avrebbe sortito, probabilmente, imedesimi effetti.
Si può dire che ad affossare definitivamente i progetti di Lauro e a ridimensio-nare il Pmp a livello locale furono tre fattori. Le pressioni della Dc, il realismoamericano – dettato sia dalla costante avversione dell’armatore al quadripartitoche dalla necessità di una destra anticomunista nel Meridione – e, infine, la man-canza di una scadenza elettorale vicina, che forse avrebbe fatto propendere persoluzioni diverse.
Lauro sindaco e “i vincoli di amicizia con la nobile America”
In un colloquio all’ambasciata con Stabler, il monarchico indipendente Selvaggiha sottolineato un punto nodale per la destra monarchica dell’epoca: “Lauro ave-va perso l’occasione d’oro – dopo lo scisma – di creare un partito di destra perchéera stato obbligato a tener conto dei sentimenti monarchici di Napoli per farguadagnare terreno al Pmp”85.
La destra, o almeno la destra di Lauro, era condannata, per il momento, ad es-sere monarchica e napoletana per sopravvivere. Ciò non toglie che l’ambizionedel Comandante fosse quella di insidiare l’egemonia democristiana. A partire dalSud avrebbe voluto conquistare il vasto fronte moderato ormai deluso dalla Dc.Un progetto di tal natura, però, faticò sempre a concretizzarsi.
La strategica appartenenza partenopea prima che italiana emerse in due occa-sioni, in cui il “Lauro sindaco” prevalse sul “Lauro leader di partito”. Ci riferiamo
82 J.W. Jones (Director, Bureau of European Affairs, Department of State) to E. Durbrow (MinisterCounselor), June 12, 1954; E. Durbrow to J.W. Jones, July 1, 1954, NARA, RG 59, Subject files relatingto Italian Affairs, 1944-1956, Lot File 58D357, Box 15, f. 435.03 OSP 1953-54.
83 The effect of the monarchist split on the italian parlamentary situation, F.T. Williamson (Counselor ofEmbassy) to the Department of State, July 19, 1954; Memorandum of conversation, A. Lauro, G. Fioren-tino (Pmp), E. Durbrow (Minister Counselor), W. Stabler (Second Secretary of Embassy), July 28, 1954,NARA, RG 59, C-3, Box 5.
84 Sui timori per la crescita del comunismo al Sud si veda il primo aggiornamento del NSC 5411/2:Progress Report on Nsc 5411/2, United States Policy toward Italy (Period covered April 15, 1954 – Novem-ber 1, 1954), December 16, 1954, DDEL, WHO, NSC Staff Papers, 1948-61, OCB Central File Series,Box 45, f. OCB 091.Italy (File #1) (2) December 1953 – December 1954.
85 Memorandum of conversation, E. Selvaggi (Monarchist Deputy), W. Stabler (Second Secretary ofEmbassy), February 8, 1955, NARA, RG 59, Central Decimal Files (d’ora in poi CDF), Box 3603.
62 n. 4/2011 CSn
alla richiesta di cibo e vestiario da destinare alla città tramite una missione ame-ricana e al viaggio negli Stati Uniti. In entrambi i casi il Comandante puntò adaccreditarsi come figura di riferimento per la “grande Nazione amica”. Nel mar-zo ’55 Lauro scrisse a Clare Boothe Luce per chiedere di diventare l’interlocutoredel Capo delle forze alleate del Sud Europa, con lo scopo di assicurare una certaquantità di beni di prima necessità per la popolazione di Napoli86.
Alla fine, la distribuzione non ebbe luogo. Esistevano conflitti di competenzache pregiudicavano la mediazione di Mrs. Luce in favore del sindaco. L’ammira-glio Fechteler intervenne per ricordare l’estraneità della Nato a progetti di talgenere. Dunque né il Comandante delle forze alleate, né l’ambasciata potevanofare molto. Era la flotta americana, che prendeva ordini dal Chief of Naval Ope-rations di Washington, ad occuparsene87.
L’altro momento, in sé non particolarmente clamoroso ma emblematico dellamentalità del Comandante, è stato il viaggio negli Usa dell’autunno ’55, precedu-to dall’incontro con alcuni sindaci americani. In settembre, Napoli aveva ospitatouna delegazione di amministratori di importanti centri urbani, tra cui San Fran-cisco. Lauro aveva colto l’occasione, prendendo spunto dalla presenza di nume-rosi italiani oltreoceano, per auspicare “un sempre migliore avvenire” e per “pro-seguire la bonifica materiale e morale” della sua città. Ne erano nati tanti rapporticordiali, dove la politica nazionale era sempre rimasta sullo sfondo. I colloquifurono incentrati su progetti di tipo culturale, volti a rafforzare il legame traNapoli e l’America.
All’origine delle manifestazioni organizzate per “gli Eminenti Colleghi” c’era-no proprio, continuava il sindaco, “gli impulsi del cuore di una Napoli di cui sap-piamo di essere interpreti e che non può né vuole dimenticare l’aiuto portole neimomenti più cruciali della sua esistenza”. La città partenopea, insomma, voleva“fecondare [...] e rinsaldare i vincoli di amicizia con la nobile America”88. Intanto,dalla delegazione del capoluogo campano in visita negli Usa, giungevano notizieentusiasmanti sui fiorenti rapporti con la città di Denver. In una lettera del 21settembre sembrava imminente la programmazione, proprio a Napoli, di un fe-stival cinematografico americano in grado perfino di superare quello di Venezia.L’iniziativa poi si arenò per il rifiuto del governo italiano89.
Qualche settimana più tardi Achille Lauro salpò alla volta degli Stati Uniti.Prima di partire aveva cercato l’intermediazione della Luce per un colloquio conEisenhower:
Mi consento, poi, di rivolgere viva preghiera alla E.V. perché voglia degnarsi di patroci-nare un mio incontro con S.E. il Presidente Eisenhower, dal quale ambirei di essere rice-vuto per recarGli il doveroso omaggio della Città che ho l’onore di rappresentare e che
86 Lettera di A. Lauro a S.E. la Signora Clara Boothe Luce, Ambasciatore degli Stati Uniti d’America,4 marzo 1955, NARA, RG 84, CBL, Box 1, f. “C”.
87 Si vedano i relativi documenti conservati in NARA, RG 84, CBL, Box 1, f. “C”.88 Lettera di A. Lauro a S.E. la Signora Clara Boothe Luce, Ambasciatore degli Stati Uniti d’America,
19 settembre 1955, NARA, RG 84, CBL, Box 2, f. Cultural Affairs. Nel medesimo fascicolo c’è anche ilprogramma delle attività in onore dei sindaci americani, svoltesi dal 17 al 23 settembre 1955.
89 Nella lettera Lauro scriveva addirittura che la “cornice” napoletana avrebbe “garantito” il supera-mento della manifestazione di Venezia, si veda Lettera di A. Lauro a S.E. la Signora Clara Boothe Luce,Ambasciatore degli Stati Uniti d’America, 21 settembre 1955, sempre in NARA, RG 84, cit. Sul fallimen-to del festival si veda G. FUSCO, Le mani sullo schermo. Il cinema secondo Achille Lauro, Napoli, Liguori,2006, pp. 10-14.
63
per ospitare la Nato ha modo di più e meglio apprezzare la sensibilità del nobile popoloamericano per gli italiani in generale e per i miei concittadini in ispecie che in largo nume-ro risiedono negli Stati Uniti90.
Anche in questo frangente non nascose il desiderio di mettere in mostra i pro-pri successi imprenditoriali e politici. Aveva deciso di dare un ricevimento a bor-do della motonave “Roma”, durante il quale sarebbe stato proiettato “il documen-tario delle bellezze di Napoli e delle opere compiute per la sua ricostruzione”.
Nelle carte personali di Eisenhower e tra quelle dell’amministrazione repubbli-cana non è stata trovata traccia dell’incontro tra i due. Anzi, è utile ricordare comegli interlocutori di Lauro abbiano reagito alle sue continue e spesso insistentirichieste. Da quanto risulta dalla documentazione, ad incontrare il Comandantefu sicuramente Livingston Merchant, Assistant Secretary of State for EuropeanAffairs. Prima di vederlo, ricevette dettagliate istruzioni da John Wesley Jones,direttore dell’Office of Western European Affairs. Nel documento si legge chel’armatore era “uno dei tre uomini più ricchi d’Italia”. Il partito – definito da Jones“proprietà personale di Lauro” – era basato su una combinazione “in stile bor-bonico” tra la “decadente tradizione aristocratica” e il “sottoproletariato urbano diNapoli”. Il legame tra Lauro e la monarchia era ritenuto “totalmente opportunisti-co”. Alla luce di queste premesse e del fatto che il Comandante aveva sempre cer-cato la riconoscenza degli americani, Merchant avrebbe dovuto essere molto cauto:
La sua attuale visita negli Usa, progettata per aumentare il prestigio in patria, è un af-fare interamente privato. [...] Il governo americano non ha alcun legame con il suo viag-gio e tu sei l’unico funzionario del Governo Federale che formalmente lo riceverà. [...]Siamo riusciti a eludere una gran quantità di tentativi di farsi ricevere dal Presidente e dalVice-Presidente (sottolineando il viaggio del vice a Denver e il suo programma già inten-sissimo al ritorno). A giudicare dall’atteggiamento finora tenuto a Washington, Lauro èa dir poco indignato per non essere stato trattato come un Capo di Stato.
Dunque, non poteva essere trascurata la natura privata della visita. Napoli eraun’importante “Nato city” e andava guardata con rispetto per non incrinarne ilprestigio. Altre linee guida – “nel caso in cui Lauro ti desse l’opportunità di direqualcosa” – erano le seguenti: apprezzare il suo sforzo per attrarre turisti ameri-cani ed esprimere rammarico per l’assenza sia del Vice-Presidente che del segre-tario di Stato. L’ordine era chiaro e perentorio: rimanere sul generico senza toc-care la politica italiana, in modo da non dare adito al temuto rilancio del sindacosulla scena nazionale91. I toni quasi allarmati dal possibile “contagio” con Lauro,fanno capire lo scarsissimo interesse dei funzionari statunitensi per la destra lau-rina. Al probabile accordo non esplicitato con la Dc si aggiungeva la non sinceritàdi fondo dietro a quel nome – Partito monarchico popolare – che delimitava l’azio-ne del Comandante. A lui, almeno a parole proiettato ben oltre lo scenario regio-nale92, il ritorno in patria impose i confini di Napoli e l’identità monarchica.
90 Lettera di A. Lauro a S.E. la Signora Clara Boothe Luce, Ambasciatore degli Stati Uniti d’America,10 settembre 1955, NARA, RG 84, CBL, Box 1, f. “C”.
91 Citazioni tratte da Achille Lauro, Mayor of Naples, J.W. Jones (Office of Western European Affairs)to L. Merchant (Assistant Secretary of State for European Affairs), October 10, 1955, NARA, RG 59,Subject Files relating to Italian Affairs, 1953-1956, Lot File 58D71, Box 6, f. 131 Italians in the UnitedStates July-Dec 1955.
92 Su questo si veda A. LAURO, La mia vita. La mia battaglia, cit., pp. 72-90.
64 n. 4/2011 CSn
Neanche quando, nell’ottobre ’55, fondò il “Fronte democratico nazionale” lecose cambiarono molto. Emblematico dell’inquietudine della destra e, secondoalcuni, “creatura della Dc”93, il “Fronte” avrebbe dovuto coinvolgere altre perso-nalità al di fuori del Pmp. Ambiva ad essere il decisivo trampolino di lancio diun’opposizione di destra democratica e non monarchica, allo scopo di contrasta-re l’avvicinamento della Dc ai socialisti. Lauro, secondo quanto ha raccontato ilsuo stretto collaboratore Cafiero, credeva che “il governo Segni fosse la bruttacopia di quello di Scelba”. Perciò era necessario istituire una “opposizione costi-tuzionale” che prevenisse l’apertura a sinistra. Il “Fronte” si sarebbe opposto allemisure contrarie agli interessi nazionali. Interlocutori principali erano la “LegaFratelli d’Italia” di Longanesi, il maresciallo Messe e il generale Battisti. Nemicigiurati Covelli e Michelini94.
Pur sorto con grandi aspirazioni, il Fdn non fu mai competitivo, sia per l’am-bizioso compito di unire le forze di destra senza l’etichetta monarchica, che perla concorrenza di Msi e Pnm, impegnati in un riavvicinamento. Quanto, poi, aldesiderio di fare della “Lega Fratelli d’Italia” l’architrave del “Fronte” al Nord,Williamson annotò: “è letteralmente scomparsa dalla vista”95. Con pesanti riper-cussioni su Lauro: la “condanna” – di nuovo – a non uscire da Napoli e ad essereosannato dal sottoproletariato assai più che dalla borghesia imprenditoriale.
L’ultimo paradosso del Comandante: necessario per gli Usa e inopportuno per la Dc
L’assenza di una credibile formula alternativa al centrismo preoccupava di gior-no in giorno gli osservatori americani. Nel 1956 si inasprirono i commenti suGronchi e le elezioni amministrative catalizzarono l’attenzione sull’Italia. In talecontesto, la destra continuava ad arrancare.
La tornata elettorale era il primo importante test dopo il 1953. Erano coinvoltipiù di 40 milioni di italiani, il 98,7% della popolazione. Al di là del potenzialeelettorato – non molto distante da quello effettivo, data l’affluenza superiore al90%96 – la consultazione interessava in ugual misura centro, destra e sinistra.
In virtù dell’endemica instabilità governativa da una parte e dell’attivismo gron-chiano dall’altra, un’affermazione non convincente del centro avrebbe potutoaprire la strada alla crisi di governo. Gli Stati Uniti, favorevoli alle forze al gover-no, decisero di mantenere una politica di non intervento. “Qualsiasi indicazioneo accusa di interferenza americana nelle elezioni – ha scritto Williamson – po-trebbe essere usata dalla sinistra e/o dalla destra a danno di quegli elementi chevorremmo vedere rafforzati”97.
93 Ci riferiamo a Patrissi, vice segretario del Pnm, si veda Memorandum of conversation, E. Patrissi (Vice-secretary of Pnm), W. Stabler (Second Secretary of Embassy), J. Getz (Second Secretary of Embassy),October 19, 1955, NARA, RG 59, CDF, Box 3604.
94 Memorandum of conversation, R. Cafiero (Pmp Deputy), W. Stabler (Second Secretary of Embassy),October 7, 1955, NARA, RG 59, CDF, Box 3604.
95 Developments on the right, F.T. Williamson (Counselor of Embassy) to the Department of State,November 29, 1955, NARA, RG 59, CDF, Box 3604.
96 Dati tratti da F. MALGERI, La stagione del centrismo, cit., p. 247.97 Memorandum on administrative elections, F.T. Williamson (Counselor of Embassy) to the Department
of State, February 23, 1956, NARA, RG 59, CDF, Box 3604. Secondo il National Intelligence Estimatedi quei giorni, gli equilibri post-elettorali sarebbero stati i medesimi, con un lieve spostamento verso si-nistra, NIE 24-56: The Political Outlook in Italy, W. Park Armstrong Jr. to the Acting Secretary, February21, 1956, NARA, RG 59, cit.
65
I risultati del 27-28 maggio ’56 confermarono, in larga misura, l’assetto esisten-te. Rispetto agli equilibri governativi non ci furono sconvolgimenti clamorosi. Lacoalizione di centro ottenne buoni risultati, la sinistra socialista non sfondò equella comunista non ebbe il tracollo previsto. Per quel che riguarda la destra,l’esito elettorale confermò il trend negativo a vantaggio del Pli. Come ha effica-cemente notato Tassani, le amministrative del ’56 hanno espresso “se non l’iniziodella crisi elettorale per le destre, comunque la fine di una spinta propulsiva”iniziata nel ’5198. Solo grazie all’affermazione di Lauro e del Pmp non ci furonogrosse perdite per la destra. Nella sua Campania il Comandante ottenne 406.000dei 560.000 voti riportati a livello nazionale. A Napoli, dove la Dc ottenne soloil 16% e fu scavalcata dal Pci, Lauro riuscì a conquistare la maggioranza assolutacon il 51.7% dei consensi99. Achille Lauro, insomma, non poteva essere ignorato.In particolare, suscitava interesse per il suo potenziale apporto alla lotta al comu-nismo nel Meridione, dove si stavano concentrando gli sforzi dell’amministra-zione Usa. Nella situazione venutasi a creare dopo le elezioni, Jernegan – tempo-raneamente a capo dell’ambasciata a causa dell’assenza di Mrs. Luce – sintetizza-va così la funzione del Comandante:
Se la vittoria personale di Lauro non fosse stata così grande, la figura della destra sareb-be stata probabilmente peggiore. Lauro e il Pmp sono una necessità temporanea sullascena politica italiana, perché senza quel gruppo non democratico di destra, i voti del Sudpotrebbero deviare verso un gruppo non democratico di sinistra.
E qualche giorno dopo notava che, in diverse aree, “la destra aveva mostratoinequivocabili segni di disgregazione”. Gli americani, in teoria, avrebbero dovutoessere contenti di vedere che il centro guadagnava terreno a spese di missini emonarchici. Jernegan, però, ricordava che la destra era “parte integrante del siste-ma”. In altri termini, non era per nulla scontato che gli elettori delusi da Lauro,Covelli e Michelini andassero a ingrossare le fila del centro democratico. I votiestremisti, grazie al radicamento di una destra nostalgica, non sarebbero andati aPsi e Pci. Era questo un pensiero ricorrente dei funzionari di via Veneto. Il Pmpandava a inserirsi nella più ampia strategia di rafforzamento del Psdi, vale a direuno dei punti fermi della politica americana verso l’Italia del ’56. In uno scenariodel genere la destra era necessaria. Non più come “ruota di scorta” del governo,ma piuttosto come “tampone “ per i voti estremisti100.
Lo stesso Lauro, pur galvanizzato dall’affermazione personale, era cosciente deinumerosi problemi esistenti; ammetteva “candidamente” di aver sfruttato l’eti-
98 G. TASSANI, Le culture della destra italiana tra dopoguerra e centrosinistra. Gentilianesimo, cattolicesi-mo ed evolismo a confronto e in concorrenza, «Nuova Storia Contemporanea», a. VII, n. 2, marzo-aprile2003, p. 144. Si veda anche P. ROSENBAUM, Il nuovo fascismo, cit., p. 113.
99 Si vedano F. MALGERI, La stagione del centrismo, cit., p. 251; C.M. Lomartire, ’O Comandante, cit.,p. 123; P. ZULLINO, Il comandante, cit., pp. 99-100.
100 La prima citazione è tratta da J.D. Jernegan (Charge d’Affaires ad interim) to J. W. Jones (Directorof Western European Affairs, Department of State), June 4, 1956, NARA, RG 84, Italy, U.S. Embassy,Rome, 1956-1958, Box 92, f. 350 – Italy elections 1956-57. L’altro rapporto, edito e più articolato, è del26 giugno, disponibile in Foreign Relations of the United States (FRUS), 1955-57, XXVII, pp. 361-370.Cenni sulla necessità di incoraggiare “gli elementi di destra moderata fuori dal centro (il cui esempiomigliore è probabilmente il Pmp)”, in J.D. Jernegan to the Secretary of State, July 11, 1956, NARA, RG59, CDF, Box 3605, 765.00/7-1156. Malagodi notava che la destra fosse «in fase di disgregazione», Memo-randum of conversation, G. Malagodi (Pli Secretary), W. Stabler (Second Secretary of Embassy), June 11,1956, NARA, RG 59, CDF, Box 3605.
66 n. 4/2011 CSn
chetta monarchica per far leva sull’elettorato più reazionario. Ma del ritorno dellaCorona gli importava assai poco. Pensava che l’istituzione monarchica potessetornare “solo con la violenza”. Non a caso, nel futuro di Lauro e del suo bracciodestro Cafiero c’era il progetto di un “Movimento meridionale” basato sui principidel Pmp, ma senza riferimenti alla monarchica. Una tale forza avrebbe dovuto fareda collettore per i voti di tutto il Sud, con il dichiarato scopo di agganciare la Dc einfluenzarne le politiche101. Un’operazione che sarebbe andata ad accrescere il nu-mero dei tentativi unitari della destra di quegli anni. Dopo il vagheggiato movimen-to-partito del ’54 – in cui cercò di coinvolgere sia gli Usa che gli industriali del Nord– e il Fronte democratico nazionale, anche questa iniziativa non avrebbe avuto fu-turo, esaurendosi quasi immediatamente dopo la sua enunciazione.
Un fatto non trascurabile di questo periodo è stato l’avvicendamento all’amba-sciata americana tra Clare Boothe Luce e James David Zellerbach. La Luce avevamanifestato il desiderio di tornare in patria fin dall’inizio del ’56, principalmenteper motivi di salute, ma anche per una stanchezza “morale” dovuta ai risultati nonsempre brillanti. Dopo qualche rinvio, alla fine di agosto la Luce comunicò uffi-cialmente le proprie dimissioni a Eisenhower.
Con ogni probabilità, qualsiasi personalità sarebbe risultata di tono minore ri-spetto alla Signora. Inoltre, il temperamento mite di Zellerbach, la maggiore au-tonomia dei subordinati e il nuovo contesto – internazionale e italiano – venutosia creare nel 1956 hanno fatto emergere le differenze in maniera lampante e resodi più difficile interpretazione gli anni del secondo mandato di Ike102.
I principali eventi che coinvolsero Lauro e il Pmp nel periodo post-elettoralefurono i tentativi di costituire la “grande destra”, lo scioglimento del consigliocomunale di Napoli e le politiche del 1958.
Lungo l’intero decennio, gli anni ’57-’58 furono il periodo in cui sembrò piùprobabile l’unione delle forze di destra, ovvero di monarchici, Unione combat-tenti italiani, parte del Pli e del Msi. A favorire i contatti tra le varie formazionipolitiche furono sia i continui annunci della temuta fusione socialista, sia l’ap-prossimarsi delle elezioni politiche, programmate per il 25 maggio 1958. Tali fat-ti, naturalmente, costrinsero i partiti di destra a interrogarsi sulla strategia otti-male per far fronte alla sfida elettorale e all’apparente rinvigorimento socialistaseguito al congresso di Venezia.
L’atteggiamento del Pmp era seguito dagli Usa con una certa attenzione, benmaggiore rispetto a quella riservata al Pnm. In un memorandum tra Mudd, segre-tario d’ambasciata, e Carbonelli, giornalista di punta del “Roma”, emersero aspettiinteressanti. Secondo Carbonelli, il Pmp non era veramente un partito monarchi-co, poiché sapeva che la monarchia non poteva tornare in Italia. Comunque, “laparola monarchia era utile per il Sud, dove il partito aveva gran parte dei suoiconsensi”. Il Pmp, concludeva, “era parte della Dc”, ma non voleva essere unacorrente e tanto meno un partito clericale103.
In maniera più disincantata, commentando un meeting regionale del partito diLauro, Bond scriveva:
101 Memorandum of conversation, A. Lauro, R. Cafiero (Pmp Deputy), P. Carbonelli (Rome corrispon-dent for Lauro newspapers), J.D. Jernegan (Charge d’affairs ad interim), W. Stabler (Second Secretary ofEmbassy), J. Getz (Second Secretary of Embassy), NARA, RG 59, CDF, Box 3605.
102 L. NUTI, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra, cit, p. 107.103 Memorandum of conversation, P. Carbonelli (Correspondent of Roma, Achille Lauro’s journal), R.
Mudd (Second Secretary of Embassy), May 22, 1957, NARA, RG 59, CDF, Box 3607.
67
Il Pmp rimane primariamente una forza meridionale, e il meeting di Bari ha messo inevidenza gli sforzi del partito di estendere la propria influenza in tutto il Sud, anche al difuori della roccaforte di Napoli, dove è relativamente debole. L’obiettivo di Lauro di tra-sformare il Pmp in una significativa forza nazionale sarebbe raggiungibile solo con unconsiderevole appoggio esterno. [...] I riferimenti all’unità della destra riecheggiano larecente campagna del Pmp per una “grande destra”, ma Lauro sta ovviamente pensandodi assorbire la forza del Pnm e del Msi, e non di allearsi veramente104.
I due maggiori esponenti del partito – Achille Lauro e Gaetano Fiorentino –avevano opinioni diverse rispetto alla “grande destra”. Se per il Comandante laproposta rimaneva aperta a tutti, per il vicepresidente del Pmp l’alleanza dovevaessere preclusa ai missini e ai seguaci di Covelli. Con ogni probabilità, l’idea erala medesima, cioè una solida formazione di destra costruita attorno al Pmp. MaLauro, a differenza di Fiorentino, credeva nella possibilità di assimilare Msi e Pnmdopo un iniziale periodo di collaborazione.
I problemi irrisolti, insomma, erano sostanzialmente quelli dell’inizio del de-cennio: il nodo della collaborazione coi neofascisti, da molti ritenuti impresenta-bili e pregiudizialmente ostili ai monarchici; la concezione, in sé contraddittoria,di un partito monarchico, ulteriormente aggravata dalla scissione del ’54; l’assenzadi un leader riconosciuto; la necessità del coinvolgimento dei liberali per garantirecredibilità al progetto e, infine, l’insistente ricerca dell’appoggio americano.
Gli Stati Uniti, quindi, “dovrebbero essere più comprensivi nei confronti delPmp”, riconoscere “i meriti e il valore del partito nella lotta al comunismo, nelcombattere lo statalismo socialista, nel sostenere la libera impresa, e nel provarea fare qualcosa per il Sud arretrato e povero”105.
Tra la fine del ’57 e l’inizio del ’58, i liberali si sarebbero distinti come l’ago dellabilancia. La dura critica del Pli all’iniziativa unitaria avrebbe contribuito a polariz-zare ulteriormente i contrasti tra le forze di destra. È stato il segretario Malagodiad opporsi esplicitamente al progetto di “grande destra”106. Venuta meno la pos-sibilità di includere i liberali e tramontata l’ipotesi di un partito monarchico riu-nificato, la “grande destra” poteva considerarsi definitivamente naufragata agli inizidel ’58.
Gli Stati Uniti seguirono gli incontri/scontri tra i vari partiti di destra avendobene in mente il problema che più interessava loro, cioè il contenimento del co-munismo al Sud107. La crescita del Pci nel Mezzogiorno veniva giudicata un pro-blema a cui alcuni partiti – su tutti il Pmp – avevano posto un argine decisivo. Si
104 Pmp regional meeting in South, N. Bond (Counselor of Embassy) to the Department of State, July16, 1957, NARA, RG 59, CDF, Box 3607.
105 Si vedano Views of Pmp leaders, E. Sohm (First Secretary of Embassy) to the Department of State,July 31, 1957; Memorandum of conversation, G. Fiorentino (Pmp), Colonel G. D’Autilia (CommunalCouncilor and Administrative Secretary to A. Lauro, Mayor of Naples), A. Childs (American vice-con-sul, Naples), J. Lord (American vice-consul, Naples), C. D’Ambrosio (Local employee, American Con-sulate General, Naples), July 22, 1957; Memorandum of conversation, A. Lauro (President of Pmp, Mayorof Naples), Colonel G. D’Autilia (Communal Councilor and Administrative Secretary to A. Lauro, Mayorof Naples), V. Bufi (Pmp City Councilor), A. Childs (American vice-consul, Naples), J. Lord (Americanvice-consul, Naples), C. D’Ambrosio (Local employee, American Consulate General, Naples), July 22,1957, NARA, RG 59, CDF, Box 3607.
106 A. CIANI, Il Partito Liberale Italiano da Croce a Malagodi, Napoli, Esi, 1968, pp. 135-136, citato inA. UNGARI, Il rifiuto della “grande destra”, cit., p. 62 n.
107 Lo si deduce soprattutto da Progress report on United States policy toward Italy (NSC 5411/2), Sep-tember 3, 1957, NARA, RG 273, Records of the National Security Council (NSC), Policy Papers 5410-5413, Box 30, f. NSC 5411/2.
68 n. 4/2011 CSn
trattava, secondo gli americani, di un elettorato fluttuante tra estrema sinistra edestrema destra. Costantemente delusi dal governo, ingrossavano le fila dei movi-menti di protesta. Ne consegue che l’interesse per la “grande destra” era, ad ognimodo, secondario rispetto alla presenza di un forte partito nostalgico – che nonfosse il Msi – al Sud.
I funzionari Usa giudicavano indispensabile una formazione che potesse fun-gere da collettore per l’elettorato meridionale, tendenzialmente arretrato e rea-zionario. Proprio quell’elettorato che vedeva in Lauro una sorta di “nuovo mo-narca”. Vanno in questa direzione i prudenti contatti con il Comandante. Simil-mente, lo stupore dell’ambasciata di fronte alle simpatie di Fiorentino e Lauroper i missini serviva a chiarire l’atteggiamento degli Usa in un contesto in cui ilPmp era ormai troppo radicato per poterne fare a meno.
Anche i laurini, da parte loro, comprendevano le riserve di Zellerbach di fronteal coinvolgimento del Msi, la cui posizione – al di là dell’atlantismo – rimanevaantitetica a quella degli Usa. Proprio Lauro, pur convinto che fosse un erroreisolare il Msi, dopo un incontro con l’ambasciatore si convinse ad “abbandonareimmediatamente” i tentativi di agganciare Michelini. Si trattava della consuetaprofessione di fedeltà all’America. Non solo. Era anche l’ennesimo tentativo diingraziarsi Zellerbach e, magari, istituire un canale preferenziale con Washington.Basti pensare che il sindaco di Napoli, nel corso dell’incontro, arrivò a chiedere– invano – di incontrare direttamente Eisenhower o Nixon.
Da parte statunitense, quindi, c’era una benevola tolleranza nei confronti delPmp e nessun appoggio all’idea di un fronte delle destre. L’etichetta monarchica,come ha ricordato l’ambasciatore, era ancora “fonte di sospetto” perché associataalla reazione e al fascismo. Ma lo “slogan monarchico” – questa la replica di Lauro– aveva un certo fascino per la “povera gente”. E bastava per portare a casa “mez-zo milione di voti”108.
È facile intuire la necessità temporanea di una tale forza nel Mezzogiorno. Ladestra, quindi, poteva (anzi, doveva) esistere solo a livello locale e senza aspira-zioni governative. Solo ed esclusivamente al Sud, perché sul piano nazionale lascelta obbligata era ancora il traballante centrismo.
In vista delle politiche del ’58 era, dunque, il Sud a catalizzare l’attenzione degliStati Uniti. Ritenuto meno dotato di anticorpi contro il comunismo e riserva dicaccia delle destre, il Meridione sarebbe diventato un territorio decisivo in occa-sione del delicato test elettorale.
Un rapporto del consolato di Napoli descrive lo straordinario seguito popolaredell’armatore. Il Pmp, si legge, era “l’organizzazione personale di Lauro”. Moltepersone “votavano per lui e non per il suo partito”. Probabilmente l’alto numerodi consensi dipendeva dai continui riferimenti di Lauro all’orgoglio locale e allasensazione che stesse combattendo per rendere Napoli uguale al resto d’Italia, senon migliore. Ne conseguiva che il Pmp aveva “il sostegno di diversi elementinella popolazione, dai più poveri ai più ricchi”. I critici del “laurismo”, secondoi funzionari del consolato, sottolineavano i metodi autoritari nella gestione delpotere e lo spaventoso dissesto economico. Tuttavia – si glissava in maniera un
108 Sul cambio di prospettiva relativamente al Msi, legato agli ammonimenti di Zellerbach, e sulla neces-sità dell’aggettivo monarchico si veda Memorandum of conversation, The Ambassador, A. Lauro, G. Fio-rentino, P. Carbonelli, A. Velletri, December 3, 1957, NARA, RG 59, CDF, Box 3607.
69
po’ ambigua e tautologica – “la povertà di Napoli era responsabile della difficoltàfinanziaria della città”109.
In seguito al fallimento delle contrattazioni volte a raggruppare i partiti di de-stra, la Dc stava realizzando che il Pmp era più un rivale che un potenziale allea-to110. Le intenzioni del Comandante non erano molto chiare. Da un lato sembravafarsi interprete di un disegno quasi separatista o neoborbonico, accusando il Norddi avere perpetrato una politica economica troppo penalizzante per il Sud. Dal-l’altro, si faceva strada l’idea di “intimorire” la Dc. Far capire la potenza del “lau-rismo” per poi offrire l’alternativa in vista delle politiche del ’58.
Fino all’ultimo, Lauro pensava di avere un potere contrattuale abbastanza forte.Un peso che avrebbe scoraggiato azioni drastiche da parte di Roma per contenerel’anomalia del Pmp. La realtà era ben diversa111.
Il partito dello Scudo Crociato, infatti, mise in atto delle contromisure pesantiin vista delle elezioni. Puntando sulla cattiva amministrazione del Comandante,il ministro dell’Interno Tambroni avviò un’inchiesta per accertare le responsabi-lità del sindaco.
Nella sua relazione, Tambroni ha posto l’accento su tutta una serie di elementinegativi: dalla “carenza di ogni concreta iniziativa” alle “spese ingentissime, nep-pure coperte dalle entrate effettive di bilancio, per il personale”. Per poi conti-nuare con la “prodigalità senza misura nell’assunzione di impegni di spesa”, le“irregolarità sistematiche del settore dei lavori pubblici” e “le gravi irregolaritàaccertate nel servizio elettorale”.
Il giudizio – così si concludeva il rapporto – sull’operato degli organi prepostial Comune non poteva che essere “interamente negativo”. Tali organi, “con laloro azione improntata al dispregio della legalità, alla facile erogazione del pub-blico danaro, alla trascuratezza del potenziamento delle entrate, alla elusione deicontrolli di legge ed all’incauto perseguimento di obiettivi assolutamente spro-porzionati alle possibilità finanziarie dell’Ente” avevano pregiudicato “in modoassai grave la situazione, già obiettivamente difficile, del bilancio comunale”112.
Pochi giorni dopo la relazione, il 5 gennaio, Lauro si dimise da sindaco. Comeha notato Zullino, non voleva subire l’umiliazione di “essere sciolto”. D’altra parteuna giunta diversa, retta da Sansanelli, ex federale fascista di Napoli, non potevaessere incolpata e sciolta per atti commessi dalla precedente. Così facendo, ilComandante voleva conservare il potere pur non ricoprendo (almeno ufficialmen-te) la carica di sindaco113.
Sempre in gennaio l’ormai ex primo cittadino avrebbe espresso le proprie ra-gioni in una risentita conferenza stampa, con l’obiettivo di rispondere punto perpunto alle accuse. In realtà, visto il clima da campagna elettorale, Lauro lanciòaccuse tanto alla Dc, quanto a destra e sinistra, prevedendo un boom di addirittu-
109 Citazioni tratte da Background information on Southern Italy, A. Gillikin (American Consul, Naples)to the Department of State, November 26, 1957, NARA, RG 59, CDF, Box 3607.
110 Si veda la ricostruzione, assai vicina alle posizioni di Lauro, fatta da P. ZULLINO, Il comandante, cit.,pp. 109-117.
111 C.M. LOMARTIRE, ’O Comandante, cit., pp. 151-157.112 Il testo della relazione di Tambroni è riportata interamente in A. LAURO, La mia vita. La mia bat-
taglia, cit., pp. 159-164. Sulla vicenda si veda la corrispondenza tra Ortona e C.D. Jackson a seguito di unarticolo di «Time», assai negativo su Napoli, e la successiva risposta de «Il Tempo», in DDEL, CharlesDouglas Jackson Papers (CDJ), Box 80, f. O-Misc. (3).
113 P. ZULLINO, Il comandante, cit., p. 111.
70 n. 4/2011 CSn
ra due milioni di voti per il suo Pmp. A febbraio, però, Gronchi firmò il decreto discioglimento dell’amministrazione comunale, portando a compimento, di fatto,l’offensiva della Dc – e in particolare di Fanfani – contro il feudo del “laurismo”.
Insomma, Roma si stava prendendo la sua rivincita su Napoli. Il governo cen-trale ridimensionava il monarca – fino a quel momento amatissimo – dai metodineoborbonici. Con lo scioglimento della giunta, qualcosa si era incrinato nellasua Napoli. La mobilitazione fortemente voluta in difesa del partito e della cittàebbe scarso seguito. Messe e Giannini furono tra i pochi ad esprimere solidarietà,ma il grande assente fu il popolo. La manifestazione, alla fine, si ridusse a “unasfilata di donne che innalzavano vecchie effigi del Comandante e le attaccavanocon grinta fiera ai cofani delle automobili”114. I due milioni di voti erano semprepiù un miraggio. E la scadenza elettorale incombeva.
L’ambasciata e il consolato napoletano avevano seguito con interesse le accusereciproche tra la Dc e Lauro. Secondo Zellerbach, le drastiche azioni, “escogitatedall’abile Fanfani”, rispondevano a una chiara logica pre-elettorale. C’era senz’al-tro il timore, con un Pmp troppo potente, di perdere voti nell’Italia meridionale.Ma alla base dell’intervento congiunto di Fanfani, Tambroni e Gronchi c’era an-che la volontà di colpire i missini coinvolti nella giunta e, in particolare, l’ex fe-derale Sansanelli, che aveva preso il posto del sindaco. Il divieto a Lauro di tenereun comizio il giorno successivo allo scioglimento andava sempre in questa dire-zione. L’obiettivo era avvalorare l’immagine di una Dc non collusa con le destre,in grado di premunirsi di fronte ai prevedibili attacchi della sinistra sul trattamen-to favorevole riservato a monarchici e missini. Fanfani – ha scritto l’ambasciatore– non voleva dare adito a prove di “clerico-fascismo”, facilmente utilizzabili dasocialisti e comunisti.115.
Contrariamente a quanto era stato prospettato dai funzionari Usa, alle elezionidel ’58 non ci fu il temuto exploit del Pci al Sud. È vero che la destra perse moltivoti, ma questi andarono in gran parte a favore della Dc. Da notare, poi, il succes-so dei socialisti, galvanizzati dal congresso di Venezia e dal nuovo scenario che liponeva – tenendo conto del serrato dibattito interno – sulla strada della parteci-pazione governativa.
La Dc di Fanfani superava il 42% dei consensi, confermandosi l’architrave dellademocrazia in Italia. Il Pci si manteneva sostanzialmente stabile. In alcune regio-ni raggiungeva percentuali assai alte, ma non sfondava nel Meridione. A registra-re un risultato ampiamente soddisfacente è stato, invece, il partito socialista ita-liano. Con 84 seggi alla Camera dei Deputati e 35 al Senato superava la soglia del14% dei voti. Liberali, repubblicani e socialdemocratici rimanevano sulle medesi-me percentuali del ’53.
I veri sconfitti della tornata elettorale furono i partiti di destra. Perdite di uncerto rilievo contraddistinsero l’esito di Pnm, Pmp e Msi. I monarchici, divisi,ottennero solo il 4,8%, cedendo così più del 2% rispetto a cinque anni prima. Da40 deputati passavano a 25. Di questi, 14 erano del Pmp e 11 del Pnm.
Per quanto il Comandante avesse dichiarato di riuscire a incassare 2 milioni divoti, il suo partito si arrestò a poco più di 700.000, segnando così l’inizio della suaparabola discendente. Egli stesso non venne eletto senatore, battuto dal rivaledemocristiano Gava.
114 P. ZULLINO, Il comandante, cit., p. 116-117; C.M. LOMARTIRE, O’ Comandante, cit., pp. 158-163.115 Telegram G-43, J. Zellerbach to the Secretary of State, February 15, 1958, NARA, RG 59, CDF,
Box 3608.
71
Le ragioni del collasso sono da ricercare, oltre che nella costante litigiosità in-terna al fronte monarchico, anche nelle trasformazioni economiche. Inevitabil-mente, gli albori del miracolo economico hanno avuto un certo impatto sulle aspet-tative dell’elettorato. Come ha efficacemente osservato Kogan, “il sottoproleta-riato meridionale stava divenendo meno sensibile agli appelli tradizionalisti deimonarchici e alle distribuzioni di pasta o indumenti con i quali si cercava di com-prare i loro voti; esso ora aspirava a qualcosa di più della semplice beneficenza”116.
Conclusione
Il rapporto tra i vari centri decisionali americani e Achille Lauro ha subito va-riazioni nel corso del decennio. All’inizio il Comandante si era imposto all’atten-zione degli Usa per il gran numero di preferenze ricevute alle amministrative. Daquel momento avrebbe cercato costantemente di entrare in contatto, a tutti i li-velli, coi rappresentanti degli Usa. Ma senza successo.
Dopo il mancato raggiungimento del premio di maggioranza – che naturalmen-te avrebbe evitato problemi di allargamento della base democratica – qualcosacambiò. Il risentimento degli Stati Uniti nei confronti della Dc aumentò espo-nenzialmente. Troppo soft nella lotta al comunismo, troppo succube della Chiesacattolica e poco saldo nel difendere il libero mercato dalle tentazioni stataliste, ilpartito di De Gasperi e Fanfani era ormai lontano dai successi del ’48. I contattidell’ambasciata con la destra monarchica vanno letti nel quadro della generaledelusione provocata dalla Dc.
Al centro dei colloqui con Lauro dei primi mesi del ’54 c’era la possibilità dicostruire una destra democratica, occidentale ed europeista. Il sostegno a prov-vedimenti decisivi come la Ced ne avrebbe accelerato l’evoluzione. Tuttavia,un’apertura alla destra monarchica così com’era – nostalgica, antimoderna e osti-le al quadripartito – non interessava117. La mancata trasformazione in senso de-mocratico ed europeista del partito, timoroso di perdere il proprio elettoratonostalgico, infastidì Clare Boothe Luce e i funzionari dell’ambasciata. D’altron-de, le incomprensioni fecero anche emergere i limiti interpretativi di Mrs. Luce.L’ambasciatrice mal sopportava la Dc e condivideva la necessità di nuove forze ingrado di fronteggiare il comunismo senza abdicare alle pregiudiziali democrati-che. I monarchici, in questo senso, furono una costante fonte delusione.
Con la scissione, com’è noto, il potere contrattuale delle due formazioni diminuì.Da parte dei monarchici di Lauro perdurarono i tentativi di intercettare il con-
senso americano. La scarsa attenzione ricevuta, sia dal punto di vista finanziarioche propagandistico, sembrava addirittura incomprensibile. Secondo Lauro, gliStati Uniti avrebbero dovuto essere entusiasti di sostenere e sponsorizzare unpartito connotato da un acceso anticomunismo.
Ma l’approccio statunitense era ben diverso. Esaurite le speranze di una destradi ampio respiro – sia territoriale che ideale – i monarchici laurini tornavano utilisolo per intercettare voti estremisti. Dovevano rimanere, quindi, confinati al Sud
116 N. KOGAN, Storia politica dell’Italia repubblicana, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 133. Utile anche S.COLARIZI, Storia del novecento italiano, cit., p. 352.
117 È opinione anche di una personalità certo non vicina alle posizioni dell’ambasciata come WilliamColby, si veda W. COLBY, La mia vita nella Cia, Milano, Mursia, 1996, p. 86.
72 n. 4/2011 CSn
e rimarcare la propria nostalgia della Corona e del passato regime. Analizzando lacopiosa documentazione prodotta dall’ambasciata, si può dire che i contatti coimonarchici fossero volti a cercare una maggiore stabilità e non, semplicemente,a riacutizzare lo scontro118.
Nella seconda metà del decennio l’approccio americano al nostro Paese diven-ne ancor più pragmatico e meno idealista. Dall’ingenua ricerca di una destra de-mocratica al silente appoggio al laurismo anticomunista di Napoli e dintorni.Perché il problema, appunto, era il comunismo. Archiviato l’iniziale impeto voltoa creare una destra europeista e non nostalgica, i vertici dell’amministrazione Usae dell’ambasciata si resero conto che la situazione era molto più complessa. E cheavevano bisogno di quell’armatore dai metodi discutibili, almeno fino a quandol’ostilità democristiana lo avrebbe lasciato al suo posto.
Infine, va fatta una considerazione importante sulla città. Napoli andava tratta-ta coi guanti per la presenza di importanti sedi diplomatiche. Tant’è che in undocumento del 1957 prodotto dal Consolato si legge:
Il fatto che il quartier generale della Nato per l’Europa meridionale e il Comando disupporto della marina americana siano a Napoli pone quest’area in una luce speciale perle relazioni italo-americane. In generale, gli italiani del Sud sono più amichevoli di moltialtri popoli europei. Certamente c’è un po’ di risentimento, dovuto all’apparente ricchez-za, ma c’è anche tanta ammirazione. [...] Questa mancanza di frizioni ha un considerevo-le significato politico. Il fatto che la Nato e gli americani siano accettati con pochissimeproteste aiuta la causa del mondo libero in un’area che è strategicamente importante epoliticamente decisiva119.
118 Su questo punto adottiamo una chiave interpretativa diversa da quella proposta da Nuti, secondo cuil’approccio dell’ambasciata – e in particolare della Luce – non era volto ad allargare la maggioranza, ma amantenere l’avversario sotto pressione, si veda L. Nuti, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra, cit., p. 18.
119 Background information on Southern Italy, A. Gillikin (American Consul, Naples) to the Departmentof State, November 26, 1957, NARA, RG 59, CDF, Box 3607.



































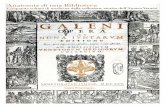







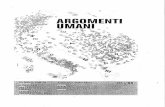
![Gebru Abba C̣hequn to Achille Raffray, 16 Jan. [1881]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317f85c3394f2252e028a6e/gebru-abba-chequn-to-achille-raffray-16-jan-1881.jpg)



![[JOURNAL ISSUE] 2014_E. Casetta, V. Giardino (a c. di), Mettere a fuoco il mondo. Conversazioni sulla filosofia di Achille Varzi, Isonomia](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631bcfae3e8acd9977059b4e/journal-issue-2014e-casetta-v-giardino-a-c-di-mettere-a-fuoco-il-mondo.jpg)




