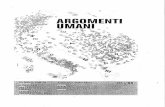Just passin’ through. Movimento e spazio nel road movie impossibile
Transcript of Just passin’ through. Movimento e spazio nel road movie impossibile
© 2009 Edizioni Cineteca di Bolognavia Riva di Reno 7240122 Bolognawww.cinetecadibologna.it
Redazione Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne
Progetto graficoLorenzo Osti, Mattia Di Leva per D-sign
Per la preziosa collaborazione nella ricerca delle immagini grazie ad André Chevailler della Cinémathèque Suisse
Questo volume esce in occasione della rassegna Il cinema di Monte Hellman, organizzata dalla Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna (Assessorato alla Cultura) e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino, Associazione Circuito Cinema di Modena, Cinemateca Portuguesa e Filmoteca Española. La rassegna è curata da Andrea Morini e Isabella Malaguti
Michele Fadda, Americano, straniero... il caso Monte Hellman 7
Alberto Morsiani, L’esistenza come mobile home 15
Alberto Pezzotta, Hellman, o della lentezza 23
Roy Menarini, Hellman e la ‘politique’ dei generi cinematografici. Hellman, Corman e altre storie (de)codificate 29
Leonardo Gandini, La frontiera rarefatta 37
Giacomo Manzoli, Il piacere del racconto illeggibile 43
Nicole Brenez, Dei finali e di una finalità singolare del cinematografo. Robert Bresson con Monte Hellman 53
Rinaldo Censi, Monte Hellman: figure nel paesaggio 61
Giorgio Avezzù, Just passin’ through. Movimento e spazio nel road movie impossibile 67
Quentin Tarantino, Un insolito dolore 81
Michel Ciment, Non sottolineare l’evidenza 89
Franco La Polla, ‘Reazionario’ innovatore 105
Brian Albright, Il suono del silenzio 109
BIOGRAFIA 129
FILMOGRAFIA 135
BIBLIOGRAFIA 172
67
Strada a doppia corsia, più che un road movie anomalo, è un road movie impossibile, che evita sistematicamente ogni mitologia legata all’automobili-smo, alla strada, al paesaggio statunitense – cioè tutto quello che dovrebbe stare alla base del genere.
Nonostante le auto, le gare e il fanatismo dei protagonisti, Strada a doppia corsia si tiene a distanza da quella mistica dell’automobile così in voga tra gli anni Sessanta e Settanta. L’esoterismo dei discorsi tra Pilota e Meccanico ha qualcosa di certamente ossessivo, come d’altronde osserva lo stesso GTO, che a sua volta non si può proprio dire immune da un entusiasmo patologico, pe-raltro menzognero come è nel suo carattere, visto che le sue reali conoscenze tecniche sono molto limitate.
Monte Hellman non vuole assegnare all’euforia automobilistica quel carat-tere genuinamente americano che invece Tom Wolfe descrive solo pochi anni prima. “L’auto è libertà, stile, forza, movimento, colore – tutto insomma”1, scrive Wolfe, ed è il migliore esempio dell’unico stile artistico veramente americano, che chiama “moderno barocco aerodinamico”. Hot rod, dragster, stock car contribuirebbero a creare un nuovo e aggiornato entusiasmo fron-tieristico. E accanto alle auto truccate e verniciate di colori brillanti, i numi tutelari della nuova America non sarebbero più Paul Bunyan o John Henry, ma i supereroi dei fumetti come Captain Marvel e Captain America. Junior Johnson, un pilota Nascar, diventa addirittura “l’ultimo eroe americano” – così si intitola il lungo articolo che gli dedica Wolfe su “Esquire”. Nasce pure un folklore: Junior Johnson, prima di correre in pista, seminava la polizia trasportando alcool distillato illegalmente; basta questo a farne, per Wolfe, un erede di Jesse James.
È facile trovare l’esaltazione di questo ribellismo automobilistico in un buon numero di film tra gli anni Cinquanta e Settanta – e lo stesso articolo di Wolfe diventa il soggetto di Il diavolo del volante (The Last American Hero,
69
Lamont Johnson, 1973). Ma nulla del genere si trova in Strada a doppia cor-sia che, pur contenendo tutti gli elementi potenzialmente utili per glorificare un patriottismo aggiornato, rifiuta di metterli in gioco nel modo più banale.
Se l’auto in America, come dice Wolfe, è “fatta per metà di fantasia”, Hel-lman, scettico, si interessa dell’altra metà e rifiuta il minimo investimento di immaginario, rivelando come ossessiva e patologica la pretesa di vedere nelle automobili e nelle gare più di quello che sono, cioè solo delle automobili e delle gare automobilistiche. Esternamente, la Chevrolet del 1955 del Pilota e del Meccanico di Strada a doppia corsia non ha molto di accattivante, e anzi proprio questo (la sceneggiatura è esplicita) li aiuta a vincere le gare e a trarre in inganno tra gli altri pure lo stesso GTO, lui sì con il culto delle auto appariscenti (come direbbe Wolfe, “kolor karamella”).
La gara non ha alcun significato aggiunto, sostiene lo sceneggiatore Rudy Wurlitzer, e vincerla non porta ad alcun cambiamento esistenziale. E così, continua, pure il mito americano della strada, della libertà è appunto solo un mito: non c’è redenzione, non c’è risoluzione, non c’è climax, non c’è finale in Strada a doppia corsia, nulla che possa dare un significato al movimento dei protagonisti attraverso l’America.
Nessun viaggio simbolico, nessuna riscoperta del Paese avviene nel film di Hellman, scrive Galosi, anzi: “Il vecchio mito frontieristico, il whitmanismo che caratterizza tanto nuovo cinema americano è un sottofondo mitologico (ideologico) presente al film, non fosse altro che per il suo materiale die-getico, ma Hellman lo assume e lo lascia costantemente affiorare in modo derisorio”2. In realtà ben più apertamente derisorio sarebbe stato, di lì a pochi anni, il cormaniano Anno 2000, la corsa della morte (Death Race 2000, Paul Bartel, 1975), che ridicolizza in modo fumettistico la pretesa americanità della gara automobilistica da costa a costa.
Sono due le figure cui è tradizionalmente legata la mitologia del viaggio americana: quella del pioniere e quella del vagabondo3. L’avventura del pio-niere ha come fine la conquista dell’America; il suo viaggio ha una meta, o comunque una direzione verso la quale esercitare un’azione civilizzatrice. Il vagabondo invece vive ai margini della società e non ha intenzione di contri-buire al suo consolidamento; la sua azione non è positiva e il suo movimento è caratterizzato dall’assenza di direzione. Al Pilota e al Meccanico manca certo l’entusiasmo del pioniere, mentre la filosofia della strada di GTO si rende presto ridicola. Ma i protagonisti non sono nemmeno dei vagabondi, perché se la figura del vagabondo è certo oppositiva rispetto al mito frontieri-stico, nondimeno trae significato proprio da questa opposizione, si confronta direttamente col mito magari nel rimpianto o addirittura nel tentativo di una sua riformulazione – ed è spesso comunque legata a una rivendicazione li-
70
bertaria4. Invece Strada a doppia corsia si astiene da ogni confronto diretto col mito.
Questo distingue il film di Hellman da molti road movie più o meno suoi contemporanei. A cominciare da Easy Rider – Libertà e paura (Easy Rider, Dennis Hopper, 1969), che sembrerebbe condividere con Strada a doppia corsia, oltre alla lunghezza del viaggio, la direzione del movimento attraverso l’America: da Ovest verso Est, cioè nel verso contrario rispetto a quello di avanzamento del pioniere. Nel caso del film di Hopper questo ha un evidente significato di critica e rinegoziazione del mito della frontiera. Billy e Wyatt infatti – e non è un caso che i loro nomi siano così western – guardano di continuo il paesaggio americano durante il viaggio, lo riconoscono, se lo indi-cano a vicenda e il film non manca di mostrarlo. Il trattamento del paesaggio nel film di Hopper è sentimentale e fotograficamente turistico, addirittura5. I personaggi di Easy Rider ricordano il tempo in cui l’America “era un gran bel Paese” e si chiedono cosa le sia successo. Billy e ‘Captain America’ Wyatt sono incontestabilmente dei patrioti, a loro modo, e se vengono cacciati dalla parata cittadina è perché non tutti comprendono il modo che hanno di ma-nifestarlo.
Tutto il contrario di Strada a doppia corsia, definito infatti da Bonitzer l’“anti Easy Rider”6, nonostante sia stato ovviamente il successo del film di Hopper (per Hellman “una truffa”7) a permettere la produzione di quest’altro film, che si sperava altrettanto giovanilista. Il Pilota e il Meccanico di Strada a doppia corsia non ricordano alcunché, non parlano del passato del loro Pa-ese, né d’altronde si sa nulla del loro passato personale. GTO, da parte sua, ha troppe versioni diverse del proprio passato perché una in particolare sia credibile. Non solo i personaggi del film di Hellman non ricordano nulla, ma non guardano nemmeno il paesaggio, e tengono semmai gli occhi fissi sulla strada. Mancano le scenografie maestose della Monument Valley di Easy Ri-der, ad esempio, ma non solo quelle. Paradossalmente, il paesaggio più spet-tacolare del film è quello dell’oleografica pubblicità di birra che si intravede sulle pareti del roadhouse in Arkansas, simile a un altro paesaggio oleografico significativamente usato come trompe l’oeil in un’inquadratura di Electra Gli-de (Electra Glide in Blue, James William Guercio, 1973).
Strada a doppia corsia è estremamente avaro di inquadrature paesaggi-stiche, cosa davvero inusuale per un road movie. Su una di queste poche inquadrature è utile soffermarsi: quella che mostra, verso la fine del film, la diga di Cheoah, in North Carolina. La diga è alla base di una delle più potenti “narrative dei nuovi inizi” americane, quella che consiste nella “redenzione delle regioni aride” grazie all’ingegneria e alle tecnologie idrauliche8. Basti pensare a come la diga veniva magnificata meno di una decina di anni prima
71
nello spettacolare finale in Cinerama di La conquista del West (How the West Was Won, Henry Hataway, John Ford, George Marshall, 1962). In Strada a doppia corsia viene invece lasciato cadere ogni riferimento simbolico: è sem-plicemente una diga, e non viene mostrata alcuna fascinazione per quello che dovrebbe essere, peraltro, uno spettacolare esempio di “sublime tecnologico americano”, come lo definisce Nye9. L’inquadratura della diga in Strada a doppia corsia, in un certo senso emblematica di tutto il film, è muta e in-capace di rimandare ad altro oltre che a se stessa. Rimane come rovina del rapporto ormai dimenticato che univa simbolo e concetto.
In altre occasioni il cinema della New Hollywood si serve dell’immagine della diga proprio per giocare con i resti di questo rapporto fisso. In Un tran-quillo week-end di paura (Deliverance, John Boorman, 1972) Lewis (altro nome non casuale), pure così ossessionato dalla necessità di ritrovare “lo spirito dei pionieri”, non riconosce alla diga la sua innata americanità e anzi la ritiene causa di ogni male. In Chinatown (Roman Polanski, 1974) serve ai loschi affari privati di un vecchio magnate dell’acqua che lascia a secco una Los Angeles sulla quale incombe la minaccia dell’aridità e del deserto10.
Se in Chinatown e in Un tranquillo week-end di paura intorno alla diga viene articolato un discorso piuttosto revisionista rispetto alla specifica “nar-
Strada a doppia corsia
72
rativa dei nuovi inizi”, in Strada a doppia corsia l’immagine della diga rimane inutilizzata, rovina muta che non attira né critiche né nostalgie. Il problema è a monte, nell’impossibilità di attribuirle la sostanza simbolica che meritereb-be. È questo in fondo quello di cui parla tutto il film, e non è solo la diga ma l’intero paesaggio americano che fatica ad essere riconosciuto e qualificato come tale11.
Il road movie dovrebbe essere “la più perfetta sublimazione dell’espe-rienza americana” e il suo anti-eroe, pur sempre un eroe, dovrebbe incarnare l’innocenza archetipica della nazione. Un po’ westerner ma anche un po’ gangster, cercherebbe di realizzare a modo suo il sogno americano12. Di Easy Rider si è detto, ma anche ai protagonisti di Punto zero (Vanishing Point, Richard C. Sarafian, 1971), Sugarland Express (Steven Spielberg, 1974) e Convoy – Trincea d’asfalto (Convoy, Sam Peckinpah, 1978) vengono esplici-tamente attribuite delle virtù americane. Il protagonista di Punto zero, Ko-valski, nei deliri del DJ radiofonico Super Soul, sarebbe “l’ultimo eroe, il più grande eroe americano, l’incredibile cavaliere del motore, il superpilota
Strada a doppia corsia
73
del fantastico e dorato West…”. Il convoglio del titolo del film di Peckinpah richiama ovviamente le carovane dei pionieri del West, e suona strano che venga ridicolizzato il discorso finale nel quale il governatore paragona (ma per scopi politici) il trucker al cowboy, visto che, come osserva Videtta “le due ore di proiezione hanno proposto esattamente questo paragone mitologico”13. La carovana di camion di Convoy viene accolta con entusiasmo nelle cittadi-ne che attraversa, e così pure i fuggitivi di Sugarland Express, tanto che lo sceriffo del film di Spielberg deve correre ai ripari: “Si mettano bene in testa che non è una festa nazionale!”. Invece in Strada a doppia corsia manca assolutamente ogni patriottismo. Pilota e Meccanico non vanno alla ricerca dell’America, né quindi possono lamentarsi di non trovarla.
All’anti-eroe del road movie tradizionale, destinato inevitabilmente a una morte violenta, si contrappone un sistema repressivo, a volte un po’ ottuso, rappresentato di solito dalla polizia. Non sarebbe possibile immaginare Punto Zero, Zozza Mary, pazzo Gary (Dirty Mary Crazy Larry, John Hough, 1974), Sugarland Express o Convoy senza le forze dell’ordine. Anche in Strada a doppia corsia compaiono per tre volte, ma sono proprio gli inseguimenti della polizia a essere stati tagliati nell’edizione finale (uno, in Arizona, è stato com-pletamente eliminato, e l’altro, a Boswell, è interrotto a metà) e non si sente per nulla la loro mancanza. Evidentemente la loro importanza è nulla dal punto di vista narrativo. Forse, per l’uso spiazzante della polizia rispetto alle convenzioni del genere, Strada a doppia corsia si avvicina a Electra Glide, che è, come è noto, un road movie rovesciato dal punto di vista di un agente della stradale cui manca letteralmente la statura dell’eroe, e che non ama troppo il proprio lavoro né la propria moto.
È vero che sempre, nel road movie, “il paesaggio è vissuto male dai pro-tagonisti, che nella indecifrabilità, nella difficoltà di messa a fuoco, nello spostamento continuo, abitano precariamente il mondo”14. Ma questa, lungi da esserne un ostacolo, sarebbe proprio la condizione preliminare alla mito-poiesi americana tout court: scrive D. H. Lawrence che “in America […] si trova sempre una certa diabolica resistenza nel paesaggio. […] Il paesaggio americano non si è mai identificato con l’uomo bianco. Mai”15. Quello che manca in Strada a doppia corsia è invece proprio la minima sofferenza per la separatezza, la minima ambizione a un legame organico con lo spazio americano.
Insomma, attraversare l’America potrebbe essere la migliore occasione per confrontarsi coi miti americani della mobilità, della frontiera, della fondazio-ne o eventualmente della rifondazione nazionale, ma Strada a doppia corsia sembra invece disinteressarsene. Eppure Hellman crede davvero che attra-versare l’America in automobile serva a fare esperienza del Paese nel modo
74
migliore, mentre invece sorvolarlo in aeroplano in poche ore non arricchirebbe in alcun modo la conoscenza della nazione16. È per questo che ha scelto di girare in sequenza per le vere strade d’America e nelle vere località indica-te in sceneggiatura: Needles in California, Flagstaff in Arizona, Santa Fe e Tucumcari nel New Mexico, Boswell in Oklahoma, Little Rock in Arkansas, Memphis in Tennessee. L’intento è quello di rendere il viaggio più realistico, ma il mito, che ha poco di realistico, messo alla prova non risponde e manca di attivarsi. L’impressione infatti, nota Ciment, è quella di uno spazio indif-ferenziato, nonostante Hellman, convinto del valore documentario del film, obietti che lo spazio per lui non è per nulla neutro, che il Nuovo Messico non è l’Oklahoma, e ribadisca di non aver mai utilizzato una scena fuori dal suo contesto geografico17.
Nei discorsi dei personaggi di Strada a doppia corsia ricorrono spesso riferimenti topografici (alcuni solo in sceneggiatura): Bakersfield, San Fran-cisco, Denver, Seattle, New Orleans, Montreal, Boston, New York, Chicago, il Messico, l’Arizona, St. Petersburg, Miami e la Florida, Columbus in Ohio, e ovviamente Washington, meta infine dimenticata. Sono i luoghi sui quali i personaggi esprimono un loro parere, i luoghi da dove dicono di provenire o verso i quali pensano di essere diretti, o dove pretenderebbero addirittura di rimanere stabilmente. Ma sono luoghi solo nominati e mai raggiunti, che sembrano esistere solo nelle loro parole. Delle parole di GTO non ci si può fidare, né dei suoi ricordi né dei suoi progetti, ma anche alle città citate dagli altri personaggi è difficile dare una consistenza reale, immaginare che ci sia altro oltre alla toponomastica. I nomi di città nel film hanno certamente qual-che relazione con il romanzo Flats di Wurlitzer, pubblicato proprio nel 1970, come risponde Hellman intervistato da La Polla18. In Flats, Memphis, Omaha, Flagstaff, Halifax, Abilene e gli altri non sono nomi cui corrispondono città, ma invece nomi di personaggi, o piuttosto di diversi sentimenti dello spazio personificati, di stati di coscienza tutti peraltro inadeguati.
Strada a doppia corsia attraversa un Paese privato di quello che dovrebbe essere il suo immaginario, così come altri film coevi, per esempio La rabbia giovane (Badlands, Terrence Malick, 1973) e, ancora, Un tranquillo week-end di paura, mostrano proprio la scollatura tra paesaggio, avventura nello spazio e investimento di significato culturale. Quello di Malick “può essere inter-pretato come un film su come viene realizzata la significazione: come storie, narrazione, fantasie di fuga e memoria tentano di dare significato a una su-perficie senza profondità”19. Kit, il protagonista di La rabbia giovane, finisce la propria avventura ancora convinto di aver vissuto un mito valido, quando invece il film mostra chiaramente che quello che ha abitato è un immaginario di seconda mano. Nel film di Boorman i personaggi pretendono di ritrovare
75
nella natura il perduto spirito pionieristico, ma quegli spazi che si volevano incontaminati si ribellano alle loro fantasie. In Strada a doppia corsia invece nessuno cerca di rimarginare la frattura tra spazio, movimento e immagi-nario, a parte forse GTO, ma i suoi millantati rimbalzi da una parte all’altra dell’America non riescono proprio ad assurgere a una dimensione mitica.
Se lo spazio resiste a una ‘misattribuzione’ di valori, la muta toponomasti-ca è tutto ciò che resta. Come in altri film dell’epoca, l’America rivela di esse-re davvero solo un ‘posto nella mente’. In Un uomo da marciapiede (Midnight Cowboy, John Schlesinger, 1969) Rico arriva nella tanto sognata e nominata Florida solo da morto. “Quando dicono ‘Bolivia’, tu pensa alla California” dice Butch a Kid in Butch Cassidy (Butch Cassidy and the Sundance Kid, George Roy Hill, 1969), ma la vera Bolivia non è certo all’altezza delle aspettative e, se l’equazione è vera, la California, cioè l’America, deve mostrare al con-tempo il suo carattere di invenzione (per l’Australia sarà ancora peggio: i due hanno appena il tempo di immaginarla prima di essere uccisi). La separatezza tra il territorio e la sua mitologia può produrre delle vere aberrazioni e portare a girare un western in Perù, come in Fuga da Hollywood (The Last Movie, Den-nis Hopper, 1971). Non sorprende che questo porti alla ribellione dei nativi, che accusano gli americani di aver loro rubato i set.
In Strada a doppia corsia è come se lo scenario mitico fosse stato sottrat-to. L’effetto è quasi quello di un road movie girato in terra straniera, cioè di un film privato dell’americanità che gli spetterebbe, proprio come il western sudamericano di Hopper (Fuga da Hollywood, come Strada a doppia corsia, fa parte di quel pugno di ‘nuovi’ film supervisionati per la Universal da Ned Tanen). Forse non è un caso che la maggior parte dei progetti non realizzati di Hellman, come osserva Brad Stevens, tratti proprio di americani all’estero20. Non è fuori luogo allora citare Wenders, un cineasta cui Hellman si sente mol-to legato, e che più volte ha raccontato di stranieri in America. Nella prima parte di Alice nelle città (Alice in den Städten, 1973), un film che Hellman ama molto, il paesaggio americano non soddisfa il fotogiornalista tedesco che non è nemmeno capace di scrivere una storia sul Paese. Lo spazio, nel film di Wenders come in quello di Hellman, delude chi da esso pretende troppo, ma se la delusione nel film tedesco ha voce sullo schermo, in quello americano deriva, nella ricezione, dalla frustrazione dell’orizzonte d’attesa del genere.
Una breve inquadratura di Strada a doppia corsia può servire a illustrare il difficile rapporto dei personaggi con la geografia americana. La mappa stra-dale degli Stati Uniti, aperta sul cofano della Pontiac GTO, viene tenuta ben distesa dal Meccanico che evidenzia sbrigativamente il percorso della gara. Ma quando resta il solo GTO, un po’ distratto e confuso, a tenerla ferma sul cofano della propria auto, sembra che la mappa si ribelli e che il vento debba
76
portarsela via. GTO, senza ripiegarla per bene, la getta sui sedili posteriori. Anche in altri road movie ‘deboli’ i personaggi hanno uno strano rapporto con la mappa stradale: in La rabbia giovane Holly la guarda come se fosse un libro delle favole, mentre in Non torno a casa stasera (The Rain People, Francis Ford Coppola, 1969) Killer afferma che intendeva comprarla ma che poi, semplicemente, se n’è dimenticato.
Pure la storia produttiva della pellicola sembra confermare un senso di disorientamento. Warren Oates, parlando del fatto che agli interpreti era stata negata la sceneggiatura e che quindi non sapevano che cosa li aspettasse, usa una metafora topografica: gli attori non avevano una “road map” per orientarsi21.
Al movimento di Strada a doppia corsia non corrisponde un itinerario morale. Per questo si è pure citato Falso movimento (Falsche Bewegung, Wim Wenders, 1975), road movie tedesco (se l’espressione ha un senso) che sembrerebbe mostrare uno spostamento altrettanto deludente, tuttavia evidentemente intriso di cultura germanica (Goethe e Eichendorff innanzi-tutto). Ben più dei film di Wenders, che non mancano di interrogarsi sempre esplicitamente e spesso verbosamente sul significato dei movimenti mostrati, Strada a doppia corsia aspira a essere un road movie “fenomenologico”22. Ma un road movie fenomenologico, che ignori cioè quella sostanza mitica che fonda il genere e che si limiti a mostrare il movimento attraverso il nudo spazio, uno spazio non qualificato, da un punto a un altro, è impossibile e contraddittorio.
D’altra parte le strade di un’America sempre attraversata e poco mostrata sembrano l’unico posto abitabile dai protagonisti del film. Le fantasie fami-liari di Strada a doppia corsia sono in partenza destinate alla frustrazione e automaticamente, enunciate da GTO, diventano bugie (nel roadhouse: “We’re a big family, but we know how to keep it together”). Vicini al film di Hellman sono allora altri road movie deboli come Non torno a casa stasera, Cinque pezzi facili (Five Easy Pieces, Bob Rafelson, 1970) e in parte Alice non abita più qui (Alice Doesn’t Live Here Anymore, Martin Scorsese, 1975), tutti più o meno velleitari tentativi di allontanamento da casa. Al contrario di Sugarland Express, nel quale il movimento avrebbe invece come obbiettivo la ricostru-zione del nucleo famigliare. Da questo punto di vista Strada a doppia corsia si colloca proprio all’opposto di un’altra pellicola del 1971, Cane di paglia (Straw Dogs, Sam Peckinpah), così incentrata sul tema della violazione della casa e della sua difesa, sebbene in effetti interpreti in modo sintomaticamen-te diverso la medesima insicurezza culturale.
Mentre in Le colline blu la baracca che serve da rifugio ai banditi viene incendiata, come anche la casa nel finale di Amore piombo e furore, in Strada
77
a doppia corsia, è la stessa pellicola a prendere fuoco, inadeguato contenitore di un’elegia nazionale. Al movimento sulla strada corrisponde ovviamente il movimento della pellicola nel proiettore, come già annunciato dai titoli di testa, e l’ultima scena decreta quindi il fallimento di entrambi. Un finale imparentato con altri finali metacinematografici simili dell’epoca, come la ripetuta scena della morte di Kansas in Fuga da Hollywood e la pellicola del filmino familiare di Il re dei giardini di Marvin (The King of Marvin Gardens, Bob Rafelson, 1972) che scorre fino a esaurirsi e a bloccare il proiettore.
L’ambizione del road movie più tradizionale sarebbe di aggiornare il we-stern, proprio quando però, ormai da un paio di decenni, “il grande protago-
Monte Hellman sul set di Strada a doppia corsia
78
nista scenografico e ideologico del western classico, lo spazio, si [è ristretto], o quantomeno [ha visto] ridursi il proprio senso, il proprio valore, il proprio destino”23. È questo che traspare da un road movie depotenziato come Strada a doppia corsia, che proprio non presentando espliciti riferimenti al genere western come Easy Rider o Punto zero fa in ogni momento avvertire la loro mancanza, lasciando al loro posto non la nostalgia ma solo il vuoto, e i per-sonaggi come dei rifugiati, orfani inconsapevoli di un immaginario spaziale in rovina, oltre che, come osserva Galosi, di un immaginario amoroso altrettanto perduto (Hellman considera Strada a doppia corsia un film d’amore).
Eppure Wurlitzer, che ama i romanzi e i film western, trova che comunque al film rimanga un residuo metaforico dell’America. Non tanto nel senso ro-mantico e trascendentale che assume la strada nel romanzo beat di Kerouac, però. Strada a doppia corsia sarebbe per Wurlitzer più simile al viaggio che lo scrittore e supereroe controculturale Ken Kesey intraprese verso la metà degli anni Sessanta attraversando (e filmando) con i Merry Pranksters l’Ame-rica da costa a costa (anche in quel caso da Ovest verso Est). Si direbbero due esperienze del Paese ben diverse, eppure forse hanno propositi analoghi. Nel caso di Kesey veniva messo in discussione quanto c’era di vero nei miti libertari assegnati al viaggio americano proprio nell’ostentazione chiassosa di un caricaturale patriottismo itinerante. Il film di Hellman, similmente ma con una strategia opposta, indifferente all’americanissimo stile ‘barocco ae-rodinamico’, all’altrettanto americano ‘sublime tecnologico’, alla retorica ne-ofrontieristica, alle convenzioni del road movie, fatta tabula rasa insomma di ogni patriottismo, mette alla prova la validità del mito del viaggio attraverso gli Stati Uniti facendolo scontrare con il mutismo di un paesaggio che in ogni occasione sembra indifferente.
Solo nell’ultima scena il film mostra, prima della partenza della gara, già senza sonoro, una breve soggettiva del Pilota che guarda a sinistra il paesag-gio fuori dal finestrino. Nel controcampo sembra per un attimo che il Pilota intuisca qualcosa di quel paesaggio, che per la prima volta lo sfiori la con-sapevolezza che avrebbe potuto guardarlo in modo diverso (o semplicemente guardarlo).
79
1 Tom Wolfe, La baby aerodinamica kolor karamella, Feltrinelli, Milano 1969, p. 10. Lo sceneggiatore Rudy Wurlitzer è consapevole che l’automobile è il miglior esempio della creatività americana, come afferma nel commento dell’edizione dvd Criterion di Strada a doppia corsia.
2 Fausto Galosi, Two-Lane Blacktop: un road movie funereo, “Cinema e cinema”, n. 21, ottobre-dicembre 1979, pp. 121-128.
3 Cfr. Marco Videtta, La Fuga Impossibile. Il mito del viaggio nel cinema americano da Huckleberry Finn a Easy Rider, Napoleone, Roma 1980, pp. 28-36.
4 Cfr. Kenneth Allsop, Ribelli vagabondi nell’America dell’ultima frontiera. L’hobo e la sua storia, Laterza, Bari 1969.
5 Cfr. Henrik Gustafsson, Out of Site. Landscape and Cultural Reflexivity in New Hollywood Cinema 1969-1974, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 2007, p. 62 e segg.; Franco La Polla, Il nuovo cinema americano (1967-1975), Marsilio, Venezia 1978, p. 38 e segg.
6 Pascal Bonitzer, Lignes et voies (Macadam à deux voies), “Cahiers du cinéma”, n. 266-267, maggio 1976, pp. 68-71.
7 Romuald Karmakar, Ulrich von Berg, Monte Hellman: finale aperto, p. 69, in AA.VV., Bergamo Film Meeting 1990, pp. 69-74. Anche Wurlitzer sostiene che Strada a doppia corsia sia (visivamente) l’“opposto” di Easy Rider.
8 David E. Nye, America as Second Creation. Technology and Narratives of New Beginnings, The MIT Press, Cambridge-London 2003, p. 220. Cfr. pp. 205-259.
9 David E. Nye, American Technological Sublime, The MIT Press, Cambridge-London 1996.
10 Henrik Gustafsson, op. cit., p. 167 e segg.
11 Duel (Steven Spielberg), altro road movie (a sua volta anomalo) del 1971, è ben
più esplicito nel mostrare i sintomi dello stravolgimento dell’immaginario dei grandi spazi americani, spazi non redenti né salvifici.
12 Marco Videtta, op. cit., pp. 72 e segg.
13 Marco Videtta, op. cit., p. 132.
14 Alberto Morsiani, Scene americane. Il paesaggio nel cinema di Hollywood, Pratiche, Parma 1994, p. 55.
15 David H. Lawrence, Classici americani, Bompiani, Milano 1966, p. 78.
16 Lo sostiene nel commento dell’edizione dvd Criterion del film.
17 Cfr. Michel Ciment, Entretien avec Monte Hellman, “Positif”, n. 150, maggio 1973, pp. 51-64.
18 Franco La Polla, “Reazionario” innovatore, “Cineforum”, n. 297, settembre 1990, pp. 17-21.
19 Jonathan Bignell, cit. in Henrik Gustafsson, op. cit., p. 128 (traduzione mia).
20 Cfr. Brad Stevens, Monte Hellman. His Life and FIlms, McFarland & Company, Jefferson-London 2003, p. 140.
21 Susan A. Compo, Warren Oates. A Wild Life, The University Press of Kentucky, Lexington 2009, p. 221.
22 Di Strada a doppia corsia come road movie fenomenologico Wurlitzer parla nel commento del dvd Criterion. Per la dimensione fenomenologica dei road movie di Wenders cfr. Luca Antoccia, Il viaggio nel cinema di Wim Wenders, Dedalo, Bari 1994, p. 33 e segg.
23 Franco La Polla, Consummatum west, ovvero: sulla traslazione retorica di un mito cinematografico americano, in id., Stili Americani, Bononia University Press, Bologna 2003, pp. 265-272.