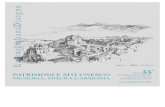Definizione dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
Transcript of Definizione dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
Alessandro SaggioroSapienza – Università di Roma
1. Questione dello spazio a Roma arcaica e defi nizione del paganesimo come oggetto controverso; continuità e durata
La gestione dello spazio è uno dei cardini o dei caratteri fortemente ca-ratterizzanti la religione di Roma arcaica. La concettualizzazione dello spazio ha infatti una serie di correlazioni signifi cative con tutta la re-altà esistenziale e culturale: è, al tempo stesso, realtà concreta, luogo di gestione della quotidianità e dell’esistenza materiale, e realtà simbolica, rimando a signifi cati altri, accezione cristallizzata del vivere, dialettica narrativa e rituale. Lo spazio cittadino e quello rurale, quello pubblico e quello privato, quello sacro e quello profano, quello degli dèi e quello degli uomini, lo spazio proprio e quello dei nemici, quello dei vivi e quello dei morti… tutte le singole accezioni hanno una declinazione complessa, che si può articolare nelle dialettiche fra identità e alterità, fra realtà im-mediata e rimando simbolico, fra natura e cultura. Tutte articolazioni di senso, che qui sono costretto a sintetizzare in maniera succinta, che hanno ragione di essere attraverso i secoli, in diverse accezioni e situazioni, con in più, dunque, una diacronia che complica a dismisura il discorso.
Il problema dello spazio fu uno dei più signifi cativi della fondazione di Roma1: non a caso la sua defi nizione, mitica e rituale, occupa un ruolo importante nella letteratura2. I territori dei colli, che sarebbero poi stati
1 Per una raccolta delle fonti inerenti i rituali di fondazione della città cf. Briquel 1987, Colonna 2004.
2 Paradigma dell’analisi delle simbologie spaziali per la Roma arcaica resta il volume di
7_Saggioro.indd 1437_Saggioro.indd 143 02/07/2015 16:19:4702/07/2015 16:19:47
Alessandro Saggioro
[ 144 ]
occupati dalla Città per eccellenza, dovevano essere stati ostili e ben poco ospitali per le prime comunità. Le prime costruzioni, di cui gli archeologi hanno rintracciato le rarefatte vestigia, andavano a occupare luoghi in cui trionfava una natura selvaggia. Trasformare rade baracche in uno degli agglomerati urbani più importanti del mondo antico fu un’impresa che dobbiamo per forza di cose defi nire mitica, non solo nell’accezione tecnica storico-religiosa in senso proprio, ma anche in quella corrente del linguaggio contemporaneo: sia perché si trattò per certo di un evento proprio eccezionale, fuori di una qualsiasi norma umana e fuori misura; sia perché in senso letterale ciò che ce ne viene tramandato è sostanzial-mente mito di fondazione, ad opera di esseri a un tempo sovrumani e mostruosi3.
Scaturita da condizioni estreme, consolidata attraverso guerre epiche, nobilitata da un passato remoto elevato agli onori delle più raffi nate forme di letteratura e di rinarrazione dei miti di fondazione, la città di-veniva così, quasi facilmente, faro e punto di riferimento della storia del Mediterraneo: da umile agglomerato di capanne di pastori a centro ne-vralgico di un impero, luogo di costruzioni magnifi che e di monumenti eterni, abitato civile con molteplici stratifi cazioni socio-culturali, diffe-renziate funzioni istituzionali, variegate connotazioni.
Questa storia complessa presenta certamente forti tratti di continuità. Vale, questo discorso, per il semplice fatto che i luoghi, una volta defi niti e istituiti, una volta costruiti per durare, sono rimasti in piedi nei secoli, e rimangono tutt’ora, vedendo mutato il proprio signifi cato, le destinazioni d’uso, le rappresentazioni4; nel senso che una volta edifi cato, un oggetto concreto e reale porta in sé caratteristiche sue proprie, che possono ap-partenere a sistemi valoriali, a sfere semantiche, a reticolati complessi di segni che lo contraddistinguono e che stanno lì a riplasmarne nel tempo l’identità5.
Oltre alla continuità degli oggetti spaziali in sé, si deve fare cenno brevemente anche alla continuità dei sistemi religiosi. La dicotomia pa-
Piccaluga 1974. Per considerazioni relative alla simbologia dei confi ni in relazione ad aspetti giuridico-religiosi si veda Catalano 1978. Sintesi recente in De Sanctis 2014.
3 Rimando anche in questo caso a un “classico” intramontato: Brelich 2010.
4 Per un primo approccio si faccia riferimento a Steinby 1999-2003, Fiocchi Nicolai – Granino Cecere – Mari 2001-2008.
5 Smith 1987, Smith 2004, pp. 323-339.
7_Saggioro.indd 1447_Saggioro.indd 144 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
[ 145 ]
ganesimo-cristianesimo, cui questo intervento fa riferimento, viene rap-presentata come rottura, a un certo punto, della storia. È noto a tutti che l’idea stessa di paganesimo come religione coerente si defi nisce solo per reazione dialettica e sostanziale rispetto al cristianesimo6. Solo la costi-tuzione di un concetto autonomo di religione rende possibile l’elabora-zione di una serie di religioni che condividono uno spazio, che si trovano in contrapposizione, che interagiscono. Interazione, come vedremo più avanti, signifi ca anche in questo caso, potenzialmente, continuità: osmosi fra paradigmi, azioni, fi gure; sovrapposizione fra luoghi, situazioni, spazi, contesti. L’uso della dialettica paganesimo-cristianesimo impone anche uno sguardo emico rispetto a questi concetti, a partire dalle coordinate esistenziali dei rispettivi sistemi religiosi: sguardo dal di dentro che assu-merà come punto di osservazione proprio la defi nizione degli spazi sacri.
2. La questione spaziale come problematica interrelata a fat-tori religiosi
Ancora in termini generali, non ci si può astenere dal prendere nota del fatto che la questione spaziale, per l’orizzonte che qui inizialmente consideriamo, ovvero quello della religione della Roma pre-cristiana, è strettamente interrelata e intrecciata con altri importanti sistemi di signifi cato. Come si è già detto, tutta la vicenda arcaica di Roma è ca-ratterizzata da una particolareggiata narrativa di fondazione che è an-zitutto fondazione spaziale7: i luoghi in cui la città dovrà sorgere ven-gono defi niti, delimitati, contrassegnati a un livello mitico8, che vuole anche essere, al tempo stesso, fondazione di rituali, di comportamenti, di gestualità che si ripeteranno nel tempo. Così, gli spazi costruiti e edi-fi cati, sottratti alla natura e ad altre funzioni sacrali, si insinueranno nel tempo a conservare e rinarrare quelle tradizioni di fondazione; saranno oggetti narranti, sia rispetto alla loro storia, sia rispetto alle correla-
6 Su questo tema, leit motiv di parte signifi cativa della ricerca di D. Sabbatucci, si veda ora Saggioro 2011.
7 La produzione bibliografi ca sulle origini di Roma è sterminata: si rinvia pertanto alle bi-bliografi e contenute in Cornell 1995, Forsyth 2005, Grandazzi 2008. Per un orientamento critico nell’approccio a tale bibliografi a cf. Ampolo 2013.
8 Si pensi al valore simbolico che la tradizione attribuiva al sulcus primigenius. Su questo aspetto cf. Citarella 1980.
7_Saggioro.indd 1457_Saggioro.indd 145 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Alessandro Saggioro
[ 146 ]
zioni con gli spazi circumvicini. Mi sembra appena il caso di ricordare che, rispetto alla questione della così detta demitizzazione romana9, un cinquantennio fa Brelich suggerì che quei racconti dei miti divini, che la romanità non sembrava avere come prodotti propri, potevano al-tresì essere rintracciati nelle disposizioni dei templi, nella prossimità dei luoghi, nelle continuità spaziali dell’Urbe10. Al tempo stesso, queste con-tiguità spaziali hanno riscontro nel calendario11: le scansioni festive, le ricorrenze, le articolazioni periodiche non possono essere pensate come casuali concrezioni di eventi senza nessi, ma devono essere riconosciute per le costruzioni simmetriche, le assonanze, le contiguità12. Le defi ni-zioni degli spazi sacri non sono isolate ma fanno parte di una rete di sovrastrutture simboliche in cui si incastonano narrative mitiche, azioni rituali, scansioni calendariali. Un altro aspetto è dato dai percorsi: la via sacra come fi lo conduttore interiore, le grandi vie consolari come tramite rispetto all’esterno, il pomerium come delimitazione sacrale dell’interno, le mura come demarcazione rispetto all’esterno13; simil-mente, i percorsi nel tempo lineare e storico, da una festività all’altra, da un mese all’altro, da un anno all’altro, passando attraverso la scan-sione mensile in idi e calende, tempi sacri ogni volta connotati da ca-ratteristiche proprie, in un insieme generale di grande complessità e pregnanza14.
9 Su questo aspetto cf. Dumézil 1966, Montanari 2001.
10 Brelich 1966, pp. 227-228. Sul tema della demitizzazione cf. Sabbatucci 1975, Monta-nari 1976. Per una storia dei luoghi, nello specifi co il Palatino, cf. Coarelli 2012.
11 Per la documentazione e la struttura del calendario romano Degrassi 1963.
12 Per una storia del calendario romano e della scansione e percezione del tempo cf. Michels 1967, Fraschetti 1989, Liou-Gille 1992, Morelli 1993; sui mutamenti intervenuti nella scansione del tempo in seguito all’interazione tra cultura pagana e cristianesimo cf. Salzman 1990, Di Berardino 2005, Belayche 2007.
13 Magdelain 1976, Andreussi 1988, De Sanctis 2007. Sulla funzione puramente sim-bolica del pomerium cf. Liou-Gille 1993; ulteriori posizioni e aspetti in Lindersky 1986, Mastrocinque 1998, Coarelli 2000.
14 La complessità di quanto affermato non sarebbe esauribile in una sintetica bibliografi a. Mi limito dunque a rimandare, per la dimensione temporale non disgiunta da quella spa-ziale, a Sabbatucci 1988. Cf. anche Samuel 1972, Brind’amour 1983, Rüpke 2011.
7_Saggioro.indd 1467_Saggioro.indd 146 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
[ 147 ]
3. Individuazione di rituali particolari di ‘defi nizione’
In generale, possiamo parlare di spazio degli dèi e spazio degli uomini. Il primo può essere in misura maggiore o minore riservato: si possono dare luoghi naturali immaginati come integrali riserve della presenza divina, al cui interno è interdetta qualsivoglia intrusione umana; e si possono dare delle enclaves interne agli spazi umani, ovvero quelle aree consacrate su cui edifi care i templi, che saranno luoghi di condivisione e interazione potenzialmente profi cua fra le due aree15. Il secondo, lo spazio degli uo-mini, è sempre concepito come sottratto al divino, o da esso reso fruibile in conseguenza di un patto, di un accordo, sancito da un rituale16. La natura, originariamente sottostante a un controllo divino diffuso, viene desacralizzata, al fi ne di essere messa a disposizione delle esigenze umane; la culturalizzazione implica la realizzazione di rituali iniziali, ovvero la loro reiterazione, ove possibile, anche con un atto simbolico di stabilizza-zione attraverso l’edifi cazione di templi, are etc.
Ad esempio, come troviamo nel De agri cultura di Catone, penetrare in un lucus al fi ne di compiervi dei lavori agricoli signifi cava entrare nella sfera controllata da una divinità, potenzialmente ignota, che subiva una violazione: per porre rimedio a questa situazione, si rendeva necessario un sacrifi cio espiatorio, che avrebbe profanato lo spazio, ovvero lo avrebbe messo nella disponibilità temporanea degli uomini. Della formula ripor-tata da Catone colpisce, in particolare, l’incertezza del destinatario: dice infatti «si deus, si dea es, quoium illud sacrum est»; ovvero: l’apparte-nenza dello spazio a un’alterità divina è certa, pur nell’incapacità di in-tendere l’identità divina stessa; sì che il sacrifi cio espiatorio deve essere necessariamente celebrato in maniera generica, con la certezza però che andrà a buon fi ne, ovvero accontenterà la sfera divina, quale che ne sia il rappresentante specifi co17.
15 Per un approfondimento di queste dinamiche in relazione a Roma cf. Gros 2007.
16 Riguardo i riti di consecratio, dedicatio, inauguratio etc. cf. Magdelain 1977, Espejo Muriel 1997.
17 Cat., Agr., 139: «Lucum conlucare Romano more sic oportet: porco piaculo facito, sic verba concipito: “Si deus, si dea es, quoiium illud sacrum est, uti tibi ius est porco piaculo facere illiusce sacri coercendi ergo harumque rerum ergo, sive ego sive quis iussu meo fecerit, uti id recte factum siet, eius rei ergo hoc porco piaculo immolando bonas preces precor, uti sies volens propitius mihi domo familiaeque meae liberisque meis: harumce rerum ergo macte hoc porco piaculo immolando esto”». Cf. Dumézil 1975, pp. 46 sgg.
7_Saggioro.indd 1477_Saggioro.indd 147 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Alessandro Saggioro
[ 148 ]
Più complessi sono i rituali di costruzione di templi e in generale di edifi ci sacri. In questi casi devono intervenire gli augures, che hanno il compito di tracciare nello spazio l’area da destinare alla nuova costru-zione18. L’atto di questi sacerdoti viene concepito come una liberazione da altri impegni simbolici del territorio stesso, laddove per procedere a una nuova imposizione di senso sacro – quella imposizione che si sarebbe determinata con la nuova costruzione – è anzitutto necessario assicurarne la disponibilità; al tempo stesso, l’area viene delimitata e defi nita, per circoscrivere questa disponibilità, che consiste in una desacralizzazione, ovvero in una sottrazione ad altre presenze, potenzialmente sottostanti e ignote19. In seguito intervenivano i pontifi ces, che potevano risacralizzare l’area, ovverosia consacrarla in maniera mirata20. Sulla base del tipo di auspicio ricavato dai sacrifi ci, si poteva determinare la costruzione di un tempio, ovvero di uno spazio che avrebbe avuto una valenza simbolica anche sul piano istituzionale, in cui sarebbe stato possibile riunire il se-nato e amministrare gli affari dello stato (Serv. Dan., VA I 446).
Le due azioni, quella di liberare uno spazio naturale e quella di edi-fi care un templum, coincidono nella individuazione e edifi cazione sim-bolica del nucleo stesso della città che sarebbe stato il Capitolium. Nel racconto virgiliano, l’avvento di Enea e l’incontro con Evandro impli-cano la necessità di riconoscere a quei luoghi una totale occupazione da parte di forze divine non identifi cabili, con cui sarà necessario scendere a patti. Nel racconto dell’VIII libro dell’Eneide si vedono in compresenza i luoghi che furono, ovvero le rocche di Giano e di Saturno, quelli che sono, ovvero un bosco frondoso che occupa la vetta del Campidoglio e incute sacro timore, e quelli che saranno, ovvero i templi aurei del tempo di Augusto, affi ancati dall’Asylum di Romolo, dal Lupercale, dalla rupe Tarpea. Al centro di questa grandiosa costruzione temporale, si dovrà ergere il tempio di Iuppiter, che però Evandro, nel rivolgersi a Enea, non sa individuare come dio del luogo. Anche in questo caso troviamo una formula che denota incertezza: «Hoc nemus, hunc» inquit «frondoso vertice collem (quis deum incertum est) habitat deus» (Verg., Aen. VIII 351-352)21. Sarebbe passato ancora del tempo prima che Lucio Tarquinio
18 Su questi temi si rimanda al testo fondamentale di Catalano 1960.
19 Su questi aspetti cf. Guittard 2009.
20 Cf. Catalano 1978, pp. 467 sgg., Bouché-Leclercq 1975, pp. 187 sgg.
21 Capdeville 2014, pp. 809-810.
7_Saggioro.indd 1487_Saggioro.indd 148 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
[ 149 ]
Prisco, in seguito alla vittoria sui Sabini, decidesse di avviare i terraz-zamenti necessari alla costruzione del tempio (Dion. Hal. 3, 69). Livio racconta che la fondazione sarebbe stata anche interrotta da una vera e propria crisi diplomatica con le divinità del luogo: infatti, al momento dell’intervento degli àuguri, sia Terminus che Juventas e Mars avrebbero rifi utato di andarsene, fi nendo per essere inglobati di fatto nel culto capi-tolino22. Emblematico, per la questione spaziale, il caso di Terminus e del suo complesso sacrale. Al 23 febbraio si celebravano i Terminalia23, che avevano al centro del rito Terminus, pietra di confi ne e dio tutelare ad essa corrispondente: la caratteristica del dio era quella dell’immobilità, garanzia dei confi ni delle proprietà agricole, così come dei confi ni del territorio pubblico, sì che in occasione della festa avvenivano celebra-zioni sia private, fra i proprietari di campi confi nanti, sia pubbliche, in un’area al sesto miglio della via Laurentina. La richiesta umana rivolta a Terminus consiste proprio nell’esortazione all’immobilità, che è garanzia dell’ordine. Dunque, in occasione dell’inaugurazione dello spazio in cui si sarebbe dovuto collocare il tempio di Iuppiter, Terminus, coerente con il proprio ruolo, rifi utò di spostarsi e fu inglobato nella costruzione: ciò avrebbe determinato la tutela dei confi ni come fatto privato, interno, ma anche la possibilità, per Roma, di estendere a dismisura i propri confi ni fi no a rivolgersi alla conquista del mondo conosciuto. La sovrapposi-zione spaziale fra le due divinità nel centro dell’impero risulta dunque funzionale alla prospettiva ideologica di conquista24.
4. Il templum come spazio di rottura in autori cristiani
La forza ideologica e politica degli spazi sacri, esaltata dall’opera di re-stauro avviata da Cesare e realizzata su larga scala da Augusto25, divenne poi un punto di crisi con il cristianesimo.
Me ne occupo in maniera necessariamente sintetica, in rapporto a due autori, Tertulliano e Agostino, per mostrare due volti o due fasi della po-lemica. Nel primo caso l’autore ironizza sulla funzione del tempio come
22 Piccaluga 1974, pp. 196 sgg.
23 Oltre a Piccaluga 1974, cf. Campbell 1996.
24 Cf. De Sanctis 2012, in part. il cap. 2, “Luoghi”, pp. 41-65, e De Sanctis 2014.
25 Per una panoramica sull’opera restauratrice di Augusto e i suoi risvolti propagandistici cf. Zanker 1989.
7_Saggioro.indd 1497_Saggioro.indd 149 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Alessandro Saggioro
[ 150 ]
ricettacolo di una cattiva gestione del divino, paragonabile a quella at-tuata nei teatri. Un passaggio emblematico è nell’Apologeticum, opera dunque di difesa ma anche di contrattacco teologico-giuridico-morale. Il tempio, come problema, emerge dopo che Tertulliano si è a lungo soffer-mato a criticare la presenza degli dèi sulla scena degli spettacoli – gli effe-minati pantomimi che mettono in scena gli amori di Iuppiter, le passioni e le vicende più favolistiche degli dèi26; le violenze del teatro, del circo e dell’anfi teatro, in cui i racconti mitici venivano realizzati in concreto, mutilando Attis o bruciando vivo Herakles. La dialettica del polemista critica direttamente queste azioni aprendo una comparazione diretta con lo spazio del tempio, in cui si compiono azioni non diverse. Le prime, apertamente deprecabili (dal suo punto di vista) per il disprezzo implicito nei confronti delle divinità rappresentate e degli uomini che le devono rappresentare, sono ludicra, sono fi nzioni sceniche, e si collocano in uno spazio sacro che viene declassato a ecclesia diaboli; le seconde, le azioni sacre che si compiono nel tempio, vengono qui chiamate in causa per analogia, al fi ne di ridimensionare portata e signifi cato del rituale, rap-porto fra uomini e dèi, spazio stesso in cui si realizza quel rapporto, che viene sminuito e annichilito:
nei vostri templi si combinano adulteri, […] tra gli altari si tengono infami mercati, […] nei tabernacoli stessi dei custodi e dei sacerdoti, sotto le medesime bende, sotto le mitrie e la porpora, mentre l’incenso brucia, si dà sfogo alla libidine […] mi chiedo se i vostri dèi non deb-bano dolersi più di voi che dei cristiani27.
Più oltre Tertulliano evoca una religiosità romana risalente, quella isti-tuita da Numa, in cui non erano ancora presenti templi e simulacri, e in cui frugalità e povertà trionfavano in piccoli altari improvvisati e umili
26 Tert., Apol. XV 2: «Sed et histrionum litterae omnem foeditatem eorum designant. Luget Sol fi lium de caelo iactatum laetantibus vobis, et Cybele pastorum suspirat fasti-diosum non erubescentibus vobis, et sustinetis Iovis elogia cantari, et Iunonem Venerem Minervam a pastore iudicari».
27 Tert., Apol. XV 7: «Sed ludicra ista sint! Ceterum si adiciam, quae non minus conscien-tiae omnium recognoscent, in templis adulteria componi, inter aras lenocinia tractari, in ipsis plerumque aedituorum et sacerdotum tabernaculis, sub isdem vittis et apicibus et purpuris thure fl agrante libidinem expungi, nescio, ne plus de vobis dei vestri quam de Christianis querantur. Certe sacrilegi de vestris semper apprehenduntur; Christiani enim templa nec interdiu norunt; spoliarent forsitan ea et ipsi, si et ipsi ea adorarent».
7_Saggioro.indd 1507_Saggioro.indd 150 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
[ 151 ]
offerte28. In quel tempo, soprattutto, non c’era un Campidoglio a innal-zarsi sprezzante verso il cielo e non erano ancora sopraggiunte le statue che Roma avrebbe derivato dall’Etruria e dalla Grecia: era, è la conclu-sione di Tertulliano, una Roma non ancora religiosa – come se la religione romana fosse immedesimata esclusivamente sull’importazione etrusca e greca – e dunque non fu la religione a rendere grandi i Romani. Qui si rie-cheggia senza dubbio Cicerone, e l’idea che i Romani superassero di gran lunga gli altri popoli per religione, ovvero per la loro capacità di mettersi in relazione correttamente e profi cuamente con il divino. Il meccanismo messo in atto da Tertulliano è semplice: sembra evidente che egli voglia ridurre l’origine romana a una dimensione assimilabile al cristianesimo coevo per sobrietà e semplicità, per poi individuare il tempio maggiore di quella religione come deviazione deformante, conseguenza della ric-chezza e della conquista imperiale. In altre parole, il tempio è simbolo al contempo della debolezza intrinseca della religione romana e dell’impero stesso: «I Romani – secondo Tertulliano – non furono religiosi prima di essere grandi, e perciò non furono grandi perché religiosi»29.
In maniera analoga Tertulliano se la prenderà con i cristiani e con la necessità di non cadere nello stesso errore dei pagani nel De idolola-tria. L’obiettivo non consisterà più solo nel difendere i cristiani ma anche nell’edifi care i loro costumi religiosi in contrapposizione rispetto alle de-generazioni attribuite ai pagani. Dopo aver messo in atto la scelta giusta allontanandosi dai templi delle false divinità i cristiani non devono cadere nell’equivoco di rendere le loro stesse case dei templi sacrileghi: dunque, si rielabora l’idea che una sovrastruttura templare troppo complessa sia una deformazione dell’idea stessa di religione e che questa deformazione possa partire già dal modo in cui viene concepita, alla stregua di tempio, la propria casa30.
Si può qui osservare, in fi eri, il concetto che in Agostino sarà rielabo-rato nella dialettica fra civitas terrena e civitas dei: l’eccessivo amore di sé si traduce in disprezzo di Dio e genera la città terrena; l’amore di Dio por-
28 Tert., Apol. XXV 12-13.
29 Tert., Apol. XV 13: «Ergo non ante religiosi Romani quam magni, ideoque non prop-terea magni, quia religiosi».
30 Tert., Idol. 14, 11: «Tu lumen es mundi et arbor uirens semper. Si templis renun-tiasti, ne feceris templum ianuam tuam. Minus dixi: si lupanaribus renuntiasti, ne indueris domui tuae faciem noui lupanaris».
7_Saggioro.indd 1517_Saggioro.indd 151 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Alessandro Saggioro
[ 152 ]
tato fi no al disprezzo di sé genera la città celeste: la prima induce a sog-giogare il prossimo, la seconda si realizza nella carità e nella disciplina31. Nel De civitate Dei si ripetono le discussioni sull’approccio dei pagani alle loro divinità, con specifi co e prolungato riferimento al problema degli spettacoli, che sono descritti strutturalmente quali annichilimenti morali e teologici, secondo l’ottica stessa di chi avrebbe voluto al con-trario usare quegli atti per celebrare le proprie divinità. Il tema della de-cadenza dei costumi pagani insieme a quelli delle divinità percorre tutta l’opera. Oltre al tema del teatro, anche quello del tempio abbandonato e negletto si afferma in maniera continuativa. Agostino individua una defi -nizione di rapporto e di mutuo scambio: gli dèi avrebbero dovuto offrire al popolo comandamenti di vita morale; in cambio, ne avrebbero dovuto ricevere templi, sacerdoti, sacrifi ci, misteri, solennità festive e celebrazioni di spettacoli. Ma queste realizzazioni erano a esclusivo benefi cio degli dèi (ovvero: dei demoni), che le accoglievano lasciando di rimando il popolo privo di un tornaconto, ovvero portandolo così a cadere nella deprava-zione e nella menzogna32. A lungo Agostino si sofferma, nel IV libro, con un chiaro obiettivo sarcastico e distruttivo, sul ruolo paradossale della dea Felicitas, che avrebbe dovuto avere, a suo dire, un altro spazio e un altro ruolo nel pantheon romano, tale da mettersi al pari e superare lo stesso Iuppiter: laddove l’edifi cazione del tempio sul Campidoglio aveva visto l’opposizione di Mars, Juventa e Terminus, sì che fosse messo in dubbio sul nascere il culto del sovrano degli dèi, per contro lo stesso Iup-piter e i suoi stessi avversatori non avrebbero avuto nulla a che ridire sul ruolo della dea Felicitas, che avrebbe messo d’accordo tutti. Qui Agostino nel tratteggiare questa dea spinge al paradosso l’apparato concettuale e teologico del paganesimo, aggiungendovi una dea che reputa logicamente indispensabile e superiore, in funzione degli scopi di quella religione, che
31 Aug., CD XIV 28.
32 Aug., CD 2, 22, 1: «Sed quod pertinet ad praesentem quaestionem, quamlibet lauda-bilem dicant istam fuisse uel esse rem publicam, secundum eorum auctores doctissimos iam longe ante Christi aduentum pessima ac fl agitiosissima facta erat; immo uero nulla erat atque omnino perierat perditissimis moribus. Vt ergo non periret, dii custodes eius populo cultori suo dare praecipue uitae ac morum praecepta debuerunt, a quo tot templis, tot sacerdotibus et sacrifi ciorum generibus, tam multiplicibus uariisque sacris, tot festis sollemnitatibus, tot tantorumque ludorum celebritatibus colebantur; ubi nihil daemones nisi negotium suum egerunt, non curantes quem ad modum illi uiuerent, immo curantes ut etiam perdite uiuerent, dum tamen honori suo illa omnia metu subditi ministrarent».
7_Saggioro.indd 1527_Saggioro.indd 152 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
[ 153 ]
si realizzano nel mondo. È importante notare che la concepisce come dea templare, ovvero che nel prospettarla la immagina al centro di un culto in un tempio, che superi quello di Iuppiter e vi si sovrapponga, soppian-tandolo, al centro dell’impero e della romanità rappresentato dal colle del Campidoglio33.
Auspice della chiusura dei templi pagani, intransigente contro gli agi-tatori pagani che resistono alla chiusura, tuttavia egli sosteneva anche che si dovessero combattere i demoni nei cuori delle persone piuttosto che negli spazi reali, e che privare la comunità dei templi avrebbe semmai alimentato la tensione identitaria anticristiana.
5. Impostazione legislativa in età costantiniana: rapporti con gli spazi sacri altrui, edifi cazione e consacrazione degli spazi sacri identitari cristiani
Se l’ultima dedica in oro al tempio del Campidoglio si può rintracciare in una costituzione del 429 di Teodosio II e Valentiniano34, il secolo che intercorre fra l’editto di Milano e la pubblicazione del Codex Theodo-sianus vide alterne vicende nella gestione dei templi e degli spazi sacri da parte delle autorità imperiali.
33 Aug., CD 4, 23, 3: «Ipsi ergo dii si per auguria uel quolibet modo eos posse consuli putant, de hac re consulerentur, utrum uellent Felicitati loco cedere, si forte aliorum ae-dibus uel altaribus iam fuisset locus occupatus, ubi aedes maior atque sublimior Felicitati construeretur; etiam ipsi Iuppiter cederet, ut ipsum uerticem collis Capitolini Felicitas potius obtineret. Non enim quispiam resisteret Felicitati, nisi, quod fi eri non potest, qui esse uellet infelix. Nullo modo omnino, si consuleretur, faceret Iuppiter, quod ei fecerunt tres dii, Mars, Terminus et Iuuentas, qui maiori et regi suo nullo modo cedere loco uo-luerunt. Nam sicut habent eorum litterae, cum rex Tarquinius Capitolium fabricari uellet eumque locum, qui ei dignior aptiorque uidebatur, ab diis aliis cerneret praeoccupatum, non audens aliquid contra eorum facere arbitrium et credens eos tanto numini suoque principi uoluntate cessuros, quia multi erant illic, ubi Capitolium constitutum est, per augurium quaesiuit, utrum concedere locum uellent Ioui; atque ipsi inde cedere omnes uoluerunt praeter illos quos commemoraui, Martem, Terminum, Iuuentatem; atque ideo Capitolium ita constructum est, ut etiam isti tres intus essent tam obscuris signis, ut hoc uix homines doctissimi scirent. Nullo modo igitur Felicitatem Iuppiter ipse contemneret, sicut a Termino, Marte, Iuuentate contemptus est. Sed ipsi etiam, qui non cesserant Ioui, profecto cederent Felicitati, quae illis regem fecerat Iouem. Aut si non cederent, non id contemptu eius facerent, sed quod in domo Felicitatis obscuri esse mallent quam sine illa in locis propriis eminere».
34 CTh 11, 1, 34.
7_Saggioro.indd 1537_Saggioro.indd 153 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Alessandro Saggioro
[ 154 ]
Le testimonianze di Eusebio in merito alle distruzioni dei templi da parte di Costantino sono state messe in dubbio35. Tuttavia, anche Gero-lamo36 e Orosio37 ricordano una legge con cui Costantino avrebbe ordi-nato di chiudere i templi pagani; il De rebus bellicis (2, 1) testimonia che in questo periodo ai templi sarebbero stati sottratti grossi quantitativi di oro, argento e pietre preziose. Libanio per parte sua riferisce che in questi anni, se anche i templi versavano ormai in povertà, si poteva tuttavia assistere al compimento di tutti i riti38. A prescindere da questi principi generali, le notizie che abbiamo, relative a distruzioni di templi da parte di Costantino, in Eusebio, riguardano quello di Asklepios ad Aigai39 e quelli di Aphrodite a Gerusalemme40, a Eliopoli41 e ad Afaca42. D’altra parte, non si può dimenticare che la politica dell’imperatore in materia comprende anche l’autorizzazione concessa alla costruzione di un tempio della gens Flavia a Hispellum: episodio controverso, su cui la critica si è a lungo esercitata, ma che riporta l’imperatore al ruolo di garante di determinate dinamiche della religione pubblica, che restano in funzione fi no ad epoca tarda (fi no a quando Graziano rinuncia, nel 382, al titolo di pontifex maximus)43.
Nel 342 gli imperatori Costanzo e Costante emisero una legge generale, rivolta al prefetto urbano, Catullino, con cui si tentava di proteggere gli edifi ci templari al di fuori delle mura. Questa legge da una parte ci docu-menta il fatto che i cristiani attaccassero questo tipo di struttura, in virtù dell’identifi cazione dei templi con il ricettacolo dei demoni; dall’altra, la consapevolezza degli imperatori circa il fatto che intorno a questi templi si realizzassero rituali e altre attività che erano fortemente sentite dalle popolazioni locali. In particolare, la legge fa riferimento ai ludi e agli
35 Margutti 2013, p. 308.
36 Chron. ad a. 331: «Edicto Constantini gentilium templa subversa sunt».
37 Adv. pag. VII 28,28: «edicto siquidem statuit citra ullam hominum caedem paganorum templa claudi».
38 Or. 30, 6; or. 52, 8. Cf. anche Socr. he I 18; Soz. he II 5.
39 Eus., v.C. III 56.
40 Eus., v.C. III 48; 50; 51.
41 Eus., v.C. III 58.
42 Eus., v.C. III 55.
43 Il decreto di Hispellum è in CIL XI, 5265. Da ultimo, per una sintesi sulla questione e bibliografi a aggiornata: Gregori – Filippini 2013, p. 520 e pp. 533-534, nn. 19-23.
7_Saggioro.indd 1547_Saggioro.indd 154 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
[ 155 ]
spettacoli circensi e alle gare che in quelli erano nate e proliferate, costi-tuendo parte del vissuto popolare, che l’imperatore non riteneva di dover interdire e anzi si sentiva chiamato a difendere44.
Sta di fatto che nel 362 Giuliano, una volta preso il potere, si dedicò alla riapertura dei templi che erano stati chiusi, curò quelli che erano an-dati in rovina, restituì molte delle prerogative che erano state sottratte ai custodi dei templi, riattivò in ogni modo le attività sacrifi cali e cultuali45.
Nel 382 Teodosio promulgò un provvedimento con cui ordinava che venisse mantenuto aperto il tempio di Edessa per l’alto valore artistico delle statue in esso contenute, sì che esso potesse continuare ad essere frequentato dalle folle, fermo restando il divieto di celebrarvi sacrifi ci46. Fu tuttavia lo stesso Teodosio a permettere gli scontri e la conseguente distruzione del Serapeo di Alessandria47, a seguito delle sollecitazioni del vescovo Teofi lo; la chiusura del tempio di Artemis a Efeso, una delle sette meraviglie del mondo; la distruzione del Marmeion nella regione di Gaza.
Nel 396 Arcadio e Onorio promulgarono la legge in cui si esplicitava il fatto che la religione della secta Iudaeorum non risultasse proibita da alcun provvedimento legislativo, e nel far ciò sottolineavano la necessità di preservare i luoghi di culto ebraici e il diritto di riunione48. Nel 397 gli stessi imperatori rivolsero ad Anatolio, prefetto del pretorio per l’Illirico, una costituzione con cui si dava ordine di difendere le sinagoghe49.
44 CTh 16, 10, 3: «Quamquam omnis superstitio penitus eruenda sit, tamen volumus, ut aedes templorum, quae extra muros sunt positae, intactae incorruptaeque consistant. Nam cum ex nonnullis vel ludorum vel circensium vel agonum origo fuerit exorta, non convenit ea convelli, ex quibus populo romano praebeatur priscarum sollemnitas voluptatum».
45 Arce 1975.
46 CTh 16, 10, 8: «Aedem olim frequentiae dedicatam coetui et iam populo quoque com-munem, in qua simulacra feruntur posita artis pretio quam divinitate metienda iugiter patere publici consilii auctoritate decernimus neque huic rei obreptivum offi cere sinimus oraculum. Ut conventu urbis et frequenti coetu videatur, experientia tua omni votorum cele-britate servata auctoritate nostri ita patere templum permittat oraculi, ne illic prohibitorum usus sacrifi ciorum huius occasione aditus permissus esse credatur». Cf. Lepelley 1994.
47 Su questo evento cf. Hahn 2008.
48 CTh 16, 8, 9: «Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam satis constat. Unde graviter commovemur interdictos quibusdam locis eorum fuisse conventus. Sublimis igitur magni-tudo tua hac iussione suscepta nimietatem eorum, qui sub Christianae religionis nomine illicita quaeque praesumunt et destruere synagogas atque expoliare conantur, congrua severitate cohibebit».
49 CTh 16, 8, 12: «Excellens auctoritas tua rectores conveniri praecipiat, ut percepta
7_Saggioro.indd 1557_Saggioro.indd 155 02/07/2015 16:19:4802/07/2015 16:19:48
Alessandro Saggioro
[ 156 ]
Nel 399 Arcadio e Onorio (ma si tratta della politica di Arcadio in Oriente) si rivolgono a Eutichiano, prefetto del pretorio, ordinando che i templi nelle campagne siano distrutti50; in precedenza, nel 395, gli stessi imperatori avevano interdetto la celebrazione di qualsivoglia sacrifi cio in ambito templare, di fatto determinando l’obsolescenza funzionale dei luoghi di culto51.
Nel 423 viene pubblicata una legge con cui si vieta che le sinagoghe vengano sottratte ai legittimi proprietari e si postulano dei sistemi di com-pensazione economica a fronte di eventuali sottrazioni ormai irreversibili:
Piace che per il futuro assolutamente nessuna sinagoga dei Giudei o venga qua e là sottratta loro o sia ridotta in cenere dalle fi amme, e se dopo la legge di recente stesura qualche sinagoga è stata strappata o è stata rivendicata alle Chiese e consacrata ai misteri certamente venerandi, in cambio di queste siano offerti loro dei luoghi nei quali possano costruire, naturalmente a misura di quelle sottratte. Ma se è stato anche sottratto qualche altare, venga restituito a loro stessi nel caso in cui non sia stato ancora consacrato ai sacri misteri; qualora invece la veneranda consacrazione non lo permetta, in cambio di que-sti sia riconosciuto un prezzo della stessa entità. Per il resto, d’ora in avanti non venga più costruita alcuna sinagoga, mentre quelle vecchie rimangano nella loro forma52.
Nel 435 Teodosio II ordina la distruzione di tutti gli edifi ci pagani di culto53: «fana, templa, delubra si qua etiam nunc restant integra»54.
notione cognoscant oportere a Iudaeis irruentum contumelias propulsari eorumque syna-gogas in quiete solita permanere».
50 CTh 16, 10, 16: «Si qua in agris templa sunt, sine turba ac tumultu diruantur. His enim deiectis atque sublatis omnis superstitioni materia consumetur». Gaudemet 1990, p. 29.
51 CTh 16, 10, 13: «Statuimus nullum ad fanum vel quodlibet templum habere quem-piam licentiam accedendi vel abominanda sacrifi cia celebrandi quolibet loco vel tem-pore». Di Mauro Todini 2007.
52 CTh 16, 8, 25: «Placet in posterum nullas omnino synagogas iudaeorum vel auferri passim vel fl ammis exuri et si quae sunt post legem recenti molimine vel ereptae syna-gogae vel ecclesiis vindicatae aut certe venerandis mysteriis consecratae, pro his loca eis, in quibus possint extruere, ad mensuram videlicet sublatarum, praeberi». V. anche CTh 16, 8, 27.
53 Su questo aspetto cf. Lavan 2009.
54 CTh 16, 10, 25: «Omnibus sceleratae mentis paganae exsecrandis hostiarum immola-
7_Saggioro.indd 1567_Saggioro.indd 156 02/07/2015 16:19:4902/07/2015 16:19:49
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
[ 157 ]
Nel 451 viene promulgato da Marciano Augusto un editto che com-mina la pena di morte a chiunque turbi in qualsiasi modo la pace e la quiete delle chiese e degli altri luoghi degni di religioso rispetto.
Nel secolo e mezzo che va dall’editto di Milano alla pubblicazione del Codex Theodosianus la religione pagana tradizionale verrà gradual-mente messa fuori legge55. Ciò avverrà su più fronti. La concezione dello spazio intesa in senso tradizionale viene meno nelle sue strutture por-tanti56, per articolarsi in una serie di modalità che abbiamo visto sinteti-camente esemplifi cate da queste posizioni istituzionali:
1. lo spazio sacro è, oltre che luogo religioso, anche bene economico. Come tale ha un valore, merita di essere sottratto, riutilizzato, ride-stinato; le appropriazioni indebite devono essere interdette e frenate;
2. gli imperatori tendono a difendere la sacralità degli spazi, non esclu-sivamente di quelli cristiani, ferma restando una politica di intran-sigenza nei confronti di attività cultuali messe fuori legge o attività considerate immorali o contrarie all’ordine pubblico;
3. comincia a farsi largo la concezione dello spazio sacro come poten-ziale luogo di raccolta di beni artistici, a prescindere dai signifi cati religiosi, e delle statue cultuali in sé, come beni preziosi e ornamentali (ma era, questa, una tensione che veniva da lontano);
4. si attivano dinamiche di scontro fra diverse comunità religiose, in-torno ai luoghi di culto, per il loro signifi cato intrinseco o per la pos-sibilità di una sostituzione nell’usufrutto.
Le epoche successive recepiranno questa varietà di approcci, da una parte nella dimensione di preservazione di una identità in fi eri ma intesa come monolitica, “insulare”, potenzialmente assoluta; dall’altra, nella necessità dell’interrelazione con dinamiche plurali, interattivamente coin-cidenti nelle ramifi cazioni e stratifi cazioni del divenire storico57.
tionibus damnandisque sacrifi ciis ceterisque antiquiorum sanctionum auctoritate prohi-bitis interdicimus cunctaque eorum fana templa delubra, si qua etiam nunc restant integra, praecepto magistratuum destrui collocationeque venerandae Christianae religionis signi expiari praecipimus, scientibus universis, si quem huic legi aput competentem iudicem idoneis probationibus illusisse constiterit, eum morte esse multandum».
55 Sintesi in Fraschetti 2005.
56 Cf. Ward-Perkins 1999, Ward-Perkins 2003, Goddard 2006.
57 Vaes 1989, Saradi-Mendelovici 1990, Sotinel 2004.
7_Saggioro.indd 1577_Saggioro.indd 157 02/07/2015 16:19:4902/07/2015 16:19:49
Alessandro Saggioro
[ 158 ]
Dal punto di vista dei culti pagani, ciò signifi cherà un graduale ineso-rabile smantellamento, che come è noto darà luogo a distruzioni, sostitu-zioni, sovrapposizioni58. Venute meno le tradizionali funzioni istituzionali, sacerdotali e, più in generale, sacrali, i templi, i teatri, i luoghi simbolo di ogni genere, fi niranno per fare da sfondo ai panorami urbani, con o senza una diversa attribuzione di senso religioso, di segno cristiano59.
Bibliografi a
Ampolo C., 2013, Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti, I, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. 5, 5 (1), pp. 217-284.
Andreussi A., 1988, Roma: il pomerio, in «Scienze dell’antichità» 2, pp. 219-234.
Arce J., 1975, Reconstrucciones de templos paganos en época del emperador Juliano (361-363 d.C.), in «Rivista Storica dell’Antichità», 5, pp. 201-215.
Belayche N., 2007, Des lieux pour le profane dans l’empire tardo-antique? Les fêtes entre koinônia sociale et espaces de rivalités religieuses, «Antiquité Tardive», 15, pp. 35-46.
Bonamente G., 2009, Politica antipagana e sorte dei templi da Costantino a Teodosio II, in Criscuolo U. – De Giovanni L. (a cura di), Trent’anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive, Napoli, pp. 25-59.
Bouché-Leclercq A., 1975, Histoire de la divination dans l’Antiquité, IV, Divination Italique (Étrusque – Latine – Romaine), New York (ripr. facs. dell’ed. Paris 1879-1882).
Brelich A., 1966, Introduzione alla storia delle religioni, Roma.Brelich A., 2010, Tre variazioni romane sul tema delle origini, a cura di
A. Alessandri, Roma (ed. or. Roma 1955).Brind’amour P., 1983, Le calendrier romain. Recherches chronologra-
phiques, Ottawa.
58 Su questi aspetti cf. Orselli 2009.
59 Su questi temi: Kunderewicz 1971, Klein 1995, Karivieri 2002, Bonamente 2009, Mar-gutti 2013.
7_Saggioro.indd 1587_Saggioro.indd 158 02/07/2015 16:19:4902/07/2015 16:19:49
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
[ 159 ]
Briquel D., 1987, I riti di fondazione, in Bonghi Jovino M. – Chiaramonte Treré C. (a cura di), Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive, Milano, pp. 171-190.
Campbell B., 1996, Shaping the rural environment: surveyors in ancient Rome, in «The Journal of Roman studies», 86, pp. 74-99.
Capdeville G., 2014, Il paesaggio religioso in Virgilio, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» 80/2, pp. 801-820.
Catalano P., 1960, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino.Catalano P., 1978, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso
romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», II, 16 (1), pp. 440-553.
Citarella A.O., 1980, Cursus triumphalis and sulcus primigenius, in «La Parola del Passato», 35, pp. 399-414.
Coarelli F., 2000, Mundus, pomerium, ager: la concezione dello spazio a Roma, in Camassa G. – De Guio A. – Veronese F. (a cura di), Paesaggi di potere: problemi e prospettive, Roma, pp. 285-292.
Coarelli F., 2012, Palatium. Il Palatino dalle origini all’impero, Roma.Colonna G., 2004, La “disciplina” etrusca e la dottrina della città
fondata, in «Studi Romani», 52, 3-4, pp. 303-311.Cornell T.J., 1995, The Beginnings of Rome, London-New York.De Sanctis G., 2007, Solco, muro, pomerio, in «Mélanges de l’École
française de Rome», 119/2, pp. 503-526.De Sanctis G., 2012, La religione a Roma, Roma.De Sanctis G., 2014, Spazio, in M. Bettini – W.M. Short (a cura di), Con
i Romani. Un’antropologia della cultura antica, Bologna, pp. 143-165.Degrassi A., 1963, Fasti anni numani et iuliani: accedunt ferialia,
menologia rustica, parapegmata (Inscriptiones Italiae, 13 II), Roma.Di Berardino A., 2005, Tempo sociale pagano e cristiano nel IV secolo, in
Saggioro A. (a cura di), Diritto romano e identità cristiana: defi nizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari, Roma, pp. 95-121.
Di Mauro Todini A., 2007, A proposito di CTh. 16. 10. 13., in Studi per Giovanni Nicosia, III, Milano, pp. 189-218.
Dumézil G., 1966, La Religion Romaine Arcaїque, Paris.Dumézil G., 1975, Fêtes romaines d’été et d’automne, Paris.Espejo Muriel C., 1997, La consagración del espacio en Roma, in
«Florentia Iliberritana», 8, pp. 55-84.Fiocchi Nicolai, V. – Granino Cecere M.G. – Mari Z., 2001-2008 (a cura
di), Lexicon Topographicum Urbis Romae: Suburbium, 5 voll., Roma.Forsyth G., 2005, A Critical History of Early Rome, Berkeley-Los Angeles.
7_Saggioro.indd 1597_Saggioro.indd 159 02/07/2015 16:19:4902/07/2015 16:19:49
Alessandro Saggioro
[ 160 ]
Fraschetti A., 1989, Le feste, il circo, i calendari, in Giardina A. – Schiavone A. (a cura di), Storia di Roma, IV, Caratteri e morfologie, Torino.
Fraschetti A., 2005, Principi cristiani, templi e sacrifi ci nel codice Teodosiano e in altre testimonianze parallele, in Saggioro A. (a cura di), Diritto romano e identità cristiana: defi nizioni storico-religiose e confronti interdisciplinari, Roma, pp. 123-140.
Gaudemet J., 1990, La legislazione antipagana da Costantino a Giustiniano, in Beatrice P.F. (a cura di), L’intolleranza cristiana nei confronti dei pagani, Bologna, pp. 15-36 (= La législation anti-païenne de Constantin à Justinien, in Cristianesimo nella Storia, 11, pp. 449-468).
Goddard C.J., 2006, The evolution of pagan sanctuaries in late antique Italy (fourth to sixth century A.D.): a new administrative and legal framework. A paradox, in Les cités de l’Italie tardo-antique (IVe-VIe siècle), Rome, pp. 281-308.
Grandazzi A., 2008, Alba Longa: histoire d’une légende, 1-2, Rome. Gregori G.L. – Filippini A., 2013, L’epigrafi a costantiniana. La fi gura di
Costantino e la propaganda imperiale nella comunicazione epigrafi ca, in Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla fi gura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto Editto di Milano. 313-2013, I, Roma, pp. 517-541.
Gros P., 2007, Le concept d’espace à Rome, in Genet J. P. (sous la direction de), Rome et l’État moderne européen, Rome, pp. 97-114.
Guittard C. 2009, La délimitation du «templum» augural: les formules d’ «auguratio» de Varron (L, VII, 8) et de Tite-Live (I, 18, 6-10), in Devillers O. – Meyers J. (sous la direction de), Pouvoirs des hommes, pouvoir des mots, des Gracques à Trajan: hommages au professeur Paul Marius Martin, Louvain-Paris, pp. 77-89.
Hahn J., 2008, The conversion of the cult statues: the destruction of the Serapeum 392 A.D. and the transformation of Alexandria into the “Christ-loving city”, in Hahn J. – Emmel S. – Gotter L. (edited by), From Temple to Church. Destruction and renewal of local cultic topography in late antiquity, Leiden-Boston, 2008, pp. 335-365.
Karivieri A., 2002, From Pagan Shrines to Christian Churches: Methods of Conversion, in Guidobaldi F. – Guiglia Guidobaldi A. (a cura di), Ecclesiae urbis, Atti del congresso internazionale di studi sulle chiese di Roma (IV-X secolo), Roma, 4-10 settembre 2000, I, Città del Vaticano, pp. 77-84.
Klein R., 1995, Distruzioni di templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale, in «Atti dell’Accademia Romanistica
7_Saggioro.indd 1607_Saggioro.indd 160 02/07/2015 16:19:4902/07/2015 16:19:49
Defi nizioni dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo
[ 161 ]
Costantiniana», 10, Il Tardo Impero. Aspetti e signifi cati nei suoi rifl essi giuridici, Convegno internazionale in onore di Arnaldo Biscardi, Spello, Perugia, Gubbio 7-10 ottobre 1991, Napoli, pp. 127-152.
Kunderewicz C., 1971, La protection des monuments d’architecture antique dans le Code Theodosien, in Studi in onore di E. Volterra, IV, Milano, pp. 137-153.
Lavan L., 2009, The End of the Temples: Towards a New Narrative?, in Lavan L. – Mulryan M. (edited by), The Archaeology of Late Antique Paganism, Leiden-Boston, pp. XV-LXV.
Lepelley C., 1994, Le musée des statues divines. La volonté de sauvegarder le patrimoine artistique païen à l’époque théodosienne, in «Cahiers Archéologiques», 42, pp. 5-15.
Lindersky J., 1986, The Augural Law, in «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt», II 16 (3), pp. 2146-2312.
Liou-Gille B., 1992, Le calendrier romain: histoire et fonctions, in «Euphrosyne», n.s. 30, pp. 311-322.
Liou-Gille B., 1993, Le pomerium, in «Museum Helveticum», 50, pp. 94-106. Magdelain A., 1976, Le Pomerium archaïque et le Mundus, in «Révue
des Études Latines», 54, pp. 71-109. Magdelain A., 1977, L’inauguration de l’urbs et l’imperium, in «Mélanges
de l’École française de Rome», 89, pp. 11-29.Margutti S., 2013, Costantino e i templi, in Costantino I. Enciclopedia
costantiniana sulla fi gura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto Editto di Milano. 313-2013, I, Roma, pp. 303-315.
Mastrocinque A., 1998, Roma Quadrata, in «Mélanges de l’École française de Rome», 110 (2), pp. 681-697.
Michels A.K., 1967, The Calendar of the Roman Republic, Princeton.Montanari E., 1976, Roma. Momenti di una presa di coscienza culturale,
Roma.Montanari E., 2001, Categorie e forme nella storia delle religioni, Milano.Morelli A., 1993, La réinterprétation chrétienne des fêtes antérieures au
christianisme, in «Religiologique», 8, pp. 1-9.Orselli, A.M., 2009, I processi di cristianizzazione della città tardo-antica,
in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni», 75 (1), pp. 315-333.Piccaluga G., 1974, Terminus. I segni di confi ne nella religione romana,
Roma.Rüpke J., 2011, The Roman Calendar from Numa to Constantine: time,
history and the Fasti, Chichester-West Sussex (ed. or. 1995 Kalender und Öffentlichkeit: Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifi kation von Zeit in Rom, Berlin-New York).
7_Saggioro.indd 1617_Saggioro.indd 161 02/07/2015 16:19:4902/07/2015 16:19:49
Alessandro Saggioro
[ 162 ]
Sabbatucci D., 1975, Lo stato come conquista culturale, Roma. Sabbatucci D., 1988, La religione di Roma antica. Dal calendario festivo
all’ordine cosmico, Milano.Saggioro A., 2011, La religione e lo stato. Cristianesimo e alterità religiose
nelle leggi di Roma imperiale, Roma.Salzman M.R., 1990, On Roman Time. The Codex-Calendar of 354
and the Rhytms of Urban Life in Late Antiquity, Berkeley-Los Angeles-Oxford.
Samuel A.E., 1972, Greek and Roman Chronology: Calendars and Years in Classical Antiquity, Munich.
Saradi-Mendelovici H., 1990, Christian Attitudes toward Pagan Monuments in Late Antiquity and their Legacy in Later Byzantine Centuries, «Dumbarton Oaks Papers», 44, pp. 47-61.
Smith J.Z., 1987, To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago-London.
Smith J.Z., 2004, Here, There, and Anywhere, in Id. (edited by), Relating Religion. Essay in the Study of Religion, Chicago-London.
Sotinel C., 2004, La disparition des lieux de culte païens en Occident. Enjeux et méthode, in Narcy M. – Rebillard É. (sous la direction de), Hellénisme et christianisme, Villeneuve d’Ascq, pp. 35-60.
Steinby E.M.,1999-2003 (edited by), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Roma.
Vaes J., 1989, Nova construere sed amplius vetusta servare: la réutilisation chrétienne d’édifi ces antiques en Italie, in Duval N. (sous la direction de), Actes du XIe Congrès international d’archeologie chrétienne: Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoste, 21-28 septembre 1986, Rome, pp. 299-319.
Ward-Perkins B., 1999, Re-using the Architectural Legacy of the Past: entre idéologie et pragmatisme, in Brogiolo G.P. – Ward-Perkins B. (edited by), The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden-Boston-Köln, pp. 225-244.
Ward-Perkins B., 2003, Reconfi guring Sacred Space: from Pagan Shrines to Christian Churches, in Brands G. – Severin H.G. (herausgegeben von), Die spätantike Stadt und ihre Christianisierung, Symposion vom 14. bis 16. Februar 2000 in Halle/Saale, Wiesbaden, pp. 285-290.
Zanker P., 1989, Augusto e il potere delle immagini, trad. it., Torino (ed. or. 1987, Augustus und die Macht der Bilder, München).
7_Saggioro.indd 1627_Saggioro.indd 162 02/07/2015 16:19:4902/07/2015 16:19:49