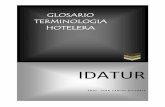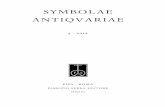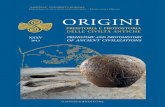La terminologia del 'sacro' in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi
Transcript of La terminologia del 'sacro' in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi
Edizioni dell'Orso Alessandria
2001
Estratto
a cura di ROSA BIANCA FINAZZI
e ALFREDO VALVO
Atti del Seminario Nazionale di studio (Brescia, 14-15-16 ottobre 1999)
Pensiero e istituzioni del mondo classico nelle culture del Vicino Oriente
1 C. De Meo, Lingue tecniche del latino, Bologna 19862, pp. 148 ss. 2 C. De Meo, op. cit., pp. 85 s.
Premessa. Intendiamo prendere in esame con questa nota alcuni punti problematici dello studio del lessico religioso nelle lingue indeuropee anti- che, proponendo qualche iniziale riflessione critica in margine ad alcune conclusioni di studiosi che hanno trattato la materia. Mi rifaccio in parte a mie considerazioni sull'argomento svolte occasionalmente in precedenti lavori, e in parte anticipo qualche spunto d'indagine che mi auguro di pote- re svolgere in modo più approfondito in successive ricerche.
Più precisamente, i punti che vorrei qui affrontare sinteticamente sono i seguenti: 1. Il carattere conservativo del lessico religioso; 2. La tentazione di interpretare il lessico religioso sulla base di categorie precostituite; 3. La difficoltà di un'indagine diacronica del lessico religioso. Premetto che le osservazioni qui proposte si limitano rigorosamente allo studio del sistema lessicale indeuropeo, mentre non intendiamo toccare, neppure di passaggio, il problema della religione indeuropea, che è troppo vasto e troppo delicato per potere essere esaminato in questa sede.
I. Che il lessico religioso sia per sua natura fortemente conservativo è affermazione generalmente ammessa e ripetuta in molti manuali. Nel suo libro sulle lingue tecniche del latino C. De Meo individua il massimo di conservatività nella lingua della religione, e dedica un intero esteso para- grafo al carattere arcaico della lingua sacrale 1: afferma che, se la terminolo- gia giuridica deve la sua autorevolezza e la sua solennità anche alla patina di arcaismo che la contraddistingue, nel caso della terminologia religiosa siamo di fronte a un immobilismo linguistico ancora più radicale2• La stes- sa sensazione si avverte nell'analisi delle lingue moderne. Per rifarsi alla nostra esperienza di parlanti italiano, parole come cresima o domenica fanno parte del patrimonio comune, ma pochi sanno che il primo termine significa precisamente 'unzione' e il secondo '(giorno) dedicato al Signo- re'. I fedeli che partecipano alla Messa di rito ambrosiano ripetono tre volte Kyrie eleison prima della benedizione finale, ma pochi saprebbero il valore
Moreno Morani
LA TERMINOLOGIA DEL 'SACRO' IN LINGUE INDEUROPEE ANTICHE: RIFLESSIONI E PROBLEMI
. . rinvio ai due scritti di E. 7 Per un affronto generale di questa delicata problematica . ( d ) Linguistica stori-
., . . ". · · · . , lt /e in R Lazzerom e · • . A p Campamle, La ncostruuone linguistica e cìt ura • · . . , . doeurop=- in . e · · · 1 124 125) e A11ttch1ta in r · · ca Roma 1987 pp 115-146 (in partico are pp. -
1 ·mportanti rifless1om , , . . 19942 19-44. A tre i . . . Ramar (cdd.) Le lingue indeuropee, Bologna • PP· . Il a Saggi di lmgwstt· · • - lt' ella rmsce ane · si troveranno in altri articoli dello stesso autore racco 1 n d. questa impostazione
. · 1 p· R a 1999 In forza 1 E . ca comparativa e ricostruzione cultura e, isa- om. · D Q Adams (edd.), ncy- . · f · I I me di J Mallory- · · trascuriamo di proposito di are ncorso a vo u ·
c/opedia of Indo-European Culture, 1997.
· t it Chiaramente, non vorremmo caricare questa . d uropeo ricos rui o. . h dell'in e . t" h on può e non desidera avere: non pensiamo e e . e di contenu 1 c e n . . . . h 0pcraz1on . t . un lessico indeuropeo umtano (ntemamo e e . . veramente ncos rmre , . . , . si possa . 1 · 0 si può riconoscere I antichità, o, se vogliamo, lti cast a massim i) d 1, in _mo · ità" di alcune parole 0 di alcune forrnaziom e, secon o _assun- l' .. indeurope 11 messa ci asteniamo da qualunque pretesa dl dare,
d . h. arato ne a pre , . . 1 . to re 1 . . 1 t. individuati come appartenenti al essrco comu-
b e di alcum e emen 1 1.
. sulla as . ffi · e di un mondo di idee e di credenze re igiose ''potet1ca ra igurazion . I d ne, un 1 , d Ila relativa unità indeuropea: la cultura degh n eu- . ttate nell epoca e f hé . pro1e . . .. , . 'bile in modo troppo vago e s ocato, pere e St . pnmittvt e nconosc1 . . . . rope_ 1 h' · he sappiamo affermazioni troppo impegnau- dedurre dal poc rssimo e . possa d' D t l'elenco di Delamarre possono essere assunti
7 Le tabelle I evo o e f tt ve . . la loro valutazione deve sempre essere a a semphce proposta, ma . . . bi . · come 1 A he il dizionario di Buck presenta limiti o ietnvi: , n o-rande caute a. ne lt di co o . . esso uestioni complicate, esso opera una sce _a oltre a ~empl_1f1_care ~p .· q birraria o poco orzanica: nel caso specifico , aboli assai nstretta, spesso ar I , o . voc,, . I . dro d'insieme il fatto di avere collocato acc~n~o a una m~g.g10- ~.uo~e ;. q::01e o concetti di valore generale termini tecruci della trad1z1o~e ianz~ t p . ih h) che in alcune lingue non possono, per ovvie cris.tia~a (~.es. bapti:e, et ~~e Abbiamo però preferito, nonostante tutti_ i limi- r~1~1on.1, esser~ r~~f :~~e~ ~h~ era possibile individuare, rifarci a questi reper- ~~;ri~ ~~;:~~: e~sendo la scelta dei vocaboli da stu?iare emin~~~~;:n~~ ss:~~ zettiva in un ambito semantico come quello c~e st1~~0 esa~to da ~eceden- brava così di attenuare, lavorando s~ un m.atenale g:a eia~~ aria e pquindi in ti studiosi il rischio di operare noi stessi una sce ta ar I r '
· ' dif r eccesso ultima analisi poco rappresentativa, o per '.etto oye . nto mai con- i risultati scaturiti da questo raffronto incrociato s?no qua indeuro-
. . . · · · · · ·aie Dal lessico comune trastanti con la posizione di prmctpto uuzi · . 1.
e il lessico . , d fi I I . · co delle smgole mgue, peo non st puo proce ere mo a essi . . . Ile che si
Il d . ·t' ssai supenon a que delle singole lingue presenta de e rversi a_ a , Già Meillet notano in altri ambiti lessicali. La conclusione no~ e ~uo~a.ngues indo- scri veva nel\' Introduction à l 'étude comparative es a
167 · I · d I 'sacro" in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi La termino ogia e
3 G. L. Beccaria, Sicuterat, Milano 1999. 4 Cari Darling Buck , A Dictionarv of Selected Svnonvms in the Principal Indo-Euro-
pean Langutiges; Chicago & London 1949 (= 19882). 5 G. Devoto, Origini indeuropee, Firenze 1962. 6 X. Delarnarre, Le vocabulaire indo-europée n, Lexique étvmologique thématique-
Paris 1984. La sezione dedicata al lessico religioso si trova alle pp. 71 ss. (Religion, Mytho- logie et Droit).
della formula, e tanto meno sarebbero in grado di analizzare esattamerhef due parole che la compongono. In qualche caso la terminologia diffu··~·'• attraverso la liturgia o l'insegnamento religioso è penetrata profondamen nel tessuto della lingua (si pensi a lavabo, tanto per fare un esempio), e J tradizione religiosa ha permesso la conservazione di termini che nell'u} normale appaiono desueti come prece o requie, anche se, nella genera{' diminuzione dell'informazione religiosa, molte parole sono utilizzate conf metafore di cui non è noto il referente, e si dice per esempio babele o bu(ja samaritano pur ignorando l'episodio biblico da cui è scaturito l'uso di qu~ ste parole. Ci sembra superfluo continuare in un'esemplificazione ch!11 potrebbe essere molto estesa, anche perché l'influsso di termini della tradi.2, zione religiosa o biblica sulla lingua comune è stato recentemente studhttQ'., dal Beccaria nel suo fortunato volume Sicuteratì. , ·f''
Stando così le cose, ci aspetteremmo di trovare nel lessico religio&J.,k delle diverse tradizioni indeuropee una grande omogeneità e il ricorrere d\:,q elementi comuni, se non in tutta, quanto meno in gran parte della terminolQ~·n gia che esprime questo ambito semantico. In realtà la situazione è ben dive[~.~; sa. Abbiamo cercato la controprova di quest'affermazione, ponendo a con:-:;'~ fronto tre repertori, affidabili anche se non certo perfetti, che muovono da · due prospettive opposte: da una parte il volume di Cari Darling Buck", che allinea i termini usati dalle lingue indeuropee antiche e moderne per espri- mere un determinato concetto, dall'altra le tabelle inserite da G. Devoto nel volume Origini indeuropeeì, in cui partendo dalla radice indeuropea si indi- cano le principali derivazioni che le varie lingue storiche ne hanno tratte, affiancato dal più recente volume di X. Delamarre, che procede nella mede- sima direzione, anche se l'assunto non è quello di segnalare le varie deriva- , . zioni di radici indeuropee più o meno diffuse su tutto il territorio, bensì quel- · f Io di elencare una serie di formazioni presumibilmente presenti nel periodo comune suddividendole per area semantica6. Da una parte dunque una rap- presentazione, sufficientemente compiuta e attendibile, del sottosistema del lessico religioso nelle lingue storiche, dall'altra due rappresentazioni, inevi- tabilmente approssimative, dell'ipotetico sottosistema del lessico religioso
166 Moreno Morani
10 "Both as the Body, Community, and as the Building except as noted. a for fonner, b for latter".
. -~ 8 A. Meillet, lntroduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, Pari:~~ 8 ' ~ t1 1937, p. 401. ·~ .• vi 9 Ci limitiamo alla pura e semplice ripresa dei termini riferiti da Buck, anche se ~/).
qualche caso si potrebbero trovare ulteriori equivalenti o si preferirebbero altre fonnè·,u,:11 luogo di quelle segnate. Nella colonna del greco abbiamo riportato i termini moderni (adatf,:, tando la grafia secondo la riforma del monotonik6), solo quando questo poteva avere un~'i' qualche importanza. o;,!(i
H 'f ... ,
. ~f·
svarga-, devaloka-, etc. darnàna-
manaI]h5, vahista- aIJhU
yamasya gare bhavana-, de mana-,
vanhaus
erkink' ark'ayut'iwn
upavas- (com) pahel 25 baptize pamisw baptizàre
26 fast (vb.) VT]OTEUlù (ecci.) iéiùnàre
31 hcaven oùpav6ç caelum
mkrtel
24 curse (vb.) ica-rcxpcioµm exsccràri, sap- maledìcere
zav-, àfrì- anicel, nzovel,
23 bless EÙÀoyl:w benedìcere svasti dha-, (a)fn- etc.
awrhnel
22 preach KT]pt\oow praedicàre (rùayyEì..iço- µ.m)
k'arozel, awet(aran)el
Inglese Greco latino Sanscrito Iranico
Il Religion 8pT]01Ccta religiò dharma- daéna (rùol:pna, Tà eria)
12 God 8r6ç Deus deva-, sura- baga- Astuac
13 tempie va6ç, icpov ternplurn, caitya-, stupa- taèar aedés
14 altar pwµ.6ç, ara, altare euotaonjpiov
15 sacrifice, euo{a sacrificium yajfia-. yasna-, offering medha- hotrà zaoùrà rut'iwn, ,!;':'•
patarag, '·.·), o·:\1i,t
ancay, tawn;'\{' (vb.)jawnel }'
(b) tcuptaKOV
(late) ÒCICÀT]Ota
(late) ecclèsia; (b) basilica
ekelec'i
noly, sacred \.Ep6ç, sacer, éiywç, ooioç sanctus
(punya-, etc.) spenta- surb, srbazan
\.EpcUç sacerdos [mod. nandç]
rtvij-, hotar- aeravan-, zaotar-
k 'ahanay, eréc' k'urm (pag.)
oi:poµat, venerali, yaj- yaz- pastel, zohel,
npoo xu vi:w adorare (ap. yad-) yazel, zenul
[mod. npootc1JVW]
cuxoµ.at, precari, yàc-, ap. jad-, alawt'el;
àpcfoµ.m o rare pràrthaya- av. frì- rnalt'el
[mod. npom:ux ourn]
.. , européennes che "nulle part !es vocabulaires des langues indo-européenJ ne divergent plus que par les termes relatifs à la religion, sans doute par; que chaque tribu avec [sic! lgd. avait] ses cultes propres; nulle part on/ rencontre moins de rapprochements certains; et par suite, la linguistiif indo-européenne ne saurait apporter à la mythologie comparée que peu':' témoignages solides'". Anche Delamarre conferma quest'impressione: '( restitution du vocabulaire de la religion est difficile. En effet, les corres '' dances qui ne portent souvent que sur deux ou trois langues ne permei' d'obtenir dans la plupart des cas que des reconstructions hypothétiqu'"\;, mal assurées phonétiquement". Ma si può portare qualche ulteriore e :,,,,, buto a queste riflessioni. Riportiamo di séguito l'elenco dei termini stJ'. nella sezione 22 di Buck, con l'aggiunta di tre termini inseriti in altre s :, ni ma pertinenti anche l'ambito religioso, limitandoci alle tradizioni cl, lunga data, quelle delle lingue classiche e indo-iraniche, e aggiurig l'armeno (assente, come noto, dal repertorio di Buck): su quest'ultima gua avremo poi modo di tornare successivamente9•
I ue Mlll'l!l\o Moram La terminologia del 'sacro' m lmgue mdeurl\~I! llft!ll!ftl!~ n11em11n1 I! 11r11blem1 J !'IY
Escludiamo i termini propri del Cristianesimo, vale a dire i numeri 21, 25 e 36, e limitiamo il confronto alla trentina di termini restanti. Se trala- sciamo le coincidenze indo-iraniche, che risultano abbastanza numerose (anche se assai meno di quello che ci attenderemmo) per la nota contiguità etno-linguistica primitiva delle due aree, in un solo caso troviamo indicate sulla stessa riga in due lingue le continuazioni di una stessa forma indeuro- pea: è il caso del numero 12 'Dio', per il quale troviamo il deus del lat. e il deva- dell'aind., comune eredità di una voce che possiamo ricostruire come *deiuo-, e del numero 17. I 5 "credere", ove troviamo un termine composto da un corradicale di got. hairto 'cuore' con la produttiva rad. *dhe- 'fare, porre': si tratta di un'antica formazione sopravvissuta, come altri termini del lessico religioso-istituzionale, solamente in alcune aree marginali parti- colarmente conservative dell'estremo occidente (latino e area celtica, irl. cretem) e dell'oriente (indo-iranico). In altri casi possiamo trovare su righe diverse formazioni tratte dalla medesima radice, ad es. aywç del greco (19) e yaj- dell'aind., vaz- dell'avestico (22), ma, anche con questi limiti, l'enu- cleazione di elementi comuni è per la verità assai povera.
Il risultato non cambia se operiamo dall'altra prospettiva e, col Devoto e il Delamarre, partiamo dalle radici indeuropee. Per la verità nelle tabelle di Devoto non abbiamo una sezione specifica dedicata al lessico religioso, che viene compreso all'interno della sezione IV Meteorologia e religione: radici il cui significato è, talora in modo approssimativo, assimilabile a quello dei termini dati da Buck vanno cercate all'interno di altre sezioni, mentre nella IV troviamo termini che col lessico religioso hanno connessio- ni vaghe (come 380 semen 'festa' o 367 neu 'grido di gioia') o ancora meno
nd8oµcn, mo tréco
anima, atrnan-, urvan-, anjn animus, pràna- mainyu- spiritus
credere sraddhà- zrazdà-, var- hawatam
ljlUXTl, euµoç, 1lVEiiµa
baxt (bava) fortuna bhàgya- ( fors, càsus)
47 omen naxansan, c'oyc'
o men, auguriurn, auspicium
oì.wvoç, ~Vlç
46 Guardian spirit
fravasi- (genera/mente pi.)
genius òa{µwv
La terminologia dcl "sacro' in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi 171
37 idol ElÒWÀOV ldòlum (prati rnà-) kurk: 41 superstiti on ÒELOLÒat superstiti o
µo via awelorda. pastutiwn
42 magie, µayc{a, magica ars, yàtu-, krtyà, witchcraft, µayucii
yatu kaxardank: magi ce, maya
sorcery TQVT), magia YOTJTda, (j)apµaKda, paoKavia
43 witch, (j)apµaKiç saga, striga, yatudhani Jahl vhuk': sorceress [mod. maga (o jahika) µaywoa, t'ovc'ic
yàtumain, OTptyÀa) pairika
44 fairy (vuµ(j}TJ) (nyrnpha) (or the like) [mod. µoipa]
parik
45 ghost, (/x:lVTaoµa manes (pl.), pitaras (pi.), uruakan specter, (OKta poet.) larva, pretabhuta. phantorn [mod. phantasrna oro1xno, (/x:lvrnoµa]
35 dernon (ecci.) (ecci.) raksas- (Evi! Spirit) òa{µwv, daemon,
òmµovwv daemonium
36 pagan, (eccì.) E8VT) gentes (pi.), heathen (pl.), È8v11Coç gentìlis,
[mod. ethnicus, EÌÒWÀOÀa- paganus TpT)ç)
33 angel
naraka-, etc. dnìjò dzoxk ', da rnàna-, gehen etc.
(aditya-) yazata- hrestak
qòT]ç infema [mod. tneut. p/ur.), 1C0Àao1ç] infernus,
infemum ayycÀoç (ecci.)
angelus
ò1ap0Àoç (ecci.) diabolus
34 devii
32 hell
170 Moreno Morani
arjra- mainyu- satanay, 16. fortune
sandaramet 17
daèva-, ap. dew, dik' 16. soul, spirit dai va-
11
het'anos 17. bclieve 15
Trascuriamo i numerosi teonimi o gli epiteti che Delamarre enumera nella prima parte della sua lista (/. Les dieux et /es héros) e non entriamo nel merito circa l'opportunità o meno di proiettare alla fase comune primiti- va alcune corrispondenze che si presentano in modo molto frammentario in parti lontane e isolate del territorio e con ambiguità semantiche tali da scon- sigliare lattribuzione alla forma primitiva di un significato (e di un signifi- cato nell'ambito religioso in particolare) oppure, essendo attestate solamen- te in aree che hanno dato vita a un intenso commercio linguistico in età pre- sumibilmente post-diasporica, possono ragionevolmente essere considerate innovazioni recenti limitate a una sola parte del territorio. Anche in Dela- marre, come in Devoto, troviamo inserite nell'elencazione voci che toccano l'ambito religioso in modo marginale: p. es. yii.tes 'devin, poète', erkos 'chant, louange', dheter 'fondateur', k''oinii, apolc'itis 'réparation, compen- sati on, prix', oitos 'serrnent', règs 'le rei', règiom 'royaume', e altri. Ovviamente non si può fare cieco affidamento sulla ricostruzione: ad esem- pio le tabelle di Devoto non indicano un lemma per cielo, semplicemente perché le diverse lingue hanno voci differenti e non siamo in grado di defi- nire una forma comune a più tradizioni e riconoscibile quindi come antica: ma non è pensabile che nel periodo comune le varie tribù non possedessero i termini necessari per designare il cielo. Molte parole o forme originaria- mente estese a buona parte del territorio possono essersi perdute o perché sostituite da innovazioni più coerenti con nuove idee che si erano venute affermando nel frattempo o per ragioni tabuistiche. Pur con questi limiti, balza comunque agli occhi una straordinaria povertà di questo settore del lessico e si rileva con una certa perplessità come, di fronte a un singolare sovraccarico di qualche area semantica, ci sia la sorprendente mancanza di termini relativi a nozioni fondamentali dell'ambito religioso. Il fatto che le parole per cielo siano acquisizioni recenti e che nell'area indo-iranica la nozione di 'cielo' sia espressa con perifrasi dal significato trasparente ~a pensare a una tabuizzazione della parola originaria. Non stupisce eh~ te~~·~ ni come 'tempio, altare' non compaiano perché nel periodo più antico I nn sacri si facevano all'aria aperta e senza bisogno di altare: il che fra l'altr~ concorderebbe con quanto sappiamo del periodo più antico di alcune tradi- zioni. Ma è anche interessante il fatto che poche delle radici indicate dalle tabelle di Devoto appaiono produttive in età storica, che nella maggior parte dei casi le formazioni tratte dalla radici sono limitate a poche aree e
45. ghost, specter, phantom: d11roughos; I 6.17. fortune: bhrtus ('la Fortune', 'qui apporte'); dhug"a ('Fortune,
Richesse'); ank- 'necessité, destin'; 16.11. soul, spirit: ansus, nsus; d11!:fesos 'esprit?'.
La terminologia del 'sacro' in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi I 73
11 Sia il significato sia la forma d 11 d' . . Delamarre (salvo piccoli ritocchi fo e/ ra ice ncostrurta sono sempre quelli di Devoto e tazione dei fonemi indeuropei ricos~~.1 .per.d.are un~ minimale uniformità alla rappresen- discutere sia leventuale precarietà d~1 i~, e.v1t1~m~, /n c~re~za col principio già detto, di il significato fondamentale attribuito al~a r:~i~:~tom atte nsahre a una medesima radice sia
11. religion: (lègs 'loi religieuse', dhemis, dl'èmn dh<Jtis 'I 1 · 1 f dement') (peri-sta 'piété, foi'); ·' a 01, e on-
12. God: deiuos, diuios, dièus potèr; 15. sacrifice, offering: dapnom; g~,,eumn 'Iib · •
lk 1 atron ; iagos 'hornmage"; to - 'sacrifice, repas rituel'; ·
18. priest: bhlag11"!en (der. bhfag11monion 'prétrise'); 19. holy, sacred: isoros ('inspiré saint'); koilus 'saint · t t' k~ ' · , , . , ' ' , in ac ; uentos samt, sacre ; noibhos bon, saint'; sakro; ~
' 42. magie, witchcraft, sorcery: kudos 'pouvoìr magique',· soitos enchantement, magie';
Ancora più esile la quantità di dati che si ricavano dal volume di D I marre: 1 e a-
I I. religion: 480 kàs 'dottrina religiosa'; 12. God: 336 dieu-(p<Jter) 'Giove'; 337 deiuo 'Dio'·
, ff 15· sacrifice, offering: 374 ueik ueig 'scegliere, ~ffrire'; 377 uenos o erta come filtro magico'; ~
, 16· worship (vb. ): 375 ueg"}: eug(")h 'consacrare, proclamare'· 376 ieg consacrare'; ' - ...
17· pray: 371 811edh 'pregare'; (122 prek 'chiedere'); 18· priest: 354 bh/ag(s)men 'sacerdote'· '
2192· holy, sacred: 379 kuento 'santo'; 3S3 sak, tieg" 'considerare sacro'
· preach: 355b karu 'annunciatore'· 45. ghost, specter, phantom: 343 dhre~gh 'spettro'; .16. 17. fortune: 342 (s)mer 'attrarre il destino' ( + 340 bha _ 'fare le
parti, assegnare'; 341 ait- 'fare le parti'); g . 16. 11. soul, spirit: 338 dheyes d'u-m 'spirito"; 343a onr 344 . l 'anima': • . , sa1ue o-
17. 15. believe· 481 kred dh-' f d bh ·dlz. e · - e porre e e come ragionamento'· 482 et porre fede come sentimento'. '
~h.e vaghe, come 362 moks 'subito', 363 pro 'davanti' 364 -t u dietro' 365 · , , pos pos-q bbia:
11 seni senza', 356 kenk 'esitare' e varie altre. Fondamentalmen-
te a ramo :
I 72 Moreno Morani
14 Od. XIV 48. 401 ecc. . 15 Od. I 14 (Calipso); IV 382. 398; X 400 (C1rc_e) ecc.. . (< *SEooç), chiaramente 16 Si può solo affermare !"esistenza. di un -s-, mtervocahco
posto da<>li antichi composti 8Eom:moç o 8Eo(\)cxtoç. presup "
"t' di· i·ntegrare il lessico nel momento in cui i culti si tra- Ila necessi a . . . · ·. , ·1 a. a . d <lesionare oggetti 0 nozioru pnma sconoscmtl. e i . 0 e s1 evono · b . . " , d ., h ,
sforrna~1 , he risale alla medesima radice di E~T\Y an ai e e ~ e caso di ~wµ.oç, e t antica come mostra la modalità della sua formazio-
. zi one certa men e , denva ne; . mento della terminologia, per cui parole nuove vengono
b a un nnnova · · d . . e concetti o idee comunque ereditati a epoca prece- .1. te per espnmer 1· f . un izza, . d. " ' ov se è corretta l'etimologia che g t con ensce un
t · e 11 caso t ucnµ. ' · · lt h den e. '· l'Id della divinità come dispensatrice, o re e e d. 'dispensatore . 1 ea ., - valore t f 1 vedico-omerica degli dèi 'datori di bem (gr. ÒW'!T\PEç if] . a nella orrnu a . . b 1 n ess h in altre tradizioni in termim come apers. aga- e as .
. , v) appare anc e ·' d ' · EctW ' 11 d. *bhag- che significa 'fare le parti e e m h . · rifanno a a ra ice . /Jogu, e e st id d. d tino come parte che sia pure espressa con mezzi _ 1 · e ali' 1 ea 1 es i ' ' - . te az1on . . . o nell'aind bhii.gya- quanto nel gr. µ.01.po:. que- different1, ntroviamc: t~nt d l B. k ma è cronologicamente preceden- st' ultima parola non e npo~tat~. a uc , te a 1UXT\, priva di ~tt~s~az1om in Om_er~i nuove Ad esempio non è privo di
c. ali' affer~ars1 d1 idee e coi°cezio ff 8E6ç sia diversa da quella che significato che in gr~co la pa~ol~e ~~~ou~o,indeu;opee. Il greco deve avere compare nella magg1oran~a e 1 d latino al deva- indiano, al dievas conosciuto un termine eqmvalente a eu~ d ivato "'or Venuta meno la , . erva l'aggettivo en ot, ..,. , lituano e cosi via, e ne ~ons . d . òloç si è desemantizzato ed e connessione col sostantivo da c~1 er~~~va, ssando dal valore di 'divi- tendenzialmente uscito dall'ambito ~e igioso, pa mantico appare dagli usi
· d. ' lso' · 11 trapasso se no' a quello genenco t ecce . 1 , d. ntità che hanno un ruolo . . . 1· ..:- . accompagna a nome I e . . ornenci nei qua 1 otoç si . . . d appellativi generici di per-
marginale nel pantheon greco o di_ van ~~01 o ~1 es òtoç u<\)opp6çl4, e sonaggi che hanno uno stat,o s~~1.ale plm ~:;:d~~, ~ostra al di là di ogni inoltre l'espressione òia 8EO:WV - ecce s~ . tto a 8E6ç. Nel senso di dubbio come òloç si ponga ~u un al~ro pian~tspe va parola, vale a dire 'divino' si utilizzò l'aggett1:0 denvato = a ~~~E6ç non siano chiari 16, 8Eio<. Per quanto i particolan della formazionbeb i e messa in dubbio:
.., . l' dik' non dovre e esser la sua connessione con ar~. t a inserire in un qua- siamo quindi di fronte a un isoglossa greco-_ai:m~na, dt in un'epoca poste- dro di innovazioni che sono da collocare _ve~1:im1lmen p~artenente alla prei- riore alla rottura dell'unità indeuropea prìrmnva, ma a
17~ · 1 · d I 'sacro in lingue indeuropee antiche: ritlessioni e problemi La rerrmno ogia e
12 Per più ampie informazioni sul valore originario di questa parola rimando al mio precedente articolo Le parole del sacro in Grecia, in Banfi E. (ed.), Atti del Secondo lncon- tro Internazionale di Linguistica Greca, Trento 1997, pp. 175-193.
13 Cfr. JEW, p. 348, e soprattutto A. Corlu, Recherches sur les mots relatifs à I 'idée de prière, d'Homère aux tragiques, Paris 1966, soprattutto pp. 17 s. (etimologia di E1lxoµat) e pp. 23 ss. ("Déclarations ne cornportant pas de relation entre un homme et un dieu").
che oltre tutto in molti casi le continuazioni indicate hanno assunto signifi: cati che le hanno sensibilmente allontanate dall'ambito religioso: così tra ld derivazioni di 343 dhreug"- troviamo lit. drugy s 'febbre' e russo droz · 'tremo'. La conclusione da trarre non è però che nel periodo più antico là.
.J
terminologia religiosa era povera e lacunosa: la povertà del lessico comune ricostruibile accenna piuttosto al fatto che le diverse tradizioni hanno cam-« biato e innovato, lasciando perdere gran parte del materiale comune e sosti- tuendolo con altri termini.
Infatti, se restringiamo il nostro campo di osservazione al greco, il cui ] patrimonio lessicale conosciamo in modo soddisfacente a partire da un'e- · poca di molto anteriore all'avvento del Cristianesimo e che ha per di più il carattere di una tradizione concordemente considerata come altamente con- servati va, non solo sul piano lessicale, ma anche su quello fonologico e morfologico, dobbiamo concludere che il materiale di origine indeuropea rappresenta la maggioranza in questa sezione del lessico. Dobbiamo distin- guere però diverse possibilità:
I. Materiale di diretta ascendenza indeuropea che ha mantenuto il significato primitivo: è un'evenienza che appare nettamente minoritaria;
2. Termini di ascendenza indeuropea attratti in ambito religioso: è il caso di h:p6ç, il cui valore originariamente profano ('forte, veloce [?]') sem- bra mostrato sia dagli usi vedici sia dagli usi omerici: già nella terminologia micenea (Omero in questo caso conserva probabilmente una situazione più arcaica di quella delle tavolette) tEp6ç è perfettamente integrato nel lessico religioso12; anche per EÙXrl e termini correlati la specializzazione nel signi- ficato religioso di 'preghiera' appare nella sua fase di completamento, dal momento che la medesima radice compare in altre lingue col valore di 'pro- clamare solennemente' o semplicemente 'dire' (arm. gog)13 e nello stesso greco il verbo appare ancora largamente usato col valore di 'gloriarsi, vanta- si'; poiché anche il lat. voveo è impiegato solamente in ambito religioso, si può pensare che la specializzazione del greco prosegua e concluda una linea di tendenza iniziata già nella fase preistorica della lingua.
3. Innovazioni monoglottiche formate con materiale indeuropeo: queste innovazioni sembrano dovute:
17 4 Moreno Morani
1 !-.ll\..u1uu • <lln!e1m.: u~v n · a divinità straniere, forze pote~zi 1 i di possibile provenienza evocAnche nel latino pagano troviam~ e1_emend~ massima l'introduzione di
. h spex ma in mea l bi sca in caeremoma o aru : , if re}icriosa o un cam iamen- etfll . do V! e una n orma "' · · di
le straniere avviene quan . , .. ntrodurre terrmm 1 conte- paro 1 uente necessita di 1 . . . .
d . relioione (con a conseg . hanno nmanegg1ament1 di io 1 ° l t )· in questo caso st . .
t tecnico molto e eva 0 · 1 . e.rpretaz1one m senso nega- nu o . l'abbandono o a reìne . .
t la terminologia, con . 1 1 . latino crrstiano documenta rut a d t' Lo studio de ess1co · · · · . di parole prece en 1. . . nella lìngua terrmm sermu- 11 "0ste possibilità: mentre fanno 11 loro ~ng~ess~e baptizare, ecclesia, ange- q~e orne amen, alleluia, .s~bbatum, ~rec1sm1 co assumono una connotazio- c1 ~(prestiti), gentes, Trmitas (calchi), p~r co~tr~mefiinum, daemon. Effetti fu: gativa termini precedentemente es1stentI. cijla ove ad esempio il termi- ne I~~crhi sono prodotti dalla riforma ~oroastna i 'demone' (av. daèvai. a~a r~esistentc per l~ divi~ità as~u~e il _se~so d~ervativo in quanto vi si po~- n p In conclusione, il le~s1co rehg10~o_e si c~n iutt'altro che rigido: esso e,
. no rinvenire elementi molt~ arca1~i, ma e li, dovendosi continuamente ~o . molto sensibile ai cam~iai:nent_i cult~ra iJOYL Anche l'esame somma- anz1, all'1'mporsi di concez1om e di valori n ia percorso da una intensa ·idattare e si . " he abbiamo condotto mostra com~ sso "pare soprattutto a livello di n? e . e in ogni caso la conservazione ar . che in lat. sopravvive un dinamica, . E' d e ntpio, . . . f anti non di significati. vero, a ~e anche una sua discreta pro- sigm re 'r1·0 relitto come uis (che mantten~- -) ma è anche vero che il vero e prop . d · t' ·- ,uro • . . ·t' come documentano l enva i zits, ello che possiamo cogliere outnvi a, · · d'1 qu
d Il a parola appare lontamss1mo . e è un relitto che appare contenuto e . , 1 · fmlfi . . . ' . l nte vedico yo/:z: quest u timo te A , s è indeclmabde e viene nell eqmva e , , . ,, . v· yo. h'
l ente nella formula sam ca yos ca. ve al sostantivo sàm, anc esso so :i: solamente nel sintagma _eh~ l? c~ll~~~ mo p.es. RV II 33, 13 ~s . bil di senso non chianss1mo. citi~. 111dechna 1 e e ~ bh · ~ Marutah saar': y~ vo esaja. ·.!. bhu.
yii sarhtama, vrsano. Y~ ']1ay0
Yani Manur avr1Jftii, pita nas, , . d , ssmi ·
tii sarh ca y6s ca Ru rasya vv t quelli che sono al massi.- . · · d. !"1aru ' l e 11
"Quelli che sono i vostn pun nme i, o tari, quelli che M_anu se: ~. ,
fi . o potenti quelh che sono sali'd. . ne di· Rudra 10 voglio . In 0 bene rei, ' b t- 1z10 , ·
m ro adre: questi e il beness:re _e la ~~. or arap6 dadhata "cosi a noi nostX lp5 5 si chiede ai Pitaras atha nah. satfl Yl " Le due parole accennano RV • d' · n~ Jta e · · t sa sem-
b nessere e bene iz10ne se za I~; . deve essere in e ' . Procurate e . . 1 Q t utuma . · erfez10-
Ila salute fisica e spmtua e. ues , no stato privo d11mp dunque a , h. e u , com- . so esteriore: quello che e c testo , dall'aggettivo arapa= bra 1Il sen e : d ' e .nata . ' do passo citato l 1 ea e con1eri ·- m: nel secon
storia delle due lingue. La motivazione dell'innovazione potrebbe torse] individuarsi nel fatto che sia in greco sia in armeno l'antica designaz~one;. dell'uomo come 'essere terrestre' fu sostituita da una diversa designaz1onei dell'uomo come 'essere mortale' (arm. mard, gr. ppo-roç): nel contempo! entrava in crisi anche l'antica denominazione della divinità come essereì celeste, crisi peraltro accentuata dal fatto che, mentre ovunque l'importanza', del padre cielo veniva offuscata dall'emergere di nuove divinità (si ricordi' che a Dyauli è dedicato un solo inno nel RV), cresceva nell'ambiente medi-: terraneo (e indiano) l'importanza della terra, rappresentata come divinità e;, in alcune tradizioni addirittura stabilita come compagna del padre cielo: inj conseguenza di ciò la designazione dell'uomo come essere terrestre risulta-] va inadeguata perché, essendo la terra assunta a essere divino, il riferimento] ad essa per definire la precarietà e la corruttibilità dell'essere umano non' era più adatto. Poteva mantenersi la contrapposizione tra il dio come tnou- · pdvtoç e l'uomo come tmxe6vtoç, perché questi epiteti stabilivano chia- , ramente che la contrapposizione faceva riferimento al luogo dove si svolge l'esistenza dei due esseri, non a una loro intrinseca natura. Se questa era la motivazione del cambiamento, la mancanza di ulteriori collegamenti sicuri tra 8E6ç e altri radici indeuropee ci impedisce di precisare la natura esatta della contrapposizione: poiché a fronte della mortalità dell'uomo dovreb~e stare l'immortalità del dio, ricordando come questo concetto venga conti- nuamente ribadito nei poemi omerici (gli dèi sono aU:v èovr«; o ain yE- vérm) e richiamando un verso come Il. VI 527 ÒWl] tnoupavfotat 8rntç cìrt yEVÉT1Jat, ci aspetteremmo per 8E6ç un valore di 'eterno', anche se mancano prove certe per sostenere questa ipotesi, in quanto il collegamento tra la parola e la radice indeuropea *dhues- 'spirare, respirare', che rende- rebbe plausibile questa spiegazione, non può dirsi certo acquisito.
4. Acquisizione di termini stranieri. Anche questa eventualità è minori- taria, ed è significativo che in greco termini di sicura o probabile origine straniera compaiano solamente nel lemma 42 'magie, witchcraft, sorecry", vale a dire per designare la magia e le pratiche che vi sono connesse: il che conferma la radicale inconciliabilità che esiste tra religione e stregoneria, vale a dire tra percezione del soprannaturale e riverenza che esso suscita da una parte, volontà di appropriarsi delle forze che trascendono l'umano dal- l'altra. Un termine di origine straniera è certamente pamcav{a: se il con- fronto col lat.fascinum ci riporta con discreta probabilità a una voce di ori- gine indeuropea, la corrispondenza tra lat. t- e gr. P- indica che comunque la parola è giunta al greco da una tradizione indeuropea diversa da quella fondamentale (in cui a fronte di unaf- latina avrcmmo é-), da un'area ove le originarie sonore aspirate si confondevano con le sonore semplici. Gr. µayoç si rifà ad ap. magu-, nome di una stirpe meda che esercitava funzio-
'"'"'-•·----------------------------------
19 R. Boyer, Il mondo indoeuropeo, in J. Ries (ed.), Trattato di antropologia del sacro. Milano 1987 ss., voi. 2, pp. 7 ss.
. , -nto soggettivo abbia un peso consistente sia nella scelta dei testi sia I t.'.icJTie · . · di . . d' id d . , . che si decide di dare a ciascuno 1 essi, m 1v1 uan ovt un caratte- it.'.1 peso , . . . . 1 . -aico e conservativo che si puo rmrnrmzzare o accrescere quasi ad rt.'. .• i rea. i valorizzano ·alcuni testi a scapito di altri, e si opera una selezio- i ib1tum. s . . . . .
, le cui modalità sono mev1tab1lmente condizionate, poco o tanto, dalla 11~ 'bilità e dal mondo valoriale del ricercatore. Nel secondo volume di ,cnst . . . . I T di l · . , · opera uscita da non molti anm, muto ata rattato 1 antropo o- un ,unpia ' . . . . . d 1.;ia del sacro troviamo una sezione dedicata alla relt.gton~ ,m o~uropea. ~I
· . t e Rézis Boyer scrive tra l'altro: "Questa diversità tscii. del poli- <uo ,w or ' o ' . . , . .
· · deuropeo) questa molteplicità spiegherebbe la relativa tolleranza teismo 111 ' • ' • . .•
Il . tiaione indoeuropea. Con ognt probabilità essa poteva essere dc a re o I 1· · . I nte esoterica e iniziatica( ... ): ma tutto fa pensare cheta e re 1g10- uuuu me · < • • • • • ·, f . . lo abbiamo appena detto, di natura politica e che ignorasse ti ne osse, . , · d · · . o· qui· certamente la sua estrema capacita di a attamento o lanat1smo. l . .
addirittura, se posso dirlo, di fagocitosi .. occ.orre ~alta atte~z1on~ e una profonda conoscenza della mentalità p~r nusclfe. a n.tr?vare .dietro 1 appor- to indoeuropeo ciò che poteva essere, m fatto di religione, 11.fon~~ autoc~ terno: sicuramente prova di una adesione profonda e volontana, piu che ~1 una imposizione brutale. D'altra parte, col sostegno della. ~aleontolog1~ linguistica, sembra chiaramente dimostrato che questa r~lt.g1one,. benc.h~ no~ ignorasse i tabu e gli interdetti, restava pur. s~mpre re~1~1o~e di ,u?mtm liberi"!". Mi riesce difficile non soltanto condividere opimom cosi .impe- znative e affermate con tanta sicurezza, ma anche semplicemente ncono- ~cere le basi sulle quali esse si fondano. . . .
Tuttavia, anche senza arrivare a estremi così palesemente viziati ~a pregiudizi e da un'utilizzazione quanto meno stravagante dei testi, anc~e. m ind~aini più fortemente aazanciate alla concretezza della realtà lingms~1.c~
e 00. . · ·, li' s1hta càpita di trovare conclusioni sicuramente sproporzionate. nspetto .a . e . .
dei dati di partenza. Scrive Benveniste nel suo Vocabolario delle istuuuoru indoeuropee: "Lo studio della designazione del 'sacro' ci mette in ~r~sen~a
· · · · · · · · ·I · assenza di termine specifico m di una sttuazione linguistica ongma e. · . 1 . d · · in molte linzue indoeuropeo comune da una parte, dup tee esignazione 1 . .o
( ... )dall'altro. La ricerca( ... ) tende a precisare la struttura di una no~10n~ . . · ma due segni Lo studio di la Ctl l espressione sembra esigere non uno, · · . .
ognuna delle coppie attestate ( ... ) ci spinge ad ammettere nella prei.st?n~ L • • , " h , · di presenza divina una nozione di segno duplice: positivo c10 e e e canco
La terminologia del 'sacro' in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi 179
17 Sulla questione cìr. M. Morani, Lat. sacer e il rapporto uomo-dio nel lessico religio- so latino, "Aevum", 55 ( 1981 ), pp. 30-46 (con ulteriore bibliografia).
18 Subhadra Kumar Sen (ed.), Proto-Indo-European: A Multiangular View, "JIES" 22, 2: pp. 67-90. Il brano tradotto, ispirato a un episodio dcll'Aitareya Bràhmana 7, 33, J, ini- ziava con le parole reks deiwos-kwe. Gli autori delle versioni erano, per la precisione: Subhadra K. Sen, Yoel L. Arbeitsman, Eric P. Hamp, W. P. Lehmann, M. Mayrhofer, Joan Puhvel.
2. L'interpretazione delle realtà antiche sulla base di concetti o di id" moderne è un rischio che sta continuamente in agguato, e da cui il ricercs tore moderno dovrebbe sempre guardarsi e cautelarsi: è sempre possibil che nell'interpretazione di realtà lontane nel tempo siamo, in misura picc , la o grande, condizionati da modi di pensare che ci sono più consueti ·à anche da ideali o concezioni nostre personali. Se questo rischio è reale presente nell'affronto delle culture classiche, la cui descrizione e interpreta' zione dovrebbe essere orientata dall'esame di un corpus di testi comunqu vasto, tanto più lo è quando parliamo di indeuropeo: dovremmo sempr ricordare che qui non siamo in presenza né di una linzua né di una cultur ; b . perché l'indeuropeo ricostruito non è un sistema linguistico, ma un insiem · di isoglosse ricavate dalla comparazione di forme linguistiche storiche: Quanto sia forte l'influenza del modello che ogni studioso ha presente , stato mostrato in maniera palpabile da un esperimento tentato non moli anni fa, quando il "Journal of Indo-European Studies" propose ad alcuni indeuropeisti di diversa estrazione la traduzione di un breve testo e si ebbe- ro tanti risultati totalmente diversi, quanti erano i ricercatori invitati all'e~ sperimento, con esiti ora più prossimi all'anatolico ora più prossimi all'in~~ do-iranico e così via, a seconda della specializzazione e del modello teorico: di riferimento di ogni studioso18. .
Quando si affronta il livello culturale le difficoltà e le insidie si pre-; sentano in misura ancora più rilevante, perché in questo caso per definire come indeuropei determinati tratti culturali è necessario proiettare nel pas=, sato elementi ricavati da testi appartenenti a tradizioni e culture ormai sta- ' bilmente differenziate, ed è inevitabile che in un procedimento del genere
posto con rapas- (altra parola isolata e di uso raro) 'imperfezione co rea'. Il valore della parola indiana può dunque essere interpretato co · 'adeguamento alla perfezione'. In latino la parola significa 'norma di co · portamento fra gli uomini', essendo intervenuta una laicizzazione della p mitiva terminologia religiosa, che ha portato alcune originarie parole ·· lessico religioso nell'ambito della terminologia giuridica I 7.
178 Moreno Morani
persone possono essere dichiarate 'sacre': e in quest'ultimo caso il valore di «acer inclina nettamente più verso il sacro per interdizione che non verso il sacro per forza interna. Il carattere di sacer è eminentemente pubblico: non può chiamarsi tale né ciò che riguarda la devozione privata né ciò di ctii gli dèi stessi di loro iniziativa hanno preso possesso mediante segni spe- ciali (per designare queste ultime realtà si usa il termine tecnico religiosus).
Per il greco la situazione è ancora più complicata, perché i termini da prendere in considerazione sono tre t(p6ç, aywç, ocnoç, e addirittura quattro, se teniamo conto del fatto che accanto ad aytoç dovrebbe essere tenuto presente anche ayv6ç, unica forma che compare in Omero e nella fase più antica della lingua, in cui ayto<; è assente. I rapporti reciproci tra l.cp6ç, ayv6ç e ocrwç sono difficili da definire, ma certo esorbitano dal quadro tracciato da Benveniste, e la comparsa di ayioç aggiunge ulteriore complicazione, in quanto una specializzazione, sia pure sottile, tra questo e ayv6ç è rilevabile nei testi postomerici. Se proprio volessimo cercare nel lessico greco l'idea del 'sacro per interdizione' dovremmo richiamarci a un aggettivo che fin dalla documentazione più antica è privo di risonanze reli- giose, ma un'analisi linguistica e comparativa più precisa mostra che esso si è allontanato dal lessico religioso dopo averne fatto parte, vale a dire 0q1v6ç. Il suo valore originario emerge dalla considerazione che: 1. 0q1v6<; è l'originario ppp. di cr(poµ.m che, insieme a molti suoi corradicali (si pensi soprattutto a (ÙO(pr)ç, àcr(pna), ha conservato l'idea delladevo- zione; 2. il significato originario della radice è quello di 'provare timore religioso, tenersi discosto', come appare dal confronto con aind. tyajati 'ha paura' e termini connessi. Il cambiamento di significato di cr(µ.v6ç, e soprattutto il fatto che nessun'altra parola di significato equivalente le sia subentrata, farebbe propendere per la conclusione che nella fase più antica del greco l'idea del 'sacro per interdizione' fosse poco importante.
Della coppia germanica è superfluo accennare, perché neppure Benve- niste appare del tutto convinto che essa risponda alla differenza stabilita: esprimo qui una personale convinzione, che spero di poter approfondire suc- cessivamente, circa la possibilità che nei due termini si rifletta una varietà diatopica, intravedendosi una prevalenza di weihs nella zona orientale del territorio e una prevalenza di hailags nella zona occidentale e settentrionale (ma nel tedesco superiore, in quanto area marginale, persiste wfg): i testi paiono anche accennare a una crescente affermazione di hailags, anche per- ché in weihs vengono ravvisate delle connotazioni pagane che portano a un uso sempre più limitato del termine. Ma su tutta questa problematica conto di tornare più ampiamente in altra occasione, per meglio precisare (o even- tualmente per correggere) le affermazioni qui presentate, che nascono da convinzioni sostenute da uno spoglio ancora iniziale dei testi.
La terminologia del 'sacro· in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi 181
20 , E. Benveniste, Il vocabolario dell . . . . . Le vocabulaire des institutions ind e, 1stttuzw111_111doeuropee, Torino 1976 (trad. it. di 21 M' . . o-europeennes, Pans 1969) p 419
. . I permetto di rinviare ai miei preced . . . ' .: . . . latino (in "Aevum" 198I) . enti contributi, gia citau, sul lessico religioso · . e greco (negh Atti d / s nd guisttca Greca). e· eco o Incontro Internazionale di Lin:
22 G D , ·1 .. .. . umez1 ' La religione roman . . . . . archatque, Paris 1974) Mila 1977
a arcaica (trad. it. di La re/igwn romaine • no • pp. 125 ss.
Ho avuto occasione di valutar · I vando alla conclusione che al e in a tra sede questa problematica, arri- diversa" Richiamo . t . meno per le lingue classiche la realtà è
· sm eticamente le co I · · . testi più significativi mi aveva condottoncp~~t?m a_ cm ~~a revi~i~n_e, dei assegnare a sanctus il valore d. , . · 11. latino, I impossibilità di l'osservazione che Dumézil p~rs:~~~t~n ~ua~~? mterde~to' e~erge già dal- individuava in sacer e augu's t .. d an ~ . impostazione di Benveniste,
. u!> 1 ue terrrum della co · 22. "' nascere 11 sospetto che i due studi . bbi _PP1a · gia questo fa trario il valore dei due aggettivi s~os1ta iano forzato m modo un po' arbi- . . . anc use augustus pe f r . un significato prestabilito: oltretutto sii , . r ar I co~1spondere a sume l'esistenza sia di sacer sia del ~~;~se terr~!ne recenz1or~ che pre- anche per sacer la documentazione latina on sancio da ess? denvato; ma valore originario di 'sacro per fo . t ' on permette di affermare un
• 1· rza m erna · sace ' ., h , . . propnetà divina da un funzionar· d li · . re c10 e e e dichiarato di zione tutt'altro che ori inaria ~~n ~ o st~t?: sr tratta q~i.ndi di una condi- politica, da qualunque ;ggett , s1h acquisita, per decisione dell'autorità
o o anc e persone, dal momento che anche le
got. weihs germanico aated. heilag
sanctus sacer
" aytoç h:p6ç greco
latino
av. yaoidàta av. spanta- iranico
termine positivo (sacro in quanto interdetto)
termine positivo (sacro per natura, carico di presenza divina)
e negati ' ·' h , · · . , ivo ero e ~e proibito al contratto con gli uomini'v-". Questa d r; cita emergerebbe m tre aree linguistiche (iranico latino up
1
q~attro, se si tiene conto anche dell'area germa . ' I . , greco), e f?rs. viene esaminata d B . mca, a cm documentazion coppie sarebbero i ~g:e:~~:mste con qualche riserva. I termini delle varie
180 Moreno Morani
26 Per la verità la radice verbale in questo caso non è direttamente attestata, ma la sua esistenza è desumibile dalle varie formazioni che fanno capo a *kyen-: cfr. !EW, p. 630.
27 Buck, op. cit., p. 1462.
f,itto che una quantità dei termini per 'sacro', tanto di formazione antica quanto nati all'interno di singole tradizioni linguistiche, siano forme di ;Jg.gettivi in -~16 o -~6 collegati con radici verbali, forme cioè di participio passato, q~a~1 che .s1 voless~ .afferm.are il c~!attere a~qui~ito, non originario ddla cond1z1one di sacro: citiamo aind. ya1na- e gr. ayvoç; av. spenta-, asi.
11·eul, lit. sveiitas26; lat. sanctus, o. saahtum. II fatto che sia in area indiana ·si~ in greco nel corso della tradizione yajiia- e ayv6ç subiscano la concor- renza di un aggettivo corradicale con diversa suffissazione (yajya- e ay1.0ç) 110n mi sembra privo di significato: all'idea del sacro in quanto affermato come tale (e quindi in conseguenza di un'azione umana) subentra un'altra e diversa valutazione circa il sacro, la sua natura e le sue modalità di presen- tarsi agli uomini.
Introducendo l'esame delle parole che significano 'religione' Buck scrive: "'Religion' involves a belief in supernatural power, the desire to stand well with them, and practices devoted to this end. 'A religion' dcnotes a particular body of such beliefs and practices. In its early pha- scs, as stili among primitive peoples and with survivals among those of IE speech, it consisted of crude 'superstition"'27. Anche in questo caso, muovendo da una petizione di principio, non si è in poi in grado di valu- ' tare i fatti nella loro concretezza. Nel caso specifico non è tanto la man- canza di un termine comune che dovrebbe muovere la curiosità dello stu- dioso, bensì la mancanza di un termine per 'religione' agli albori della tradizione classica e la grande difficoltà a trovare nelle tradizioni indeu- ropee dell'Asia delle equivalenze abbastanza precise. Lasciamo al Buck la responsabilità del giudizio sbrigativo per cui nei popoli primitivi la religione non è altro che superstizione, e limitiamoci a dare uno sguardo ai termini segnati. Se osserviamo le quattro tradizioni che ci attestano un lessico religioso non ancora adattato al Cristianesimo (greco, latino, indiano, iranico), notiamo che manca nella fase più antica un termine che si possa considerare l'equivalente esatto della nostra parola 'religione'. Ovviamente, la mancanza del termine per religione non comporta né la mancanza del sentimento religioso né la mancanza di una religione isti- tuzionalizzata.
II greco 8pllaKda è attestato a partire da Erodoto e, pur con alterne vicende (la parola cade in disuso nel periodo ellenistico e ricompare in epoca imperiale), diventa, attraverso la versione dei LXX, il termine usuale
La terminologia del 'sacro' in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi ) 83
. n Cfr. ~· .Eliade, Trattato di storia delle re/i ioni J: . . . ', sto11Y!21es _relt,~t011s, Paris 1948) p. 29. g , onno 1976 (trad. it, d1 Traité d'hi-i
Ctr. Ehade UfJ cit p 20 ( f · 25 : · ., · e r. m genere pp. I 9 e ss ) Che surb sia parola di tradizione indeuro ca , .".. , . .
posto Benveniste, è problema insolubile ( f p, o prest1t~ dall iranico. come aveva pro- Armenischen mit sprachvergleich d Ec 1··r. p.es. R. Schmitt, Grammatik des Klassisch-
. en en r auterun I b Dte Stel/ung d es Armenischen un K .: d . dgen, nns. ruck 1981, p. 78; G. R. Solta, ' pp 441 . R S rctse er in ogermanischen S h Wi · s., · tempel Armenisch surb 'l .1. . pica en, ren I 960 0
· ' 1e1 tg rein': Erb , d Le ' nens Christianus, Festschrift fùr CD C M.'.11 . . .. wort o er hnwort", in Nubia et '
s.). La difficoltà a scealiere tra le d. ·. . ". ": Koln 1988, pp. 239-242; Olsen, pp 30 M
. · e- ue ipotesi e ben· m t d Il · · - ayrhofer, che nel KEWf! · 1. . e os rata a e diverse soluzioni di ·, n mc mava ad accettar r · d 1 . piu recente EWA/! tende a con id ' e ipotesi e prestito iranico, mentre nel
. . . . Sl erarc surb parola di erediti . d possibile ongme iranica di b ·1 f. e I a m europea. In realtà contro la h sur sta 1 atto che te · · , d' · . . rano trovarsi in arca iranica· li . .. , . rmrm .corra icali di aind .. subhra- non sern- è argomento dcfmit1vo in . ~mfoss1b1hta di una obiettiva identificazione della fonte non linguistico iranico potr~bbequ,an o admaneata attestazione di termini corradicali in ambiente
essere ovuta al carattere I d Il ne. ma toglie molto valore all'i otcsi d , . . . acunoso e a nostra documentaZio- d~I carattere indeuropeo di surb è i.I fa~~p:~~l~~o s~:u lf~lllco._ ~lteriore argomento a favore gro, nel NP Partusoubra ( cfr. I M Diak ff V p essa ormazione sembra ritrovarsi in fn- 129) . . ono - .. Neroznak, Phrvgian, New York I 998 'p.
~~sostanza l'individuazione di una duplicità di termini . te, piu che coi dati desumibili dal lessico del) I" a _1 sembr~ c~ere della storia della relizioni eh . e mgue antiche, coi pnnc'
. b , e insegnano come I' ap · I ~eu:~~:~f~~~é ~~ s~c; ~ se~pre dupÌice: ~Ile epifanie ~ra~~~~~r~fa~~~7q naturale) si e i.n teano a presenz~ di qualcosa che trascende l'ordì . . acco~pa.gna sempre la nozione di forza e di efficacia+' , stess~, te.mpo t~tt1 gl.1 og~etti toccati dalla forza divina divengono ~e ne. per c10 stesso isolati e vietati in quanto "· . emut1 ontologico una forza di n t . , acq.u1stano per rottura del li veli modi d. id . a ura pru o meno incerta'v". Questi due dive .
I cons1 erare Il sacro veng d . . . r tabu dagli storici della ~elioione ;no I es_1gn~ti nspeuivamcnte con mana, visare in mod . , e . er I resto, i termini m cm è possibile ra
o pru o meno netto l'Id d .. quest'idea e quella di purezza e i eal' i. sacro m.ostrano u.na contiguità got. hailags, da collesare con ;si o~~v 'aind .. p~vztr~-, o di sanità, come l'aind. suci- Una co b . : u sano innero, o di luminosità, co · che è in arm.eno la pamroplrae:_enzda d1 tuttle e tre queste idee si ravvisa in quel
l Ol] amenta e per la d .: · l'approdo al valore di 'sac , d esignazronc del sacro, sur ro parten o da quell d. , , · sostantivo srbut'iwn 'guarigione' e dal v b o I sano si deduce d, ·~on.sacrare'' conserva anc;ra quello di ~~noa sr~em, _che, oltre al. valore sioru come srbem zmawrus 'fare la ba b . re , , e s1 usa anche m espre permette di collegare surb con l'a· d ~r bah radere . D'al,tronde .)'etimologi' so'2s. Un elemento da consider in ./u ra-, che vale splendido, lumino]
are a tentamente dovrebbe essere anche i
I 82 Moreno Morani
3\ Cfr. p.es. PI., asin. IV 1; cure. II 3; mere. V 2; Ter., Andr. IV 3; V 4; heaut. Il 1; IV 1. 32 W. Belardi, Superstitio, Roma 1976 (al quale rimandiamo per un'approfondita
discussione della parte qui delineata).
Nel periodo più antico del latino religio non si renderebbe adeguata- ente con 'religione': in Plauto e in Terenzio sia il termine fondamentale
fll·t i suoi derivati appaiono solamente col valore di 'scrupolo (morale)' ~\< • , -;enza nessuna speciale connotazione religiosa o cultuale31. Solamente in t,ucrezio, ma in un contesto polemico e ostile, religio appare con un valore sirnile a quello affermatosi poi definitivamente. La conclusione che se ne rrae dovrebbe essere la seguente: nel periodo che intercorre tra la comme- dia e Lucrezio la parola assume contenuti nuovi, e la specializzazione semantica così prodottasi determina in maniera definitiva la storia successi- va della parola. Le novità di questo uso romano della parola sono di tre ordini : l. l'aver compreso in religio non soltanto la pratica cultuale, ma anche il sentimento religioso; 2. l'aver specializzato religià al solo ambito religioso, distinguendo fra religione e moralità, coerentemente con quelle che sono le idee generali romane: soltanto a Roma si distingue tra ius efas, vale a dire tra religione e norme che regolano la convivenza tra gli uomini, norme che devono sì ispirarsi alle leggi divine, ma rappresentano comun- que un livello di rapporti interpersonali normati e fissati dalla comunità umana; 3. l'aver riservato re ligio al senso di 'atteggiamento corretto verso gli dei', distinguendo religii5 da superstiti8. Infatti è all'incirca in questo periodo che si fissa la divaricazione fra religii5 e superstitii5: la differenza tra le due parole, "lanciata" da Cicerone (per usare un termine di Belardi, che a superstiti8 ha dedicato una densa monografia32), risale a un periodo che precede di poco Cicerone stesso, forse a una o due generazioni avanti lui (maiores nostri superstitionem a religione separaverunt). Che religi8 abbia assunto un valore vicino a quello nostro abituale, e che escluda il livello dei rapporti interumani, appare da passi come Cic., de leg, I 14 Neque solum in homines obsequia, sed etiam in deos caerimoniae religio- nesque tollentur, quas non metu, sed ea coniunctione quae est nomini cum dea conservandas puto. L'esatta distinzione tra religii5 e superstitio è affer- mata invece da Cicerone in passaggi come Pro Cluent. 68 deos immortalis de suo scelere testatur neque ìntellegìt pietate et religione et iustis precibus deorum mentis. non contaminata superstitione neque ad scelus peificien- dum caesis hostiis passe placari; dom. sua 40 XL. Aspicite, pontifices, hominem religiosum et, si vobis »ideuo: quod est bonorum pontificum, monete eum modum quendam esse religionis: nimium esse superstitiosum non oportere. Quid tibi necesse fuit anili superstitione, homo fanatice ?; nat.
La terminologia del 'sacro" in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi 185
,. Sull'opportunità di separare daena 'reli . • • f lch, lnd1v1du~htat. Ein theologisch-philoso h. grone da ~aena mneres Wesen, geistiger :J schen und religiosen Eigenschaften e· p ischer Begriff, die Gesammtheit der seeli- .: dualitat' cfr. Chr. Bartholomae Alti i~e~ Men~.chen, sei ne seelische und religiose Indi vi- , 'i
, " H B"'k indica tra ; ",,;_;0; •;:;:~I; ';0W~,'7"buch, Strassburg I 904, pp. 662 ss. •) re generico di 'strada' passa nella dot ~ ne anc~e marga- (pah magga-), che dal valo- : Buddha per sfuggire alla miseria del!' . trma buddhista, a designare la via indicata dal ché h . esistenza. La propost b .
bh m_arga- . a un significato lontano da quel! d. ' 1· . a .non_ sem ra convincente, per-
akti- che m bi 0 1 re igione S1 potrebb · · . . ' am ito soprattutto ind . . . . . e se mai indicare atti d~~ulto dovuti alle divinità. uista indica la devozione personale e il complesso di .
. . Cfr. B. A. Olsen, The Noun · B ìbl · . ~m-New York, 1999 (p. 652: krfmkt'.i < t*ktcal Arme~1~11. Origin and word-Formation. Ber- bear, carry'). urawn < g rhmno-, derivato dalla rad. *guerh2-
per 'religione' nel greco cristiano e · · .
1
non siamo in grado di stabili , s?pravv1ve fmo ar nostri giorni. alla base della paro! . . tre u~ et1i:nologia certa, tutto lascia cred con ep OKT , a vi s1~ matenale mdeuropeo: epnmccia è da col rio di ~T\<J:~~c~~::~e os~er:are una_n~r~a religiosa': il valore ori' religiosa'. Un altro ter~n~u~d1 essere 1~1zialm~nte quello di 'osseri, pna, che però non e' spe . 1· a pre~dere m considerazione sarebbe &
. eia izzato m senso r r · . atteggiamento di devozione a h di e ig1?so, p~tendo mdic ' specializzato nell'ambito rei" n~ e I fr~nte_ a essen umam: epnmccia ~' le e la partecipazione alle pr~~:~~~, ml~ '~?1ca sopratt,utt? l'adesione fo cato più vago, che però mette ma cui ua I, me~tre_ rnocpcia ha un sigt. affettiva e un'ad . gg ormente m nsalto una partecipazi
. es1one personale A un 1 . . . . , , nporta probabilmente anch I'. . . va ore ongmano d1 osservanzaf e iranico· av d - f · da(i)- che significa 'ved , . . aena, ormato su una rad. anche se la radice apparese e che appartiene_ al fondo antico del lessi' iranica-" Parente della sclarsame~te produttiva al di fuori dell'area in'
. · paro a avestica è ·1 t · stano per 'religione' di I I d" . . ' ermme che tuttora si usa in ·' · ' n. n n ia troviamo dh l · ·' zione nell'ambito del lessico reli ios , . arma-, a cm stessa colloé ma- indica il complesso del! g o ~a adito a qualche perplessità: dh ·•
. e norme etico-religi h · · re, all'mterno delle quali p . tose e e st devono osserv'
I. . assono collocarsi anche . d .
re igione e al culto· dharm , 1 oven connessi afi , · , · a- puo anche essere ' 1 · · , , ~ virtu, moralità legge'F? Anch bh k . . re ig1one ' ma e piuttost
d ' · e a Ll termme h · "' ·
tar o-brahmanica e induista indi . , , . e e SI auerma nella fas dovuta dall'individuo che n~n la1calp1~ la devozione alle pratiche cultuali;
d. d re rgione come co I d. . , 1 ere enze e di pratiche A 1 . . mp esso 1 sentimento'[ · · un va ore simile · · ' "·
sostantivo formato, per mezzo d I ffi et nporta l arm. krawnk~,'ir · , . e su isso -awn sulla b d 1 gerere , di origine non chiara· il si if ' ase e verbo krem~
va essere quello di 'ordine leg. ,;gm reato fondamentale di krawnk' dove-:!,. , ge .
184 Moreno Morani
33 Si tratta di un aggettivo formalo da erkiwl 'paura'. Sulla parola e la sua costruzione cfr. G. Bolognesi, S1udifilologici gfo1tologici orientali, Brescia 1990, pp. 335-337.
. . . la arnia compare, Act. 25, 18, sT\;:-fiµ.m:~ 34 Nell'unico altro passo àcl NT i~ cui' p , ç crù;:òv KaÌ. m:p{ nvoç 'IT\oou_
iìf nva mpì. 1fiç ì8{aç 8~ioi8_at\10Y':_aç l:ixo~ ,7l~oparola è meno esplicito, perché I~ s1 T[8VT)K010' ov [Q)aOK[V o ncru/.oç sT\V, . uso e p lo· dal suo punto di prospettiva • ..,, . · I' accuse a ao · 'd trova inserita nel resoconto d1 Pesto circ~ e d. G,., potrebbe anche essere cons1 erata
Ila di Paolo, che asserisce la resunc1.1one ~i_ 1:~u, 'vo astratto né il verbo 8not8al- que . . ,' Nei Settanta non s1 trova ne il sostanti una 'superst1z.1on1: · ' . . . . .
, ~ l'acrcrettivo a cui essi s1 ntanno. µ.ovcw n1: "'"'
· . . nche solamente analoga in altre . · , ·eamentaz1one a · . i ·,t1i\C. reperire una s o orne corrispondente di lat. super- _. oss . Il Buck seana c . . ,
P , dcl inondo antico. , . 0 , rivo né l'aagettivo su cm esso e
t, gtl"' _, vie: ne Jl sostan 1 , o . . . . tl . _ . 1 !!r. 8EtOloCXl\.lO · . d li' età attica e \' acqms1Z1one di un
. 't10 i ~- , .· trovano pnma e , . . " ._ 1 5not8atµ.wv, si . !l'El\ ismo è presente in molti testi: pm · e·110· tosi ne enL ' ._.cr , , i1e<Tativo, accentua f . cu·1 si mette alla berlina la figura . \ore e . · d. Teo rasto m . ,va ·1 iJasso dei Caratteri i ·1 ttere di 'debolezza' di questo sent1- chc i , . . accentua I cara - , , ,
; dei 8Etot8Cll\.lwv e st {a òoC,ru:v <aV> dvat 8n~ta ~poç ~o . , i o (il 8ncn8aq1ov . . so di Filone, in cm leggiamo cu- ~c::~ovtoV!, c~terem1;1° caso :t~t~a~:~~i.av S( npayµa à8r7'.(\)òv »:
'r<[taV 11 cv rì,.a-uvovi:wv, . Ab 1 16) Ma nel greco ellenistico OE1, t"" r , V (De Camo et e e . ~[i.a Ka1a0Krua-,~vi:w . iù largo del lat. superstitio, ed essa no~ \a p;1rola ha un a:nb1to s~mantl,c~:i celebre passo di Polibi? VI 56, 7 ~m vale certame~te su~erstt:10~'~ì,.ou; àv8pwnotç òvn8tt;,oµrvo~' i:~ui:o µ.ot 8oKEl ~o nap~ rou; e;- 7'.[yw 8( 1Tiv 8ncnòmµovwv.: m un cruv{:xnv t« 'PwµatWV npa'ljd\.lalli:a, la è quello di 'religione', sta pure
·1 valore e a paro · · id tt contesto dcl genere i . . zzo dall'intellettuale el\emst1co e n o a .a ccrnsiderata con malcelato d1spr~ l' tili zazione in senso strettamente poli-
. . E ncora. se u I iz . . li' - i11stru111e11tum ieg111. , 'a , . ualche margine di dubbio su acce iico di 8ncrt8mµovta puo 1_a~ciar:1{a arola, qualunque incertezza .viene zione fondamentalment~ pos1~~:idfa dì ~ncrtòai.µwv negli Atti degli Ap~- ('uaata se si rammenta 1 uso e . . . proprio col richiamo alla reli-
0 • d. p 1 in Atene iruzia sto/i: la predicazione I ao O 1 - Krvtà rtctV1a W<; 8ncrtÒCXt\.l0- . · "Avòpr< A811vat0t, "'" , n. ' ~ùosità degli Ateniesi: ~, , ya' p K,..,t àvaerwpwv t« o(..,a- ~- - 8trpxo11 rvoc "'" _,, " vrn1i:pouç uµdç erwpw· , ; • , , ani:o "'A'ljVW01~ 8r~ · o , _ .,. al. Aw11 ov rv w rnrYQ/P , _ 17 22
oµ,a1a uµ,wv (Upo~ K _.., ..... - t w Kai:a'ljy[ÀÀW uµw (Act. , oùv à'ljvoouvi:rç rucrrpn i:r, 10~~0 "Id 011· Ateniesi non certo a un loro
li 1 ·enso reha1oso eo , s.)· Paolo fa appe 0 a s b bb del tutto incongruente, e , . . ·o cosa che sare e . , 1· . 'ltteaaiamento superst1z1os ' . d'venta ancora p1u esp 1C1ta ' co · · d ll'aagettivo 1 .. comunque la valen~a po~1t1va - e 34 La arala greca finisce sì per ~cqu~s~- a\Ja luce del successivo rucrrPn 1( . . Pd. ersa rispetto al latino: m ong1-
. . · a per una via iv · re un s1amficato detenore, m . . . , . d' D" o' e la valenza negati- ne òn~8cnµov\.a significa 'reltg1os1ta, timor I I ,
deor. I 42 horum enim sententiae omnium non modo superstitionem,' in qua inest timor inanis deorum, sed etiam religionem. quae deoru pio continetur ; de nat. deor. II 28 Non enim philosophi solum, verum. maiores nostri superstitionem a religione separaverunt. Nam qui tot.' precabantur et immolabant, ut sibi sui liberi superstites essent, supei: sunt appellati, quod nomen patuit postea latius; qui autem omnia qu' cultum deorum pertinerent diligenter retractarent et tamquam relege sunt dicti religiosi ex relegendo, tamquam elegantes ex eligendo, ( quam] ex diligendo diligentes, ex intellegendo intellegentes; his en{ verbis omnibus inest vis legendi eadem quae in religioso. lta factum -: superstitioso et religioso alterum vitii nomen alterum laudis. Sulla s ,. linea di pensiero Varrone, nel XIV libro delle Antiquitates, fr. 191 ~)- [Varro] religiosum a superstitioso ea distinctione discernat, ut a supe.' tioso dicat timeri deos, a religioso autem tantum vereri ut parentes, no ·. hostes timeri. In sostanza, nel latino della tarda età repubblicana I 'us · religio mostra un' avvenuta strutturazione, ormai stabile, del campo se ' tico relativo, con l'inclusione nel termine sia del sentimento religioso<, degli obblighi imposti al fedele: religio si oppone da parte una a pietas: quanto quest'ultimo, come il suo corrispondente greco cùcr[pna, no._. specifico dell'ambito religioso) e dall'altra a superstitià, in quanto il sec ' do indica un puro terrore per le manifestazioni che eccedono l'ordine na raie, mentre il primo richiama a un corretto atteggiamento di riverenza, e" (come dice l'etimo della parola stessa) non esclude il timore di Dio (co · ponente necessaria del sentimento religioso: non per nulla fanno appelli all'idea di timore sia il latino verèri sia il gr. òncrtòmµov{a sia soprattuttd l'arm. erkiwlac, nel suo duplice significato di 'pavido' e di 'pio'33; la stessa religione cattolica pone il timore di Dio fra i doni dello Spirito Santo), m: non risiede solamente in questo. Il Cristianesimo aggiunge a religià il valo-] re di 'fede religiosa': in molte lingue europee, accanto al diffondersi di ter-] mini ripresi dalla parola latina, e in qualche caso anteriormente al prestito.j l'idea di 'religione' è espressa con formazioni che fanno capo a verbi o a ' radici che significano 'credere': citiamo ad esempio anord. trua, aingl. geleaj, aat. gilouba, lit. tikyba (cfr. il verbo tikèti 'credere'), asi. vera.
In conclusione: il latino ha segmentato in modo molto preciso l'ambito semantico relativo all'idea di religione, e le lingue europee moderne hanno o ereditato o ripreso, insieme al termine religio, il complesso di concetti e di valori che questo portava con sé. Sembra difficile, se non addirittura
187 . . . deuropcc antiche: riflessioni e prohlemi La terminologia del 'sacro' in ltngue 111
I 86 Moreno Morani
'
35 Aug., c. lui. 6, 9, 26 verbum baptizare ex Graeco Latina consuetudo sic habet, ut 11011 soleat alibi nisi in sacramento refrigerationis intellegi.
36 L'idea che il tingere la lana costituisca una corruzione della sua natura originaria è fortemente avvertita dalla poesia pagana: cfr. Verg., ecl. 4, 62 (mentiri ... co/ores); georg. Il 465; ecc.
renderebbe difficilmente accessibile la predicazione della nuova religione e ne limiterebbe fortemente la diffusione. Quanto incertezza vi fosse nella primitiva comunità cristiana di lingua latina tra il ricorso al prestito e il neologismo appare in varie circostanze: molti termini greci si diffusero in latino attraverso il Cristianesimo (prestiti come presbyter, diaconus, eccle- sia, martyr, diabolus, parabola, evangelium, calchi come dominica dies, Trinitas, incarnatio); in qualche caso la sostituzione di un termine greco con l'equivalente latino ebbe successo (confessio sostituì exhomologesis), in altri no (antistes non prevalse su episcopus). La vicenda di baptizo è esemplare. Nei primi scrittori cristiani il tentativo di sostituire il termine greco con tinguere è frequente. Nelle citazioni bibliche che si trovano nel testo di Tertulliano spesso si trova la parola latina: p.es. bapt. 13 tinguentes (citazione di Mt. 28, 19); bapt. 14 non ... me ad tinguendum Christus misìt (citazione di I Cor. l, 14 ); de resurrect. 4 7 in Christum Iesum tincti sumus (citazione di Rm. 6, 3): in tutti e tre i passi le versioni bibliche hanno con- cordemente baptirare. E ancora cfr. ad Mare. 4, 27, in un passo che non deriva immediatamente dal testo biblico, cur non prius tinctus esset. La for- tuna di baptizare è dovuta in parte al contenuto tecnico del verbo, che desi- zna un'azione e un concetto che non esistono al di fuori del Cristianesimo, ~meritano quindi una parola appropriata ed esclusiva (come rileva Agosti- no, dando prova, come spesso, di un'acuta sensibilità linguistica35), e in parte al contenuto negativo che aveva già assunto nel latino pagano tingere, che andava sviluppando il valore di 'alterare' (ad esempio nell'espressione tingere nummos 'falsificare la moneta')36. In questo caso l'esistenza della coppia di termini e l'accezione negativa percepita in tingere ha dato modo agli scrittori cristiani cli attuare un'interessante specializzazione terminolo- gica: con baptizare si indica il battesimo conferito dalla Chiesa, con tingere il battesimo degli eretici: cfr. Cipriano, ep. 72 foris extra ecclesiam tincti o 71 ut putent eos, qui apud haereticos tincti sunt, quando ad nos venerint, baptizari non oportere.
La documentazione del latino e del greco, con la possibilità di docu- mentare sulla base di testimonianze concrete le vicende legate al diffonder- si del Cristianesimo, ci mette in condizioni favorevoli anche per la com- prensione delle dinamiche linguistiche di altre tradizioni. Il caso dell'arme-
La terminologia del 'sacro in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi 189
va con cui la filosofia ellenistica tendenzialmente si pone di ii fronte alla re"' gione, essendo questa considerata una debolezza (anche la frase di Teofri sto citata si pone su questa linea), condiziona la sorte ulterioore della parof non pi~ .dunque u~a r~ligion~, fatto in sé. pos.itivo,. c?nt1trapposto a u~'. s~pe~stlZlone, fatto m se negativo, come fa il latmo (si npenrcorrano le fra~ di Cicerone), bensì una sensazione di pregiudiziale disprepgio di fronte ·'' fenomeno religioso, che può essere di gente semplice e inucolta, non ceré dell'intellettuale che considera la vita e le sue vicende conii ben altra chia1: rezza. Succes,sivamente il greco cristiano consolida la valeenza negativa di òncnòaqwvm, perché la religione dei pagani è reinterpretaata, alla luce de' Cristianesimo, come una credenza superstiziosa: la Vulgatéa rende òncri-:'J; òmµovEcr-ri:po~ç del discorso di Paolo ali' Areopago con srnperstitiosiore~!f e òncriòaiµovm di Act. 25, 18 con superstitio. A questo proocesso potrebbe. non essere estraneo il fatto che l'ambito semantico dei vcocaboli greci si'\: stesse allineando con quello dei vocaboli latini, secondo un processo che si' inserisce nel quadro di un' osmosi culturale sempre più consistente tra: mondo latino e mondo greco, grazie anche al diffondersi de :i valori comunii portati dalla predicazione cristiana.
·~ ·I
. 3. Se notevole è la mobilità e lo sforzo di adattamento idei lessico reli- il gioso, quanto meno a livello di significati, alle trasforrnazioeni culturali che ;! i~vestono una deter~inata tradizione, ancora più acuti sono i problemi che ·i si pongono quando si ha a che fare con una completa trasfonmazione dovu- '.. ~a all'ingresso.di cre~enze e culti radicalmente nuovi. La reinterpre~azione ;; m senso negativo dei personaggi, dci riti, delle reliquie delha religione pre- cedente .è, come già detto, un dato di fatto diffuso: ne è prcova l'av. daeva quant? ~I lat. daemon: gli dèi della religione precedente diiventano spiriti malefici. Altrettanto c?mprensibile l'eliminazione dei terrnini in cui più fo.rte ~pp~re la connessione con credenze e culti della religione precedente, e ~~evitabile ~a loro sostituzione con termini di nuova coniaz:ione o con pre- ~t1t1 da alt~a lmg~a: ad esempio, templum e fiinum sono inadatti per indicare il luogo di preghiera cristiano, e si ricorre a ecclèsia. Fatti d:i questo genere sono ben noti, e lo studio delle trasformazioni e dagli adattamenti con cui il lessico religioso pagano è stato riutilizzato dal Cristianesimo ce ne mostra un numero cospicuo di esempi. In realtà l'adattamento del lessico alla nuo:a religione .com~orta problemi delicati, e porta a utilizzare strategie s:a,nate. In molti casi .la terminologia va inventata completamente, perché vi e una prevalenza di contenuti tecnici, relativamente sia ai concetti sia all'organizzazione del culto, per la quale è impossibile trovare parole ade- guate: d'.alt~onde il ricorso eccessivo al prestito è impedito da ovvie consi- derazioni di natura pratica: una presenza troppo elevata di parole straniere
188 Moreno Morani
1 , · e dedicata agli imprestiti iranici, e sezione Echtar111~1'.isc.h del .volume, con /rl~111. a. se)~1~~W == J. Pokomy, J11dogerma11isches
. · ·. · · numen indicano il lemma, non a pagina, . ,. ,· . cosi via. t .. , . eillet 1929 ==A. Meillet, Le mot ekelec 1, cit.; etrmologisches Worterhuch, Bern I ~54 ss.; M . ,· . - G R Solta Die Stellung o'tsen ==B. A. Olsen, The Noun in B1h/1cal Ar111e111an, ctt., Solta - · · · , des Armenischen, cit.
l 1. krawn-k ', origine incerta, v. sopra nota 30; den, dall'iranico ( cfr. av. daena); k'es, dall'iranico (cfr. np. kes);
12. Astuac, origine ignota (cfr. Olsen, pp. 545 .. ss.),; . 13. taèar, dall'iranico (cfr. ap. taèara; np. tajar camera nscal?a~a p~r
· '· cfr Olsen p 952)· mehean dall'iranico (il valore ongmano l'inverno . · , · . , .' , della parola è all'incirca 'pertmente ~ M~tr~ ); . .
14. xoran, dall'iranico; selan, di ongme ignota (cfr. Olsen, p. 299. da una rad. *kel- 'bend, slope' ?); _ . .
l 5. roh, dall'iranico ( cfr. av. zao8 ra, phl. z.ohr); patarag: presumibil-
d ll'j nico (cfr Olsen p. 901: "tne precise source ... is apparently mente a ira 1 . • ' . , .. "): · l 'consacrare' dall'iramco (cfr. pero Hubschmann, Echt.
unknown , 1awne ' . . . . ' ' *d k di ( · · e [ncerta: cfr aind amhati- dono ? o dalla rad. e - 1 469)· ancav ongm · · · : , ' ') f JEW p 189· Olsen, p. 96 "unclear"); tawn, (cfr. lat. gr. 80.: oum ecc .. , c r. · '
daps· Olsen, p. I O 1 ); . . · 1 ' v l dì · ine iranica da un *parista- che st ntrova, in a tra \6. paste, 1 ong1 ' ·V , • , , •
· b ·Vt 'pio' ktaparist 'idolatra' e amparzst empio nonché m forma 111 areparzs , , . · z pastei~ 'onorare' (Bologn~si 1960, ~P· 34 s.); zohel, dall. iramco; yaze , dall'iranico; zenul, origine mcerta (Hubschmann, Echt. 44,5), . l .
17. alawt'el, origine incerta (Aèaryan, I 138); malt el, cfr. itt. ma tai
'prega' ecc. (IEW p. 722); . . . , · , 1 8. k' ahanay, dal siriaco; e ree,' parola di onp ne indeuropea a_nziano '
nel senso di 'sacerdote' calco sul greco np[O'~~:C[poç, fors_e, con mte~~e- . . . . ( f Meillet 1929)· k'urm dal sinaco (kumra sacerdos ), diazione smaca c r. ' ' . . b
19. surb, di origine presumibilmente indeuropea (v. sopra), sr aian, dal precedente con suffisso -zan formatore di aggemvr. . . . ')
21. ekelec'i, dal greco ÒCKÀT)O'ta, con intermediazione incerta (siriaca.
cfr Olsen, p. 931 ); . . · · · (k - - . 22. k'arozel, deverbale da k'aro: 'predica': dt ~ngme sma~a aroz~
'nuntius, praeco'); a-wet(aran)em, deno~in~ttvo di ~wetaran v~ngelo ~ formazione (con suffissazione di origine ira~1~a) co,mata s~ a":'.et annun zio', di origine indeuropea (cfr. aind. vadati parla ' gr. auÒT). Olsen, p.
789);3. awrhnel, di origine iranica (Bolo~nesi 1960, pp. 61 s.),; - r 8 24. anicel, di origine probabilmente mdeuropea (cfr. gr. o vrt co ecc.,
La terminologia del 'sacro' in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi 191
37 A. Meillet, Sur /es terrnes religieux iraniens e11 arménien, "REArm" I (1921), pp. 233-236 (rist. in Etudes de linguistique et de philologie arméniennes, II, Louvain 1977, pp. 193-196).
38 A. Meillet, Le mot eketeci, "REArm" 9 (1929), pp. 131-136 (rist. in Études de /i11- guistique et de philologle arméniennes, II, Louvain 1977, pp. 259-264 ).
39 Su questo argomento si veda anche lo studio complessivo di G.B. Jahowkean sul lessico armeno, Opit semantièeskoj klassifikacii i areai 'nogo raspredeleni]a indoevropej- s~uj leksiki armjanskogo jaivka, compreso nel volume miscellaneo di G.B.Dfaukjan [Jahowkean], L.A. Saradzeva, C.R. Arutjunjan [Harowt'yownean], Oèerki po sravitel'noj leksikologii annjanskogo jazyka, Erevan 1987, pp. 5-116.
40 Nel fare riferimento ai repertori di etimologia armena usiamo le seguenti abbrevia- zioni: Aèaryan =H. Aèaryan, Haveren armutukan baiaran, Erevan 1971-1979; Bolognesi =G. Bolognesi, Lefonti dialettali degli imprestiti iranici in armeno, Milano 1960; Hiìbsch- mann =H. Hubschrnann, Armenische Grammatik, Leipzig 1897 (con Eclit, viene indicata la
no è da questo punto di vista molto interessante. La documentazione sia, guistica sia culturale dell'armeno è tutta posteriore alla conversione, e ·~, l'Armenia pagana sappiamo soltanto quelle poche e sporadiche notizie(' ci sono offerte dagli storici armeni. Come conseguenza di questo, anc ·. travaglio di adattamento del lessico alla nuova religione, che nella tradì •, ne latina e greca ci si presenta nel suo farsi, in armeno è già avvenuto, ~'· terminologia religiosa armena appare davanti ai nostri occhi già assestata~~·
Al lessico religioso armeno Meillet dedicò due brevi, ma importa' contributi: un articolo del 1921 sui termini religiosi iranici in armeno37 e · articolo del 1929 sulla parola eketec'P", La tesi sostenuta nel secondo/ questi contributi è che nel fondo del vocabolario armeno del Cristianesi vi sono elementi aramaici, elementi iranici ed elementi oscuri, alcuni quali hanno una fisionomia probabilmente iranica: l'apporto diretto dé greco è limitato ad alcuni termini tecnici di origine colta come episkopos_~ Nel primo dei due articoli citati invece Meillet conclude che le influenz · iraniche che si ravvisano nella terminologia religiosa e nell'onomastic~' armena non ci riportano all'Avesta: si tratta di influssi che datano dell'epo-j ca parta e coincidono in modo solo parziale con le dottrine avestiche: prova] fondamentale della scarsa conoscenza dei culti zoroastriani in Armenia è( considerato il fatto che il nome di Zoroastro compare due volte negli storici più antichi (Eznik e Eliseo) nella forma zradast, e successivamente nella forma zradest, con un vocalismo cioè molto lontano da quello originario, il che fa sospettare una ripresa da una fonte scritta.
Indubbiamente queste conclusioni sono esatte, e possono essere ribadite anche dall'esame della terminologia riferita in questa sede. Infatti se esaminiamo i vocaboli indicati nella nostra tabella39, abbiamo sintetica- mente i seguenti risultatit'':
190 Moreno Morani
mentre la maggior parte della terminologia è acquisita in data relativamente recente, ed è di origine iranica o, in misura minore, siriaca o greca. Indub- biamente, se nella tabella riportata all'inizio di questa nota prendiamo in considerazione la colonna del latino, noteremo che anch'essa presenta un cospicuo numero di parole di origine straniera (21. ecclesia, basilica; 25. naptizare; 33. angelus; 34. diabolus: 35. daemon, daemonium; 36. ethnicus; 37. idolum; 42. magica ars e termini connessi), ma le due situazioni non sono paragonabili, perché sia la consistenza sia la qualità del materiale di origine straniera è in latino nettamente minore. Tuttavia la distanza che sembra separare le due tradizioni è più apparente che reale, ed è dovuta al fatto che in armeno, a differenza di quanto avviene in latino, il fondo antico del lessico, vale a dire la componente indeuropea (comunque rielaborata) e gli elementi provenienti dal sostrato ma penetrati nella lingua in epoca anti- ca, rappresentano una percentuale ridotta dell'intero sistema lessicale, men- tre una parte copiosa del lessico è costituita da elementi di origine straniera ormai stabilmente integrati all'epoca della conversione. In realtà sia l'una sia laltra lingua hanno proceduto in modo parallelo, modificando il signifi- cato dei termini che già possedevano, risignificandoli in modo anche rile- vante se ciò era necessario, introducendo termini nuovi laddove non era possibile colmare in altro modo la lacuna. L'unica differenza dunque consi- ste nella diversa e più complessa stratificazione del lessico posseduto dal- 1 'armeno ali' epoca della conversione, ma le strategie utilizzate dalle due lingue per adattare il lessico alla nuova religione sono in gran parte analo- ghi. Nella lista degli apporti lessicali stranieri imposti dall'accoglimento della nuova religione si devono annoverare soltanto, in linea di massima, gli elementi di provenienza greca, mediati o no che siano attraverso il siria- co, non i termini di origine iranica, che facevano parte del corpus lessicale armeno già anteriormente all'avvento del Cristianesimo. Da un certo punto di vista larmeno è anche più conservatore del latino: ad esempio per 'bat- tezzare' il latino accoglie il termine greco, mentre l'armeno riutilizza una parola che significava originariamente 'immergere', con un procedimento simile a quello che troviamo nelle lingue germaniche (got. daupjan, ted. taufen). Un'analogia di procedimento tra armeno e lingue germaniche abbiamo anche nella parola per 'digiunare', poiché in entrambe le aree si muove dall'idea di 'custodire, conservare' (got. fastan). Così nella parola per 'angelo' in latino troviamo un prestito dal greco, mentre l'arm. preferi- sce utilizzare il procedimento del calco, e poco importa che arm. hrestak sia di origine iranica, perché questo era il termine corrente per 'messaggero' nel momento in cui si è imposta la necessità di riprodurre il gr. ayyr) .. oç nel senso specifico assunto nella tradizione cristiana. Anche in armeno si è ten- denzialmente respinta la terminologia eccessivamente compromessa coi
La terminologia del 'sacro' in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi 193 IEW 7 · i phl. ~~j a~O), m~ d1 forma~io~e incert~; nzovel, di origine iranica C 413); z , con a rad. zu- chiamare, invocare': Aèaryan III 448; I
25 mkrtel, di origine ignota (cfr. Acaryan III 330)· 26. pahel 'custodire' p· 1 di · · ' 'di . ' , aro a I ongine persiana ma nel . "fi 1gmnare' è un calco d 1 .1 ' sigru re
(sauma 'di . , a greco; I sostantivo com 'digiuno' è dal si: · rgiuno : Olsen, p. 931 ); . :,,,
31. erkink', di origine inde . k' ,. .<1~ ark'ay 're' parola di . . uropea, ar ayut twn, 'regno dei cieli•\.•.'
' 1 origrne greca · Il' •1 mediazione aramaica o iranica (OI ' ma6glmnta a armeno attraverso ;.'"
32 dv , ,. . sen,p. 2e913); J/ · zoxk , dall 1ramco ( *d v 1· • ', · Aeaiyan I 142· OI 877 . uzax a-, opposto a vah1stav- 'paradis"''
33. hreftak d;l~~,r~· . ), gehe~: ter~ine tecnico di origine semitica il vocalismo B~lognesin;~~6phl./;;s~ak messaggero': Acaryan II 146; ·. dialettale iranica: Bolognesi 19lo ~S ~rmf . anche hrstak, da di versa a., .
34 ' p. , e r. anche Olsen pp 242 e 892).' ·'.i . satanay, dal semitico; sandaramet dall'. . . ' . '}. 35 d (i ' traruco; c)l'/1 . · . ew m composto nella forma diw-: cfr d. k , . t.~.z
diwaharim 'essere posseduto') dall 'i . . .. , .. twa an demoniaco[:·'.· ( < *d"es-es, cfr. gr. 8r6ç: Solra 'pp 30~an'.c~,I dtk ' isoglossa greco-armeq~.
36 het'ano d I "e ' . s., sen, p. 172); , J\; 37. kuik' d~' ~ ?r. r. voç con mediazione incerta (cfr. Olsen p 932)·•;;;
· ' 1 ongine incerta (conne k · ' · •'·.\ 16); sso con irem 'scolpisco': Olsen, p."'Q! 41. awelordapastut'iwn, lett. 'eccessiva osservan ' + .Y!!i)
superstùis; za , rorrnato come Jat.'.;; 42. kaxardank', di origine iranica (cfr. av. kax" d. . . ·' 43 h k di · · . ara a) . v u , i ongme ignota ( cfr. Acaryan IV 345. . , . . . ,
secondo Benveniste citato da Olsen 589)· , v,.:,d1 pro:~me~za iraruca 44 ·k d. · · ' p. ' 1 ove le ' di ongine 1gnot · -pan ' 1 ongine iranica (av fJairika'd , a, 45 k · · · · emone , phl pryk 'st ')· . urua an, di origine ignota; . rega , 47. naxansan, da nax- 'prima' e nsan 'se n '· ·' ' . . .
ropea (< *skeusk- cfr gr suo- o , g 0 'e oyc 'd1 origine indeu- ' ,." · tcooçecc.:/EWp.588).
16.17 baxt, dall iranico; ' 16.11 anjn, di origine presumibilmente ind
pp. 122 s.; Olsen, p. 120); hogi paro! d. . europea (!E~, p. 43; Solta, ma', IEW, p. 847 semanticam' . a I ~timo oscuro (cfr. irl. uan 'schiu- < *phou(h)io- dalÌa rad * h hente insoddisfacente e formalmente incerto;
17 15 h ' . . '!! ~u - secondo Olsen, p. 441); . awatam, dr origme incerta (H .. b h
hawat 'faithfully' cfr m h , .u se mann, Echt. 237; yawat <i ' · · part. mwd believe, Olsen, p. 891).
Lo spoglio dei termini pone di fronte . . . parole appartenenti al fond . , . a una s1tuaz1one smgolare: le
o piu antico della lingua sono una minoranza, '1' '~
192 Moreno Morani
43 Si veda su tutta questa problematica l'esauriente articolo di G. Schrenk iEp6c; n~l Grande Lessico del Nuovo Testamento edito da G. Kittel e G. Friedrich (trad. ital., Brescia 1986 e ss., voi. IV, coli. 739 ss.). Si veda inoltre la sezione strettamente linguistica (di O. Proksch) dell'articolo aywç; (ibid., voi. I. coli. 233 ss.).
44 Di origine iranica: cfr. av. xsaera; Olsen, p. 865.
ferito a questa parola. Per 'monaco' si ricorre al calco mianjn 'persona sola', e la parola che significa 'vita' vark' si specializza talora nel senso di 'vita monastica'.
In qualche caso la volontà di riprodurre in modo preciso la terminolo- sia zreca porta a soluzioni ancora più interessanti, anche se di vita effimera. Nel0greco ellenistico e imperiale la complessa terminologia greca per la designazione del 'sacro' si era semplificata, e dei tre o quattro termini che il parlante aveva a disposizione (e che avevano dei confini sem~ntici sei:n~~e più labili e tendevano a sovrapporsi creando delle ridondanze insostenibili) sopravvive soltanto aywç: quest'ultimo è il termine abituale per 'santo' nel linguaggio cristiano, mentre ir p6ç è usato quasi unicamente nel neutr~ sostantivato rò icoév (o i::à irpa) 'tempio'43. Ma mentre nel NT, se non si tiene conto di rò upév (reso con taèari, irp6ç ricorre un'unica volta nel- l'espressione i::à irpà ypaµµ.ai::a (I Cor. 9, 13), alcuni autori ~risti~ni u~i: lizzano ancora entrambi i termini, senza che vi sia un'apprezzabile diversità tra essi. Mentre alcune delle versioni armene di questi testi trascurano la diversità, e rendono entrambe le parole con surb, il traduttore dello pseudo- Dionizi l'Areopagita si sforza di trovare due diversi equivalenti, e rigorosa- mente rende aywç con surb e irp6ç con srbazan: e poiché lo pseudo-Dio- nigi usa anche òotoc, il traduttore rende quest'ultimo termin~ con surb (p.es. CH p. I 21, 19 Thomson), ritenendo evi~entem~nte }a distanza tra òoto ; e irp6ç inferiore rispetto alla distanza tra aywç e l~po~. .
Ma più che queste osservazioni di dettaglio, sono altn gh elementi che meriterebbero di essere osservati. Per indicare i pagani l'arm. usa het'anos, che tanto sul piano formale quanto su quello semantico non si sovrappone perfettamente al gr. Eevoç, sia perché la parola armena indi~a il pagano, e non le nazioni pagane, sia perché l'inserimento della -a- mediana presuppo- ne la mediazione di una fonte straniera che non siamo in grado di identifi- care con precisione. Ma, al di là di questo, la parola armena presuppone una rilettura del valore di [8VT) che ha i suoi presupposti nel greco neotesta- mentario e che trova un perfetto parallelismo nel valore assunto da natio o da genti/es nel latino cristiano. Anche il fatto che per 'laico' si usi un termi- ne come asxarhakan, vale a dire un aggettivo, derivato per mezzo del suf- fisso -kan, dal sostantivo asxarli 'mondo'44, pone dei problemi culturali
La terminologia del 'sacro' in lingue indeuropee antiche: riflessioni e problemi 195
41 In air. daiva sono i demoni, contrapposti al dio zoroastriano baga-, 42. A sua volta di ascendenza indeuropea, da pari- 'intorno'+ la rad. sta- 'stare', con
evoluzione semantica 'stare intorno> servire' analoga a quella che si ha p.es. nel gr. àµ.(j){- noxoç,
~ulti paga~i, e in conseguenza di ciò si è avuta una duplice terminologia per?' Il luogo di preghiera, col tempio pagano (mehean) opposto alla chiesa cri-./? stiana (ekelec'i), e il crearsi di una coppia di termini come nel lat. fiinum _,:\ ecclesia o nell' asi. crùky - chramù. In qualche caso la situazione dell' arme-·~ no è più complessa, perché di fronte alla duplice terminologia di altre lin-< gue l'armeno possiede anche più termini: per indicare l'opposizione dèi.] pa~ani - J?io cristiano le lingue classiche hanno una coppia di termini (gr. 8rnç - cSmµ.wv, Iat. deus - daemon), mentre l'armeno ha a disposizione tre, termini (arm. Astuac - dik', dew), perché, oltre a reinterpretare in senso negativo il precedente dik', della cui origine già si è detto, l'arm. possedeva già un termine di origine iranica con una forte connotazione negativa dew41• '
In sostanza, sembra che nell'adattare il proprio lessico al Cristianesimo I'~rmeno abbia un atteggiamento più conservativo di altre tradizioni lingui- stiche, e sembra preoccupato dall'opportunità di limitare l'introduzione di parole straniere a quei soli tecnicismi per i quali non vi è altra soluzione. Per 'comunione' si usa gohut'iwn, che, nel suo antico valore di 'rendimento di grazie, benedizione', si configura come un calco di rùxaptcn{a. Per 'evangelo' si usa awetaran, cioè un derivato di awetik' 'annunzio' (da cui anche il verbo awetem 'annunziare'): un altro derivato dalla medesima ra- ~ice è Awetunk' 'Annunciazione'; tutto il gruppo è poi ampiamente produt- tivo, e ha scarso interesse la considerazione che awetik' a sua volta sia parola di origine indeuropea, se il nostro intento è quello di capire le dina- miche con cui l'armeno ha adattato al Cristianesimo il suo vocabolario. In una parola, la prospettiva diacronica in questo caso darebbe (come sempre) delle informazioni in sé utili per la storia della lingua, ma superflue per l'assunto che qui tentiamo di svolgere. Se è vero che raramente si trovano termini di diretta importazione greca, è anche vero che, pur utilizzando materiale di altra provenienza, l'armeno si sforza di riprodurre Io spirito del lessico religioso greco: ambarist 'empio' e bareparist 'pio' sono gli esatti equivalenti di gr. àcrr~iiç e rùcrr~iiç, essendo formati nella seconda parte da una voce iranica42 che contiene essenzialmente l'idea del servizio divino e nella prima parte dai suffissi am- e bari- che equivalgono semanticamente a. gr. à- e rù.-. Si riutilizza il verbo p 'orjel, di incerta origine, ma presumi- bilmente antico, per rendere 'tentare' nel senso che il Cristianesimo ha con-
194 Moreno Morani
\.
'\ .:.
interessanti: siamo di fronte a un calco del gr. Kooµuc6ç, con un'evoluzio- ne semantica dell'aggettivo (e del sostantivo a cui la parola rimanda) analo- i
ga a quella che troviamo nel lat. mundus. L'origine di questa reinterpreta-· zione di xéouoç si riconosce nel greco neotestamentario, in passi come /oh. 12, 31 vùv Kp{oiç èo tìv roù xéouou toiirou, VUV Ò apxwv roo xéouou roiitou Ètcpì.. rietjanm rçw; /oh. 14, 17 rò nvruµa tijç àkll- 8daç, o 6 tc6aµoç où òuvatm ì..apriv; /oh. 14, 27 Eiprjvriv à${riµi uµiv, dprjvriv rnv tµTiv òlòwµi uµiv· où ica8wç ò 1e6aµoç òlòwoiv tyw òlòwµi uµiv, e così via. Dalla realtà linguistica traspare dunque una circolazione di valori comuni, in Occidente come in Oriente, portati dalla predicazione cristiana e veicolati attraverso la lingua greca, che segneranno profondamente lo sviluppo successivo della cultura e della civiltà, tanto in Europa quanto nelle culture dell'Oriente permeate o toccate dall'influsso greco.
196 Moreno Morani