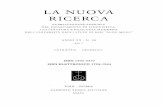L'immaginazione simbolica tra «meteore spirituali» e 'allegoresi' dantesca. Pascoli lettore del...
Transcript of L'immaginazione simbolica tra «meteore spirituali» e 'allegoresi' dantesca. Pascoli lettore del...
La modernità Letteraria
collana di studi e testi
diretta daAnna Dolfi, Alessandro Maxia, Nicola Merola
Angelo R. Pupino, Giovanna Rosa
[52]
000a_PAG.ED.TOMO1.indd 1 18/11/15 11.32
La funzione Dantee i paradigmi della modernità
Atti del XVI Convegno Internazionale della MOD Lumsa
Roma, 10-13 giugno 2014
a cura diPatrizia Bertini Malgarini, Nicola Merola
e Caterina Verbaro
Edizioni ETS
000a_PAG.ED.TOMO1.indd 3 18/11/15 11.32
© Copyright 2015Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 [email protected]
DistribuzioneMessaggerie Libri SPA
Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)
Promozione PDE PROMOZIONE SRL
via Zago 2/2 - 40128 Bologna
ISBN 978-884674365-7ISSN 2239-9194
www.edizioniets.com
Il presente volume è stato pubblicato con il contributodella Libera Università Maria SS. Assunta (Lumsa) di Roma
000a_PAG.ED.TOMO1.indd 4 18/11/15 11.32
Manuele Marinoni
L’immaginazione simboLica tra «meteore spirituaLi» e ‘aLLegoresi’ dantesca.
pascoLi Lettore deL poema sacro
il 20 dicembre 1899 comparve sulla rivista napoletana «Flegrea» un articolo pascoliano dal titolo Intorno alla Minerva oscura1, seguito da un secondo, sulla medesima rivista, il 5 febbraio 1900. il poeta ha alle spalle la pubblicazione della Minerva oscura (accompagnata dall’esito negativo del concorso indetto dai Lincei presieduto da carducci)2 e sta portando a ter-mine il secondo volume di argomento dantesco: Sotto il velame. Saggio di un’interpretazione generale del poema sacro. cesare garboli, nella premessa al testo dell’edizione antologica mondadoriana, specifica che questi articoli registrano lo spostamento dell’attenzione per il «sistema penale della Com-media» verso «l’interpretazione simbolica del paesaggio e del bestiario del poema». dunque «il dantismo pascoliano» avrebbe «cambiato oggetto di ricerca, o, se si preferisce [...] posizione». ma questo non toglie una certa coerenza di fondo: un unitario paradigma ermeneutico dove tutto si gioca sulla ricerca, per dirla con guido guglielmi, di una «semantica profonda» e di una «semantica di superficie» ove «corrispondenze formali e relazioni di somiglianza ricevono nuove determinazioni»3.
1 il testo si legge in Giovanni Pascoli, Poesie e prose scelte, a cura di cesare garboli, 2 Voll., milano, mondadori, «meridiani», 2002, Vol. ii, pp. 373-430. da cui sono tratte tutte le citazioni degli scritti danteschi del pascoli. i titoli sono: Minerva oscura. Prolegomeni: la costruzione morale del poema di Dante (1898); Sotto il velame. Saggio di un’interpretazione generale del poema sacro (1900); La mirabile visione. Abbozzo di una storia della “Divina Commedia” (1902) e In Or San Michele. Prolusione al Paradiso (1903). un quarto volume, mai scritto, si sarebbe dovuto intitolare La poesia del mistero dantesco.
2 molti dati in proposito si trovano in Giovanni caPecchi, Gli scritti danteschi di Giovanni Pascoli. Con appendice di inediti, introduzione di marino biondi, ravenna, Longo editore, 1997.
3 cfr. Guido GuGlielMi, Pascoli lettore di Dante, in id., L’invenzione della letteratura. Moderni-smo e avanguardia, napoli, Liguori, 2001, pp. 29-41. di tutta l’acuta analisi di guglielmi credo siano da ridiscutere gli esiti entro cui viene letta la sommatoria dell’interpretazione pascoliana di dante;
077_Marinoni_881.indd 881 18/11/15 13.54
La funzione Dante e i paraDigmi DeLLa moDernità882
non tenteremo l’azzardo di registrare connessioni fra le iper-significa-zioni simboliche (quello che il pascoli poeta trasforma negli insiemi fun-zionali del linguaggio, tra un alto e un basso – per riprendere contini e, sull’asse di un’autonomia fonica generatrice di sensi inediti, beccaria – en-tro cui oscilla un «nuovo» linguaggio poetico e della «verità»)4 individua-te nei microelementi del poema dantesco, nell’unificante grammatica del «velame»5 e la vocazione macrostrutturale (verso il Libro di poesia)6 della práxis poetica pascoliana, ma partiremo ugualmente dal presupposto che il conturbante processo di un’ermeneutica del metaforico e dell’allegorico sia determinante per cogliere la traccia semantica delle «meteore spirituali», tra pathos della rêverie e malinconia dell’antico. tenendo presente i risultati ottenuti in proposito nei Poemi conviviali e, nello specifico, nella riscrittura del mito di odisseo, di cui si vedrà un minimo esempio.
È doverosa una breve parentesi, tenendo conto degli anni in questione, sulla rilettura del mito dantesco che nel medesimo periodo sta avvenendo per opera di d’annunzio e di angelo conti. il discorso è naturalmente mol-to complesso, ma ricordo che nella planimetria mitopoietica dannunziana
specie l’idea che il poeta «dà voce» ad un certo tipo di «lontananza», la medesima entro cui pascoli colloca i testi antichi, e attraverso cui «misura il presente su modelli». semmai pascoli trova una lontananza (certo incolmabile – cosa che non credeva d’annunzio) dei livelli semantici propri di un contesto culturale ‘altro’ che era, in passato, capace di organizzarsi universalmente. nonostante la ci-clicità, l’epos, le macrostrutture, quello che pascoli registra nel moderno, specie in relazione all’antico, è sempre un forte paradigma di fragilità delle connessioni; e da ciò deriva la necessità di operare su un’etimologia del suono e sull’idea di un mito ‘semantico’ (fatto di simulacri che galleggiano su un’on-tologia del negativo; la stessa che, nutrita più del pessimismo di Hartmann che di schopenhauer, traccia livelli comuni con la lettura che emerge dalla Nascita della tragedia; e quindi verso un ‘senso del tragico’ del reale, così come affiora chiaramente dai Poemi conviviali che si nutre anche (e soprat-tutto) dello spirito tragico (contro una linea critica che pensa ridotta ai minimi termini l’influenza della tragedia antica sul modo di leggere il passato ellenico del pascoli). ricordo solo, per i problemi del rapporto tra pascoli e la tradizione pessimistica ottocentesca, che non è da sottovalutare l’opera di giacomo barzellotti che, vicino ad aurelio covotti ed ettore zuccoli, ebbe modo di diffondere il pensiero schopenhaueriano (e non solo) in area bolognese (proprio tra carducci e pascoli).
4 un discorso ancora tutto da affrontare con dettaglio è quello che riguarda i rapporti della sperimentazione fonosimbolico del pascoli con la teoresi dell’atuonomia del suono proveniente da certa scuola romantica, nell’ambito di una peculiare ‘metafisica del suono’. Qualche notizia in enrico elli, Pascoli e l’antico. Dalle liriche giovanili ai “Poemi conviviali”, novara, interlinea, 2002. Le stesse ricerche di un’«archeologia acustica del suono» (che vedono il pascoli legato a medesimi interessi dannunziani) partono, nel pascoli, da specificihe conoscenze tecniche; ricordo, per esempio, i risultati di chlandi proposti in Akustik (del 1802) noti, come ci informa nava, attraverso Flammarion.
5 dell’attenzione al «tessuto diacronico dell’itinerario poetico di dante» e della «totalità del-la visione» parla dante della terza nell’intervento Pascoli dantista. Risvolti metodologici e analogie proiettive, in Pascoli e la cultura del Novecento a cura di andrea battistini, gianfranco miro gori e clemente mazzotta, Venezia, marsilio, 2007, pp. 333-346.
6 cfr. nadia ebani, Pascoli e il canzoniere. Ragioni e concatenazioni nelle prime raccolte pascolia-ne, Verona, Fiorini, 2005.
077_Marinoni_881.indd 882 18/11/15 13.54
L’immaginazione simboLica tra «meteore spirituaLi» e ‘aLLegoresi’ dantesca 883
dante ricopre un ruolo funzionale e mistificatorio nel più generale corredo eroico-civile (al di là dello scavo verso un paesaggio ‘infernale’ fra Forse che sì forse che no e le tragedie del côtè medievale); e l’aura mistica, quasi dio-nisiaca, che abbraccia il personaggio-dante, discende direttamente dall’e-stetismo europeo che ha saputo leggere l’autore della Commedia attraverso i riti romantici e post-romantici e le diottriche esoteriche (cultura ben nota al pascoli), nella generale visionarietà di cui ha magistralmente offerto una cartografia John dixon Hunt7. Lo stesso conti, sulle pagine del «marzoc-co», evocava uno dei suoi numi tutelari in proposito: «nessuno, o pochi dopo il carlyle, avevano veduto dante come forza della natura, nessuno aveva sentito passare nel suo poema le stesse forze che generano le selve e le montagne». ricordo inoltre, solo di sfuggita, che a partire dai prodromi della «revue Wagnérienne» sin verso gli esiti del più acceso wagnerismo napoletano e bolognese, accanto a una lettura, appunto, ‘wagneriana’ dei Rerum petrarcheschi, si sviluppò anche un’attenta proiezione wagneriana di dante.
tornando all’esegesi pascoliana è bene specificare innanzitutto il livello ‘figurativo’ che il poeta coglie nella struttura dell’opera dantesca (e dico strut-tura specialmente in contrapposizione alla lettura crociana). Leggiamo dal paragrafo dell’articolo Intorno alla Minerva oscura, titolato La selva oscura:
[…] poi tutto parla di adolescenza nei luoghi che si riferiscono allo smarri-mento. dante afferma d’essere stato pien di sonno nel punto che si smarrì. non è questa sonnolenza un ricordo del concetto platonico per il quale l’anima è attonita e trasognata sulle prime del flusso e riflusso della materia?
e perché dunque non spiegare con le stesse parole i vv. 17-18 del Sonno di Odisseo: «e lontano / s’immerse il cuore d’odisseo nel sonno» e così i vv. 35-36: «ma non già lo vide / notando il cuore d’odisseo nel sonno»; ecc (cfr. tutti i distici finali delle sette lasse, eccetto gli ultimi, vv. 125-126 che chiudono circolarmente e si contrappongono ai vv. 17-18)8. sono i giorni, nove per l’esattezza, del viaggio di odisseo verso itaca. tutta la figuratività del reale che si presenta al viaggiatore è inattingibile al suo sonno «mitico» ed «eroico» che nega inconsciamente la meta (uso il termina ‘inconscio’ con molta cautela, privandolo non poco di tutte le superfetazioni psicanalitiche che hanno aggredito da decenni la poesia pascoliana). e non sarà certo sta-to oscuro a pascoli, nel duplice pellegrinaggio (dante e odisseo), la comu-
7 cfr. Jhon dixon hunt, The Pre-Raphaelite Imagination 1848-1900, Lincoln, university of nebraska press, 1968.
8 cito da Giovanni Pascoli, Poemi conviviali, a cura di giuseppe nava, torino, einaudi, 2008.
077_Marinoni_881.indd 883 18/11/15 13.54
La funzione Dante e i paraDigmi DeLLa moDernità884
ne derivazione (in omero) del sonno (῞Yπvoς) da ῎Eρεβος e da θάνατος. un sonno della coscienza con risvolti etici in dante e un sonno come «viaggio sotterraneo», secondo l’esegesi di nava, ove emerge il chiaro diagramma «leopardiano e pascoliano insieme, dell’occasione mancata, dell’inattualità del piacere, della felicità irraggiungibile». e, ancor più in generale, la prefi-gurazione, rispetto a un immaginario dell’antico, dell’idea, centrale in Sotto il velame, che «la comedia ha per argomento l’abbandono della vita attiva per la vita contemplativa». ma su questo tornerò in chiusura, riprendendo il tema delle «meteore spirituali».
proseguendo nell’esegesi del primo canto della Commedia, pascoli torna insistentemente sul problema dell’adolescenza come stato aurorale dell’ir-razionale (il tema verrà ripreso in Sotto il velame):
ell’è in vero una selva oscura, selvaggia, aspra e forte, tanto amara che poco è più morte, tremenda al pensiero e quasi ineffabile. non può essere se non quel che noi possiamo imaginare di peggio. e io rispondo ch’ella è oscura, selvaggia e aspra e forte, amara mortalmente, ineffabile e impensabile, e pur non è se non l’inganno, o vogliamo dire errore, ma con senso traslato sì, pur vicino al proprio, dell’adolescenza. […] perché la parte razionale dell’anima non discerne ancora. e questo appunto accade nell’adolescenza.
il discorso sull’irrazionalismo dell’antico in contrapposizione a una fi-deistica razionalità ‘cristiana’ che pascoli vuole nella struttura dantesca va connesso, nonostante l’esito cristiano, con le letture genealogiche e antropo-logiche di Leopardi e Vico su cui ha insistito nava (strumenti che tornano chiaramente, specie quello vichiano, anche per l’esegesi dantesca). È un fat-tore di cosmologia coscienziale (sempre alla luce dei problemi di carattere etico puntati sulla Commedia) quello che pascoli sta mettendo in campo per cristallizzare lo status dantesco prima dell’Itinerarium.
in fatti nell’uomo vivere è ragione usare, e chi non la usa, non vive, è morto […] ora essere, in certo modo, morto, ed essere nella selva amara quasi quanto la morte, tenendo conto del linguaggio figurato, è la stessa cosa. La stessa cosa dun-que dante dice di chi non ubbidisce, nella sua adolescenza, quando la ragione non perfettamente discerne, ai comandamenti de’ suoi maggiori, e di chi, pur nell’ado-lescenza, si lascia andare dietro le false imagini del bene.
ma c’è un punto ancor più importante che pascoli evidenzia nel circui-to ragionativo; e si tratta, nello specifico, «dell’anima semplicetta cHe sa nuLLa, non d’un uomo immerso nei vizi o nell’ignoranza; nell’ignoranza, dico, quale noi intendiamo». «La selva oscura è, come simbolo di mancanza di lume o di virtù che consiglia o di prudenza, così simbolo, conseguente-
077_Marinoni_881.indd 884 18/11/15 13.54
L’immaginazione simboLica tra «meteore spirituaLi» e ‘aLLegoresi’ dantesca 885
mente, di servitù». pascoli ha così costruito il profilo psicologico del perso-naggio costretto nella gabbia adolescenziale, che è innanzitutto distanza dal razionale, a partire del simbolismo della selva e da tutti i rispettivi connotati.
spostando per un poco il discorso dal piano esegetico al piano del lin-guaggio critico, notiamo come pascoli adoperi un lessico ben preciso per decodificare i circuiti significanti danteschi. e quindi i vari «simbolismo», ma anche le numerose «figurazioni» e il «mistero». un lessico che ha mol-to a che fare con l’orizzonte culturale di cui si parlava all’inizio, quello dell’estetismo europeo; quello della scrittura «veggente» e «visionaria» che tanto riuscì a sedurre i banchi di prova della cultura fin-de-siécle (compreso, naturalmente, pascoli). e mi riferisco, in primis, a Walter pater, le cui opere pascoli conosceva bene9. e qui si spiega anche molto del platonismo che agisce non solo in talune costruzioni poetiche, ma anche nell’interpretazio-ne di dante e della sua opera10. e con esso il modello esoterico (capovilla11 faceva i nomi di gabriele rossetti e di edmond aroux, a cui si potrebbe aggiungere – tutti da discutere – quelli di Frédéric ozanam, per Dante e la filosofia cattolica del tredicesimo secolo, del 1841, e di Francesco Flamini, specie, fra vari lavori danteschi, per I significati reconditi della Divina Com-media, del 1903).
torniamo per un poco sui problemi dell’«adolescenza». dopo aver riba-dito che «dove si parla di selva erronea», fra Commedia e Convivio, «e di selva oscura, si riscontrano più nell’idea d’adolescenza che in quella di selva» (pa-scoli parla già di «senso allegorico e anagogico»), e dopo essersi ampiamente soffermato sul rapporto dante-beatrice, pascoli ricorda gli «inganni cui l’ani-ma è soggetta […] causati dall’imperfezione naturale della conoscenza uma-na». all’interno di Sotto il velame si deve ora fare un salto molto lungo verso il ii paragrafo de La fonte prima dove leggiamo che «la comedia di dante ha questo argomento»: «il dramma della vita attiva e contemplativa». ancor più nello specifico, in una dicotomia che ha matrice platonica (anzi neo-platonica; non possiamo non ricordare tutti i percorsi del bios theôrêtikós da pltotino a
9 cfr. isabella nardi, Pascoli e il platonismo dell’età vittoriana, in Convegno internazionale di studi pascoliani, barga 1983, prima edizione speciale dei Quaderni pascoliani, 3 Voll., barga, 1988, Vol. ii, pp. 87-114 e il più recente elisa bizzotto, Riflessi dell’estetismo e suggestioni pateriane nell’opera di Pascoli, «strumenti critici», 3, 2005, pp. 379-402.
10 al di là delle ovvie e numerose letture, anche in un’ascendenza di ‘filologia della suggestione’, ricordo il ruolo essenziale, in proposito, di Francesco acri, antihegeliano e vicino allo spiritualismo rosmi-niano, traduttore e commentatore di platone. ma anche autore di un Abbozzo d’una teorica delle idee, del 1870 e, ancor più importante per il nostro discorso, di notevoli studi sul tomismo medievale, con indagini sui problemi dell’etica, confluiti in San Tommaso e Aristotele, nel 1908. studi di cui pascoli si servì quasi sicuramente per ripercorrere i sentieri ‘etici’ della tassonomia dantesca dei peccati
11 cfr. Guido caPovilla, Pascoli, roma-bari, Laterza, 2000, pp. 136-143.
077_Marinoni_881.indd 885 18/11/15 13.54
La funzione Dante e i paraDigmi DeLLa moDernità886
giamblico e proclo, con la centralità della dimensione assente, e mistica allo stesso tempo, del «silenzio» – altro tema essenziale ed esistenziale dei Convi-viali) prima che aristotelica, verso un «“altro viaggio”, che è, prima, dell’atti-vità dispositiva alla contemplazione, e poi della contemplazione, se la volontà purificata dall’ultimo fuoco sarà da sé disposta». guglielmi ha commentato questo passo connettendolo al «tema del poeta che ottiene il dono della veg-genza, ma a prezzo di una rinuncia. il poeta non ha occhi per la vita pratica. e l’aedo (aoidós) che ha veduto (oide), ma aoidós […] era, secondo un etimo poetico, colui che non vede. ci troviamo qui di fronte a una poetica plato-nizzante, in cui poesia è conoscenza per illuminazione». La trasfigurazione del reale, sia essa tramite rigenerazione ‘fonica’ o ri-semantizzazione ‘mitica’ (in pascoli va detto però che prevale la prima in virtù di una trama mitica di tipo ‘esclusivo’), passa attraverso una ‘riscrittura’ delle trame percettive (ecco le potenzialità ‘verticali’ del simbolo)12, in un circuito che sta fra i confini del «mistico» (e ce lo spiega bene attraverso dante, dall’attivo al contemplativo), e che porta elementi del comune verso un silenzio della materia prima che tace, per far parlare un linguaggio più profondo, del sogno, del mistero e dell’ignoto. È un’intuizione mistica che sta alla base della práxis poetica del simbolo; ed è un percorso ascendente che ha il corpo del viaggiatore, sia esso in perpetua distanza (nostos) dalle radici del senso, sia, come dante, vicino alla rigenerazione dell’interiore, la stessa della «morte […] che rigenera», di cui pascoli parla nel XXV capitolo della Mirabile visione, in una dimensione in cui «dante, esce dal passo: muore. e si riposa, cioè comincia a rivivere».
Quello che, a livello poetico, ha le medesime sembianze delle
meteore spirituali che scoppiano nel silenzio del sonno, e lasciano, al risveglio, l’anima rinverdita e rinnovata come dal refrigerio d’una tempesta. (corsivi miei).
12 sul simbolismo pascoliano cfr. almeno GiusePPe nava, I Canti di Castelvecchio. Simbolo o allegoria?, in Giovanni Pascoli. Poesia e poetica, atti del convegno internazionale di studi pascolia-ni, san mauro, 1-2-3 aprile 1982, santarcangelo di romagna, maggioli editore, 1984, pp. 327-346; Maurizio PeruGi, Dantismo pascoliano e orfismo europeo, in «Operosa parva» per Gianni Antonini, studi raccolti da domenico de robertis e Franco gavazzeni, Verona, edizioni Valdonega, 1996, pp. 315-327 e Marco antonio bazzocchi, Pascoli: interpretazione e simbolismo, in «rivista pascoliana», 7, 1995, pp. 9-30. di nava si vedano anche tutti i preziosi commenti pascoliani. importanti, in altra direzione, le riflessioni sul simbolo di luiGi baldacci, Poesie del Pascoli, in id., Ottocento come noi. Saggi e pretesti italiani, milano, rizzoli, 2003, pp. 209-245. ulteriori recenti approfondimenti in Pier vincenzo MenGaldo, Antologia pascoliana, roma, carocci, 2014 (più nelle singole analisi dei testi che nell’introduzione). sarebbe assai fruttuoso, alla luce dei lavori di raimondi, Viazzi e maxia, intra-prendere un discorso sistematico sulle modalità simboliche (o esiti distinti di una medesima modalità) all’interno di una processualità funzionale della parola (e quindi del simbolo) nelle varie fasi poetiche del pascoli (e così alla luce delle differenti relazioni con l’antico).
077_Marinoni_881.indd 886 18/11/15 13.54
INDICE DEL VOLUME
Il Convegno 13
RELazIONI
Tullio De Mauro, La Commedia e il vocabolario di base dell’italiano 17Clelia Martignoni, Funzione Dante/Funzione Gadda. Contini
tra contemporaneità e medioevo 25annamaria andreoli, Dantolatria fra Otto e Novecento:
il caso d’Annunzio 37Marco antonio Bazzocchi, Matelda, un mito simbolista 53Enrico Elli, Odìsseo, Ulisse, Nessuno: le metamorfosi novecentesche
di un mito 65Sandro Gentili, Il realismo di Dante (da De Sanctis ad Auerbach):
una categoria critica per la modernità letteraria 85Stefano Carrai, La funzione Dante nel dialogo del poeta con i defunti 109Pietro Cataldi, Dante in Ungaretti e in Montale 121Daniele Maria Pegorari, L’ermetismo italiano sub specie Dantis 131
COMUNICazIONI
Stefano Evangelista, Ugo Foscolo: il «Discorso sul testo della Divina Commedia» e i due articoli della «Edinburgh Review» 149
Enza Lamberti, Il pittore dell’uman genere: il Dante “europeo” di Foscolo tra storia, lingua e poesia 159
Maria Panetta, Suggestioni dantesche in Foscolo 173Elena Rondena, Dante nei Conciliatori 181Mauro Bignamini, Dantismi manzoniani tra Inni sacri e
Fermo e Lucia: prime riflessioni e qualche ipotesi di lavoro 189
004_indice_909.indd 909 19/11/15 11.02
La funzione Dante e i paraDigmi DeLLa moDernità910
Maria Luisa Pani, «In qual dimora le bestie morte fosser vive ancora»: il paradigma dantesco nell’aldilà dei Paralipomeni della Batracomiomachia 201
Novella Primo, «O dell’etrusco metro inclito padre». Considerazioni sul dantismo leopardiano 209
Matteo Basora, L’«Inferno» dantesco “travestito” in milanese. La versione di Carlo Porta e di Francesco Candiani a confronto 219
Giuliana Ortu, Enrico Costa e i personaggi danteschi del romanzo storico 227
Clara Borrelli, Francesca da Rimini nella tragedia della prima metà dell’Ottocento 237
Rosanna Morace, La tragedia del conte Ugolino tra Alfieri e Marenco 251Alessio Giannanti, La fortuna otto-novecentesca del Conte Ugolino
nel romanzo italiano 261Francesca Tomassini, La stesura di Porcile. Pasolini tra Dante,
Peter Weiss e il Living Theatre 271Anna Cesaro, Dall’Inferno al Paradiso: un percorso ascendente
alla ricerca del ‘senso’ (Tre Lai di Giovanni Testori) 279Carmela Citro, La Divina Commedia di Federico Tiezzi
(Cividale 1991) 289Monica Venturini, Una incerta fedeltà: Pirandello lettore
e studioso di Dante 297Francesca Riva, Trementina dantesca nelle vernici di Svevo 309Alberico Guarnieri, I librai all’inferno. Su Tre croci
di Federigo Tozzi 317Annibale Rainone, Riflessi danteschi in Moravia 331Silvia Ceracchini, Rimembranze dantesche nell’Isola di Arturo
di Elsa Morante 339Luciano Longo, Il Dante ‘pre-umanista’ di Giuseppe Ungaretti 347Agata Irene De Villi, «Come una candela al sole». Saba e la querelle
Dante-Petrarca 355Maria Silvia Assante, Sul limite del limite: suggestioni dantesche
in Montale 367Matteo Zoppi, «Il mio Inferno a poco prezzo»: la Genova dantesca
di Camillo Sbarbaro 377Caterina Francesca Giordano, «Nell’infinito mi parlavi, o Padre!»:
le incidenze dantesche nella poesia di Gozzano 385
004_indice_909.indd 910 19/11/15 11.08
indice del volume 911
Costanza Geddes da Filicaia, La presenza di Dante in Campana: riflessioni e suggestioni 393
Carlangelo Mauro, «In pro del mondo che mal vive»: Quasimodo e Dante 399
Luigi Ernesto arrigoni, Citazioni e contaminazioni dantesche nell’opera di Alfonso Gatto 409
Valentina Puleo, La discesa agli inferi in Dino Buzzati: dal paradigma dantesco alla memoria del mito 417
Teresa agovino, O mente che scrivesti cio ch’io vidi. Influssi danteschi nella prosa di Primo Levi 425
Maria Concetta Trovato e Liborio Barbarino, «Non si sfugge alla selva»: appunti per un alfabeto dantesco in Pavese 433
Salvatore Francesco Lattarulo, Un «maledetto toscano» all’Inferno: la prima cantica del poema di Dante ne La pelle di Curzio Malaparte 443
Sandro de Nobile, L’inferno del “Cottolengo”. Suggestioni dantesche ne La giornata d’uno scrutatore 455
Davide Savio, Libri in forma di arca. L’influenza della «Commedia» sul «Castello dei destini incrociati» di Italo Calvino 463
Michela Mastrodonato, La «pianta difforme» cresciuta dal seme di Contini: Dante secondo Pier Paolo Pasolini 471
Dario Stazzone, Note sul dantismo di Pasolini, da La Divina Mimesis a le Bolge della Visione in Petrolio 481
Gilda Policastro , La catabasi oscena da Pasolini ad Aldo Nove 493Luca Daino, Oggi l’inferno è in città. Echi danteschi nella Tempesta
di Emilio Tadini 501Sarah Sivieri, Dante detective 513Renato Marvaso, Gli incendiati di Moresco e la cosmologia dantesca 521Vittorio Criscuolo, Tra Inferno, Purgatorio e Paradiso: immaginazioni
dell’aldilà nella poesia napoletana del XIX e XX secolo 529Elena Pisuttu, La vita: una commedia tra Cielo e Terra.
Sa Mundana Cummedia di Salvatore Poddighe 541alessandro Terreni, Tra visione e voce: Antonio Porta e il Canto V
dell’Inferno 549Federico Milone, Il paradigma dantesco nelle prime opere
di Alfredo Giuliani. Dante (con Pound e lo stilnovo) fra Cuore zoppo e Novissimi 557
004_indice_909.indd 911 19/11/15 11.02
La funzione Dante e i paraDigmi DeLLa moDernità912
Riccardo Donati, Incarnazioni dantesche in Dai cancelli d’acciaio di Gabriele Frasca 565
Paolo Rigo, Riscritture dantesche per Fernando Bandini: segni dell’ultimo stilnovismo 573
Daniela Marredda, Sui Medicamenta ‘petrosi’ di Patrizia Valduga 581Maria Cristina Di Cioccio, Dante Alighieri nella poesia di Pavese
giovane 589Francesca Tuscano, L’epica dell’esilio. La funzione Dante in
Lavorare stanca di Cesare Pavese 599Veronica Tabaglio, «Amico di Caronte». L’influenza dantesca
nelle opere di Giorgio Vigolo 611Fabrizio Miliucci, Dante nelle Prose critiche di Giorgio Caproni 623Francesco Venturi, Tracce e figurazioni dantesche nella
«pseudo-trilogia» di Andrea Zanzotto 631Massimo Colella, «Di quale testo di Dante parliamo?».
Momenti e segnali del dantismo zanzottiano 639Elisa Palmigiani, «O Beny / eau bénite!». La «benedetta Beatrice»
secondo Marinetti 649Chiara Coppin, Dante personaggio sulla scena europea 659Toni Marino, La Commedia come modello di lettura del Novecento
letterario. I casi di Virginia Wolf, Derek Walcott e Giorgio Pressburger 667
Rosa Giulio, «Un sogno fatto alla presenza della ragione». La presenza di Dante in Eliot e Montale 679
Mario Rescigno, Da Caronte a Robert de Niro: riflessi danteschi nella letteratura spagnola contemporanea di Carmen Martín Gaite 693
Oretta Guidi, Jorge Borges tra alcune citazioni dantesche e suggestioni stilnovistiche 705
Marilena Squicciarini, Il «volume» squadernato. Dante nella scrittura creativa di Jorge Luis Borges 717
Ida De Michelis, «Qui si parrà la tua nobilitate»: interferenze dantesche nei palinsesti faustiani 727
Virna Brigatti, Le Rime di Dante in Einaudi: la traduzione di un testo medioevale nel Novecento 739
Elisa Donzelli, Diego Valeri, la metafora dell’angelo: da Dante agli amici pittori e poeti 749
004_indice_909.indd 912 19/11/15 11.02
indice del volume 913
Nunzia Soglia, Dante testimonial pubblicitario 759Delio De Martino, La Commedia come paradigma del consumatore
postmoderno 767Bianca Garavelli, Dante e la scienza contemporanea 775Daniela Bombara, Dante tecnologico dai videogiochi ai social network:
manipolazioni e rivisitazioni di Dante autore e personaggio 785Cinzia Gallo, Dante nella poetica del Verismo 793Rosalba Galvagno, La funzione Dante nell’insegnamento
di Jacques Lacan 803antonello Perli, L’epica dantesca, e l’analogia Dante-Dostoevskij,
nelle teorie del romanzo di Lukács e di Bachtin 813annabella Petronella, Immaginazione e poesia. Elementi di critica
dantesca in Calvino e Pasolini 823Emanuele Fazio, Influenze dantesche nella scrittura autobiografica
di Dolores Prato 831Gabriele Fantini, Dante nelle «Epoche della lingua»: la fondazione
di un paradigma 837Silvia Uroda, Dante, i Granelleschi, Gasparo Gozzi 847Ilaria Puggioni, Dante e dantismo letterario nei periodici sardi
tra Otto e Novecento 855Marco Manotta, «Turbato è il significato». Dante nella ricerca
linguistica di Luigi Meneghello 863Martina Mengoni, Li maggior loro. Dante a Torino tra le due guerre 871Manuele Marinoni, L’immaginazione simbolica tra «meteore
spirituali» e ‘allegoresi’ dantesca. Pascoli lettore del Poema Sacro 881antonio Soro, «…veggio la rete che qui vi ’mpiglia» (Pg XXI 76-77).
In limine: tra «rottami» di strofe l’uscita dal purgatorio metastorico 887Carmelo Princiotta, Dante DNA della poesia? Etica e lingua
dopo il ’68 893
IN MaRGINE aL CONVEGNO
Patrizia Bertini Malgarini e Ugo Vignuzzi, Gli scritti danteschi di Ignazio Baldelli: una silloge recente 905
004_indice_909.indd 913 19/11/15 11.02
Edizioni ETSPiazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
[email protected] - www.edizioniets.comFinito di stampare nel mese di novembre 2015
004_indice_909.indd 915 19/11/15 11.02