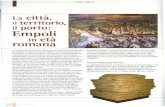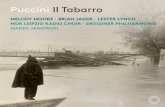Morte e rinascita simbolica: il cambio d'abito, in S. Botta (ed.), Abiti, corpi, identità. Atti del...
Transcript of Morte e rinascita simbolica: il cambio d'abito, in S. Botta (ed.), Abiti, corpi, identità. Atti del...
Sguardi Sul mondo antico Ù 3
ABITI, CORPI, IDENTITÀSIgNIfICATI E vAlENzE PROfONDE DEl vESTIRE
A cura di Sergio Botta
abiti, corpi, identità4 Ù
© 2009 Società Editrice fiorentinavia Aretina, 298 - 50136 firenze
tel. 055 5532924fax 055 5532085
isbn: 978-88-6032-125-1
Proprietà letteraria riservataRiproduzione, in qualsiasi forma, intera o parziale, vietata
Grafica e layoutMarianna ferrara
In copertinaClelia Pellicano, Wat Mahathat, Bangkok (2006)
Sguardi Sul mondo antico Ù 5
Indice
Introduzione 7
u n o S g u a r d o t e o r i c o
aleSSandro SaggioroLasciar fare all’abito, fondare l’uomo 15
gian piero JacobelliSenza cuciture 27
S g u a r d i S u l m o n d o a n t i c o marta rivaroliIl vestiario degli dèi: indossare la giusta ‘veste’ 47 lorenzo verderameLa vestizione di Inanna 63
pietro giammellaroCoperto di misere vesti. Forme del vestire e codici di comportamentonel racconto omerico di Odisseo mendicante 75
maría cruz cardete del olmoIl manto della Despina di Licosura 87
diana Segarra creSpoDa Arlecchino a Flora attraverso il vestito 99
abiti, corpi, identità6 Ù
paola carcilloL’abbigliamento femminile nell’opera di Festo: prospettive storico-religiose 115
gianluca de SanctiSMos, imago, memoria. Un esempio di come si costruisce la memoria culturale a Roma 123 arduino maiuriL’equipaggiamento saliare tra funzionalità estetica e simbologia sacrale 149
FranceSca romana nocchiMorte e rinascita simbolica: il cambio d’abito 169
S g u a r d i S u l m o n d o c r i S t i a n o carla noceL’abito nella rappresentazione della donna eretica: alcune immagini dal cristianesimo antico 205
maria chiara giordaUna questione di schema: l’abito esteriore ed interiore alle origini del monachesimo egiziano 243 FranceSca SbardellaAbiti nella preghiera dei corpi: stati mistici e pratica spirituale 255
S g u a r d i S u l l e a m e r i c h e e S u l l ’ o r i e n t e Sergio bottaVestire gli ignudi, spogliare gli dèi. Il pensiero missionario di fronte all’abbigliamento delle divinità nel Messico coloniale 273
chiara letiziaL’abito rituale fa il monaco newar. Sul rito di iniziazione delle alte caste buddhiste newar del Nepal 291
Federico SquarciniSpogliati dell’abito, vestiti di nudità. Codifiche identitarie e distinzioni del vestiario ascetico nella classicità sudasiatica 317
claudia mattalucci«Ecco il nostro cappello». Rivestire la Turchia moderna 335
Sguardi Sul mondo antico Ù 169
FranceSca romana nocchi
Morte e rinascita simbolica: il cambio d’abito
1. Linee programmatiche
festo riporta un’interessante testimonianza indicativa di come i riti di passaggio femminili si svolgessero parallelamente a quelli maschili e partecipassero dello stesso codice vestimentario: Regillis tunicis albis et reticulis luteis, utrisque rectis, textis sursum versus a stanti-bus pridie nuptiarum diem virgines indutae cubitum ibant ominis causa, ut etiam in togis virilibus dandis observari solet.1 Anche Plinio il vecchio riferisce, a proposito del medesimo indumento, che era indossato, indifferentemente, da uomini e donne: Ea (Gaia Caecilia) prima texuit rectam tunicam, quales cum toga pura tirones induuntur novaeque nuptae.2 Evidentemente le due celebrazioni, già dagli antichi, erano poste sul-lo stesso piano ed in effetti i rituali di entrambe presentano chiare analogie: il cambio d’abito, la deposizione dei simboli della fanciul-lezza (bullae, pupae), la segregazione antecedente al rito, i sacrifici e le deductiones come momento di presentazione e integrazione nella società, costituiscono un patrimonio comune; inoltre in entrambi i casi la cerimonia pubblica è successiva alla consacrazione privata. Anche i presupposti ideologici della presa della toga virile e del ma-trimonio sono identici: infatti, entrambi i riti segnano l’ingresso dei due sessi nella vita sociale con i compiti ed il ruolo che competono loro in base ai presupposti culturali tipici del popolo romano, anche
1 fest., p. 364 l.: «le fanciulle andavano a letto il giorno prima delle nozze, per scongiurare la cattiva sorte, rivestite con tuniche regali bianche e con reticelle color arancio, entrambe semplici, tessute a partire dall’alto, da persone che stavano in piedi, come si suole fare anche per i fanciulli che indossano la toga virile».
2 Plin., Naturalis historia, 8, 194: «Gaia Caecilia fu la prima a tessere una tunica semplice, come quelle che, insieme ad una toga pura, sono indossate dai giovani o dalle spose novelle».
abiti, corpi, identità170 Ù
se nell’assunzione della toga è maggiormente evidente il legame con la maturazione psico-fisica. È stato supposto, a questo proposito,3 che anche per le fanciulle, come per i fanciulli, esistettero in età arcaica riti della pubertà e cerimonie private che segnavano il passaggio alle diverse fasi della crescita.4 In epoca storica tutti questi sacra privata sarebbero stati inglobati nel matrimonio, l’unico rito di passaggio femminile rimasto: esso era considerato il momento più importante nella vita della donna, in quanto comportava per lei l’accesso nella società in qualità di potenziale mater familias. Secondo questa pro-spettiva, i costumi prenuziali, che precedevano le vere nuptiae, non sarebbero altro che il residuo di antichi riti della pubertà. Senza voler pretendere di arrivare a una soluzione del problema, qui si intende semplicemente rilevare la complessità dell’istituto del matrimonio, in cui confluiscono elementi tipici del rito di passaggio privato, ma anche la sanzione ufficiale della piena maturità fisiologica raggiunta dalla donna e la sua integrazione nella società come matrona: inoltre si intende procedere attraverso un’analisi parallela del rito di assun-zione della toga virile, per chiarire le analogie. In realtà anche in questo caso si è di fronte a molto più che un rito di pubertà: esso segna, come il matrimonio, il passaggio del giovane dalla dimensione familiare e dall’atmosfera protettiva della familia alla vita civile, con tutti i doveri di civis comportati dal nuovo status,5 così come avviene per la donna, potenziale mater familias. giustamente è stata rilevata6 una certa evoluzione anche di questo costume, che si è modificato nei secoli: il passaggio da una società familiare e gentilizia alla priori-tà assoluta della civitas ha comportato la trasformazione del rito, che da semplice sanzione privata della maturazione fisica del giovane, è divenuto riconoscimento pubblico della sua pubertas e integrazione ufficiale nella società. In effetti entrambe le cerimonie inglobano i caratteri dell’iniziazione tribale e dei riti di passaggio: in comune con la prima hanno soprattutto la componente pubblica, che mira a con-ferire all’individuo, attraverso una serie di fasi successive, lo status di membro attivo della comunità, conformandolo alle proprie esigenze
3 Per questa teoria cfr. infra, p. 191 sg.4 Su questo argomento cfr. J.P. Neredau, La jeunesse dans la literature et les institutions
de la Rome republicaine, Paris 1979, p. 153, il quale menziona tutta una serie di riti che, a suo dire, avrebbero potuto costituire riti di passaggio femminili, collegati alla figura del re Servio, che era famoso anche per aver operato una classificazione del popolo romano in base all’età. Suggestiva è l’ipotesi, per la verità scarsamente supportata dalle fonti, for-mulata da A. Illuminati, Mamurius Veturius, in «Studi e Materiali di Storia delle Religio-ni», 33 (1961), pp. 41-80, secondo il quale anticamente vi sarebbero stati tutta una serie di riti iniziatici maschili, che si svolgevano da febbraio a marzo, ad opera dei Luperci e dei Salii, tramite i quali i giovani venivano introdotti all’arte della guerra e della violenza.
5 A questo proposito Tacito (Germania, 13, 7) sintetizza emblematicamente il valore che la cerimonia aveva per il cittadino romano, paragonandola all’assunzione delle armi per i germani: Haec apud illos toga, hic primus iuventae honos; ante hoc domus pars videntur, mox reipublicae («Questo corrisponde per loro alla toga virile, questo è il primo riconoscimento onorifico; prima si considerano parte della famiglia, poi dello Stato»).
6 Neredau, La jeunesse, cit., pp. 158-159.
Sguardi Sul mondo antico Ù 171
e alla propria ideologia.7 Durante il periodo di segregazione o margi-ne i giovani apprendono le attività economiche tipiche di ogni sesso e le norme di convivenza civile, mentre il momento di aggregazione segna l’inserimento dell’iniziando nell’ordine sociale. Egli, in questo modo, è reso capace di svolgere le attività sociali tipiche della civiltà romana, come la salvaguardia delle norme sociali, la riproduzione fisica del gruppo, la sussistenza economica. Il processo prevede an-che una morte simbolica ed una rinascita ad un nuovo status: questo passaggio è rappresentato metaforicamente dal cambio d’abito.
Per comprendere la comune matrice dei due riti verranno in-nanzitutto indagate le componenti religiose, ovvero i rapporti con il divino ed i sacrifici propiziatori della prosperità; quelle profane, in particolare i riti apotropaici; infine, i presupposti sociali, che implicano l’accesso al nuovo status di civis e di mater familias. Suc-cessivamente verranno analizzati i riti vestimentari, con i quali sim-bolicamente si intendeva contrassegnare il cambiamento di vita da parte dei giovani, con particolare attenzione ai risvolti ideologici sottesi alla scelta dei nuovi indumenti.
2. Origine agraria dei riti
In epoca arcaica i giovani indossavano la toga virile il 17 marzo, giorno dedicato alla festa dei Liberalia, mentre più tardi poteva es-sere scelto un giorno qualsiasi anche se, come si dimostrerà, i Ro-mani, pur non comprendendone più le motivazioni, continuavano a considerare questa data la più adatta alla cerimonia. Per scoprire le analogie fra il rito nuziale e quello della toga virile è necessario capire a quale divinità, originariamente, fosse dedicata la festività dei Liberalia. Ovidio8 cerca di dare una spiegazione eziologica del
7 A. Brelich, Paides e parthenoi, Roma 1969, p. 18, considera l’iniziazione un costu-me mediante il quale l’individuo acquisisce le competenze per poter accedere al suo gruppo sociale di appartenenza. l’autore, però, separa nettamente il rito di pubertà, privato e individuale, da quello d’iniziazione, caratterizzato dalla componente pubbli-ca e sociale (p. 22). In questo lavoro si intende chiarire che nel caso del matrimonio e dell’assunzione della toga le due componenti sembrerebbero coesistere.
8 Ov., Fasti, 3, 771-788: Restat ut inveniam quare toga libera detur/ Lucifero pueris, candide Bacche, tuo:/ sive quod ipse puer semper iuvenisque videris,/ et media est aetas inter utrumque tibi;/ seu quia tu pater es, patres sua pignora, natos,/ commendant curae numinibusque tuis:/ sive, quod es Liber, vestis quoque libera per te/ sumitur et vitae liberioris iter:/ an quia, cum colerent prisci studiosius agros,/ et faceret patrio rure senator opus,/ et caperet fasces a curvo consul aratro,/ nec crimen duras esset habere manus,/ rusticus ad ludos populus veniebat in Urbem/ (sed dis, non stu-diis ille dabatur honor:/ luce sua ludos uvae commentor habebat,/ quos cum taedifera nunc habet ille dea),/ ergo ut tironem celebrare frequentia possit,/ visa dies dandae non aliena togae? («Resta da scoprire perché la libera toga sia conferita ai ragazzi/ proprio nella tua giornata festiva, splendido Bacchus./ È perché tu stesso sembri essere sempre ragazzo e adulto,/ di un’età intermedia tra l’uno e l’altro;/ o perché tu sei Padre, e i padri i loro tesori, i bambini,/ raccomandano alla tua protezione divina;/ o perché tu sei Liber e libera toga è conferita in tuo nome/ e costituisce l’accesso ad una vita più libera;/ oppure perché, all’epoca in cui i nostri antenati coltivavano i campi con maggiore impegno di noi,/ in cui i senatori lavoravano la terra paterna/ e il console assumeva i fasci del potere mentre
abiti, corpi, identità172 Ù
patronato di Liber sui fanciulli proponendo quattro alternative: in-nanzitutto dice che probabilmente la scelta era dovuta al fatto che Liber, da lui identificato con Bacchus, aveva un habitus giovanile e per questo era vicino ai fanciulli; inoltre il dio veniva spesso insi-gnito del soprannome di Pater,9 dunque i genitori preferivano affi-dare alle sue cure i propri figli; il nome Liber sembrava prefigurare l’accesso ad una vita più libera, qual era quella del giovane ormai divenuto adulto; infine il poeta ricorda che anticamente tutti i con-tadini si radunavano in città per festeggiarlo e questa era una buo-na occasione per celebrare anche il conseguimento della maturità da parte dei giovani. Si tratta di ipotesi piuttosto inverosimili, che testimoniano come in epoca imperiale ormai non si conoscesse più con certezza né l’origine del nome Liber,10 né la reale identità di questo dio, ma il legame fra i Liberalia e la presa della toga maschile era ancora stretto. In effetti, in base ai più recenti studi, sembra verosimile ipotizzare che i Liberalia fossero un’antica festa dedicata ad una divinità italica della fertilità, chiamata Liber Pater e che non avessero nulla a che fare con le cerimonie in onore di Dionysus, quali i Cerealia, i Bacchanalia. la festa dei Liberalia è piuttosto data-ta: è iscritta su uno dei più antichi calendari, quello di Numa, ma in epoca recenziore nello stesso giorno si sovrapposero gli Agonia, in onore di Mars.11 Proprio in virtù dell’antichità della cerimonia, possediamo scarse notizie sulle modalità dei festeggiamenti: Ovidio e varrone ci informano che delle donne anziane, sacerdotesse di
era impegnato con l’aratro ricurvo/ e in cui non era un delitto avere le mani callose,/ il popolo dei contadini veniva in città per assistere ai giochi/ [questa era allora la festa del dio, non un’occasione per divertirsi:/ in onore dell’inventore dell’uva si celebravano in questa giornata dei giochi,/ quelli che ora egli condivide con la dea che regge la fiac-cola]./ È questa la ragione per cui questa giornata non sembrò inadatta a conferire la toga:/ perché la folla, riunita, potesse festeggiare il ragazzo?»).
9 Sull’uso di questo epiteto riferito a Liber ci informa A. Bruhl, Liber Pater, Paris 1953, p. 14, il quale riferisce che esso era attribuito a divinità ed eroi in segno di vene-razione. lo stretto legame che sembra esistere fra Liber e l’appellativo Pater può, a detta dello studioso, avere due origini: o si intende in questo modo collegarsi alla concezione che i latini avevano del dio come protettore ‘maschile’ della vegetazione, oppure si voleva esprimere l’aspetto umano del dio, promotore di effetti positivi per l’uomo. l’autore, però, non esclude che l’epiteto costituisse un elemento di distinzione fra il dio greco, chiamato semplicemente Liber e la divinità italica.
10 Per l’etimologia del nome Liber cfr. Sen., De tranquillitate animi, 17, 8: Liberque non ob licentiam linguae dictus est inventor vini, sed quia liberat servitio curarum animum, et adse-rit vegetatque et audaciorem in omnes conatus facit («l’inventore del vino è stato chiamato Liber non per la licenza della sua lingua, ma perché libera l’animo dalla schiavitù degli affanni e lo dichiara libero e lo vivifica e lo rende più audace di fronte ad ogni tentati-vo»); fest., p. 103 l.: Liber repertor vini ideo sic appellatur, quod vino nimio usi omnia libere loquantur («Liber, inventore del vino è chiamato così perché coloro che bevono troppo vino dicono ogni cosa liberamente»); Cic., De natura deorum, 2, 24: Quod ex nobis natos li-beros appellamus, idcirco Cerere nati nominati sunt Liber et Libera («Chiamiamo liberi i nostri figli proprio perché furono chiamati Liber e Libera i figli di Ceres»).
11 la coincidenza non è priva di significato se si considera che l’assunzione della toga rappresentava per il giovane anche l’accesso alla leva.
Sguardi Sul mondo antico Ù 173
Liber coronate d’edera, vendevano dei dolci di miele e farina, i liba12 ed avevano con sé dei piccoli altarini su cui offrivano agli dei una piccola parte prelevata dal dolce, per conto del compratore.13
Anche Agostino è una fonte preziosa per il culto di questo dio: egli parla di culti licenziosi in onore di Liber, che prevedevano del-le falloforie. Un membro virile veniva portato in processione su un carretto prima in campagna, poi in città; a lavinio, addirittura, veniva consacrato un intero mese in onore del dio, durante il qua-le venivano pronunciate sconce invocazioni fino a quando il fallo, dopo aver attraversato la piazza, non veniva incoronato da una ma-ter familias: il rito serviva per placare il dio e renderlo favorevole al raccolto, allontanando ogni cattivo presagio.14
In base ai ritrovamenti archeologici15 gli studiosi moderni ipotiz-zano l’esistenza di un dio italico, che presiedeva alla fertilità dei cam-pi, tant’è vero che la sua festa era celebrata all’inizio della primavera e per invocare la sua protezione sui raccolti futuri venivano realizzate delle focacce con i prodotti agricoli italici: la sua assimilazione con il
12 Ovidio (Fasti, 3, 733-736) fornisce un’etimologia inventata del termine e tenta som-mariamente di spiegare l’origine del costume: egli sostiene che i liba trarrebbero il nome da Liber e che l’invenzione del miele, avvenuta in Tracia, è attribuibile a Bacchus; infine sono le donne che vendono le focacce perché il culto del dio è praticato prevalentemente da loro. È evidente che l’errore è ingenerato dalla confusione fra la divinità ellenica e Romana. Per l’usanza cfr. anche verg., Georgica, 2, 394: Ergo rite suum Baccho dicemus hono-rem/ carminibus patriis lancesque et liba feremus («Dunque, secondo l’usanza rituale, pronun-ceremo in onore di Bacchus/ gli inni dei nostri padri e porteremo piatti e focacce»).
13 varro, De lingua latina, 6, 14: Liberalia dicta quod per totum oppidum in eo die sedent (ut) sacerdotes Liberi anus hedera coronatae cum libis pro emptore sacrificantes («le feste sono dette Liberalia perché in tutta la città siedono in quel giorno delle donne anziane in qualità di sacerdotesse di Liber, incoronate d’edera e con focacce, che sacrificano a favore del compratore»); cfr. anche Ov., Fasti, 3, 713-808.
14 Aug., De civitate dei, 7, 21: In Italiae compitis quaedam dicit sacra Liberi celebrata cum tanta licentia turpitudinis, ut in eius honorem pudenda virilia colerentur, non saltem aliquan-tum verecundiore secreto, sed in propatulo exultante nequitia. Nam hoc turpe membrum per Liberi dies festos cum honore magno plostellis impositum prius rure in compitis et usque in urbem postea vectabatur. In oppido autem Lavinio unus Libero totus mensis tribuebatur, cuius diebus omnes verbis flagitiosissimis uteretur, donec illud membrum per forum transvectum esset atque in loco suo quiesceret. Cui membro in honesto matrem familias honestissimam palam coronam necesse erat imponere. Sic videlicet Liber deus placandus fuerat pro eventibus seminum, sic ab agris fascinatio repellenda, ut matrona facere cogeretur in publico, quod nec meretrix, si matronae spectarent, per-mitti debuit in theatro («varrone dice che nei crocicchi d’Italia furono celebrati i misteri di Liber con tanta licenziosità che in suo onore si ebbe un culto fallico, e almeno fosse avvenuto in un luogo un po’ appartato, ma in pubblico con sfrenata dissolutezza. Infatti, durante le feste di Liber, uno sconcio membro virile, esposto con gran solennità su un carretto, veniva trasportato dapprima in campagna nei crocicchi e poi in città. Nel paese di lavinio si consacrava a Liber un mese intero, durante il quale tutti pronunciavano del-le sconce invocazioni fino a quando l’organo fallico non riattraversava la piazza e veniva ricollocato al suo posto. la più onesta madre di famiglia doveva pubblicamente imporre una corona all’emblema disonesto. In questo modo si doveva propiziare il dio Liber per il buon esito dei semi, si doveva allontanare il malocchio, per questo si costringeva una matrona a compiere un rito che non si doveva permettere in teatro neppure ad una cor-tigiana se le matrone fossero state presenti»).
15 Bruhl, Liber Pater, cit., pp. 14-15, riferisce, ad esempio, di alcuni cippi in cui vi sarebbe il nome Liber inserito fra quelli di altre divinità italiche.
abiti, corpi, identità174 Ù
Dionysus greco dovette avvenire in epoca piuttosto antica, probabil-mente già a partire dal Iv secolo a.C.16 Qualunque sia l’identità origi-naria del dio, è indubitabile l’esistenza di un suo culto fallico legato ai riti agrari, per cui non sembra neppure inverosimile supporre che la protezione da lui esercitata sulla fecondità vegetale si estendesse anche su quella animale: non a caso, dunque, i festeggiamenti per il passaggio alla pubertà dei giovani cadevano proprio durante la cele-brazione di Liber Pater,17 quale dio della crescita e dello sviluppo.
Un’altra componente molto importante di questo culto, come si è visto, doveva essere quella apotropaica: il membro virile aveva nella tradizione italica proprio questa funzione, basti pensare all’importan-za dei versi fescennini, la cui etimologia si fa risalire a fascinum, termi-ne con cui si indica l’organo maschile. Inoltre, Plinio il vecchio parla di un culto propriamente romano: Fascinus […] qui deus inter sacra Romana Vestalibus colitur.18 Anche virgilio, nel descrivere il rituale dei Liberalia, ricorda che venivano eseguiti canti volgari ed appese delle maschere agli alberi, probabilmente per scacciare gli influssi mali-gni.19 Dunque Liber, dio della crescita, diviene protettore del ragazzo nel momento in cui egli è ormai pienamente in possesso delle sue potenzialità fecondanti: la città onora e festeggia il giovane poiché egli ne garantisce la sopravvivenza. Tale superstizione, come si vedrà, avrà un’importanza fondamentale anche nella confezione degli abiti indossati durante la cerimonia, sia per il fanciullo che per la nupta.20
Un’ulteriore prova dell’importanza della componente sessuale nella presa della toga21 è costituita dalla consuetudine di non far coin-cidere tale assunzione con un’età precisa22 (essa poteva oscillare fra i
16 Un momento saliente di questa assimilazione dovette essere, secondo Bruhl (Li-ber Pater, cit., p. 14) il 496 a.C., quando in base ai libri Sibillini si decise di ammettere la triade agraria ellenistica Demeter, Dionysus e Core nel Pantheon romano, con i nomi di Ceres, Liber e Libera: lo studioso sottolinea che il nome del dio Liber doveva, evidente-mente, essere già diffuso ed il suo culto precedentemente praticato sul suolo italico.
17 J. Toutain in Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités Greques et Romaines, Paris 1877, vI, pp. 1189-1191, s.v. Liber Pater. Secondo Neredau (La jeunesse, cit., pp. 150-1) uno dei motivi che produssero la confusione fra la divinità greca e quella italica fu proprio l’interesse di entrambe per l’iniziazione giovanile: in effetti anche il Dionysus greco è legato alle iniziazioni e agli efebi.
18 Plin., Naturalis historia, 28, 39: «Il membro virile […] dio che, fra i culti romani, è onorato dalle vestali».
19 verg., Georgica, 2, 385-389: Nec non Ausonii, Troia gens missa, coloni/ versibus incom-pitis ludunt risuque soluto/ oraque corticibus sumunt horrenda cavatis/ et te, Bacche, vocant per carmina laeta tibique/ oscilla ex alta suspendunt mollia pinu («Così anche i coloni Ausoni, gente venuta da Troia,/ scherzano con versi rozzi e con riso libero e si mettono masche-re mostruose, ricavate dalle cortecce vuote,/ ed invocano te, o Bacchus, con canzoni festose/ ed in tuo onore appendono agli alti pini mascherine fragili»).
20 Cfr. infra a proposito della tessitura della tunica recta.21 A. van gennep, I riti di passaggio, Torino 1981, p. 59, sottolinea come il carattere
sessuale fosse determinante nei riti di passaggio da un’età ad un’altra: infatti si verifica-va una separazione dal mondo asessuato e un’aggregazione a quello sessuale.
22 In epoca classica si era perso anche il legame con un giorno e un luogo preciso per l’assunzione della toga, ma come si vedrà, il 17 marzo rimase la data canonica: il figlio di Cicerone assunse la toga ad Arpino, il nipote a laodicea (Cic., Epistulae ad
Sguardi Sul mondo antico Ù 175
dodici e i diciannove anni),23 ma con il conseguimento della maturità fisica e intellettuale: in pratica si doveva osservare nel fanciullo un raggiunto equilibrio psicofisico. Secondo giustiniano pubertatem au-tem veteres quidem non solum ex annis sed etiam ex habitu corporis in masculi aestimari volebant.24 la valutazione era operata dai familiari, come te-stimonia Cicerone25 e questo è indicativo dell’importanza che veniva attribuita, presso i Romani, alla responsabilità individuale.26
Anche nel matrimonio, quale rito di passaggio femminile, assu-me un’importanza determinante la capacità procreativa della donna, necessaria per l’atto generativo e garanzia di continuità per la stirpe; inoltre il rilievo assunto dalla fecondità si lega strettamente all’origi-ne agraria del rito. In effetti, un matrimonio era considerato giuridi-camente legitimum se, fra le altre cose, entrambi gli sposi erano giunti all’età in cui era loro possibile procreare:27 la liberorum quaerendorum
Atticum, 9, 19, 1; 5, 20, 9); il figlio di Cassio celebrò il rito il 15 marzo del 44 (Plutarco, Brutus, 14). Per ulteriori riferimenti cfr. J. Marquardt, La vie privée des Romains, in Th. Mommsen, J. Marquardt, Manuel des antiquités romaines, Paris 1892, XIv, p. 145, n. 4.
23 Ivi, pp. 149 sgg.24 Inst. Iust., 1, 22: «gli antichi intendevano stimare il conseguimento della pubertà
nei maschi non solo dall’età, ma anche dallo sviluppo fisico»; gaius, Institutiones, 1, 96; Quint., Institutio oratoria, 4, 2, 5; sull’argomento cfr. infra.
25 Cic., Epistulae ad Atticum, 9, 17, 1: Volo Ciceroni meo togam puram dare («vorrei dare a mio figlio Cicerone la toga pura»); ma soprattutto ivi, 6, 1, 12: Quinto togam puram libe-ralibus cogitabam dare. Mandavit enim pater («Mi riprometto di consegnare la toga pura a Quinto il giorno della festa di Liber. Infatti suo padre me ne ha dato l’incarico»).
26 l’importanza conferita alla sfera privata ed alla scelta personale nel passaggio ad un diverso status sociale è anche uno dei presupposti delle iustae nuptiae: Quintiliano (Institutio oratoria, 5, 11, 32) chiarisce che il matrimonio non era basato su atti formali, né tantomeno sulla redazione di tabulae nuptiales, ma sulla volontà effettiva: Nihil obstat quo minus iustum matrimonium sit mente coentium etiam si tabulae signatae non fuerint, nihil enim proderit signasse tabulae, si mente matrimonium fuisse constabit («Niente si oppone al fatto che un matrimonio sia considerato valido, se erano consenzienti i contraenti, anche se il contratto matrimoniale non sia stato firmato; infatti non servirà a niente aver firmato il contratto se non sarà certo che c’era il consenso»). Al tempo di Adriano i padri non pote-vano né obbligare le figlie a sposare chi non volessero, né avevano il diritto di impedire loro di contrarre le nozze con chi desiderassero, infatti il giurista Salvio giuliano (Digesta Iustiniani, 23, 1, 11) ci informa che sponsalia, sicut nuptiae, consensu contrahentium fiunt: et ideo, sicut nuptiis, ita sponsalibus filiafamilias consentire oportet («i fidanzamenti, come i matrimoni, avvengono con il consenso dei contraenti: perciò è necessario per le nozze, come per i fidanzamenti, il consenso della figlia di famiglia»).
27 Tituli ex corpore Ulpiani, 5, 2: Iustum matrimonium est, si inter eos qui nuptias contrahunt conubium sit, et tam masculus pubes quam femina potens sit et utrique consentiant, si sui iuris sunt, aut etiam parentes eorum, si in potestate sunt («vi è matrimonio legittimo, se fra coloro che contraggono nozze vi è connubio, e tanto l’uomo sia pubere quanto la donna fertile ed entrambi siano consenzienti, se sono giuridicamente autonomi, o abbiano il consenso dei genitori, se sono sotto la loro potestà»). In pratica si poteva parlare di legitimae nuptiae quando un uomo e una donna ‘puberi’, l’uomo non doveva avere meno di quattordici anni, la donna non meno di dodici (Macr., Saturnalia, 7, 7, 6: Nam et secundum iura publica duodecimus annus in femina et quartus decimus in puero definit pubertatis aetatem), muniti nei reciproci confronti di conubium (Isid., Origines, 9, 7, 21: Dicitur autem conubium, cum aequales in nuptias coeunt, ut puta cives Romani, pari utique dignitate), stabilivano fra loro un rapporto coniugale con la volontà reciproca, continua, di essere uniti durevolmente in matrimonio e, nel caso che uno dei coniugi fosse alieni iuris, con l’auctoritas del titolare della patria potestas. In realtà a Roma la pubertà sociale precedeva la pubertà fisiologica
abiti, corpi, identità176 Ù
causa era presupposto e fine delle nuptiae. la dichiarazione giurata, fatta davanti ai censori, di vivere con una determinata donna liberorum quaerendorum causa, non aveva valore giuridico di atto costitutivo di matrimonio, ma era considerata come prova della volontà di dar vita ad un matrimonio legittimo. gellio (4, 3, 2) cita un passo tratto dal De dotibus di Servo Sulpicio Rufo riguardo al divorzio di Spurio Carvilio Ruga del 230 a.C., in cui si dice che questi ripudiò la moglie perché, pur considerandola carissima per i suoi costumi, fece prevalere sui sentimenti e l’affetto il sacro rispetto del giuramento: egli, infatti, era stato costretto dai censori a promettere che si sarebbe sposato per avere dei figli.28 Nella cerimonia nuziale vi sono continui riferimenti alla fertilità e a questo scopo sono celebrati una serie di riti atti a propiziarla: la presenza del fuoco quale elemento fecondante, che determina anche la scelta del colore del velo;29 l’uso della toga, indu-mento dalle prerogative ‘virili’ e per questo stesso motivo stesa sopra il talamo;30 il nodo erculeo, simbolo di unione;31 le torce che prece-dono la sposa durante la dedutio, accese al focolare paterno;32 il lancio
e questo è il motivo per cui le ragazze erano considerate nubili già a dodici anni, ma solo un’esigua parte di loro era in grado sin da quel momento di procreare. Per questa distinzione cfr. van gennep, I riti di passaggio, cit., pp. 58 sgg.
28 Questa formula si ritrova anche in livio, Periochae, 59: Q. Metellus censor censuit, ut cogerentur omnes ducere uxores, liberorum procreandorum causa («Il censore Quinto Metello stabilì che tutti erano costretti a prendere moglie per procreare»). la liberorum procre-andorum causa, quale elemento distintivo della volontà reciproca dei coniugi di costitu-ire un vincolo matrimoniale, è ricordata anche dai testi giuridici. Nei Tituli ex corpore Ulpiani (3, 3) leggiamo che, secondo la lex Iunia, l’aver procreato figli permetteva, ad-dirittura, di ottenere la cittadinanza. Il cittadino straniero che si era sposato con una donna romana o latina allo scopo di avere figli, poteva presentarsi ad un anno dalla nascita presso il pretore ed ottenere la cittadinanza (nam lege Iunia cautum est, ut si civem Romanam vel Latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit, postea filio filiave nato natave et anniculo facto possit apud praetorem vel praesidem provinciae causam probare et fieri civis Romanus).
29 Il flammeum era ‘color della fiamma’, una tinta fra il rosso e l’arancio, proprio in virtù dei poteri fecondanti del fuoco. Per un’analisi di questo problema cfr. f.R. Nocchi, Roma antica/1. Abiti nuziali, «Quaderni di simbologia del vestire», 6, Roma 2007, pp. 49 sgg.
30 Per questo argomento cfr. infra, pp. 196 sg.31 Secondo festo (p. 55 l.) esso stava a simboleggiare la prolificità dell’eroe greco a
scopo propiziatorio: Hunc Herculaneo nodo vinctum vir solvit ominis gratia, ut sic ipse felix sit in suscipiendis liberis ut fuit Hercules qui septuaginta liberos reliquit («l’uomo scioglie questa cintura legata con un nodo d’Ercole per augurio di buona sorte, affinché così egli stesso sia felice di ricevere i figli, come fu Ercole che lasciò settanta figli»).
32 Il corteo della deductio era sempre preceduto da fiaccole che avevano una funzio-ne apotropaica: allo stesso modo in cui esse servivano a cacciare le bestie feroci, così allontanavano gli spiriti maligni; il fuoco, dunque, simboleggiava la purificazione dagli influssi nefasti, ma anche il potere fecondante. Persino la scelta del numero delle fiaccole non era casuale: Plutarco ci informa che erano cinque (Quaestiones Romanae, 2, 263 f - 264 a-b) e da altre fonti sappiamo che il numero dispari ha virtù benefiche. Particolarmente importante era la torcia di biancospino che precedeva immediatamente la sposa: questa veniva accesa da lei nella casa paterna e diveniva oggetto di contesa fra i suoi amici e quelli dello sposo: se vinceva la donna la metteva sotto il letto nuziale, se era il marito ad impossessarsene, la faceva consumare su una tomba (fest., p. 364 l.). Anche in questo caso il fuoco, portatore di fertilità, determinava il prevalere della potenza generativa della famiglia dell’uomo o della donna.
Sguardi Sul mondo antico Ù 177
delle noci, dotate notoriamente di poteri fertilizzanti;33 l’uso congiun-to dell’acqua e del fuoco, rappresentanti simbolicamente l’unione del maschio con la femmina;34 infine, la stessa invocazione a Gaia, quale protettrice e modello delle spose, rientra in questo ambito, perché il suo cognomen ricorda una serie di eroi che vennero a contatto con il fuoco, elemento dalle potenzialità fecondatrici.35
l’importanza conferita alla fertilità della donna, nonché al suo ruolo di angelo del focolare, è specchio di una civiltà agraria, presso la quale ebbero origine questi usi: allo stesso modo la sua funzione generatrice era assimilata a quella della terra. la prova definitiva della matrice agraria delle nuptiae è costituita dalla cen-tralità assunta dalla confarreatio, che divenne la modalità più ambita di matrimonium e conventio,36 tanto da essere destinata ai patrizi. Essa comprendeva una serie di sacrifici che consistevano nell’offerta a Iuppiter Farreus di primizie e della famosa focaccia di farro, uno dei più antichi cereali italici.37
Inoltre, anche nel matrimonio, come nell’assunzione della toga, la componente apotropaica giocava un ruolo fondamentale nel cor-so di tutti i festeggiamenti, soprattutto nell’ambito dei riti nuziali non giuridicamente necessari. Non solo la sposa, ma l’intera coppia
33 fest., p. 179 l.: Nuces flagitantur nuptiis et iaciuntur pueris ut novae nuptae intranti do-mum novi mariti auspicium fiat secundum («le noci erano reclamate per gli sposi e gettate ai fanciulli che li circondavano, affinché per la nuova sposa che entrava nella casa del marito divenissero auspicio favorevole»). Il lancio delle noci, particolarmente diffuso nei riti agrari dei Floralia, corrisponde a quello del riso nei tempi moderni.
34 Serv., Commentarius ad Aeneidem, 4, 167: Varro dicit: aqua et igni mariti uxores accipie-bant. Unde hodieque et faces praelucent et aqua petita de puro fonte per puerum felicissimum aut puellam interest nuptiis. De qua nubentibus solebant pedes lavari («varrone dice: con l’acqua e con il fuoco i mariti accoglievano le mogli. Da questa usanza anche oggi le fiaccole risplendono e fa parte del rito nuziale l’acqua ricavata da una fonte pura da un fanciullo molto beato o una fanciulla. Con questa si era soliti lavare i piedi alle spose»). Sembra che con l’acqua venisse simbolicamente aspersa la sposa per purificarla o le venissero lavati i piedi, gesto tipico di una buona accoglienza; quanto al fuoco, sappiamo solo che l’uomo accendeva la torcia al suo focolare.
35 Ovidio (Fasti, 6, 625-626), inoltre, ci informa che le toghe che essa realizzò resistet-tero magicamente all’incendio nel foro.
36 la conventio era un antico istituto romano con il quale la donna passava dalla tu-tela del padre a quella del marito; cfr. gaius, Istitutiones, 1, 110: Olim itaque tribus modis in manum conveniebat: usu, farreo, coemptione («Un tempo si cadeva sotto la potestà del marito in tre modi: con l’usucapione, con il farro, con la compravendita»).
37 Al centro della cerimonia, che aveva essenzialmente carattere religioso (Plin., Na-turalis historia, 18, 10), stava il sacrificio a Iuppiter di un pane di farro alla presenza di dieci testimoni e, secondo ciò che dice Servio, del pontefice massimo e del flamen Dialis (Com-mentarius ad Georgica, 1, 31). Da gaio (Institutiones, 1, 112) sappiamo che venivano anche pronunciate parole solenni: probabilmente si tratta della formula attestata da Boezio per la coemptio, con la quale i futuri coniugi assicuravano reciprocamente la volontà di dive-nire pater e mater familias. Il rito della confarreatio prevedeva anche l’impiego dell’acqua e del fuoco, due elementi simboleggianti rispettivamente la fertilità femminile e la poten-za fecondante maschile: secondo le fonti antiche essi rappresentano l’unione degli sposi (Serv., Commentarius ad Aeneidem, 4, 103). Ancora più importante è un passo di Servio, in cui si chiarisce che durante l’offerta i celebranti (nubentes) stavano seduti su seggi uniti, sui quali era posta una pelle di pecora sacrificata (ivi, 4, 374); inoltre essi erano ricoperti da un velo (velatis capitibus).
abiti, corpi, identità178 Ù
doveva essere protetta dagli influssi negativi provenienti da coloro che provavano invidia per la condizione beata in cui essa si trovava e a questo scopo era anche necessario chiedere la protezione divi-na: infatti la cerimonia vera e propria era preceduta da una presa degli auspici;38 inoltre, all’imbrunire39 un corteo accompagnava la sposa nella casa del marito: si tratta della deductio in domum, un rito di passaggio che assemblava componenti apotropaiche e propiziato-rie. Per di più alla sposa veniva interdetto di oltrepassare da sola la soglia:40 il costume aveva funzioni apotropaiche, in quanto si temeva che inciampare sulla porta, sarebbe stato di cattivo augurio all’inizio di una nuova vita.41 Inoltre, spinta da motivazioni superstiziose, un-geva gli stipiti della porta con grasso di maiale e li ornava con bende di lana. Da Servio sappiamo che, originariamente, veniva usato gras-so di lupo:42 il gesto aveva lo scopo di allontanare gli influssi maligni dalla casa, utilizzando proprio le forze malefiche provenienti da una bestia feroce; il passaggio al grasso di porco indica il sopraggiungere della civiltà agraria che nell’animale vedeva il simbolo della prospe-rità, quanto mai auspicabile per la sposa, e questo è confermato dal
38 val. Max., Facta et dicta memorabilia, 2, 1, 1: Apud antiquos non solum publice sed etiam privatim nihil gerebatur nisi auspicio prius sumpto; quo ex more nuptiis etiam nunc auspices inter-ponuntur qui, quamvis auspicia petere desierint, ipso tamen nomine veteris consuetudinis vestigia usurpantur («Presso gli antichi nessuna azione, non solo pubblica, ma anche privata, veniva compiuta, se prima non fossero stati presi i relativi auspici. Questa consuetudine ha fatto in modo che anche oggi gli indovini partecipino delle nozze: ed anche se costoro non chiedo-no più gli auspici, il loro stesso nome rivendica ad essi le vestigia dell’antica usanza»).
39 Catull., 62, 1-4: Vesper adest, iuvenes, consurgite […]/ Surgere iam tempus, iam pingues linquere mensas:/ iam veniet virgo, iam dicetur Hymenaeus («vespero spunta. giovani, in piedi! […]/ È ormai tempo di alzarsi, di lasciare le mense sontuose./ Ora verrà la ver-gine e si canterà l’imeneo»).
40 Plut., Quaestiones Romanae, 29, 271d: «Perché alla sposa non è permesso di attra-versare la soglia della sua casa da sola, ma quelli che la stanno scortando la devono sollevare? È perché essi portarono fuori con la forza le prime spose romane e le donne non entravano di loro spontanea volontà? O volevano che sembrasse che entravano contro la loro volontà in un luogo dove stavano per perdere la loro verginità?».
41 Catull., 61, 166-9: Transfer omine cum bono/ limen aureolos pedes/ rasilemque subi forem («Poggia con felice augurio/ il tuo piedino d’oro oltre la soglia,/ supera il gradino corroso»). Isid., Origines, 9, 7, 12 offre un’altra motivazione: Nubentes puellae […] ideo ve-tabantur limina calcare, quod illic ianuae et coeunt et separantur («Era vietato alle spose […] calpestare la soglia perché in tal punto le porte si uniscono, ma si separano anche»). Un’altra ipotesi è che questo costume, persistente nei tempi moderni, sia un espediente per rinnovare in chiave simbolica il ratto delle Sabine, per cui lo sposo prende in brac-cio la moglie quasi per rapirla e trascinarla nella sua casa. Per i riti della soglia presso i diversi popoli cfr. van gennep, I riti di passaggio, cit., pp. 116 sgg.
42 Serv., Commentarius ad Aeneidem, 4, 458: Moris fuerat ut nubentes puellae simul venissent ad limen mariti, postes antequam ingrederentur, propter auspicium castitatis, ornarent laneis vittis […] et oleo unguerent, unde uxores dictae sunt, quasi unxores. Hi tamen qui de nuptiis scripsisse dicuntur, cum nova nupta in domum mariti ducitur, solere postes unguine lupino oblini quod huius ferae un-guen et membra multis rebus remedio sunt («Era proprio del costume che le spose, non appena erano giunte alla soglia della casa del marito, prima di entrare, per auspicio di castità, or-nassero gli stipiti di bende […] e li ungessero con olio, da cui sono dette uxores, mogli, quasi da unxores, untrici. Questi tuttavia, che si dice abbiano scritto sulle nozze, tramandano che quando la sposa è condotta in casa del marito, è solita ungere gli stipiti con grasso di lupo, perché il grasso di questo animale e le sue membra sono di rimedio per molte cose»).
Sguardi Sul mondo antico Ù 179
più tardo impiego dell’olio.43 Era necessario, inoltre, per scongiu-rare ogni cattivo augurio, impetrare la protezione delle divinità, a ciascuna delle quali era dedicato un culto specifico.44 Tutte queste consuetudini confermano quale ruolo ebbe la superstizione nel de-terminare una serie di precauzioni volte a proteggere la coppia, so-prattutto da quegli influssi malefici che avrebbero potuto inficiare la sua funzione generativa: l’uso del flammeum, un velo avvolgente,45 rientra perfettamente in questa prospettiva, in quanto isolava la spo-sa dal mondo esterno pieno di pericoli.46 Anche il suo colore fulvo47 avvalorerebbe la tesi di una valenza scaramantica.48
Dunque, sia il matrimonio che la presa della toga possono es-sere considerati, almeno in epoca storica, due riti che attestano
43 Isid., Origines, 9, 7, 12: Moris erat antiquitus ut nubentes puellae simul venirent ad limen mariti et postes antequam ingrederentur ornarentur laneis vittis et oleo unguerentur («Antica-mente era costume che non appena le spose giungevano alla porta dello sposo prima di entrare ornassero gli stipiti con bende di lana e li ungessero con olio»).
44 Pur essendo Iuno colei che primariamente presiedeva alla tutela del matrimonium, vi era anche un gran numero di dii certi, ovvero divinità che presenziavano alle fasi specifiche delle nuptiae: per esempio Iugatinus univa gli sposi, Domiducus conduceva la sposa nella casa maritale, Domitius ne propiziava l’ingresso. Inoltre una folla di divinità erano invocate in occasione dell’unione nella camera nuziale: Cinxia aiutava il marito a sciogliere il nodo che avvolgeva la veste nuziale della donna; Subigus interveniva per sottomettere la sposa.
45 Per questa teoria, cfr. Petron., Satyrica 26, 1: Iam Psiche puellae caput involverat flammeo («già Psiche aveva avvolto nel flammeum il capo della bambina»); Ov., Fasti, 3, 690: Anna tegens vultus, ut nova nupta, suos («Anna che copre il volto, come una nuova sposa il suo»); Mart., Epigrammata, 12, 42, 3: «Velarunt vultus». J. Champeaux, Fortuna. Recherches sur le culte de la Fortune à Rome et dans le monde romain des origines à la mort de César, I: Fortuna dans la religion archaïque, in Coll. de l’Ecole Française de Rome, Roma 1982, 64, p. 301, accosta la foggia del flammeum, che copriva il volto, con un lembo della toga che copriva la statua velata del foro Boario. gli altri veli usati dalle matrone o dalle sacerdotesse erano più piccoli del flammeum: ad esempio, la rica (fest., p. 342 l.) era uno scialle corto con frange; da questo, probabilmente, derivava il ricinum (ibidem), che era di foggia quadrata e serviva a coprire la testa delle donne in caso di lutto; dal mondo greco le donne romane avevano mutuato l’uso del theristrum (Ov., Metamorphoses, 4, 100-101; 11, 589-591), il quale, in realtà, era un mantello che fungeva da velo ed era costituito da una stoffa leggerissima; d’importazione greca era anche la calyptra, ben più ampia, che nascondeva gran parte del volto.
46 J.g. frazer (The Fasti of Ovid, london 1929, in particolare Fasti 3, 675-676) avvalo-ra la sua tesi sostenendo che il costume di ingaggiare una falsa fidanzata, che attiri gli influssi nefasti, testimonierebbe che la futura sposa ha bisogno di particolare protezio-ne il giorno del suo matrimonio.
47 Cfr. gli aggettivi che accompagnano il termine flammeum: nello scoliasta a giovenale (6, 225) viene detto sanguineum, invece sia lucano (Pharsalia, 2, 361) che Plinio (Naturalis historia, 21, 46) usano l’attributo luteum. Per un’analisi attenta di questi attributi cfr. C. fa-yer, L’«ornatus» della sposa romana, in «Studi romani», 34 (1986), pp. 7-9: la studiosa aggiunge ai termini che connotavano il flammeum nuziale l’aggettivo croceus (Ov., Metamorphoses, 10, 1; Heroides, 21, 162) con cui si indicava anche una pianta che favoriva la fertilità della donna (Plin., Naturalis historia, 24, 166); inoltre sottolinea che sia il luteus che il croceus erano tona-lità che avevano una qualche relazione con il rosso (gell., Noctes atticae, 2, 26, 5; 2, 26, 15). N. Boëls-Janssen, La fiancée embrassée, in Hommages à H. Le Bonniec, Coll. latomus, Bruxelles, 1988, 201, p. 22, ha fatto notare che raramente la parola flammeum è accompagnata da un attributo, perché si tratta di un aggettivo sostantivato usato per indicare un abito che dal suo colore prende il nome. Da Plauto, Aulularia, 510, veniamo a sapere che esistevano fun-zionari appositi, i flammarii, preposti alla tintura di questo colore; questo è confermato da festo, p. 79 l.: «Flammeari infectores flammei coloris» («I flammeari, tintori del color del fuoco»).
48 Per la funzione scaramantica del colore rosso cfr. infra, pp. 187-188.
abiti, corpi, identità180 Ù
l’avvenuta maturità dei giovani e la possibilità per loro di assolvere ai doveri assegnati secondo le tradizioni romane: quello esclusivo di assicurare la prosecuzione della stirpe per la donna, quello di cittadino insignito del ruolo di civis e di pater familias per l’uomo. Quest’ultima funzione del rito maschile può essere desunta dal si-gnificato originario dei Liberalia e dal culto fallico di Liber, nonché dal riconoscimento dell’importanza assunta della pubertas quale criterio imprescindibile per poter accedere a questa nuova fase. In entrambi i casi, comunque, i Romani consideravano molto delicato questo momento che segnava l’accesso ad un’altra fase della vita, per cui ritenevano necessario proteggere tale passaggio attraverso una serie di precauzioni scaramantiche.
3. Aspetti ‘pubblici’ dei riti
Oltre ai rituali che si svolgevano all’interno delle pareti domesti-che, di cui si parlerà nel paragrafo successivo, le due cerimonie era-no caratterizzate da riti pubblici omologhi: essi consistevano in una serie di formalità civiche e religiose con le quali veniva riconosciuto dalla comunità il cambiamento di status del novus togatus e della nupta. Per quanto riguarda il giovane, egli, dopo aver compiuto l’offerta degli insignia pueritiae ai Lares,49 veniva accompagnato da un corteo di amici nel foro: si tratta della deductio in forum.50 giunto a destinazione il giovane veniva iscritto nelle liste dei cittadini,51 secondo quanto dice Appiano. In quest’occasione gli venivano con-feriti i tria nomina, con i quali egli entrava ufficialmente a far parte della gens: Pueris non prius quam togam virilem sumerent praenomina
49 Tertulliano (De idolatria, 16, 1) parla di un sacrificio compiuto all’interno della casa ed è singolare che anche in questo caso esso sia assimilato ai sacrifici eseguiti in occasione delle nozze: circa officia privatarum et communium sollemnitatum, ut togae purae, ut sponsalium, ut nuptialium, ut nominalium («Riguardo agli obblighi delle solen-nità private e pubbliche, come l’assunzione della toga pura, i fidanzamenti, le nozze, l’imposizione del nome»).
50 Svet., Tiberius, 15, 1: Romam reversus deducto in forum filio Druso («Tornato a Roma e presentato nel foro suo figlio Druso»); Claudius, 2, 5: Togae virilis die circa mediam noctem sine sollemni officio lectica in Capitolium latus est («Il giorno che indossò la toga virile senza una solenne cerimonia fu condotto al Campidoglio in lettiga»); val. Max., Facta et dicta memora-bilia, 5, 4, 4: Hanc pietatem aemulatus M. Cotta eo ipso die, quo togam virilem sumpsit, protinus ut a Capitolio descendit, Cn. Carbonem […] postulavit («Emulando questo amore filiale, Marco Cotta, nel giorno stesso in cui indossò la toga virile, non appena scese al Campidoglio […] citò in giudizio Cneo Carbone»); Sen., Epistulae morales ad Lucilium, 4, 2: Tenes utique memoria, quantum senseris gaudium, cum praetexta posita sumpsisti virilem togam et in forum deductus es («Tu ricordi certo ancora quale gioia sentisti quando, deposta la toga pretesta, hai indossato la toga virile e sei stato accompagnato nel foro»); Plut., Brutus, 14. Il corteo in epoca imperiale era ancora maestoso, come testimonia Apuleio, Apologia, 87: Pudentilla de suo quinquaginta milia nummum in populum expunsisset ea die qua Pontianus uxorem duxit et hic puerulus toga est involutus («Pudentilla aveva speso di suo cinquantamila sesterzi distri-buendoli al popolo, il giorno in cui Ponziano si era sposato e questo ragazzino aveva preso la toga»); a questo proposito cfr. anche Plinio il giovane (Epistulae, 1, 9, 2).
51 App., Bellum civile, 4, 30; Dio., 55, 42; 56, 29. Per le supposizioni relative al luogo in cui avveniva l’iscrizione cfr. Marquardt, La vie privée des Romains, cit., p. 147, n. 3.
Sguardi Sul mondo antico Ù 181
imponi moris fuisse Scaevola auctor est.52 Del resto sugli epitaffi i fan-ciulli morti prima di assumere la toga erano definiti genericamente pupi,53 senza l’indicazione precisa delle famiglia di appartenenza.
Appiano testimonia anche che in questa occasione si svolgeva una cerimonia religiosa sul Campidoglio: purtroppo non si possie-dono testimonianze tali da poter capire con certezza in cosa essa consistesse e a quale divinità fosse dedicata. Dionigi di Alicarnasso54 riporta l’antica consuetudine, istituita da Servio, in base alla quale il nuovo togatus doveva offrire a Iuventas una moneta. Tertulliano, definisce questa divinità la protettrice di coloro che hanno appena assunto la toga: Iuventas est Dea novorum togatorum.55 Essa possedeva un tempio proprio sul Campidoglio, quindi è verosimile ipotizza-re che fosse proprio lei la destinataria del rito religioso; in realtà Servio dice che i giovani che avevano assunto la toga virile andava-no sul Campidoglio ad onorare Iuppiter: Sane Iovem merito puerorum dicunt incrementa curare, quia cum pueri togam virilem sumpserint, ad Capitolium eunt,56 ma è probabile che si tratti di un’identificazio-ne del Campidoglio con il dio più rappresentativo fra quelli che vi possedevano un santuario.57 la cerimonia si concludeva con un festino e con elargizioni al popolo, nel caso delle famiglie più ab-bienti.58 Come si vede tutti questi riti rappresentano il progressivo inserimento del giovane nella duplice realtà che ormai gli compete come civis: egli è ufficialmente assunto nella famiglia come mem-bro attivo e viene inserito nelle liste dei cittadini, con tutti i doveri ed i diritti politici che questa posizione comporta.
Simili consuetudini erano parte integrante anche della cerimo-nia nuziale: la comunità riconosceva alla donna l’unico ruolo che nell’antichità le veniva attribuito, quello di matrona e di potenziale mater familias. Anche lei, ufficialmente, entrava a far parte della gens del marito e compiva una serie di riti che tutelassero questo delicato passaggio ed il cui significato era omologo a quello dei riti pubblici maschili. Ad esempio la domum deductio per la sposa aveva una valenza similare alla deductio in forum: la nupta veniva prelevata
52 Lib. de praen., 3. Anche Tertulliano ricorda che il giovane era introdotto nella gens solo dopo aver assunto la toga (De idolatria, 16, 2-3).
53 Per il problema relativo all’assunzione dei tria nomina cfr. Neredau, La jeunesse, cit., pp. 157-158.
54 Dion., Antiquitates Romanae, 4, 15.55 Tert., Ad nationes, 2, 11, 11.56 Serv., Commentarius ad Eclogas, 4, 48-9.57 Neredau, La jeunesse, cit., p. 149.58 Ciò avveniva soprattutto per le famiglie imperiali: cfr. Tac., Annales, 3, 29, 3; Svet.,
Nero, 7, 6; il fatto che Caligola omise tali atti è considerata un’eccezione (Svet., Caligula, 10, 1: Eodem die togam sumpsit barbamque posuit, sine ullo honore qualis contigerat tirocinio fratrum eius). Anche le famiglie molto abbienti avevano questo costume, come risulta evidente da una lettera di Plinio il giovane (Epistulae, 10, 116, 1): Qui virilem togam sumunt […] solent totam bulen atque etiam e plebe non exiguum numerum vocare binosque denarios vel sin-gulos dare («Coloro che indossano la toga virile […] sono soliti convocare tutto il consiglio comunale ed un gran numero di gente comune e regalare uno o due denari a testa»).
abiti, corpi, identità182 Ù
dalla casa paterna dopo la cerimonia ed il banchetto e veniva con-dotta in quella dello sposo. Il corteo non passava silenziosamente nelle strade: sia gli invitati che i passanti improvvisavano fescennini, ovvero versi e canti licenziosi, che venivano rivolti alla coppia al fine di allontanare il malocchio attirato inevitabilmente dagli sposi felici,59 inoltre questo era un modo per annunciare alla comunità il cambiamento di status della fanciulla e sancire la sua integrazio-ne nella nuova comunità, la gens del marito. giustamente è stato rilevato60 che questo costume presenta tutte le caratteristiche di un rito di passaggio: in primo luogo si verifica una separazione dalla condizione originaria, per cui la fanciulla viene ‘strappata’ alla famiglia paterna, ed ella finge di resistere a questa violenza;61 inoltre vengono prese numerose precauzioni scaramantiche, volte a preservare dagli influssi nefasti colei che si accinge ad iniziare una nuova vita;62 sono attuati tutta una serie di riti volti ad assicu-rare la fecondità e la discendenza della coppia;63 infine sono cele-brati i riti di integrazione che segnano l’ingresso della nupta nella nuova domus.64
Anche per la sposa, inoltre, abbiamo qualcosa di similare all’ac-quisizione dei tria nomina maschili: quando giungeva presso la sua nuova casa, in base ad un’antica consuetudine, le veniva domanda-to dal marito chi fosse, ed ella doveva rispondere con la formula ufficiale: Quando tu Gaius et ego Gaia.65 Si trattava, probabilmente, dell’accettazione della donna di entrare a far parte della gens del marito,66 rinunciando alla propria condizione primitiva: ella, uffi-cialmente, dichiarava di fronte alla comunità di non appartenere più alla famiglia paterna, ma di voler dividere la propria vita e la propria dimora con l’uomo che aveva di fronte.67 Secondo la te-
59 Come si è detto, la stessa etimologia del nome, che si fa risalire al termine fasci-num, conferma la funzione scaramantica dei versi.
60 N. Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque, Rome 1993, p. 162.
61 fest., p. 364 l. Il rifiuto da parte della sposa di lasciare la casa paterna è stato interpretato come un retaggio del ratto delle Sabine.
62 Rientrano in questo campo l’interdizione per la sposa di oltrepassare la soglia con i propri piedi (Catull., 61, 166-168), l’uso delle torce e del fuoco (fest., p. 282 l.; Serv., Commentarius ad Eclogas, 8, 8, 29), l’unzione della porta con grasso di lupo (Id., Commentarius ad Aeneidem, 4, 458), ma per questi riti cfr. supra.
63 Solo a titolo esemplificativo sarà sufficiente ricordare il gettito delle noci sulla sposa (fest., p. 179 l.), ma per questo rito cfr. supra, p. 177.
64 Si tratta, in particolare, della cerimonia aqua et igni (Serv., Commentarius ad Aenei-dem, 4, 167; fest., p. 77 l.), ma per questo rito cfr. supra, p. 177.
65 Plut., Quaestiones Romanae, 30, 271 d: «Dove tu gaio, io gaia».66 Cfr. Th. Mommsen, Römische Forschungen, Berlin 1879, I, p. 11; Ch. lécrivain in
Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités Greques et Romaines, Paris 1877, vI.2, pp. 1657-1658, s.v. matrimonium.
67 Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., p. 183, pensa che queste parole ponevano i coniugi sullo stesso piano: con esse si intendeva ribadire l’idea di un matri-monio fondato sulla comunione dei beni materiali e spirituali.
Sguardi Sul mondo antico Ù 183
stimonianza di Plutarco,68 i nomi gaia e gaio erano generici per indicare la gens ed anche Quintiliano, citando la formula del ma-trimonio, dice che il nome gaia è tipico della matrona e gaio il nome comune del paterfamilias:69 l’acquisizione di un nuovo status è simbolicamente rappresentata dall’assunzione del nome con cui genericamente si designava la matrona.
Inoltre, le implicazioni scaramantiche dell’usanza tipica della sposa di portare con sé tre assi erano le medesime di quelle riguar-danti la dedica a Iuventas di una moneta da parte del novus togatus. la sposa gettava uno dei tre assi all’incrocio più vicino alla casa, uno era consegnato al marito e l’ultimo era depositato sul foco-lare: si tratta di un gesto simbolico che segna l’integrazione gra-duale della sposa nel mondo del marito.70 Infatti il denaro offerto al crocicchio serviva per conquistare la benevolenza delle divinità protettrici del quartiere; quello messo nel focolare i Lares familiares della casa; infine, la moneta consegnata al marito aveva lo scopo di ottenere il favore del Genius di lui, da cui dipendeva la prolificità della coppia. Il costume era funzionale alla richiesta di protezione da parte delle divinità maggiormente rappresentative del nuovo status, come Iuventas lo era per il giovane71 e serviva a stornare ogni influsso negativo che potesse funestare la nuova vita della sposa.
Piuttosto interessante, inoltre, risulta una notizia trasmessaci da Tertulliano, secondo il quale durante i Liberalia ogni famiglia era solita mangiare lungo la strada, di fronte alla porta della propria
68 Plut., Quaestiones Romanae, 30, 271. 69 Quint., Institutio oratoria, 1, 7, 28: Nam et ‘Gaius’ C littera significatur, quae inversa mu-
lierem declarat, quia tam Gaias esse vocitatas quam Gaios etiam ex nuptialibus sacris apparet («In-fatti ‘gaio’ viene indicato con la lettera C, mentre girata in senso contrario indica il nome di una donna, poiché anche dai riti nuziali appare che veniva usato tanto il nome Gaia quanto il nome Gaius»).
70 Nonio, p. 852 l.: Nubentes veteri lege romana asses III, ad maritum venientes, solebant pervehere, atque unum, quem in manum tenerent, tamquam emendi causa, marito dare; alium quem in pede haberent, in foco Larium familiarium ponere; tertium, quem in sacciperio condidis-sent, compito vicinali solere resenare («le spose, secondo un’antica consuetudine romana, quando si recavano dal marito, erano solite portare tre assi, quello che tenevano in mano lo davano al marito, come per pagare, l’altro, che avevano nella scarpa, lo mette-vano nel fuoco dei Lares familiares; il terzo, che avevano nascosto in una borsa, lo faceva-no risuonare nel crocicchio vicino»).
71 l’affinità fra l’offerta a Iuventas e quella dei tre assi della sposa è già stata rilevata da S. fasce, I tre assi della sposa, in «Studi Noniani», 9 (1984), pp. 107-109, la quale ritie-ne che il denaro offerto simbolicamente dalla sposa ai lari del quartiere abbia lo stesso significato di quello donato dal fanciullo: in effetti, in cambio dei diritti acquisiti con il nuovo status, quali l’acquisizione del prenome e l’iscrizione negli elenchi della tribù, la legge prevedeva che il giovane depositasse nel tempio una moneta. Per la studiosa, però, lo scopo dell’atto non era scaramantico, ma serviva per censire la popolazione: in particolare, nel caso del fanciullo era necessario per conoscere il numero degli uomini abili per la leva. Questa legge serviana si integrava perfettamente con la prescrizione di deporre in un tempio una moneta differente per gli uomini, le donne e gli impuberi allo scopo di registrare il numero complessivo dei cittadini (Dion., Antiquitates Roma-nae, 4, 15, 4). la donazione ai Lares compitales da parte della sposa, invece, rispecchiava la norma in base alla quale il paterfamilias doveva iscrivere nei registri pubblici tutti coloro che erano soggetti alla sua manus (ivi, 4, 15, 6).
abiti, corpi, identità184 Ù
casa.72 Si tratta, probabilmente, di un modo attraverso cui le fami-glie esprimevano la volontà di festeggiare collettivamente il cam-biamento di condizione del proprio figlio: tale costume potrebbe essere accostato all’usanza di celebrare gli sposi con il banchetto nuziale,73 ma gli scarsi riferimenti letterari in nostro possesso impe-discono di giungere a conclusioni definitive. l’unica supposizione che si può avanzare è che in entrambi i casi si è di fronte alla mani-festazione di una felicità corale, che tende ad estendere la celebra-zione dall’ambito dell’oikos alla comunità intera.
Un ultimo rilievo deve essere fatto riguardo al tirocinium: solita-mente con questo termine74 si suole indicare il periodo compreso fra l’acquisizione della toga da parte del fanciullo e l’ingresso nella vita attiva,75 ma già alcuni praetextati si davano al tirocinium militiae.76 In ogni caso la segregazione o isolamento per apprendere le arti di cui si dovrà far mostra una volta entrati attivamente nel nuovo status è tipico dei riti di passaggio. Per gli uomini il tirocinio poteva configurarsi come tirocinium fori e come tirocinium militiae: i giovani nobili venivano affidati ad esperti del settore e svolgevano una sorta di praticantato militare o politico.77 l’apprendistato durava di so-lito un anno, ma poteva essere prolungato e abitualmente iniziava iniziava quando il giovane aveva sedici anni.78 Cicerone descrive
72 Tert., Apologeticum, 42, 5.73 A proposito del banchetto nuziale si vedano le ipotesi avanzate da Boëls-Janssen,
La vie religieuse des matrones, cit., pp. 161-162, la quale ritiene che in epoca più antica esso si svolgesse nella casa dello sposo (Plaut., Curculio, 728; Aulularia, 261-263; Iuv., 6, 200-202), come retaggio dell’antico ratto delle Sabine, in base al quale lo sposo ed i suoi compagni avrebbero banchettato gioiosamente prima di prelevare la sposa; in epoca più recente, invece, il banchetto sarebbe stato organizzato presso la casa paterna ad opera dei parenti della fanciulla. In ogni caso, nel rispetto della mentalità romana, alla donna veniva interdetta la partecipazione.
74 Per l’origine e l’evoluzione del termine cfr. Neredau, La jeunesse, cit., p. 112.75 val. Max., Facta et dicta memorabilia, 5, 4, 2; Svet., Augustus, 26, 3; Tiberius, 54, 1.76 Cfr. Macr., Saturnalia, 1, 6, 8, in cui si racconta che il figlio di Tarquinio ricevette
la pretesta solo dopo aver mostrato il suo valore in battaglia, ma è probabile che questo episodio corrisponda con l’istituzione degli insignia pueritiae; sull’argomento cfr. infra, p. 186.
77 Ad esempio Cicerone ebbe come tutore Q. Mucius Scaevola Augur (Cic., Laelius de amicitia, 1), a sua volta guidò l’apprendistato di Caelius, Pansa, Dolabella, Hirtius (Quint., Institutio oratoria, 12, 11, 6). Cfr. anche Serv., Commentarius ad Aeneidem, 5, 546: Secundum Tullium, qui dicit, ad militiam euntibus dari solitos esse custodes, a quibus primo anno regantur.
78 Cfr. Isid., Origines, 9, 3, 36-37: Tirones dicuntur fortes pueri, qui ad militiam delegantur atque armis gerendis habiles exsistunt […] Unde et tirones dicti quique antequam sacramento probati sint, milites non sunt. Romanae, autem militiae mos fuit puberes primos exercere armis. Nam sexto decimo anno tirones militabant, quo etiam solo sub custodibus agebant («Sono chia-mati tirones i fanciulli che vengono inviati al servizio militare e sono considerati abili a portare le armi […] In seguito vengono detti tirones coloro che, prima di essere stati confermati con il giuramento, non sono ancora soldati. Era un costume del servizio militare esercitare alle armi i giovani sin dalla pubertà. Infatti i tirones svolgevano il loro servizio militare a sedici anni, quando trascorrevano un solo anno sotto un tutore»). In generale si pensa che il limite cronologico dell’educazione, oltre il quale diveniva ob-bligatorio per il giovane iniziare la carriera militare o forense, erano i diciassette anni, ma si tratta di un termine piuttosto labile che conobbe numerose oscillazioni: a questo
Sguardi Sul mondo antico Ù 185
chiaramente in cosa consistesse79 e quali obblighi comportasse per i giovani: Nobis olim quidem annus erat unus ad cohibendum brachium toga constitutus, et ut exercitatione ludoque campestri tunicati uteremur, eademque erat si statim stipendia coeperamus, castrensis ratio ac militaris. È interessante, soprattutto per la presente indagine, volta a chiarire i presupposti ideologici dei riti vestimentari, la notizia trasmessaci da Cicerone, secondo la quale veniva imposto ai tirones di tenere le braccia sotto la toga e di esercitarsi sempre con la tunica: probabil-mente si tratta di un obbligo morale e religioso con cui si intendeva preservare ancora per un anno la pudicitia dei fanciulli.80 Anche in Seneca Retore si legge: Apud patres nostros, qui forensia stipendia au-spicabatur, nefas putabatur brachium toga exserere:81 se Cicerone sotto-linea l’aspetto giuridico dell’imposizione (constitutum), Seneca ne rileva quello religioso (nefas).
Sulla base di riferimenti impliciti nelle fonti e soprattutto di al-lusioni fatte nei miti, è stato supposto82 che anche per le donne esi-stesse questo apprendistato e che esso riguardasse, essenzialmen-te, l’acquisizione delle tecniche tipiche della bona lanifica: infatti la virtù principale che connotava la matrona romana era quella di saper tessere.83 Era assoluto vanto per una sposa realizzare di
proposito cfr. gell., Noctes Atticae, 10, 28; liv., 22, 57, 9 e soprattutto Marquardt, La vie privée des Romains, cit., pp. 144 sgg.
79 Cic., Pro Caelio, 5, 11: «Per noi era stato stabilito un solo anno in cui dovevamo tenere nascosto il braccio sotto la toga e portare la tunica durante gli esercizi e i giochi nel Cam-po Marzio e se volevamo cominciare subito il servizio militare veniva imposta la stessa regola nel campo e nell’esercito».
80 Per questa interpretazione cfr. Neredau, La jeunesse, cit., p. 113.81 Sen., Controversiae, 5, 6: «Presso gli antichi si considerava sacrilego che chi veniva
iniziato alla carriera forense facesse uscir fuori dalla toga il proprio braccio».82 Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., pp. 85-95. la studiosa si basa,
soprattutto, su una versione secondaria del mito relativo alla nascita di Romolo (Plut., Romulus, 2, 4-8): nel focolare della reggia di Tarchezio, crudele re di Alba, appare im-provvisamente un simbolo fallico, e l’oracolo suggerisce di farlo accoppiare con una giovane vergine affinché venga concepito un eroe. Il re ordina subito alla figlia di pie-garsi a questo rito, ma ella, spaventata, manda al suo posto la serva che esegue l’ordine. Tarchezio, furioso, rinchiude entrambe in prigione, con la promessa di farle sposare solo dopo che abbiano finito di tessere una tela, che egli, ogni notte, provvede a disfa-re. Nel frattempo i due gemelli, Romulus e Remus, nati dalla ierogamia, vengono esposti sul Tevere ed allevati da una lupa; in seguito sconfiggono Tarchezio. In base a questo mito sembrerebbe possibile ipotizzare anche un periodo di reclusione per le giovani in procinto di sposarsi, similmente a quanto avveniva per le giovani ateniesi (Aristo-ph., Lysistrata, 641-647), ma nessuna testimonianza in nostro possesso può avvalorare questa supposizione. Al contrario, sembra verosimile che le giovani, nel periodo prece-dente al matrimonio, apprendessero l’arte della tessitura, che aveva tanta importanza durante la vita coniugale, cosa che assumeva un certo rilievo anche nel corso della cerimonia nuziale, quando veniva portato in processione il fuso e la conocchia. l’idea della reclusione in un luogo oscuro e isolato delle vergini destinate al matrimonio è stato sostenuto da J. gagé, Matronalia. Essai sur les dévotions et les organisations cultuelles des femmes dans l’ancienne Rome, in «latomus», 60 (1963), pp. 32-34 e 225 sgg. Sull’argo-mento dell’iniziazione femminile cfr. Brelich, Paides e Parthenoi, cit., pp. 229 sgg.
83 Plut., Romulus, 15, 5 fa risalire il costume del lanificium per le donne ai tempi del rat-to delle Sabine: «Infatti, dopo che i Sabini, finita la guerra, si riconciliarono con i Roma-ni, furono stabiliti accordi relativi alle donne in modo tale che esse non dovessero fare
abiti, corpi, identità186 Ù
propria mano gli abiti dei propri familiari84 e il telaio era posto proprio nell’atrio, quale emblema della donna casta e virtuosa che vi abitava. Tale praticantato avveniva probabilmente sotto il tuto-rato della pronuba85 ed il patrocinio di gaia-Tanaquilla, filandiera per eccellenza,86 che aveva un’importanza fondamentale sia per la sposa che per il tiro, dal momento che era stata la prima a tessere la tunica recta, indumento tipico di entrambi i riti. Durante questo periodo pedagogico, tipico delle iniziazioni, dunque, sia la don-na che l’uomo apprendevano le arti con le quali potevano inte-grarsi perfettamente nella società e svolgere le funzioni che erano loro destinate.87
per i loro mariti nessun altro lavoro se non quello della lana (talasia). Dunque ancora adesso si è conservato l’uso che coloro che danno in sposa una figlia, o l’accompagnano, o semplicemente assistono alle nozze, per scherzo gridano ‘talassio’, testimoniando così che la donna non è costretta a nessun altro lavoro se non a quello di filare la lana».
84 Cfr. Svet., Augustus, 73. Addirittura il flamen indossava solo abiti tessuti dalla flami-nica (Serv., Commentarius ad Aeneidem, 4, 262).
85 la pronuba aveva un ruolo essenziale nella dextrarum iunctio, ovvero univa le mani destre degli sposi, che si garantivano fedeltà reciproca. Di questo rito abbiamo solamente testimonianze archeologiche, ma non letterarie, anche se sembra vi sia un’allusione a questo costume nell’Andria terenziana (v. 297) e nelle Heroides ovidiane (2, 31). la donna, dunque, aveva un duplice compito: Isidoro (Origines, 9, 7, 8), infat-ti, dice che Pronuba dicta eo quod nubentibus praeest quaeque nubentem viro coniungit («È chiamata così poiché assiste le future spose e unisce la sposa al marito»). Ella, inoltre, quale magistra della virgo nubens, doveva essere necessariamente univira (fest., p. 282 l.), ovvero sposata una sola volta, e doveva rappresentare, con il suo comportamento, la virtù esemplare di alcune matrone celebrate nella storia. varrone, infine, testimonia che anticamente gli auspici prima del matrimonio erano presi dalla pronuba, perché ella, proprio in virtù del fatto che era univira, era di buon auspicio per la nuova unione (Serv., Commentarius ad Aeneidem, 4, 166).
86 Innanzitutto occorre precisare il ruolo che Gaia Caecilia rivestiva nel rito matri-moniale: questa donna, moglie di Tarquinio Prisco ed il cui nome etrusco era Tanaquil, divenne il simbolo delle virtù femminili, per la sua dedizione alla famiglia ed al lanifi-cium (fest., p. 85 l.): Gaia Cecilia appellata est, ut Romam venit, quae antea Tanaquil vocitata erat, uxor Tarquinii Prisci regis Romanorum, quae tantae probitatis fuit ut id nomen boni ominis causa frequentent nubentes, quam summam asseverant lanificam fuisse («fu chiamata Gaia Caecilia, quando venne a Roma, colei che prima era chiamata Tanaquilla, moglie di Tarquinio Prisco, re dei Romani, che fu tanto onesta che le spose per buon augurio in-vocavano questo nome; consideravano questa la migliore lavoratrice di lana»). Secondo alcuni studiosi era onorata quale ipostasi divina (cfr., ad esempio, Champeaux, Fortuna, cit., p. 286 e n. 197, per la quale Gaia Caecilia era una variante storicizzata della dea fortuna). In effetti ella aveva tessuto le toghe di Servio Tullio, conservate nel tempio di Semo Sancus, ed aveva inventato la tunica recta. la sua protezione era invocata più volte dalle spose durante la deductio, inoltre il corteo portava in processione il fuso e la co-nocchia guarniti di lana, attributi con cui Gaia Ceecilia veniva comunemente raffigurata (Plin., Naturalis historia, 8, 194). Per di più da Plutarco sappiamo che, fra le grida dei fe-steggianti, si pronunciava continuamente il termine talassio (Plut., Quaestiones Romanae, 30, 271 f.; Romulus, 15, 1-3; fest., p. 479 l.; liv., 1, 9, 12): si tratta, probabilmente, di un nome comune derivato dal greco, con il quale si indicava la cesta in cui veniva messa la lana che la donna doveva filare e non, come si sostiene comunemente, di un dio delle nozze altrimenti sconosciuto.
87 Interessante anche la supposizione avanzata da M. Torelli, Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio fra archeologia e storia, Roma 1984, pp. 65-66, il quale pensa ad un apprendistato culinario per le future spose, sulla base di analogie con la leggenda di Anna Perenna.
Sguardi Sul mondo antico Ù 187
4. Insignia pueritiae e riti vestimentari
Il 17 marzo, in occasione dei liberalia, il giovane che, a detta del padre, aveva raggiunto l’età puberale, deponeva nella casa pa-terna la toga praetexta e la bulla, simbolo della fanciullezza.88 Anche la fanciulla, alla vigilia delle sue nozze, consacrava la pretexta alla Fortuna Virginalis: Cum in matrimonia convenitis, toga sternitis lectulos et maritorum genios advocatis? Nubentium crinem caelibari hasta mulcetis? Puellarum togulas Fortunam defertis ad Virginalem?89 Secondo Macro-bio la toga praetexta fu introdotta da Tullo Ostilio: Tullus Hostilius, rex romanorum tertius debellatis Etruscis sellam curulem lictoresque atque praetextam quae insignia magistratuum Etruscorum erant, primus ut Ro-mae haberentur instituit. Sed praetextam illo saeculo puerilis non usurpa-bat aetas.90 In ogni caso la sua provenienza etrusca era indiscussa dai Romani91 e per loro essa costituiva un privilegio, dal momento che potevano indossarla solo i cittadini romani: Nullo iure uti praetextis licebat […] peregrinis, quibus nulla esset cum Romanis necesitudo.92
la toga praetexta era bianca, bordata di porpora ed indossata, oltre che dai fanciulli e dalle fanciulle, anche dai magistrati e dai pontefici.93 la porpora rappresentava, sin dall’epoca imperiale, il potere politico e religioso, e proprio in virtù di quest’ultimo era am-messa per i fanciulli ai quali si doveva, a detta dello stesso giovenale, il più grande rispetto;94 inoltre si credeva che questo indumento fosse dotato di virtù magiche e protettive, tanto che addirittura Per-sio la definisce ‘custode’ della sua fanciullezza: Cum primum pavido custos mihi purpura cessit/ bullaque subcintis Laribus donata pependit.95 Quintiliano asserisce che per mezzo di essa la debolezza diveniva sacralità:96 Illud sacrum praetextarum […] quo infirmitatem pueritiae et
88 van gennep, Riti di passaggio, cit., p. 113, classifica come ‘riti di separazione’ la consuetudine di dedicare alla divinità gli abiti della fanciullezza, i propri balocchi, ed in generale il taglio dei capelli ed il cambiamento di vestiario.
89 Arnob., Adversus Nationes, 2, 67: «Quando vi unite in matrimonio, stendete la toga sul letto nuziale ed invocate il genio del marito? Accarezzate i capelli delle spose con una lancia celibare? Dedicate le toghe della fanciullezza alla fortuna virginale?»; cfr. anche fest., p. 282-284 l.
90 Macr., Saturnalia, 1, 6, 7.91 liv., 1, 8, 3: Ab Etruscis […] unde toga praetexta sumpta est («gli Etruschi […] da cui
la toga pretesta ebbe origine»); Plin., Naturalis historia, 8, 195: Praetextae apud Etruscos origine invenerunt («le preteste ebbero origine presso gli Etruschi»), ma cfr. anche fozio, 584, 17; Serv., Commentarius ad Aeneidem, 3, 781; Tert., De Pallio 1, 5; per una tesi contraria all’origine etrusca cfr. l.W. Wilson, The Roman toga, Baltimore 1924.
92 Macr., Saturnalia, 1, 6, 12: «In nessun caso agli stranieri era lecito indossare la pretesta».
93 varrone testimonia che anche i re la indossavano: Reges nostri et undulatas et praetexta-tas togas soliti sint habere («I nostri re erano soliti indossare toghe ondulate e pretestate»).
94 Iuv., 14, 47.95 Pers., Saturae, 5, 30-1: «Quando la prima volta sparì per me timoroso la porpora
custode/ e la bolla pendeva offerta ai lari con la tunica succinta».96 Quint., Declamationes minores, 340, 13: «l’inviolabilità delle preteste […] con cui
rendiamo sacra e venerabile la debolezza».
abiti, corpi, identità188 Ù
sacram facimus et venerabilem. Non si deve dimenticare, inoltre, che nel Satyricon di Petronio, opera che rispecchia numerose supersti-zioni popolari, il rosso ha una funzione apotropaica. Trimalcione, il liberto arricchito, al cui sontuoso banchetto partecipano i pro-tagonisti dell’opera, indossa un accappatoio coccineus, ovvero color coccinella, un rosso intenso, quasi scarlatto; intorno al collo mette un tovagliolo bordato di frange di porpora, per evitare che influssi negativi passino, attraverso la bocca, alla sua persona.97 la prete-sta, dunque, proteggeva essenzialmente l’innocenza dei fanciulli,98 qualità che conferiva loro una capacità religiosa; di conseguenza la sua deposizione, oltre a rappresentare l’accesso all’età adulta e allo status di civis e di matrona, significava anche la perdita di purezza a causa dell’incontro con la sessualità per l’uomo e la donna e l’in-gresso nella vita militare, esclusivamente per l’uomo.99 In effetti, sia agli iniziati, sia a coloro che dovevano rivestire particolari cariche religiose, per essere accettati dalla divinità si richiedeva un’assoluta astinenza sessuale.100 Ad esempio i camilli e le camillae che erano ad-detti all’assistenza della coppia sacra del flamen e della flaminica, do-vevano avere dei requisiti ben precisi: Romani quoque pueros et puellas nobiles et investes camillos et camillas appellant, flaminicarum et flaminum praeministros.101 Questi fanciulli al servizio della coppia sacerdotale dovevano preservarne la santità proprio grazie alle loro caratteri-stiche: il termine investes, con cui venivano designati, rappresenta lo status dei giovani non ancora giunti alla pubertà e quindi illibati, inoltre era richiesta anche la purezza di nascita, attraverso la pro-venienza da una famiglia nobile, nonché la condizione di patrimi e matrimi, cioè la persistenza in vita di entrambi i genitori, a garanzia dell’assenza di qualsiasi legame con la morte.102
97 Petr., Satyrica, 28 e 32. 98 Non è un caso, probabilmente, che Isidoro faccia risalire l’etimologia di puer da
purus (Origines, 11, 2).99 Neredau, La jeunesse, cit., p. 156.100 Sull’argomento cfr. E.C. Parsons, Religious Chastity, New York 1913.101 Macr., Saturnalia, 3, 8, 7: «I Romani chiamano i fanciulli e le fanciulle nobili, non
ancora giunti alla pubertà camilli e camillae, ovvero assistenti delle flaminiche e dei flamini». Cfr. anche fest., p. 82 l.: Flaminia dicebatur sacerdotula quae flaminicae Diali pra-eministrabat: eaque patrimes et matrimes erat, id est patrem et matrem adhuc vivos habebat («Era detta flaminia la sacerdotessa che assisteva la flaminica di Iuppiter: questa era patrimes e matrimes, cioè aveva padre e madre ancora vivi»).
102 la stessa precauzione veniva osservata per i fanciulli del corteo che accompagna-va la sposa nella casa del marito (fest., p. 282 l.): Patrimi e matrimi pueri praetextati tres nubentem deducunt: unus qui facem praefert ex spina alba, quia noctu nubebant, duo qui tenent nubentem («Tre fanciulli con la pretesta e con padre e madre ancora vivi conducono la sposa: uno che porta la torcia di biancospino, poiché si sposavano di notte, due che tengono la sposa»). Cfr. anche gell., Noctes Atticae, 1, 12, 2, secondo il quale la stessa precauzione viene presa per le vestali: Qui de virgine capienda scripserunt […] minorem quam annos sex, maiorem quam annos decem natam negaverunt capi fas esse; item quae non sit patrima et matrima («Coloro che hanno parlato della ‘cattura’ della vergine vestale […] affermano che è sacrilegio prenderla minore di sei anni e maggiore di dieci, e che sia orfana di padre e madre»).
Sguardi Sul mondo antico Ù 189
Il fanciullo oltre alla praetexta deponeva anche la bulla: aurea insignia erat puerorum praetextatorum quae dependebat pectore.103 gli stessi antichi provavano imbarazzo nel ricostruire il valore origi-nario di questo monile, nonché la sua provenienza, ma la stretta relazione dell’oggetto con la praetexta indurrebbe ad attribuirgli le medesime virtù magiche e scaramantiche. Si tratta di un mo-nile costituito da due lamine concave e giustapposte, rotonde o oblunghe, che conteneva, all’interno, un piccolo oggetto di for-ma fallica, detto scaevola o turpicula.104 Mentre in Etruria, origina-riamente, lo indossavano sia gli uomini che le donne di ogni età, come una collana o un braccialetto, a Roma era riservato solo ai fanciulli e alle fanciulle fino al matrimonio o a coloro che celebra-vano un trionfo.105 Recenti ritrovamenti archeologici presso Bolse-na fanno risalire l’uso della bulla addirittura all’epoca romulea,106 ma altri scavi attestano che l’oggetto era diffuso in tutto il territo-rio italico nell’età del ferro: del resto sembra che solo a Tarqui-nia la bulla fosse indossata esclusivamente dai giovani ed è sempre dall’Etruria che provengono i prodotti più splendidi del genere.107 la questione è piuttosto controversa: comunque è probabile che gli stessi Romani fossero indotti dalla ricchezza dei prodotti etruschi e dalle affini tradizioni a considerare la bulla originaria dell’Etruria. Macrobio sembra convalidare il legame con Tarquinia, infatti dice che proprio Tarquinio Prisco per primo onorò il coraggio mostra-to dal figlio in guerra con la pretesta e la bulla, ma è incerto nel riferire se fu proprio lui ad introdurla ex novo: Alii putant eundem Priscum, cum statum civium sollertia providi principis ordinaret, cultum quoque ingenuorum puerorum inter praecipua duxisse, instituisseque ut patricii bulla aurea cum toga cui purpura praetexitur uterentur.108 È pro-babile che la novità introdotta da Tarquinio consistette essenzial-mente nell’attribuire la praetexta e la bulla, quali insignia ingenuita-tis, esclusivamente ai fanciulli: da allora le bullae assunsero anche una connotazione sociale, per cui quelle dei figli dei nobili erano
103 fest., p. 32 l.: «la bulla era un’insegna d’oro, tipica dei fanciulli con pretesta, che pendeva sul petto».
104 varro, De lingua latina, 6, 5.105 Plin., Naturalis historia, 33, 4.106 Neredau, La jeunesse, cit., p. 154-155. Questa datazione sembra avvalorata dalla
testimonianza di Plutarco, Romulus, 20, 4, il quale attribuisce l’introduzione della bulla e della praetexta a Romolo, opponendosi così ad un’origine etrusca.
107 P. gregory Warden, Bullae, Roman custom and italic tradition, in «Opuscula roma-na», 14 (1983), pp. 69-75.
108 Cfr. Macr., Saturnalia, 1, 6, 11: «Secondo altri, lo stesso Prisco, nell’ordinare le classi dei cittadini con la solerzia propria di un principe previdente, si occupò parti-colarmente del modo di vestire dei fanciulli liberi e decise che i patrizi portassero il ciondolo d’oro con la toga orlata di una striscia di porpora»; cfr. anche Plin., Naturalis historia, 33, 10.
abiti, corpi, identità190 Ù
d’oro,109 dei plebei di cuoio.110 In ogni caso la bolla assolveva anche ad una funzione morale, perché incitava i giovani che l’indossava-no ad emulare i trionfatori, ma soprattutto era un amuleto dalle virtù apotropaiche: Nam sicut praetexta magistratuum, ita bulla gesta-men erat triumphantium, quam in triumpho prae se gerebant inclusis intra eam remediis quae crederent adversus invidiam valentissima. Hinc deduc-tus mos ut praetexta et bulla in usum puerorum nobilium usurparentur ad omen ac vota conciliandae virtutis ei similis cui primis in annis munera ista cesserunt.111 Questo è comprovato anche dall’usanza di attaccare sotto il carro dei vincitori una bolla contenente un fascinum in mi-niatura, dalle riconosciute potenzialità scaramantiche.112 Dunque, sia la praetexta che la bulla, quali insignia pueritiae, qualunque sia la loro origine, sembrano assolvere ad una funzione protettiva nei confronti della fanciullezza.
Tutti questi valori sono sintetizzati nell’interpretazione che Plu-tarco dà del ciondolo, segno evidente di come già gli antichi non avessero più una chiara conoscenza del significato originario del monile: nel chiedersi, appunto, per quale motivo i fanciulli indos-sino i ciondoli, egli propone diverse ipotesi. Suppone che esso sia stato, soprattutto in origine, un elemento di distinzione e di ono-rificenza: a questo proposito riporta la vicenda del figlio di Tarqui-nio, insignito dal padre per il suo coraggio, e la leggenda del ratto delle Sabine, i cui figli indossavano la bulla in segno d’onore.113 Essa poteva avere anche una funzione morale, perché i giovani non si abbandonassero ai piaceri prima di averla deposta; infine l’autore ipotizza un qualche legame del ciondolo con la luna, in virtù della sua forma, attribuendogli, implicitamente, un qualche potere ma-gico proveniente dal pianeta.114
109 Ps. Ascon. ad Ciceronem, Verrinas, 2, 1, 152: Simul cum praetexta etiam bulla suspendi in collo infantibus ingenuis solet aurea («Ai fanciulli nobili è solita pendere al collo anche la bolla d’oro con la pretesta»).
110 Macr., Saturnalia, 1, 6, 14: Ex quo concessum ut libertinorum quoque filii, qui iusta dumta-xat matre familias nati fuissent, togam praetextam et lorum in collo pro bullae decore gestarent («Da allora anche ai figli dei liberti, purché nati da matrimonio legittimo, fu concesso di vestire la toga pretesta e di portare un collare di cuoio in luogo dell’ornamento del ciondolo»); Plin., Naturalis historia, 33, 10; Isid., Origines, 19, 24, 16; Iuv., 5, 165; liv., 26, 36, 5.
111 Macr., Saturnalia, 1, 6, 9-10: «Infatti la pretesta era propria dei magistrati e il cion-dolo d’oro dei trionfatori: lo portavano durante il trionfo, rinchiudendovi dentro gli amuleti che credevano più efficaci contro la malevolenza. Da questo fatto prese origine l’abitudine di far portare la pretesta e il ciondolo ai giovani nobili come augurio e voto di un valore simile a quello che era stato onorato con tali doni nella fanciullezza».
112 J.P. Neredau, Être enfant à Rome, Paris 1984, p. 147. l’autore ricorda come i senatori conservassero la bolla solo quando devolvevano tutto il loro oro allo Stato in difficoltà (liv., 26, 36, 5; flor., 2, 6), proprio in virtù delle sue proprietà magiche.
113 Questa ipotesi sembra coincidere con i dati archeologici che, come si è detto, sem-brano far risalire l’uso del monile sin da epoca romulea. Cfr. Plut., Romulus, 20, 4.
114 Plut., Quaestiones Romanae, 101, 287 f - 288 a-b. l’unica interpretazione che Plutarco rifiuta è quella che deriva da varrone, il quale riteneva che bulla significasse ‘buon consi-glio’ e derivasse dal dialetto degli eoli che, appunto, chiamano bulla la deliberazione.
Sguardi Sul mondo antico Ù 191
Anche le fanciulle, oltre alla toga praetexta,115 deponevano altri insignia pueritiae, quali le bambole (pupae) e la stessa bulla. In uno scolio ad Orazio si trova scritto: Solebant pueri, postquam pueritiam excedebant, dis Laribus bullas suas consecrare, similiter et puellae pupas;116 così varrone: Suspendit Laribus †manias†, mollis pilas, reticula ac stro-phia117 ed, infine, Persio: Veneri donatae a virgine pupae.118 A proposito di questo passo, lo scoliasta precisa: Solebant enim virgines antequam nuberent quaedam virginitatis suae dona Veneri consacrare; hoc et Varro scribit.119 l’usanza, evidentemente, faceva parte dei costumi prenu-ziali già all’epoca di varrone. le testimonianze letterarie sembrano attestare che questi riti subirono una certa evoluzione nel corso dei secoli: all’inizio la toga pretesta veniva consacrata nel santuario pubblico della fortuna, variamente identificata con quella virgi-nale o del foro Boario, come sembrerebbe attestare Arnobio.120 In seguito si passò ad una consacrazione privata, presso i Lares fami-liares, degli abiti e dei giochi. In epoca imperiale vi fu un’ulteriore trasformazione, perché l’offerta era rivolta a venere.
gli studiosi sono incerti se attribuire questi riti ad una fase del tutto diversa dalla cerimonia nuziale e considerarli, addirittura, riti di passaggio alla virginitas, età intermedia fra l’infanzia e lo status matronale. J. gagé, il quale ha teorizzato l’esistenza di clas-si di età nell’antica Roma,121 ha addirittura pensato che esistesse un abito diverso che identificasse la fanciulla giunta a pubertà, la toga sororiculata, simile all’undulata, la cui etimologia è collegata al verbo sororiare, cioè gonfiarsi, per seguire le rotondità del seno nascente nell’età dello sviluppo:122 la fanciulla l’avrebbe indossata dopo aver deposto la praetexta. lo studioso ritiene, inoltre, che la fortuna fosse una divinità che vegliava su questi riti di passaggio che caratterizzavano l’epoca arcaica; in effetti, l’equivalente ma-
115 Arnob., Adversus nationes, 2, 67.116 Pseudacr. in Horatium, Serm., 1, 5, 65: «I fanciulli erano soliti, dopo che facevano
il loro ingresso nella puerizia, consacrare agli dei lari le loro bolle d’oro, allo stesso modo le fanciulle consacravano le bambole». Sull’importanza dei Lares nel culto do-mestico cfr. g. Piccaluga, Penates e Lares, in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni», 32 (1961), p. 83.
117 varro, Saturae Menippeae, 463 B: «Dedica ai lari †manias†, agili palle, reticelle e fasce pettorali». I reticula, reti per i capelli, facevano parte specificamente dell’abbiglia-mento della sposa alla vigilia delle sue nozze. Su questo argomento cfr. Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., pp. 66-67.
118 Pers., Saturae, 2, 70: «Bambole donate dalla fanciulla a venere». 119 Schol. in Persium, 2, 70: «Infatti le vergini erano solite consacrare a venere alcu-
ni doni della loro fanciullezza: questa notizia la tramanda varrone».120 Arnob., Adversus Nationes, 2, 67.121 J. gagé, Classes d’âge, rites et vêtements de passage dans l’ancient Latium; à propos de
la garde-robe du roi Servius Tullius et de la déesse Fortuna, in «Cahiers internationaux de Sociologie», 24 (1958), pp. 34-64.
122 Id., Matronalia, cit., pp. 31 sgg. viene addirittura ipotizzato che questo cambia-mento fisico che caratterizzava la crescita della fanciulla avvenisse sotto il patrocinio di Iuno Sororia, ma per l’inverosimiglianza della tesi cfr. Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., p. 80.
abiti, corpi, identità192 Ù
schile della Fortuna Virgo era la Fortuna Barbata e Virilis.123 Anche Boëls-Janssen124 pensa che la tradizione di deporre la praetexta fa-cesse parte, originariamente, dei riti di passaggio alla categoria delle virgines, e che fosse legata all’apparizione del primo sangue mestruale, segno evidente della maturazione fisica della giovane e della sua capacità procreativa: successivamente essa venne ingloba-ta nei riti prematrimoniali, similmente alla dedica dei giochi infan-tili ai lari, fatta alla vigilia delle nuptiae.125
Anche per la consacrazione dei giochi, sembra si possa ipotizza-re una dedica iniziale a delle divinità protettrici del passaggio delle fanciulle al nubilato: in effetti, in base ai recenti ritrovamenti di la-vinio, Torelli ha ricostruito un calendario di iniziazioni femminili parallelo a quello maschile, nel mese di marzo, sotto il patronato di Minerva e Anna Perenna. Nel santuario di Atena Ilias, in effetti, sono state trovate statue votive rappresentanti giochi tipicamente infantili o simboli della fertilità delle nozze, come uova o fichi.126 Per Champeaux, al contrario, il fatto che in epoca storica non ab-biamo alcuna testimonianza di riti di passaggio per le fanciulle127 si spiega, probabilmente, con l’usanza, allora diffusa, di farle sposare in età prematura, addirittura a quattordici anni:128 esse, dunque,
123 Ivi, p. 37-9. Il rito della depositio barbae sopravviveva anche in epoca imperiale, come testimonia la consacrazione effettuata da Nerone nel pieno rispetto del cerimoniale (Svet., Nero, 12, 4): Gymnico, quod in saeptis edebat, inter buthysiae apparatum barbam primam posuit conditamque in auream pyxidem et pretiosissimis margaritis adornatam Capitolio consecra-vit («Durante il saggio ginnico, che avveniva nel Recinto delle elezioni, mentre si svol-geva una ecatombe, si fece tagliare la prima barba e, postala dentro una pisside d’oro, ornata di gemme preziosissime, la offrì in Campidoglio»).
124 Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., pp. 82-83.125 Ivi, pp. 62 sgg., l'autore collega la perdita di questo rito all’estensione semantica del
termine puella; originariamente, infatti, esso designerebbe la fanciulla non ancora atta alla procreazione, la impubera, ma la parola perse il suo valore etimologico in epoca stori-ca, abbracciando tutte le fasce d’età. Al contrario, il termine virgo, la cui radice è proba-bilmente da connettere al verbo virere, indica colei che può generare. Il rito di passaggio dalla categoria di puella a quella di virgo, di cui, secondo l’interpretazione della studiosa, parlerebbe Arnobio, doveva avvenire in occasione delle prime mestruazioni, manifesta-zione della fertilità femminile. Solo in tarda età virgo divenne sinonimo di donna imma-colata, in conseguenza dell’esigenza maschile di assicurare la purezza della stirpe. Di di-versa opinione è Champeaux (Fortuna, cit., pp. 288 sgg.), la quale non crede nell’esistenza di classi d’età, altrimenti non testimoniate. Infatti, la studiosa non vede alcuna evoluzio-ne storica nel termine puella: sia puella che virgo potevano essere impiegati indifferente-mente per la fanciulla in procinto di sposarsi e riferire puella esclusivamente all’infanzia è arbitrario. Semmai si può pensare ad un impiego semantico riservato ad ambiti diffe-renti: puella veniva utilizzato in senso generico soprattutto nel linguaggio amministrativo (cfr. livio, 3, 44, 8), mentre virgo aveva una connotazione più precisa, essendo impiegato prevalentemente per i rapporti individuali e per sottolineare la maturità sessuale della fanciulla (Id. 3, 44, 2; 3, 47, 6): la pubertà, infatti, era un evento strettamente privato, che non aveva sanzioni ufficiali, ed anche il culto della Fortuna Virgo, rientrando in questa dimensione, non compariva nei calendari pubblici. Per questo, conclude Champeaux, il costume di cui fa menzione Arnobio si situava direttamente all’epoca del matrimonio e non in occasione di un fantomatico rito di passaggio.
126 Torelli, Lavinio e Roma, cit., pp. 50-74.127 Champeaux, Fortuna, cit., pp. 290-291. 128 Sull’argomento cfr. M. Durry, Le mariage des files impubères chez les anciens Romains, in
Sguardi Sul mondo antico Ù 193
divenivano direttamente matrones da puellae, in virtù di nozze trop-po spesso precoci, senza passaggi intermedi per la categoria delle virgines. Per la studiosa è decisiva la testimonianza di Arnobio, che situa la dedica della praetexta direttamente all’epoca del matrimo-nio e non in occasione di un presunto rito di passaggio.129
le evidenti analogie con i rituali connessi al rito di passaggio maschile e la mancanza di testimonianze letterarie chiare a favo-re dell’esistenza di riti di pubertà femminile, non permettono di dare una risposta univoca al dilemma: certo è che l’affermazione di Arnobio e quella dello scoliasta a Persio, indurrebbero ad assi-milare i riti di deposizione dei giochi e degli insignia ingenuitatis alla celebrazione del matrimonio, e a porli in una fase immediata-mente precedente, probabilmente la vigilia delle nozze. Inoltre, gli studiosi tendono ad associare esclusivamente la deposizione di tali simboli da parte della donna con l’assunzione della toga maschile, considerandoli due riti di passaggio ad una diversa età, ma non prendono in considerazione che sia la cerimonia dei tirones che quella delle nuptiae hanno implicazioni di carattere privato e pub-blico che le uniformano: entrambe sono caratterizzate sia da una fase privata, rappresentata dalla dedica della bolla, della pretesta, delle bambole, sia da una fase pubblica, che comprende la cerimo-nia nuziale, la dedica a Iuventas, ma soprattutto la deductio in domum e in forum, segno dell’avvenuta integrazione sociale.
5. Un nuovo habitus
Una volta abbandonati i simboli dell’infanzia, i giovani nasceva-no a nuova vita ed il cambio d’abito era il simbolo di tale metamor-fosi.130 I Romani consideravano tanto importante questo evento da contrassegnarlo con termini tecnici: i fanciulli non ancora giunti a maturità erano chiamati praetextati o investes: Investis, id est sine ve-ste; nondum enim habet stolam; quod est signum maritalis virginitatis.131 Il giovane che aveva indossato la toga virile era chiamato vesticeps: Vesticeps puer, qui iam vestitus est pubertate; e contra investis, qui necdum
«Anthropos», 50 (1955), pp. 432 sgg.; Id., Sur le mariage romain, in «gymnasium», 63 (1956), pp. 187-190. la medesima affermazione viene utilizzata da Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., pp. 61-62, per sostenere la tesi contraria: i riti di nubilato sarebbero stati praticati solo in epoca arcaica, mentre in età storica l’anticipazione del matrimonio ad un’età precoce avrebbe reso impossibile il passaggio delle fanciulle alla categoria delle virgines, cosa che avrebbe comportato l’assimilazione dei riti del nubilato a quelli nuziali.
129 Champeaux, Fortuna, cit., p. 291.130 È stato giustamente notato (gagé, Matronalia, cit., p. 34) che la scelta degli indu-
menti ed il loro colore, in epoca arcaica non era lasciata al caso: si riteneva, infatti, che anche solo indossare questi abiti comportasse effetti magici e contribuisse all’efficacia dell’operazione religiosa che si stava compiendo.
131 Isid., Origines, 10,152: «Investis, cioè senza veste; infatti non ha ancora la stola, che è il simbolo dell’età da marito»; Plin., Naturalis historia, 33, 10; che la praetexta rappre-senti l’infanzia è testimoniato anche dal fatto che l’espressione «ponere praetexta» in Cic., Laelius de amicitia, 10, 33, significa uscire dall’infanzia.
abiti, corpi, identità194 Ù
pubertate vestitus est.132 l’uomo adulto, ormai inserito nella vita ci-vile, era definito togatus,133 e allo stesso modo la sposa prendeva il nome di nupta in virtù dell’usanza di portare il capo velato: Nuptae dictae, quod vultus suos velent. Translatum nomen a nubibus, quibus tegi-tur caelum. Unde et nuptiae dicuntur, quod ibi primum nubentium capita velantur. Obnubere enim cooperire est. Cuius contraria innuba, hoc est in-nupta, quae adhuc vultum suum non velat.134
In occasione delle due celebrazioni, dunque, le fanciulle ed i fanciulli indossavano indumenti non solo caratterizzati da un va-lore sacro, ma anche connotativi della mentalità tipicamente ro-mana: si tratta della tunica recta e della toga pura. Soprattutto per quest’ultima sussistono numerosi problemi interpretativi, originati dal passo di Plinio il vecchio precedentemente menzionato. Oc-corre, dunque, fare luce su tale testimonianza: Ea (Gaia Caecilia) prima texuit rectam tunicam, quales cum toga pura tirones induuntur novaeque nuptae.135 la difficoltà riguarda soprattutto la cerimonia nuziale: più comunemente si ritiene che le nuptae indossassero la tunica recta sotto la stola, che era l’indumento delle matrone roma-ne, come sembrerebbero rivelare le raffigurazioni dei matrimoni in
132 fest., p. 368 l.: «fanciullo vesticeps, che ha già raggiunto la pubertà; al contrario, investis, che non ancora ha raggiunto la pubertà»; gell., Noctes Atticae, 5, 19, 7; lo stesso Apuleio nell’Apologia conferma l’uso di investis nel senso di ‘privo di pubertas’. l’autore ac-cusa Emiliano di mostrare interesse per Pudente solo ora, a causa dell’eredità e racconta di come lo abbia traviato: Investem a nobis accepisti: vesticipem ilico reddidisti (Apologia, 98, 5). Per il termine investis cfr. Macr., Saturnalia, 3, 8, 7; Id., Metamorphoses, 5, 28.
133 Cic., De officis, 1, 79. 134 Isid., Origines, 9, 7, 10-1: «le nuptae sono chiamate in questo modo perché velano
il proprio volto: è nome figurato, derivato da quello delle nubi che coprono il cielo. Da qui anche il fatto che si parli di nuptiae, perché in occasione di esse si vela per la prima volta il capo delle future spose: obnubere, infatti, significa coprire. Il contrario di sposa è innuba, ossia non sposata: costei non vela ancora il proprio volto». la centralità dell’uso del velo nella cerimonia è confermata da una notizia trasmessaci da Nonio (pp. 208-209 l.), dal quale sappiamo che in origine entrambi gli sposi venivano chiamati nubentes o nupti: Nubere veteres non solum mulieres, sed etiam viros dicebant, ita ut nunc Itali dicunt («gli antichi riferivano il termine nubere non solo alle donne ma anche agli uomini, così come ora dicono Itali»). Nonio riporta nello stesso frammento un passo di Pomponio, altrimenti sconosciuto, a riprova di quanto ha appena asserito: Meus frater maior, postquam vidit me vi deiectum domo, nupsit posterius dotatae, vetulae, varicosae, Afrae («Mio fratello maggiore, dopo che mi vide scacciato di casa con la forza, sposò una donna ricca di dote, vecchia, piena di varici, africana»). Per l’origine del nome risulta molto importante un passo di Servio (Commentarius ad Aeneidem, 4, 374) relativo alla confarreatio, in cui si chiarisce che durante l’offerta i celebranti (nubentes) stavano seduti su seggi uniti, sui quali era posta una pelle di pecora sacrificata; inoltre essi erano ricoperti da un velo (velatis capitibus). In base a questa testimonianza e ai recenti ritrovamenti archeologici, si è dedotto (l. Peppe, Storie di parole, storie di istituti: sul diritto matrimoniale romano arcaico, in «Studia et documenta historiae et iuris», 63, 1997, pp. 158-159) che la confarreatio fu la più antica forma di matrimonio e con-ventio tipica del mondo latino e che diede origine all’uso del velo nella cerimonia; infatti l’etimologia del termine nuptiae deriverebbe proprio dall’importanza attribuita al rito, ti-pico della celebrazione, di coprire gli sposi con un drappo (obnubere) e di velarsi (nubere).
135 Plin., Naturalis historia, 8, 194: «Gaia Caecilia fu la prima a tessere una tunica semplice, come quelle che, insieme ad una toga pura, sono indossate dai giovani o dalle spose novelle», cfr. supra, p. 169.
Sguardi Sul mondo antico Ù 195
nostro possesso;136 in questo caso l’uso della toga pura sarebbe riferi-to esclusivamente ai tirones. Altri studiosi, invece, suppongono che Plinio intenda dire che le spose portavano contemporaneamente la toga pura e la tunica recta, come i tirones, ma poi non chiariscono le modalità secondo le quali questi abiti venivano indossati.137
Per interpretare correttamente il testo di Plinio, comunque, oc-corre risalire al valore simbolico che gli antichi attribuivano all’uso sia della toga che della tunica; innanzitutto entrambe erano tipi-che del sesso maschile. la tunica viene catalogata da festo come vestimentum virile:138 in epoca storica, infatti, era indossata esclusi-vamente dagli uomini, mentre solo anticamente, stando a varrone, sarebbe stata comune ai due sessi.139 In effetti le donne continua-vano a portare la toga, anche in epoca storica, solo in determina-te occasioni, ovvero quando dovevano celebrare cerimonie in cui intendevano propiziare la virtù fecondatrice maschile o entravano in contatto, anche solo idealmente, con l’altro sesso. Per esempio essa era segno di distinzione per le meretrici ed anche le donne che intendevano rivendicare la propria emancipazione ne facevano uso.140 Inoltre si ha notizia dell’utilizzo di questo abito in occasione di sacrifici al dio Mutinus Tutinus, cui le giovani fanciulle consacra-vano la loro verginità prima dell’unione con il marito,141 ed anche le vestali portavano una toga avvolta sul braccio sempre durante l’esecuzione di cerimonie sacre.142 Boëls-Janssen ne deduce che, probabilmente, l’uso della toga era strettamente legato al rappor-to con il sesso maschile ed in effetti questo è comprensibile, dal momento che, come si è detto, erano prevalentemente gli uomini ad indossarla. Del resto si credeva che lo scambio d’abiti fra i due sessi non avesse esclusivamente funzione apotropaica, ma servisse a trasmettere le reciproche virtù: in questo caso gli uomini avrebbero
136 A. Rossbach, Römische Hochzeits-und Ehrendenkmälern, leipzig 1871, tav. I.137 Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., pp. 99 sgg.138 fest., p. 342 l.: Recta appellantur vestimenta virilia («Recta sono chiamati gli indu-
menti maschili»). 139 Nonio, p. 867-868 l.: Toga non solum viri sed etiam feminae utebantur. Ante enim olim
fuit commune vestimentum et diurnum et nocturnum, et muliebre et virile («Non solo gli uomini usavano la toga, ma anche le donne. Prima infatti, di giorno e di notte, avevano le toghe, vestito comune, che indossavano sia le donne che gli uomini»).
140 Cfr. Hor., Saturae, 1, 2, 62-63: l’autore differenzia la matrona con la stola dalla meretrice con la toga. Si veda anche Iuv., 2, 68-70.
141 fest., p. 143 l.: Mutini Titini sacellum Romae fuit, cui mulieres velatae togis praetextatis solebant sacrificare («vi fu un santuario di Mutinus Tutinus a Roma, al quale le donne velate con toghe preteste erano solite sacrificare»).
142 fest., p. 4 l.: Armita dicebatur virgo sacrificans cui lacinia togae in humerum erat reie-cta («Armita era detta la fanciulla che sacrificava, sul cui braccio era posta una toga»). A questo proposito Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., p. 102, ipotizza un collegamento con il compito affidato alle vestali di custodire un fallo sacro conservato nel sacello di vesta, secondo la testimonianza di Plinio (Naturalis historia, 28, 39): Fasci-nus […] qui deus inter sacra Romana Vestalibus colitur («Il membro virile […] il quale dio è onorato nei santuari romani dalle vestali»): ancora una volta vi sarebbe uno stretto rapporto fra la toga ed il sesso maschile.
abiti, corpi, identità196 Ù
reso partecipi le future spose delle loro potenzialità fecondanti. I riti di travestimento sono tipici delle cerimonie nuziali: ad Argo, per esempio, sappiamo che le donne portavano una falsa barba la prima notte di nozze.143 Se le potenzialità maschili erano essen-zialmente fecondanti,144 lo scambio d’abito rappresentava l’unione totale e prolifica della coppia.
Del resto anche la tunica recta veniva fatta confezionare dai padri per i figli per scongiurare i cattivi presagi in occasione dell’assun-zione della toga virile; allo stesso modo le fanciulle prima delle nozze la tessevano o la commissionavano a lavoratori specializzati, sempre al fine di propiziarsi una vita felice e serena.145 le coinci-denze fra le due cerimonie di iniziazione delle vergini e dei fan-ciulli, come si è detto, erano numerose: dunque si può ipotizzare che come i fanciulli indossavano le tuniche al di sotto della toga pura, allo stesso modo avveniva per le spose, che erano abilitate a portare la toga solo in occasioni speciali, fra le quali a buon diritto poteva rientrare anche il matrimonio. Una conferma di tale teoria verrebbe sempre dalla testimonianza di Arnobio, il quale, passan-do in rassegna alcune tradizioni pagane riguardanti il matrimonio, ci informa che le spose ricoprivano il letto nuziale con una toga: Cum in matrimonia convenitis, toga sternitis lectulos et maritorum genios advocatis?146 verosimilmente la toga menzionata nel passo era quel-
143 Plut., Quaestiones grecae, 58, 304 e; Mulierum virtutes, 3, 245 f; Licurgus, 15, 5: Plu-tarco ci informa che una donna riceveva in consegna la fanciulla rapita dall’uomo per le nozze, le rasava a zero i capelli, le faceva indossare calzari ed un mantello di foggia maschile e la lasciava sola su un pagliericcio in attesa del marito. Torelli (Lavinio e Roma, cit., pp. 75 sgg.) individua notevoli analogie fra la tradizione spartana ed i riti di ini-ziazione romana. Inoltre ricorda che anche a Roma le Saliae virgines si travestivano da uomini e gli uomini da donne in occasione dei Matronalia. M. Delcourt, Hermaphrodite. Mythes et rites de la bisexualité classique, Coll. Mythes et Religions, Paris 1958, pp. 11-12, afferma che il travestimento, soprattutto delle donne, con abiti maschili era normale nei riti di passaggio.
144 Che il fuoco possedesse poteri fecondanti era idea diffusa anche nell’immagina-rio collettivo antico: in effetti esistono miti secondari che attestano la nascita di perso-naggi storici avvenuta grazie all’intervento di questo elemento. Uno di questi (cfr. supra, n. 82) ci narra una versione diversa dell’origine divina di Romulus la cui nascita sarebbe il frutto dell’unione di un simbolo fallico, comparso nel focolare della reggia di Tarche-zio (Plut., Romulus, 2), e di una giovane vergine; sia Plutarco che Ovidio sostengono che Servio, antico re di Roma, fu generato da una schiava e dal Lar Familiaris o addirittura da Vulcanus, dio del fuoco (Ov., Fasti, 6, 626-36, ma cfr. anche Plin., Naturalis historia, 36, 204 e Dion., Antiquitates Romanae, 4, 2, 1-3): infine Caeculus, fondatore di Preneste, fu concepito in seguito al contatto di una scintilla con il grembo della madre (verg., Aeneis, 7, 679-81 e 10, 543).
145 fest. pp. 342 e 364 l.146 Arnob., Adversus nationes, 2, 67: «Quando vi unite in matrimonio, stendete la toga
sul letto nuziale ed invocate il genio del marito? »; per lo stesso tema cfr. Nonio, p. 867 l.: In lecto togas ante habebant («Sul letto prima avevano le toghe»). H. le Bonniec, Le témoi-gnage d’Arnobe sur deu rites archaïques du mariage romain, in «Revue des études latines», 54 (1976), p. 111, ridimensionando il ruolo della toga sul letto nuziale, pensa che essa servis-se nei tempi antichi semplicemente a coprire gli sposi e avvalora la sua teoria sulla scorta di varrone (De lingua latina, 5, 167), il quale testimonia che anche il pallium era usato a questo scopo: Quibus operibantur, operimenta, et pallia opercula dixerunt («Chiamarono le
Sguardi Sul mondo antico Ù 197
la della sposa: il rito, con ogni probabilità propiziatorio, serviva ad assicurare la fertilità alla coppia, viste soprattutto le prerogative ‘vi-rili’ che l’abito assumeva nelle occasioni in cui era indossato dalle donne. la toga, del resto, come si è visto era parte integrante anche dei riti prematrimoniali ed in questo senso la testimonianza di Ar-nobio è per noi preziosa.147
È evidente l’importanza assunta da questo indumento nell’arco di tutta la cerimonia: esso ricorre in ogni tappa che segna il cammi-no di iniziazione della sposa, ma è interessante notare che in tutte e tre le occasioni, rito prematrimoniale, nozze e camera nuziale, c’è un filo conduttore, ovvero la propiziazione della fertilità, di cui la toga sembra essere garante.148 Alla luce di questa stretta connessio-ne fra i momenti salienti del rito nuziale, sembra opportuno con-fermare l’ipotesi che vede nella toga uno degli indumenti indossati durante la celebrazione del matrimonio sopra la tunica recta.
la toga pura149 era così chiamata in contrapposizione alla praetex-ta, orlata di porpora:150 per gli uomini essa era detta anche virilis,
cose con cui si coprivano operimenta e pallia opercula»). Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., pp. 215-216, rivaluta l’importanza del passo: la studiosa, però, crede che Ar-nobio si riferisca alla toga dello sposo e accosta tale usanza a quella di coprire lo scranno su cui sedevano entrambi i coniugi durante la confarreatio con una pelle di un animale al fine di propiziare la fertilità; anche l’accostamento con l’invocazione al genio maschile comproverebbe tale tesi, in quanto la toga farebbe da tramite delle sue virtù fecondatri-ci. Un interessante contributo alla questione viene offerto da g. Arrigoni, Amore sotto il manto e iniziazione nuziale, in «Quaderni Urbinati di cultura classica», 15 (1983), pp. 12 sgg., la quale considera il costume di giacere sotto lo stesso mantello-copriletto una tap-pa fondamentale del passaggio dallo status di virgo a quella di mulier: inoltre specifica che il gesto era carico di valenze simboliche, perché rappresentava l’unione concorde, sia istituzionale che extraconiugale (cfr., a questo proposito, Prop., 1, 4, 13-14 e 4, 7, 19-20).
147 Arnob., Adversus nationes, 2, 67, ma per questo argomento cfr. supra, p. 187.148 Per il rito prematrimoniale il legame con la fertilità è costituito dal fatto che la
giovane deponeva la toga proprio prima di sposarsi e di unirsi con il marito. 149 Per la menzione della toga pura cfr., ad esempio, Cic., Epistulae ad Atticum, 7, 8, 5;
5, 20, 9; 9, 17, 1; 9, 19, 1.150 Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., pp. 58-59, ritiene che la foggia
della toga pura della nupta fosse simile a quella di cui era rivestita la statua della Fortuna Virgo: la studiosa, in effetti, considerandola protettrice delle vergini, ritiene verosimile che fosse abbigliata allo stesso modo della sposa proprio nel momento in cui questa si accingeva ad abbandonare la condizione di nubile. la toga nuziale doveva essere allo stesso tempo pura, per analogia con quella dei tirones, ma anche undulata, secondo la testimonianza di varrone (Nonio p. 278 l.): Et a quibusdam dicitur esse Virginis Fortunae ab eo quod duabus undulatis togis est opertum («E da alcuni è detta essere della Fortuna Virgo perché è coperta da due toghe ondulate»). Con questo termine si indica la particolare foggia dell’abito, fornito di alcune pieghe, differente sia dall’antica toga etrusca dritta, sia dalla più ampia e moderna toga romana (Plin., Naturalis historia, 8, 195: «la veste on-dulata fu in un primo tempo fra le più raffinate, poi giunse fino ai piedi la sororiculata»). Ondulate erano anche le toghe che rivestivano la statua della fortuna nel foro Boario (secondo l’interpretazione di Champeaux, Fortuna, cit., p. 291 era a questa dea che le fanciulle dedicavano la pretesta poco prima di sposarsi): queste, però, erano tradizio-nalmente appartenute al re Servio, del quale la dea fortuna era stata l’amante. Si aveva, quindi, un indumento tipicamente maschile dalle potenzialità fecondanti, utilizzato da una divinità femminile. Per questo motivo la dea fortuna era invocata dalle giovani, ma le donne sposate non potevano toccare le sue toghe (Ov., Fasti, 6, 475 e 621 sgg.): nel
abiti, corpi, identità198 Ù
perché segnava il passaggio all’età adulta, nonché libera. Questo at-tributo, riferito specificamente alla toga maschile, aveva, evidente-mente, una connotazione ideologica. già Ovidio151 aveva cercato di darne una spiegazione, ricorrendo ad un’assonanza fra Liber e liberi: la toga verrebbe chiamata così perché era Liber il dio sotto il cui pa-tronato si celebrava l’assunzione della toga; oppure perché essa se-gnava l’ingresso ad una vita più libera, ed in effetti la maggior parte delle fonti depongono per questo significato. Il fanciullo, rivesten-dosi della toga, si svestiva delle limitazioni psicologiche e giuridiche comportate dallo status di puer,152 acquisendo anche la capacità giu-ridica di contrarre matrimonio, di disporre del proprio patrimonio, di fare testamento, in breve l’assunzione della toga lo sollevava dalla dipendenza dalla patria potestas.153 Se questo indumento rappresen-tava i nuovi diritti acquisiti dal giovane, esso, però, connotandolo come civis, ne sanciva anche i doveri: il fatto che tale cerimonia di vestizione si compisse prima in privato di fronte ai Lares familiares, poi pubblicamente, con la deductio in forum, l’iscrizione nella lista dei cittadini,154 la consacrazione religiosa celebrata sul Campidoglio,155 rappresentava la consapevole assunzione da parte del giovane del duplice dovere tipico dell’uomo romano, quello di pater familias e di uomo politico o soldato.156 Del resto se, come si è chiarito, la toga, quale indumento tipicamente maschile, simboleggiava anche le virtù fecondatrici tipiche di questo sesso, ben si accorda con il pa-trocinio di Liber, quale dio della crescita e della riproduzione, grazie alla quale l’uomo assicura la sopravvivenza della propria gens. In un certo senso anche per la donna la toga, indossata esclusivamente in
primo caso, infatti, veniva a lei richiesta la protezione contro i pericoli della sterilità; nel caso delle matrone si temevano i poteri fecondanti della toga che potevano attentare al pudore delle donne sposate. la fortuna del foro Boario, dunque, attraverso le toghe aveva il ruolo di garantire la fecondità, trasmettendo alle spose il potere della sessualità maschile e contemporaneamente di quella femminile.
151 Ov., Fasti, 3, 771 sgg.152 Prop. 3, 15, 3-4: Mihi praetexti pudor velatus amictus et data libertas noscere amoris iter
(«Quando mi fu tolto il pudore della toga pretesta e mi venne concesso di conoscere le vie dell’amore»).
153 Numerose, a questo proposito, le fonti giuridiche e letterarie: Tituli ex corpore Ulpiani, 11, 28: Puberem autem Cassiani quidem eum esse dicunt qui habitu corporis pubes ap-paret id est qui generare possit; Proculeiani autem eum qui quattuordecim annos explevit; verum Prisco visum, eum puberem esse, in quem utrumque concurrit, et habitus corporis, et numerus annorum («I Cassiani considerano giunto alla pubertà colui che appare pubere dallo sviluppo fisico, quindi chi possa generare; i Proculeiani, invece, colui che è giunto a quattordici anni; in verità a Prisco sembrò pubere colui che presentava entrambi questi elementi, l’età e lo sviluppo fisico»; Quint., Institutio oratoria, 4, 2, 5: De iure quaeritur, ut apud centunviros […] pubertas annis an habitu corporis aestimetur («Si pone una questione di diritto […] se la pubertà si valuti in base agli anni o all’aspetto fisico»); Inst. Iust., 1, 22; gaius, Institutiones, 1, 145; 2, 113; Tert., De virginibus velandis, 2.
154 Per questo argomento cfr. supra, pp. 180-181.155 val. Max., Facta et dicta memorabilia, 5, 4, 4; Serv., Commentarius ad Eclogas, 4, 50;
Dion., Antiquitates Romanae, 4, 15; ma cfr. supra, p. 181.156 Infatti il togatus è il civis romanus per eccellenza: gli stranieri e gli esiliati non po-
tevano indossare la toga, ed erano esclusi dal godimento dei diritti civili.
Sguardi Sul mondo antico Ù 199
occasione delle nozze, era il simbolo della sua volontà di assolvere alle aspettative che la società riponeva in lei: quale simbolo della fer-tilità e della potenza fecondatrice maschile, la toga era la garanzia di futuri parti. Quest’abito, quindi, era anche l’emblema della conce-zione di vita tipicamente romana, che valorizzava l’importanza del mondo civile e dei doveri del singolo verso di esso.157
la tunica recta, almeno in origine, nasceva come indumento inti-mo; infatti gli uomini la indossavano sotto la toga,158 le donne sotto la stola; i Romani, successivamente, avevano iniziato ad utilizzarla da sola, in particolare le donne, nei confronti delle quali, ai tempi di Tiberio, il Senato dovette prendere provvedimenti, perché contrav-venivano ai dettami della pudicizia.159 Si passò, così, dalla subucula o tunica interior, simile alle moderne sottovesti, a tuniche più complesse quali il supparum, un abito lungo fino ai piedi, fornito di maniche e posto sopra la subucula, ed infine alla dalmatica, che aveva caratteristi-che simili. l’impiego della tunica recta sotto la toga, in occasione del matrimonio e dell’assunzione della toga, potrebbe essere un retaggio degli antiqui mores, particolarmente indicato in due cerimonie per le quali il rispetto del decoro era necessario. la tunica recta veniva così a ricoprire la medesima funzione svolta dalla tunica interior nell’anti-chità e ad essere garante della pudicizia della sposa e del fanciullo, attributo che, come si è visto, era specifico di questa età.
In ogni caso è evidente che essa costituiva l’indumento distintivo della nupta, ma anche dei tirones, perché in base alle sue caratteri-stiche rivestiva perfettamente il ruolo di abito sacro. festo parla di questo ornatus in due passi: Rectae appellantur vestimenta virilia, quae patres liberis suis conficienda curant ominis causa, ita usurpata quod a stantibus et in altitudinem texuntur»;160 e ancora: «Regillis tunicis albis et reticulis luteis, utrisque rectis, textis sursum versus a stantibus pridie nup-tiarum diem virgines indutae cubitum ibant ominis causa, ut etiam in togis virilibus dandis observari solet.161 Come si è chiarito la tunica era posta a contatto diretto del corpo e di solito era ornata con varie appli-cazioni addirittura d’oro,162 ma la tunica recta si distingueva proprio perché monocroma e priva di ogni fregio; in effetti l’aggettivo recta avrebbe proprio la funzione di sottolineare la semplicità dell’indu-
157 g. Amiotti, Religione e politica nell’iniziazione romana, in m. Sordi (a cura di), Reli-gione e politica nel mondo antico, Milano 1981, p. 139.
158 Cfr. Hor., Epistulae, 1, 1, 95-96.159 Tert., De pallio, 4, 9.160 fest. p. 342 l.: «vengono chiamati semplici gli indumenti che i padri fanno con-
fezionare per i figli al fine di scongiurare la cattiva sorte, così definiti perché vengono tessuti dall’alto da persone che stanno in piedi».
161 fest., p. 364 l.: «le fanciulle andavano a letto, per scongiurare la cattiva sorte, rivestite con tuniche regali bianche e con reticelle color arancio, entrambe semplici, tessute, a partire dall’alto, il giorno prima delle nozze, da persone che stavano in piedi, come si suole fare anche per i fanciulli che indossano la toga virile»; cfr. supra, p. 169.
162 g. Blum, in Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités Greques et Romaines, cit., IX, pp. 539-540, s.v. tunica.
abiti, corpi, identità200 Ù
mento. Non è mancato chi, sulla scorta di festo, ha pensato che l’attributo dipendesse dalla tecnica impiegata per tessere:163 lo scrit-tore latino, con una enallage, assegnerebbe rectam al prodotto della tessitura e non, come di consueto, alla tecnica o al tipo di macchina-rio verticale;164 Rossbach, infine, pensa che l’autore si riferisca alla particolare foggia della toga che ‘cadeva dritta’, in contrapposizio-ne a modelli più ampi e impreziositi da pieghe,165 ma la mancanza di testimonianze letterarie e archeologiche che suffraghino queste due teorie fa propendere per la prima interpretazione, che si giu-stificherebbe anche con la necessità di presentare un’immagine im-macolata della sposa e del tiro, vista la sacralità del rito.
A questo proposito si può affermare con una certa sicurezza che l’indumento fosse bianco, in base all’analogia con la toga pura e sul-la scorta delle testimonianze letterarie dalle quali risulta che spesso la tunica nuziale era designata con l’aggettivo candida o alba;166 del resto, il bianco, simbolo di purezza, ben si adattava ad entrambe le occasioni. festo, inoltre, definisce la tunica regilla167 e Nonio consi-dera l’aggettivo un diminutivo di regius:168 Regilla vestis diminutive a regia dicta, ut et basilica; i critici moderni169 tendono a considerarlo un diminutivo di recta, ma in questo caso il testo di festo diverrebbe pleonastico, perché l’autore ripeterebbe due volte lo stesso concet-to. verosimilmente l’etimologia di Nonio va intesa in senso traslato, ovvero le tuniche erano regali perché legate ad un’usanza arcaica, probabilmente risalente all’epoca monarchica170 e da questo fatto-
163 Cfr. Isid., Origines, 19, 22, 18; Serv., Commentarius ad Aeneidem, 7, 14. giustamente fayer, L’«ornatus» della sposa romana, cit., p. 5, fa notare che se il termine rectus si riferisce alla tecnica impiegata per tessere (a stantibus et in altitudinem), esso era utilizzabile per tutti i capi d’abbigliamento antichi, dal momento che tale metodo di tessitura era l’uni-co allora impiegato; evidentemente, con l’affermarsi di nuove tecniche rectum divenne attributo specifico della tunica appartenente alla nupta e al tiro, poiché essa continuava ad essere realizzata secondo gli antichi metodi, in virtù del conservatorismo che carat-terizzava questi rituali religiosi.
164 Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., pp. 70-71. Interessante è anche l’in-terpretazione originale di l. Sensi, Ornatus e status sociale delle donne romane, in «Annali della facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi di Perugia», 18 (1980-1), p. 58, il quale pensa che l’espressione ‘a stantibus’ contenuta in festo, p. 364 l., identifichi i parenti della sposa, dai quali sarebbe tessuta la tunica, in virtù di un antico rito di ini-ziazione. Inoltre, la tecnica del telaio verticale viene fatta risalire a Tanaquil e, almeno all’inizio, fu prerogativa delle famiglie abbienti, per la possibilità di produrre stoffe di ottima qualità e a buon prezzo.
165 Rossbach, Untersuchunghen, cit., p. 276.166 fest., p. 364 l. Inoltre Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., p. 71, ritiene
che il colore bianco della veste non fosse specifico del matrimonio, ma un attributo tipico delle cerimonie religiose, come dimostrerebbe l’analogia con il rito di passaggio dei tirones.
167 fest., p. 364 l.168 Nonio, p. 864 l.: «la veste è detta regilla come diminutivo da regia o reale».169 gagé, Matronalia, cit., p. 31.170 Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones, cit., p. 73. In base a questa interpreta-
zione la studiosa ipotizza che la tunica avesse una bordatura di porpora denotante il suo uso regale.
Sguardi Sul mondo antico Ù 201
re derivava la sacralità dell’indumento. Il fatto che i padri la faces-sero tessere privatamente per i propri figli e non la acquistassero, si giustifica in base alla componente apotropaica presente in tutti i riti di passaggio: si temeva, infatti, che elementi impuri potessero contaminare l’abito e quindi anche la novella sposa ed il fanciullo che si affacciava a nuova vita.171 Inoltre festo ci informa che queste tuniche venivano realizzate stando in piedi di fronte al telaio in vir-tù del fatto che la tessitura di questi abiti avveniva, secondo un’an-tica usanza, con macchinari verticali, i cui fili della trama erano tenuti dritti grazie a pesi posti nella parte inferiore;172 la difficoltà della confezione, a detta di alcuni studiosi, consisterebbe anche nel fatto che essa era realizzata con un unico drappo di stoffa. In questo caso l’aggettivo recta potrebbe essere interpretato nel senso di ‘non cucita’,173 alla guisa delle tuniche dei sacerdoti ebraici o di quelle fatte indossare in occasione dei funerali. Anche in questo caso si è di fronte alla volontà di sottolineare la semplicità e la pu-rezza dei fanciulli, ma si intende anche non contravvenire a precise prescrizioni religiose, in base alle quali si doveva evitare il contat-to con un qualsiasi strumento fatto di ferro, compresi gli aghi per cucire e le borchie ornamentali: si tratta, infatti, di un materiale oltremodo pericoloso, in quanto componente primaria delle armi e poco adatto ad un rito che introduceva a nuova vita.174
Come si può dedurre dall’analisi fin qui condotta, indagare le consuetudini vestimentarie della civiltà romana significa fare luce sulle sue più profonde convinzioni ideologiche. Il matrimonio e l’assunzione della toga sono per questo popolo molto più che un semplice rito di passaggio: rappresentano la rinascita ad una nuo-va vita, un cambiamento definitivo, simbolicamente rappresentato dalla deposizione degli insigna pueritiae e dal mutamento d’abito. Infatti, se la tunica recta è l’emblema della purezza d’animo con cui i fanciulli si accostano alla nuova realtà, indossare la toga rappre-senta l’assunzione consapevole dei doveri nei confronti della so-
171 fest. p. 342 l.172 Si tratta della tela stans, la tipologia più antica di telaio; cfr. Ov., Metamorphoses, 4,
275; Fasti, 3, 819.173 l. Morpurgo, Chiton araphos, tunica recta, in «Rendiconti della accademia dei lin-
cei», 9 (1954), p. 99 accosta le caratteristiche della tunica recta a quelle dalla tunica indossata da gesù nel momento della morte. Ritiene che la scelta di indossare la tunica, oltre le vesti abituali, fosse dovuta alla volontà del Signore di ufficializzare la sua funzio-ne, almeno a conclusione della sua missione, inoltre essa era utilizzata per le vestizioni funebri. A questo proposito si confronti anche una lettera di girolamo (22, 19, 3), in cui la tunica inconsuta, cioè non cucita, viene considerata simbolo di purezza. la studiosa inoltre, ipotizza che, per la struttura particolare del telaio, l’abito fosse lavorato dal bas-so verso l’alto, perché i fili dovevano essere tenuti alla stessa distanza nella parte bassa, per poi raccogliersi nell’orlo del collo.
174 Questo sarebbe anche il motivo, a detta della Morpurgo, Chiton araphos, cit., p. 96, pp. 101-102, per il quale i soldati, nella spartizione delle vesti di gesù non osarono fare a pezzi la tunica, ma preferirono sorteggiarla: l’uso di un utensile qualsiasi per tagliarla avrebbe inficiato le sue virtù propiziatrici. Per l’interdizione relativa all’uso del ferro cfr. J.g. frazer, Le rameau d’or, Paris 1981, I, pp. 553 sgg.
abiti, corpi, identità202 Ù
cietà adulta, della quale essi divengono definitivamente partecipi. In questo senso le due cerimonie, comprese tutte le implicazioni pubbliche e private, si possono equiparare: del resto tale omologia era posta in rilievo già dagli antichi attraverso la scelta degli stessi indumenti sia per la nupta che per il tiro.