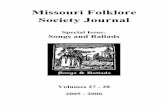Stellato fisso, domattina piove. Il folklore, l'antropologia e la poesia del Pascoli
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Stellato fisso, domattina piove. Il folklore, l'antropologia e la poesia del Pascoli
1
1
Mariano Fresta
STELLATO FISSO DOMATTINA PIOVE
Il folklore, l’antropologia e la poesia del Pascoli
1.- Con l’occhio del demologo.
Fino ai primi decenni del Novecento era possibile individuare nella regione toscana tre
sistemi ben distinti di conduzione agricola: la mezzadria, diffusa nei territori interni di piano-
colle, appoderati fin già dal XVI secolo; la piccola proprietà contadina, prevalente nelle aree di
alta collina e di montagna; infine i latifondi delle maremme in cui, per la malaria, lo sfruttamento
si limitava alle colture cerealicole e al pascolo del bestiame allevato allo stato semibrado1.
Gli studi demologici, avviati in Toscana a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, hanno
avuto come oggetto privilegiato quasi esclusivamente il mondo mezzadrile, vuoi perché questo
ha segnato, nel corso di vari secoli, l’evoluzione storico-sociale della regione, vuoi per i suoi
aspetti particolari che hanno suggerito teorie di analisi economica diverse, vuoi perché si trattava
di un sistema economico-sociale che ha conservato a lungo elementi di origine antica e quindi
appariva di particolare interesse per lo studioso di folklore. Il mondo, dunque, della piccola
proprietà contadina è stato trascurato, mentre le zone maremmane, specie quelle del Grossetano,
hanno avuto una qualche attenzione dal 1970 in poi2.
Nelle poesie del Pascoli e nei Primi e Nuovi Poemetti in particolare, da lui espressamente
dedicati a una famiglia contadina, non c’è traccia della mezzadria, per la semplice ragione che il
territorio della Garfagnana e quello di Barga in cui il poeta visse per alcuni anni e dal quale prese
temi e linguaggio per molte delle sue composizioni, essendo quasi interamente di montagna, non
avevano niente a che fare con le zone in cui predominava l’istituto di colonia. Ma, se si tralasciano
le caratteristiche giuridiche, che differenziavano il sistema mezzadrile dalla conduzione affittuaria
o da quella diretta dei piccoli proprietari, le condizioni materiali di vita e il patrimonio culturale
appaiono comuni e condivisi in tutto il mondo contadino della Toscana (e forse dell'Italia intera)
dagli inizi dell’Ottocento fino ai primi decenni del Novecento.
Nessuna meraviglia, dunque, se, a chi ha studiato il mondo mezzadrile toscano e le sue
tradizioni culturali, la lettura integrale dell’opera poetica pascoliana riserva una scoperta
sorprendente; buona parte, infatti, di tutto quanto egli ha appreso attraverso i libri e le ricerche sul
campo, se la ritrova condensata in forma poetica e spesso racchiusa in un’intuizione che ne
illumina i significati più reconditi. Anche nei componimenti ispirati da problemi molto vicini alla
sensibilità personale del Pascoli c’è spesso un accenno, un termine o un’immagine che ci riportano
alla campagna, alla vita semplice e dura del mondo contadino tra la fine del Diciannovesimo
secolo e l’inizio del Ventesimo. Insomma, pare che il Pascoli, allo stesso modo dei moderni
ricercatori di tradizioni popolari, abbia fatto ricerca sul campo non occupandosi soltanto di
stornelli e strambotti, ma rivolgendo la sua attenzione anche al lavoro manuale e i suoi strumenti,
1 Si veda G. GIORGETTI, Linee di evoluzione delle campagne toscane contemporanee, in Capitalismo e
agricoltura in Italia, Ed. Riuniti, Roma 1977.
2 Meritoria in questo senso è l'attività dell'Archivio delle Tradizioni Popolari della Maremma Grossetana.
2
2
alla vita quotidiana, al tipo di alimentazione, alla devozione religiosa, al mondo animale e
materiale che circondava quella società.
Chi si è occupato, invece, di studiare e verificare il valore poetico e letterario dei
componimenti pascoliani non ha dato molto peso a questi aspetti etnografici, limitandosi a mettere
in nota sia i riferimenti alla vita, al lavoro e al folklore contadino della Toscana, delle Marche e
della Romagna, da cui il Pascoli prendeva gli spunti, sia i suoi debiti nei confronti delle opere
demologiche che circolavano in Italia alla fine dell’Ottocento. L'attenta e minuziosa osservazione
che il Pascoli dedicò alla vita quotidiana delle famiglie contadine non ha suggerito nessuna
riflessione di carattere storico-antropologico. La critica letteraria in sostanza ha preso atto che il
mondo contadino è stato l’ispiratore della poesia pascoliana, ma non ha mai cercato (e, d’altra
parte, non era nemmeno suo compito) di indagare quel mondo, di verificare se la vis poetica del
Pascoli avesse illustrato in modo veritiero (ma che si tratti di verità si dà per scontato …) il mondo
agricolo e se questa rappresentazione poetica ha un diretto corrispettivo nella realtà delle
condizioni materiali e culturali di vita dei contadini toscani alla fine dell’Ottocento.
Questo tipo di analisi, svolta con l'occhio del demologo, mi accingo a fare adesso, pur non
tralasciando di seguire, ovviamente, le vie già percorse dai critici letterari, soprattutto quelli come
Giuseppe Nava, che hanno trovato nessi importanti tra il patrimonio folklorico e l’opera del
Pascoli, e riconducendo il tutto alla mia esperienza di studioso e di ricercatore del mondo popolare
tradizionale toscano. I miei riscontri, tuttavia, non partono dal singolo brano o dal singolo
poemetto per andare a rintracciare l’aspetto del patrimonio folklorico da cui il poeta ha preso lo
spunto; cercano, invece, di vedere in qual modo le condizioni esistenziali, sociali e culturali del
mondo contadino toscano, che le ricerche storiche e quelle antropologiche ci hanno fatto
conoscere, si riflettano nell’opera pascoliana e come si siano trasformate una volta che il Pascoli le
ha assunte e trasfuse nella sua visione ideologica e in quella poetica.
2.- La critica e il folklorismo del Pascoli.
La presenza nelle poesie pascoliane
3 di numerosi elementi tratti dal folklore non poteva
passare inosservata. Non solo si ritrovano nei Primi Poemetti e nei Nuovi poemetti componimenti
che illustrano vicende umane, comportamenti e tradizioni che ricorrono in determinati periodi del
calendario e che i folkloristi hanno inserito in precise categorie, come quelle del Ciclo della vita e
del Ciclo dell’anno, ma in tutte le raccolte c’è anche un numero considerevole di riferimenti alla
vita contadina, al mondo agricolo con tutte le sue credenze, i suoi atteggiamenti, le sue forme
espressive, dai termini dialettali ai proverbi, dai canti alle fiabe. Ovvio, pertanto, che critici
letterari e studiosi di folklore si siano soffermati ad analizzare questi elementi, i primi per
rintracciare le origini di certa poesia pascoliana, gli altri per farne riscontri con il patrimonio della
cultura popolare.
Già nel 1924 Giovanni Giannini, profondo conoscitore e accurato raccoglitore di tradizioni
popolari lucchesi, aveva pubblicato un saggio in cui aveva collazionato tutto quanto il Pascoli
avesse ripreso dalla cultura popolare, soprattutto di quella della media valle del Serchio. Il lavoro
del Giannini, essendo dunque una completa ricognizione dei testi pascoliani, risulta una
rilevazione puntuale di tutti i frammenti, piccoli e grandi, e delle suggestioni che il patrimonio
folklorico aveva proposto all’elaborazione del poeta4.
Nel 1956, al Convegno concernente il primo centenario della nascita e il cinquantenario
della morte del poeta parteciparono anche Vittorio Santoli, che pur essendo un insigne
germanista si occupava di canti o, come si diceva allora, di poesie popolari e che aveva già
3 Per semplificare, i titoli delle opere pascoliane sono indicati con le seguenti sigle: MY (Myricae), PP
(Primi poemetti), NP (Nuovi poemetti), CC (Canti di Castelvecchio).
4 G. Giannini, Le tradizioni popolari nella poesia pascoliana, in Lucca a G. Pascoli, Lucca 1924, p. 51 e sgg.
3
3
pubblicato un fondamentale lavoro filologico su cinque Canti della raccolta Barbi5; e Paolo
Toschi, in quel momento lo studioso più importante in Italia della Storia delle Tradizioni
popolari6.
Nella sua analisi Vittorio Santoli, citando più volte il saggio del Giannini, rivolge la sua
attenzione a quei passi in cui il Pascoli riprende, alla lettera o variandoli leggermente, i temi, le
espressioni, i versi e addirittura intere strofe di stornelli e rispetti della tradizione popolare. Il
Santoli chiama «intarsi» questi frammenti di canti popolari che «presuppongono la fioritura
degli studi di poesia popolare avvenuta intorno all’Ottanta [del XIX sec.]». Ma questa
influenza, secondo lui, si mescola nel Pascoli con quella che gli derivava attraverso la lezione
del Carducci dalla letteratura culta del Tre/Quattrocento, per raggiungere esiti di preziosità
decadente alessandrina. Lo stesso alessandrinismo il Santoli rileva nelle strutture metriche dei
componimenti pascoliani, le quali riprendono quelle popolari dello stornello e del rispetto,
alternandole con quelle più eleganti e complesse di derivazione madrigalesca: «E per questo
cangiantismo esse raggiungono la preziosità alessandrina» (p. 75).
In sostanza il Santoli, pur nella sua sapiente disamina, non si allontana da una critica di
stampo letterario; e continuando a parlare di “poesia” e non di “canto” popolare, fa mostra di
rifarsi ancora a una concezione romantica del folklore; in questo modo è ovvio che gli
rimangano sconosciuti tutti gli aspetti storici, demologici e antropologici che stanno dietro ai
versi dei canti popolari e dei loro portatori. In questo senso, la sua critica non coglie appieno la
sensibilità con cui il Pascoli aveva osservato la società agraria e l’aveva saputa poeticamente
rappresentare, andando di là della semplice ripresa di proverbi, stornelli e stilemi vari
dell’espressività e della cultura tradizionale contadina.
Più avvertito, a livello etnografico, è l’intervento di Paolo Toschi; anche lui parla di
«intarsi» e d’incastonature, ma soprattutto egli rileva nell’opera del Pascoli una profonda
conoscenza della cultura popolare tradizionale che riguarda
il ciclo della vita umana, la vita agricola tradizionale, e la poesia popolare; ma non
trascurabili apporti troviamo anche per i proverbi e le leggende, il ciclo dell’anno, i giuochi
fanciulleschi e varie credenze e superstizioni (pag. 168).
Osserva poi che questa conoscenza del poeta non riguarda solo la Romagna, sua terra
d’origine, ma anche le altre regioni in cui gli accadde di risiedere come la Lucania, la Sicilia e
soprattutto la Toscana. La conclusione che il Toschi trae è che
attraverso la poesia pascoliana il folklore subisca un processo di transfert sopra un piano di
“realismo magico”, sì che il documento, pur possedendo il suo pieno valore d’informazione
esattissima7, trasporta parole e cose nel clima della poesia e della lingua nazionale. (170)
L’analisi toschiana, quindi, mette in risalto le competenze folkloriche del poeta, ma
senza scendere, anche lui, più in profondità, senza mettere in rapporto questi elementi di
folklorismo con le condizioni storiche di vita di quei contadini cui il Pascoli si ispirava.
Insomma, per dirla con Gramsci, per il Toschi il folklore continuava a permanere nell’ambito
del pittoresco o quanto meno, crocianamente, nell’ambito di una psicologia minore e poteva
essere spiegato anche senza tener di conto le condizioni materiali di vita e i rapporti di
produzione nelle campagne.
Negli anni 70-80 del secolo scorso si sono occupati del Pascoli, fra gli altri, Luigi
5 V. Santoli, Cinque canti della Raccolta Barbi, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1938.
6 I due interventi si trovano in Studi per il centenario della nascita di G. Pascoli, pubblicati nel Cinquantenario
della morte (Convegno bolognese 28-30 marzo 1958) «L'Archiginnasio», Bologna 1962, vol. II, Vittorio
Santoli, Pascoli e la poesia popolare, pp. 69-77; Paolo Toschi, Pascoli e le tradizioni popolari, pp. 165-171.
7 Corsivo mio.
4
4
Baldacci e Mario Tropea8.
Il Baldacci, nell'introduzione alla sua scelta di poesie pascoliane, non si occupa,
ovviamente, del folklore in Pascoli, ma ha modo di fare qualche osservazione importante sulla
condizione esistenziale dei lavoratori agricoli. Così, infatti, commenta la seconda parte della
composizione L'Angelus:
Quei duri solchi, quella gente in riga che semina, dicono la fatica del lavoro, dicono anche
l'umiliazione di una fatica alienata (p. XXVII).
E poi ancora, riferendosi a tutto il linguaggio poetico pascoliano, scrive:
...Egli ha capito una cosa: che la poesia dialettale moderna può essere soltanto poesia gergale;
che essa non può ridursi al giochetto di verniciare di dialetto la lingua nazionale, ma che deve
individuare prima di tutto i livelli tecnici, o diciamo culturali-tecnologici, ai quali il dialetto
s'identifica col gergo, cioè con la parola che appartiene a quella e non ad altra cultura.... C'è
un'identificazione totale con un mondo religioso, retto da un sentimento profondo della vita e
della morte. E' il modo più commosso col quale la poesia italiana, da sempre, si è accostata
alla cultura pastorale e contadina. Altri dirà che è un modo paternalistico, pietistico: borghese
(p. XLIII).
A parte le sue conclusioni, su cui si può dissentire, quel che scrive Baldacci è vero: c'è
da parte del Pascoli un'adesione totale al mondo culturale dei contadini di fine Ottocento; ma,
come avrebbe detto successivamente Mario Tropea, i Poemetti e i Nuovi poemetti, pur
costituendo realmente con la loro «struttura volutamente didascalica» una «Erga kai Emérai
circoscritta in Lucchesia, piena di minute descrizioni di lavori domestici e opere campestri»,
finiscono per trasformarsi in una «mistificante rappresentazione ieratica del lavoro contadino»
(p. 28).
La critica letteraria, quindi, si divide sull’ideologia pascoliana: per Baldacci essa è
positiva, per Tropea, invece, la rappresentazione che si dà della società contadina è idealizzata e
forse anche sublimata, quindi falsa. E poi, a proposito della storia di Rosa e Rigo, Tropea
aggiunge che la
dimensione cosmico-domestica informa l’epica rustica di Rigo e Rosa, scandita dentro lo
scenario dei campi e, pur con accentuate tipicità regionalistiche, sullo scorrere del flusso naturale:
si rivedano all’interno i titoli dei cicli dalla Sementa alla Vendemmia, che sottolineano
allusivamente il nascere (L’accestire), manifestarsi (La fiorita), maturare (La mietitura) dell’amore
contadino e il suo frutto presentandosi come storia esemplare e modello irenico della piccola
proprietà contadina composta in momenti idillici sull’esempio della vita da Pascoli condotta a
Castelvecchio e di analogie che egli intravedeva tra l’età augustea di Orazio e Virgilio (i quali nelle
loro opere avevano “abolito” la schiavitù ignorando la parola servus; cfr. Il fanciullino, pag. 26) e
quella tormentata del secolo in cui egli viveva9.
Nella Letteratura Italiana diretta da Alberto Asor Rosa (Einaudi), del Pascoli si presenta
solo la raccolta di Myricae. Il commento è affidato a Stefano Giovanardi10
che, pur non
affrontando l’analisi con l’ottica dell’antropologo, tuttavia dà alcune importanti indicazioni di
lettura; a proposito del linguaggio e dei termini tecnica usati dal Pascoli così scrive:
Nell’uso comune gli oggetti non hanno nome: la loro evidenza fisica annulla
qualsiasi concettualizzazione, qualsiasi possibilità di fruizione estetica. Ma
8 G. Pascoli, Poesie, Scelta dei testi e introduzione di Luigi Baldacci, Note di Maurizio Cucchi, Garzanti ,
Milano 1974; M. Tropea, Giovanni Pascoli, in M. Tropea-G. Savoca, Pascoli Gozzano e i crepuscolari,
Letteratura Italiana, Laterza Bari 1988 (prima ed. 1981), si veda in particolare p. 28.
9 Tropea, 1988, p. 28.
10 S. Giovanardi, Pascoli Myricae, Le opere, vol. III Dall’Ottocento al Novecento, Torino 1995, pp. 1067-1090.
5
5
basta che la poesia li rinomini perché essi si carichino di un investimento
psichico che dall’autore si comunica al lettore e che conferisce in sostanza a
quegli stessi oggetti uno statuto simbolico …
Il lessico contadino, quasi del tutto privo di astrazioni
concettualizzanti e dunque a suo modo vergine di superfetazioni simboliche, si
prestava benissimo alla bisogna; e inoltre si legava al feticcio primario
dell’esistenza di Pascoli, a quell’infanzia felice nella tenuta dei Torlonia, presto
divenuta una sorta di età dell’oro … (p. 1077).
In questo modo si può concludere con lui che “la descrizione della natura agreste e della
vita dei contadini” sono assunte “di norma come mito positivo e salvifico, ma non esenti da
pronunciate inquietudini simboliche” (p.1074).
Nadia Ebani nella sua introduzione ai PP e nelle note di commento11
sorvola su tutta la
questione, privilegiando una lettura molto raffinata e dotta, lontanissima d’altronde dalle
condizioni materiali di vita e culturali della famiglia contadina. Per esempio, nel commento al
componimento Per casa, si sofferma sul fatto che il pane azzimo preparato da Rosa e le erbe
amare cucinate in padella dalla madre, come condimento alla polenta, hanno un loro
riferimento alla Bibbia, in questo caso ai cibi «necessari al passaggio, alla purificazione del
Phase …» (p. 34). Nessun commento sul fatto che polenta ed erbe amare costituissero il cibo
quotidiano dei contadini …
Molto attento alle problematiche esistenziali, filosofiche ed ideologiche del Pascoli è lo
studio di Renato Aymone premesso all’edizione dei Nuovi poemetti della Mondadori12
. Ma il
critico è anche pronto a cogliere alcuni significati antropologici, senza però andare al fondo
della questione, così come si può vedere dal seguente passo:
Un rigido e complesso sistema rituale governa le opere dei Poemetti in relazione alle
vicende stagionali, e regola congiuntamente la vita del singolo all’interno del gruppo
familiare, a seconda del sesso e dell’età, ai diversi lavori campestri e domestici (XXXIV).
E poi ancora:
Nel fitto sistema rituale che scandisce la vita dei campi si inseriscono forme cerimoniali
legate specificamente al passaggio da una fase biografica alla successiva; un passaggio che
implica sempre – come dimostra Van Gennep (Riti di passaggio,Boringhieri, Torino 1981)
– un'alta valenza di carattere sociale (XXXV).
Su questa valenza dei riti di passaggio Aymone torna più volte, come nel caso della
composizione Le armi, oppure a proposito delle vicende della storia d’amore tra Rosa e Rigo, o
a proposito della Morte del papa. Si tratta, tuttavia, soltanto di accenni fugaci alle pratiche
folkloriche, perché la sua analisi è rivolta non al materiale da cui Pascoli traeva spunto, ma agli
esiti poetici, estetici ed ideologici cui il poeta giungeva attraverso la rielaborazione di questo
materiale.
Molto più attenta al mondo popolare è l’analisi condotta sull’opera di G. Pascoli da
parte di Giuseppe Nava, da considerarsi oggi uno dei più informati critici pascoliani.
Nella sua Introduzione ai Canti di Castelvecchio, Nava riconosce questa presenza così
ricca di elementi folklorici. Il suo commento, tuttavia, tende a riportare gli elementi della
cultura contadina dentro gli schemi della classicità (Esiodo, per esempio) e alla sensibilità del
decadentismo:
L’ordine di successione [nelle poesie dei Canti] dell’anno agricolo rientra nella concezione
pascoliana, classica e decadente insieme, dell’eterno rinnovarsi della natura, in cui vita e
11 G. Pascoli, Primi Poemetti, a cura di N. Ebani, Fondazione Pietro Bembo, Ugo Guanda Editore, Parma 1997.
12 Pascoli G., Nuovi poemetti, a cura di Renato Aymone, Mondadori (Oscar classici), Milano 2003, pp. V-LXVIII
6
6
morte succedono ininterrottamente …13
.
In questo caso, usando l'aggettivo “classica”, Nava mette in secondo piano il fatto che la
concezione ciclica del tempo non appartiene al mondo classico solamente, perché essa è durata
per millenni nel mondo contadino ed è viva ancora oggi come senso comune. Probabilmente
per il Pascoli, il fatto che essa sia stata propria anche del mondo antico non fa che nobilitare i
contadini che ancora la mantengono14
.
Nel corso della sua analisi, Nava si sofferma sul recupero che fa il Pascoli di alcune
credenze popolari romagnole, come quella dei sogni e dei segni premonitori (Brivido), dei
banchetti funebri (Tovaglia). A pag 17, si esprime contro il Bonfiglioli (P. Bonfiglioli, Pascoli
e il Novecento, in Palatina, II, 7, luglio settembre 1958) che per l'uso di queste credenze aveva
parlato di “miseria psicologica”15
, mentre, secondo lui, il Pascoli attua “una mediazione” tra le
credenze folkloriche e i miti classici.
Successivamente Nava torna sul rapporto poesia-folkore in Pascoli16, con uno studio che
amplia notevolmente la lista dei fatti folklorici cui il poeta fa riferimento. Egli distingue tra gli
elementi provenienti dal patrimonio popolare della Romagna, rimossi in qualche modo dalla
memoria del poeta da quelli più propriamente toscani e garfagnini che quelli romagnoli fanno
rivivere; collega le citazioni pascoliane con gli studi teorici (Spencer, Sully, Rinach) e con le
raccolte del Tommaseo, del Tigri, del Nerucci, e del Nieri, che il poeta conosceva. Tale attenta
ricognizione gli fa esprimere le seguenti conclusioni:
… nei Canti non ci troviamo di fronte a una raccolta di materiali folclorici sparsi,
utilizzati come occasione di poesia, ma a una vera e propria mentalità, o episteme, che
si struttura in costruzione di testi organici, al di là delle apparenze (come è noto, le
raccolte pascoliane non sono mai dei puri e semplici contenitori di liriche, ma
rispondono a progetti complessi e calcolati)
Ciò significa che il mondo contadino rappresentato dal Pascoli nelle sue poesie ha una
sua organicità, esattamente come organica era la “civiltà” contadina di fine Ottocento, specie
quella dei mezzadri e quella della conduzione diretta della piccola proprietà di montagna.
Quindi le opere pascoliane vanno lette non come un testo in cui ogni tanto compare
qualche intarsio particolare, tratto da una cultura non classica o estranea alla tradizione
letteraria della poesia. Tutto l’impianto è invece, coerentemente con l’ideologia del poeta,
costruito su un progetto ben preciso e sviluppato con contenuti, stilemi e linguaggio tratti dalla
vita reale, per rappresentare il mondo contadino nella sua totalità materiale e culturale; anzi
per ricrearlo e plasmarlo perfetto e privo di imperfezioni e malvagità, in contrapposizione a
quello “imperfetto” della realtà.
3.- «Io amo di essere un contadino».
Descrivendo se stesso, il Pascoli così si rivolgeva a un amico: «Sono grosso e colorito,
ben diverso da ciò che promettevo. Non un indizio esterno ch’io conosca l’alfabeto. Molti si
13 Pascoli, G., Canti di Castelvecchio, introduzione e note di G. Nava, Rizzoli (Biblioteca Universale), Milano
1998, pp. 7-8.
14 In verità, nella nostra vita moderna e nonostante le molte sovrapposizioni culturali, anche feste laiche,
come Capodanno, Carnevale, ecc., quelle religiose, come Natale, Pasqua, San Giovanni, e quasi tutte le feste
patronali hanno a che vedere con il calendario agrario e con la concezione ciclica del tempo.
15 L’espressione è ripresa, con molta probabilità, da E. De Martino che riecheggiava, a sua volta, il giudizio
estetico di Benedetto Croce sulla poesia popolare.
16 Nava, G., Il mondo del folclore nei “Canti di Castelvecchio”, in Nel centenario dei Canti di
Castelvecchio, a cura di Mario Pazzaglia, Patron Editore, Bologna 2005, pp.227-233.
7
7
sono compiaciuti di affermare che sembro un fattore, piuttosto che un poeta … Io amo, in
verità, di essere un contadino, più che un letterato»17
.
Così, nella sua opera, il Pascoli fa del mondo contadino il paradigma della condizione
umana, che gli appare tanto perfetta da volerla fare propria. Qui non è il caso di ripercorrere il
lungo tragitto ideologico che portò il Pascoli dai giovanili aneliti di stampo anarco-socialista
all’accettazione di una concezione imperialistica espressa nel discorso di Barga La grande
proletaria si è mossa. Mi limiterò a ricordare la concezione del mondo che si ricava dalla
lettura del brano “La siepe” (PP), dove c’è l’apologia del piccolo proprietario agricolo o, come
diremmo oggi, del “coltivatore diretto”, tutto teso a proteggere la sua fonte di ricchezza contro
le insidie non solo del ladro “dorme ‘l dì” e del passeggero occasionale, ma soprattutto contro
una società che si avviava, sull’onda del capitalismo, a distruggere le strutture economiche e
sociali d’Italia che per millenni si erano basate sull’agricoltura. C’è una miopia culturale e
politica nel Pascoli che, davanti agli sconvolgimenti che si prospettano, lo fa rifugiare nel
passato, come aveva fatto settant’anni prima il marchese Gino Capponi; ma questi ebbe una
maggiore consapevolezza storica, perché, teorizzando e promuovendo l’irrobustimento di un
istituto semifeudale come la mezzadria, cercava di impedire sia l’avanzata del capitalismo e
con esso dell’industrialismo, sia quella del socialismo18
. Per il Pascoli, che forse vedeva nel
sistema mezzadrile quegli aspetti che rendevano il colono quasi un moderno servo della gleba,
la soluzione politica e sociale è solo nella piccola proprietà che fa del contadino una persona
libera e indipendente.
In Pascoli questa paura del nuovo, dei possibili cambiamenti sociali, è ribadita nel
componimento Nebbia (CC), in cui il fenomeno atmosferico serve al poeta a isolarsi, a tenersi
lontano dal mondo e a tenerlo lontano, dimostrando di avere, oltre al timore delle novità, una
chiusura ideologica ed egoistica nei riguardi del mondo esterno.
Egli vuol sentirsi ed essere contadino, per questo decide di risiedere nel territorio di
Barga, dove può vivere con i contadini, dove può frequentare contadini e fattori19
. Per questo
accetta e fa propria l’ideologia del piccolo proprietario terriero, «libero e sovrano», la quale,
come si può vedere da “La siepe”, non riguarda solo le strutture economiche della società
agraria, ma anche quelle familiari: la moglie fa parte della proprietà, perché l’anello
matrimoniale è come un contratto che “dice mia la donna che fu mia”. Si tratta di un’ideologia
patriarcale in cui il campo, la famiglia e gli animali costituiscono l’esclusiva proprietà
dell’uomo: capo, marito, padrone20
.
Nonostante questa concezione, alquanto gretta in verità, della vita e della società umana,
con il suo sentirsi contadino il Pascoli riesce a dare del mondo della campagna un’immagine
fortemente realistica e in molti casi anche altamente poetica; ma i Primi Poemetti e i Nuovi
poemetti e tutti i numerosi riferimenti ad usi e credenze folkloriche sparsi nelle altre opere, pur
essendo veri, anche nei minimi dettagli, sono sempre funzionali all’estetica e all’ideologia
pascoliane e mai rivolti, come vedremo, ad un’identificazione effettiva delle condizioni storiche
e culturali della società contadina.
17 La frase è riportata, come didascalia al corredo fotografico, sia nel volume Myricae, a cura di P.V. Mengaldo,
Rizzoli (BUR) 1998, p. 106, sia in quello dei Canti di Castelvecchio, a cura di G. Nava, Rizzoli (BUR) 1999, p.
47.
18 G. Capponi, Sui vantaggi e svantaggi sì morali che economici del sistema di mezzeria, in G.A. Bastogi, Una
scritta colonica, Tip. Ricci, Firenze 1903.
19 I suoi rapporti con il mondo contadino non furono tuttavia idilliaci; si veda a proposito Gian Luigi Ruggio,
Giovanni Pascoli. Tutto il racconto della vita tormentata di un grande poeta, Simonelli Editore, Milano 1998,
pp. 211 e seguenti.
20 Tutti i discorsi del capoccia, nella sezione intitolata L’accestire, è connotato, fa notare la Ebani, da un uso
iperbolico del possessivo “mio”; Ebani, cit. p.251.
8
8
4.-Tentativo di lettura antropologica.
4.0 - Premessa
L’analisi che mi propongo di svolgere non si basa soltanto sulle due raccolte
concernenti la famiglia di Rosa (PP e NP), nelle quali con maggiore organicità sono riportate
consuetudini della vita contadina, ma riguarda anche altri componimenti delle raccolte
precedenti e successive in cui sono disseminati molti frammenti della cultura tradizionale
delle campagne romagnole e toscane. Non tutti gli elementi folklorici presenti nelle liriche
saranno esaminati, specie là dove l'analisi antropologica tende a trasformarsi in critica
letteraria. Per esempio, nel Gelsomino notturno troviamo, tra l’altro, due evidenti elementi di
folklore: le Pleiadi, infatti, sono indicate con il nome contadino di Chioccetta21
, e nella prima
strofa è riportata la credenza secondo la quale i morti ritornano, che è patrimonio di tutte le
culture popolari e rientra anche nelle tradizioni religiose di molti popoli; sono due temi che
permettono al poeta di creare immagini del tutto originali. Tuttavia, il componimento non può
essere analizzato secondo l’ottica demoantropologica che finirebbe per impoverirlo.
La mia analisi, comunque, sarà condotta principalmente sui Primi poemetti e sui
Nuovi poemetti, le due opere cui il Pascoli ha affidato la sua rappresentazione del mondo
contadino.
Su queste due opere, tuttavia, occorre fare una precisazione: in esse il Pascoli sviluppa
la storia di una famiglia contadina seguendo le fasi del ciclo dell’anno (i cambiamenti
stagionali della natura, i determinati periodi in cui vanno fatti i lavori dei campi, ecc.)22
e
quelle del ciclo della vita (infanzia, adolescenza, giovinezza, maturità, vecchiaia, morte, a cui
sono accomunati l’ingenua gioia di vivere, l’amore, la saggezza, ecc.; ma anche i cambiamenti
di status, come quello del matrimonio, importante perché occupa la parte centrale del ciclo).
Nei suoi poemetti, però, i due cicli non hanno sviluppo parallelo, perché essi si
intrecciano e si saldano fra di loro, formando, come accade nella vita reale, un unicum
esistenziale inscindibile. La mia analisi avrebbe potuto seguire l’andamento dei due cicli, così
come ha fatto il Pascoli; ma ciò che nella sintesi poetica è chiarissimo, sarebbe diventato
estremamente ingarbugliato e disarticolato nel tentativo di realizzare lo scopo che mi sono
prefisso, cioè di mettere a confronto quanto è espresso nella poesia pascoliana con quello che
risulta dalle indagini storiche e demologiche. Cosicché, per rendere più chiara, anche se più
rudimentale, la mia discussione, raggrupperò e analizzerò i temi di interesse demologico
presenti nelle opere pascoliane in appositi paragrafi.
4.1- Condizioni materiali di vita
Il Pascoli, come si accennava poco sopra, oltre a prendere spunto dalle manifestazioni
dell’espressività tradizionale, pone molta attenzione agli aspetti materiali della vita dei suoi
personaggi, come le condizioni sociali, il lavoro agricolo e quello domestico, l’alimentazione,
ecc., pur se la loro rappresentazione è depurata da qualsiasi problematicità relativa alle
contraddizioni e ai conflitti che in quella società erano ben presenti.
Nel componimento di apertura dei PP, intitolato Alba, è descritta la scena del risveglio delle
due sorelle, Rosa e Viola, che dormono nello stesso letto. Le case contadine non erano molto
grandi e per giunta gli spazi maggiori erano riservate alle stalle e ai locali di deposito dei
prodotti e degli attrezzi di lavoro. Il Pascoli ci parla di una famiglia composta da sei persone, i
21 Si ricordi che nei Malavoglia del Verga la costellazione è indicata con il nome popolare di Puddara (Pollaio).
22 Anche i CC seguono lo svolgimento dell’anno dall’inverno all’autunno e poi ancora dall’inverno alla primavera.
Si veda a proposito il saggio di G. Nava, Il mondo del folclore cit, p.229.
9
9
due coniugi e quattro figli, una famiglia piuttosto piccola se paragonata a quelle polinucleari
mezzadrili e composte da numerosi membri che erano costretti ad abitare in spazi ristretti, in
una situazione di grande promiscuità; cosa che avveniva anche nelle famiglie dei piccoli
coltivatori. Il Pascoli coglie questa situazione, ma senza chiedersi e spiegarcene le cause; anzi,
il fatto che le due sorelle dormano nello stesso letto ci viene presentato come una
manifestazione di affetto e di solidarietà sororale. Al massimo, per la sua osservanza ai principi
piccolo-borghesi del suo tempo, fa dormire le due sorelle in una camera diversa da quella dove
dormono i fratelli Nando e Dore.
Anche nella raccolta CC si trovano riferimenti indiretti alle condizioni di vita delle
campagne di fine Ottocento. Una delle caratteristiche principali della vita campagnola era la
mancanza di circolazione del denaro, tanto che le prestazioni degli artigiani (fabbri, falegnami,
calzolai, ecc.) erano ripagate in natura. Oppure si ricavava un po' di denaro, per le spese più
immediate, come quelle per lo zucchero, il petrolio, il baccalà, ecc., dalla vendita di uova e di
qualche pollo. Il Pascoli conosce questa situazione e la rappresenta, implicitamente, in uno dei
suoi componimenti più famosi: Valentino. Il denaro, infatti, per il vestito nuovo del ragazzino è
ricavato dalla vendita di tutte le uova fornite dalle galline per un intero mese. Era proprio della
massaia l’amministrazione delle risorse domestiche che consistevano, appunto, nella gestione
di un pollaio e nell'allevamento di piccioni e conigli. Molte delle spese spicciole e quelle per il
vestiario non prodotto in casa (il lavoro di filatura della canapa e della sua tessitura occupava le
donne per molte ore delle veglie invernali) erano possibili grazie al pollaio e all’accortezza
economica della massaia. Le scarpe, invece, avevano altra provenienza: al posto della suola si
usava uno zoccolo di legno, ricavato dall’acero campestre, e per tomaia si usava quella ormai
vecchia di scarpe ormai inutilizzabili. Si trattava, però, di calzature usate solo nei mesi
invernali, perché appena arrivava il mese di marzo, tutti camminavano senza scarpe e senza
zoccoli: per marzo, ogni baco va scalzo, recita un proverbio contadino23
; ed infatti Valentino ha
il vestito nuovo, ma continua a portare le scarpe che “mamma” gli “fece”.
Le condizioni materiali di vita dei mezzadri erano soggette alle clausole del contratto
colonico il quale prevedeva che spese e utili fossero suddivisi a metà tra il proprietario (che
metteva il fondo, la casa, le bestie ed i grandi attrezzi) e il mezzadro (che metteva il lavoro suo
e della sua famiglia24
). Alla fine dell'annata i prodotti del podere, quindi, dovevano essere
suddivisi in parti uguali tra proprietario del fondo e famiglia mezzadrile; questa divisione,
tuttavia, era solo teorica perché il patto prevedeva anche una serie di prestazioni lavorative non
remunerate, come la manutenzione delle strade di accesso ai poderi e quella dei fossi per la
regimazione delle acque; prevedeva anche il pagamento di certi “dazi”, come un certo numero
di uova al mese, due galletti per Ferragosto, due capponi per Natale, metà del maiale, a
risarcimento del fatto che gli animali da cortile si erano alimentati con gli scarti dei prodotti del
fondo.
Questi “dazi” o “regalie” sono ricordati in un componimento del Pascoli che, in questo
caso, probabilmente si rifà ad una famiglia mezzadrile della Romagna, dove, diversamente
dalla Garfagnana, la mezzadria era molto diffusa. Si tratta di Primo canto della raccolta CC:
Galletti arguti, gloria dell'aia
che da due mesi v'ospita e pasce,
ora la vostra vecchia massaia,
quando vi sente, pensa alle grasce;
23 Nell’Atlante paremiologico Italiano (a c. di Temistocle Franceschi, in «Studi Urbinati di storia filosofia e
letteratura», Supplemento linguistico n. 3, 1981-1984, Università degli Studi di Urbino, 1985), alla voce
marzo, si trovano altri proverbi con lo stesso significato.
24 La quota messa a disposizione dal proprietario era proporzionale al numero delle braccia presente nella famiglia e
quindi alla quantità di lavoro che questa poteva erogare.
10
10
quando vi sente, pensa ai padroni
il contadino vostro che miete,
e mentre lega mane e covoni …
I galli cantano, ma il contadino e la massaia sanno che quegli animali sono destinati a pagare le
“grasce”, ovvero i dazi, al padrone.
4.3 Lavori stagionali e ciclo dell’anno
Sono molti i componimenti pascoliani in cui si affronta il tema del lavoro, in tutte le
modalità in cui si manifesta: quello dei campi e quello domestico, quello stagionale e quello
quotidiano. Addirittura è contemplato non solo il lavoro umano ma anche quello delle bestie e
quello delle macchine. Gli animali da lavoro compaiono quasi sempre quando la scena si sposta
sui campi, sia se sono protagonisti sia se fanno da comprimari. In MY protagonista assoluto è
una macchina complessa (Il mulino) con tutti i suoi congegni: il componimento dà ragione a
Baldacci quando dice che il poeta ha dovuto appropriarsi di un linguaggio tecnico-culturale per
poter narrare quel mondo anche nei particolari meno significativi. O, addirittura, diventa
protagonista di una canzone la granata (CC), ovverosia l'umile scopa elevata a «emblema ...
d'un esercizio quotidiano di purificazione morale» (Nava)25
.
Il Pascoli predilige, però, i grandi lavori che segnano il passare delle stagioni; in questo
modo può dare ai suoi poemetti la scansione del ciclo dell’anno. I PP, infatti si aprono con l’inizio
dell’annata agraria segnata dalla semina, i NP si chiudono con la vendemmia, che è l’ultimo
grande lavoro dell’anno.
La preparazione della semina del grano è attività essenziale, perché alla produzione di
questo cereale (che si augura se non abbondante, almeno sufficiente) si affida la vita della
famiglia; il tempo della semina, che avviene tra la seconda metà di ottobre ed i primi giorni di
novembre, segna l’inizio dell’anno agrario, è un “capodanno” agricolo. Altri “capodanni” ci sono
nel ciclo annuale, come quelli del periodo solstiziale dell’inverno, che però riguardano l’anno
astronomico, o quelli che capitano durante il passaggio dall’inverno alla primavera (per restare in
Toscana, è il periodo dei Bruscelli, delle Vecchie, delle Maggiolate e dei Maggi drammatici della
Garfagnana) e che riguardano altri momenti cruciali del lavoro e della vita dei campi. Che il
periodo della semina sia considerato come l'inizio di ogni anno agrario è ribadito anche dal fatto
che proprio in quei giorni si stipula il contratto tra proprietario e mezzadro per la nuova annata
agraria; è questo periodo, dunque, quello in cui giuridicamente inizia il rapporto padrone-
mezzadro oppure padrone-affittuario; l'undici di novembre, giorno in cui si festeggia san Martino,
è considerato l’inizio dell'anno tout court. Anche il resto della popolazione contadina, compresi i
piccoli proprietari, condivideva questo calendario. I primi giorni di novembre sono anche quelli in
cui le famiglie contadine, che per vari motivi si spostavano da un podere all'altro26
, operavano il
trasloco: “fare san Martino” è un modo di dire diffuso nel mondo contadino del Centro e del Nord
Italia per indicare il trasferimento da una dimora all'altra.
Ovvio, dunque, che il Pascoli, sentendosi contadino fra i contadini, abbia scelto, tra i tanti
“capodanni” segnati da molti riti antichi, questo caratterizzato da una delle principali attività
agrarie e contrassegnato dalla sottoscrizione, allo “scrittoio” padronale, del rinnovo del contratto
colonico o di quello d'affitto. Il dotto e convincente commento di Nava, sul perché il poeta fa
25 Nava, p. 123; tra l'altro, in nota, Nava ricorda che il bruciamento della scopa fa parte dei riti apotropaici del
carnevale contadino.
26 Per esempio, a causa di una disdetta del contratto o perché il podere era diventato troppo grande per la
diminuzione del numero dei membri della famiglia, o troppo piccolo per il motivo opposto.
11
11
coincidere l’inizio dell’anno col periodo del ritorno dei morti, va pertanto integrato con il fatto
reale che per il mondo contadino l’anno cominciava appena finita la seminagione. Che in quello
stesso periodo la tradizione folklorica fissasse il ritorno dei morti è una coincidenza sentita, molto
probabilmente, più dal Pascoli che dai contadini27
.
A testimoniare il rilievo di questo periodo nel mondo agricolo è il componimento
successivo Nei campi, in cui è espressa la trepidazione del capoccio, il capo di casa, che recita
una frase tradizionale, riferita alla semina del grano, presto è talora, tardi è sempre male, che in
qualche modo riecheggia il proverbio raccolto nella Val di Chiana senese: per san Martino la
sementa del pigherino (cioè del pigro); insomma, tra la fine di ottobre e la prima decade di
novembre, la semina dev’essere già fatta. La stessa trepidazione si trova nel componimento
successivo in cui il capoccia spera che dopo la semina venga la pioggia, senza la quale il grano
non germoglia28
. La pioggia arriva, provvidenzialmente, appunto durante la notte.
I tre componimenti di esordio di questo poemetto sono da mettere a confronto con quelli
che aprono i NP, soprattutto con Accestisce. Mentre, infatti, nei primi vediamo gli uomini
depositare nel grembo della natura i semi che produrranno il nuovo raccolto, negli altri assistiamo
all’inizio dell’idillio tra Rosa e Rigo: in questo modo gli avvenimenti del ciclo dell’anno, che
appartengono a tutta la comunità, si fondono con quelli del ciclo della vita che, invece,
appartengono ai singoli29
. Altro collegamento, secondo me necessario, è da farsi con il
componimento Il seme (NP), in cui si narra di Rosa e Rigo che si accingono a sposarsi. Siamo
un'altra volta all’inizio del nuovo anno: c’è stato di già il raccolto del grano, sono finiti i grandi
lavori stagionali: c’è il tempo, dunque, per preparare questo “passaggio” di status e c’è,
soprattutto, una disponibilità finanziaria, con il grano già immagazzinato e magari già venduto,
che permette di approntare il corredo e tutto quello che occorre per fondare una nuova famiglia.
Intanto, si deve pensare alla scelta delle sementi per la prossima semina e, così, il ciclo dell’anno
di nuovo si salda con quello della vita.
Un altro lavoro stagionale è l'aratura che anticipa di poche settimane la semina; ma
quest'attività si svolge anche per altre coltivazioni che occupano un'estensione non piccola del
fondo. La prima immagine di aratura è già in MY (Arano), nel gruppo intitolato L'ultima
passeggiata, in cui i versi sono modulati sul ritmo lento dei buoi che tirano l'aratro. Altri episodi
di aratura e vangatura si trovano nel componimento Il torcicollo (NP) in cui si descrive la semina
del mais e della canapa. In questo brevissimo poemetto, in cui si parla anche della costruzione di
uno spaventapasseri a difesa dei semi sparsi nei solchi, si può vedere la conflittualità tra
natura/animalità/umanità, vista dal Pascoli come un intreccio inscindibile che caratterizza
l'esistenza universale.
La vigna, più di ogni altra coltura, esige cure assidue; tra queste c’è la potatura delle viti,
uno dei lavori paragonabile per importanza alla semina del grano. Occorre una certa sapienza nel
sapere quali tralci tagliare e quali lasciare per la produzione. Nel mondo contadino questa attività
è riservata agli uomini, mentre le donne ne svolgono una più modesta, quella di raccogliere i tralci
in fascine che serviranno per cuocere il pane nel forno. Nel componimento Il cuculo vediamo
Rigo che pota la vigna e lega le viti; dietro di lui, Rosa e Viola raccattano i tralci tagliati. Il grano
è già avanti e le viti hanno ormai qualche gemma: occorre sbrigarsi, prima che arrivi il cuculo che
conferma col suo canto che si è già in piena primavera. E difatti, non appena Rigo ha finito di
potare l’ultimo filare e Rosa e Viola hanno raccolto l’ultimo fastello, ecco che si sente risuonare il
verso del cuculo. E’ il momento in cui arrivano i genitori di Rosa e suo fratello Dore: il gruppo,
con Rigo, prefigura la nuova famiglia che da lì a poco si formerà. Ancora una volta ciclo della
natura (con la potatura e la legatura delle viti avvenute durante la luna “buona”) e ciclo della vita
27 G. Nava, Il mondo del folclore nei “Canti di Castelvecchio”, p. 230.
28 “Semente in terra – e speranza in cielo”, recita un altro proverbio contadino: T. Franceschi, cit, 8.5.6.8.
29 Ancora un altro accostamento tra ciclo dell’anno e ciclo della vita: nella notte in cui arriva la pioggia che farà
germogliare il grano, Rosa ripensa al racconto di Rigo e sogna il suo futuro di sposa.
12
12
(il fidanzamento di Rosa e Rigo, con gli auspici dell’imminente primavera), collimano.
Il lavoro della mietitura s’intreccia con l’ultima fase dell’allevamento dei bachi da seta e
con i preparativi per le nozze di Rosa (NP, I Filugelli). Sono, quelli della mietitura e della
trebbiatura, lavori molto massacranti che si svolgono tra giugno e luglio, dalle primissime ore del
mattino fino a tarda sera, con un intervallo nelle ore più calde del giorno. Le attività sono febbrili,
sia nel campo dove operano i falciatori e quelli che raccolgono i fasci di grano in mannelle e
predispongono il trasporto del raccolto nell’aia; sia sull’aia dove si batte il grano e si insacca e
s’innalza lo stollo (un palo lungo) intorno al quale costruire il pagliaio30
; sia in casa, dove la
massaia e le donne più esperte cuociono e preparano i cibi che in quei giorni devono essere
abbondanti e molto calorici, mentre le ragazze fanno la spola tra la cucina e il campo di lavoro
cariche di brocche d’acqua e fiaschi di vino. Durante la mietitura e la trebbiatura, lavori che
esigono molte braccia, molte energie e tempi stretti, era consuetudine tra i contadini aiutarsi
reciprocamente: per questo ogni famiglia ospitante cercava di non far cattive figure offrendo agli
ospiti pietanze numerose e abbondanti, immolando per l’occasione buona parte di quello che il
cortile e l’orto offrivano. Si può dire che i pranzi e le cene consumati durante questi lavori
possono essere paragonati, per l’abbondanza dell’offerta, ai banchetti nuziali dove la quantità del
cibo è ben augurale e funzionale alla ritualità della festa.
Ma di tutto questo nei versi del Pascoli non c’è traccia, intento com’è a creare il consueto
parallelismo tra i cicli naturali e le vicende personali di Rosa. Al massimo c’è una ricerca costante
e meticolosa nell’uso di una terminologia tecnica tratta dal dialetto toscano o dall’italiano
arcaico31
.
La vendemmia è l’ultimo lavoro stagionale dell’anno, con la raccolta dell’uva che desta
tanta allegria. E difatti tra le vigne si inseguono gli stornelli: ne sono riportati ben quattro che si
alternano alla descrizione del lavoro; e, mentre cantano, le ragazze colgono i grappoli recidendoli
con le piccole ugne esperte …
al nodo che si trova – a mezzo il gambo32 .
E’ un affresco piuttosto vivace e lieto quello che dipinge il Pascoli, ma il poemetto, nella seconda
parte, affronta la vicenda triste della morte del primo figlio di Rosa. L’esaltazione gioiosa della
vita è sempre accompagnata nel poeta dal sentimento della fine; un tema questo che percorre tutta
la sua opera e che impregna tutta la sua concezione dell’esistenza: nascita e morte si alternano
nelle vicende umane e così, mentre piange il suo bambino morto, Rosa avverte che nel suo grembo
è in gestazione un’altra vita.
4.3.1 Lavori femminili
Al lavoro femminile il Pascoli dedica molti componimenti33
forse più di quanti ne dedichi
a quello maschile. La ragione di questa discrepanza può dipendere dal fatto che il mondo
femminile e quello domestico in generale erano più congeniali alla sensibilità del poeta, ma
oggettivamente il lavoro delle donne era quantitativamente maggiore di quello degli uomini. Le
30 Si veda Paese notturno, in MY, Tristezze.
31 Maliziosamente si può qui ipotizzare che il silenzio del poeta sulla trebbiatura fu dettato, per una specie di
ritorsione inconscia, dal litigio che vide protagonisti il Pascoli e i suoi vicini di casa: costoro effettuavano la
trebbiatura, con fastidiosi rumori e schiamazzi, proprio nell’aia su cui si affacciava il balcone del poeta. Si veda
Ruggio, cit.
32 La vendemmia, Canto I, II, vv. 19-21. E’ il realismo di questi particolari che contrasta con l’idealizzazione che il
poeta fa del mondo contadino.
33 Oltre a quelli dei PP e dei NP che riguardano Rosa, Viola e la loro madre, anche MY e CC contengono
componimenti dedicati al lavoro femminile, come, per es., La cucitrice, Ida e Maria, Notte, Lavandare (MY);
La figlia maggiore, La tessitrice (CC).
13
13
donne, infatti, oltre ai lavori domestici (allevamento dei figli, pulizia della casa, preparazione dei
cibi, bucato), cui gli uomini non partecipavano se non in casi eccezionali, aiutavano anche nei
lavori agricoli meno impegnativi e poi la sera, mentre gli uomini giocavano a carte o
chiacchieravano, esse erano dedite alla filatura della canapa e alla tessitura, ai lavori di rammendo
e di cucitura del vestiario.
Abbiamo già visto, in alcuni componimenti concernenti i lavori stagionali, le donne intente
ai lavori campestri che loro competevano; ma è soprattutto sul lavoro casalingo che si appunta
l’attenzione del Pascoli, sia nelle prime raccolte, con riferimenti più o meno brevi, sia soprattutto
nei PP e nei NP dove le attività femminili sono trattate in poemetti piuttosto estesi, come Il bucato
e I filugelli.
In MY abbiamo già una prima scena di donne che lavorano (Galline):
Cantano a sera intorno a lei stornelli
le fiorenti ragazze occhi pensosi
mentre il granturco sfogliano, e i monelli
ruzzano nei cartocci strepitosi.
Si tratta di una scena realistica, anche se nei versi pascoliani essa risulta idealizzata
calligrafica e manieristica. Era proprio delle serate di fine estate, calato il fresco, stare sull’aia a
separare i tutoli dalle foglie, per avere il mais pronto da macinare per la polenta o da sgranare per i
polli. Qui siamo davanti ad uno di quei componimenti per i quali il Santoli parlò di “intarsio” e di
“alessandrinismo” e in cui i contadini sono ritratti in atteggiamenti idillici, purificati dalla loro
corporeità e senza nessuna connotazione storica34
.
E’ nei PP che il poeta affronta con maggiore continuità e con maggiore realismo le varie
attività femminili. Il terzo componimento della raccolta, Per casa, si apre con il fruscio della
scopa che percorre la cucina: è il primo lavoro di ogni giornata che si svolge non appena sono
state aperte le finestre. Gli uomini sono già al lavoro, a seminare, le donne accudiscono alle
faccende domestiche, in rapida successione. Non appena la casa è spazzata ecco che Rosa si mette
al telaio, mentre Viola esce a far pascolare le mucche. Il lavoro al telaio è accompagnato dal canto
di Rosa che ripete alcuni versi della Passione di Cristo, un testo probabilmente ripreso da una
Sacra rappresentazione garfagnina35
. Qualche tempo dopo, la madre la chiama per farsi aiutare a
preparare la desina, il pranzo per i seminatori. Rosa, quindi, staccia la farina, impasta il pane, lo
cuoce (Il desinare). Poi, mentre Rosa cuoce la polenta, la madre appronta il condimento: nella
padella infuocata versa un po’ d’olio, aggiunge qualche spicchio d’aglio e delle erbe campestri. La
sagacia e l’esperienza della massaia riescono a rendere appetibile la povera polenta solo con un
po’ di olio soffritto ed aromatizzato e qualche erba spontanea. Il pranzo è pronto; torna Viola e
tutte e tre le donne vanno a trovare i loro uomini occupati nella semina, portando loro il pasto.
In questi primi poemetti è descritta una normale giornata di lavoro di una famiglia
contadina. Si tratta di una descrizione paradigmatica, perché per tutto l’anno le giornate saranno
eguali e perché non ci sarà nessuna pausa, tranne forse quella delle giornate invernali. Le quali,
tuttavia, non saranno di riposo assoluto, perché le donne continueranno ad eseguire i lavori
domestici e gli uomini avranno da fare sempre qualcosa nella stalla o avranno da riparare attrezzi
di lavoro o piccoli oggetti casalinghi. Il Pascoli su queste attività prolungate e ripetitive non dà
nessun giudizio, non le colloca nel contesto più ampio della condizione contadina, ma le accetta
incondizionatamente e le fa accettare ai suoi personaggi come qualcosa cui non ci si può sottrarre.
34 Il calligrafismo e l’alessandrinismo sono accentuati dal costrutto alla greca di “ragazze occhi pensosi” e
dall’aggettivo “strepitosi” usato nel suo significato etimologico.
35 In tutta la Valle del Serchio e nelle zone limitrofe la tradizione del teatro popolare, che contempla, oltre alla Sacra
rappresentazione anche il Maggio drammatico ed altre forme di spettacolo, è molto radicata e diffusa anche oggi.
Il Pascoli, tuttavia, ne accenna brevemente, e senza indicazioni di sorta, solo in questo componimento.
14
14
Allo stesso modo accetta l’inferiorità e la subalternità delle donne in seno alla famiglia contadina,
nella quale solo gli uomini hanno la prerogativa di dirigere tutta l’attività economica del fondo e di
svolgere quei lavori in cui il ruolo del sapere e della decisione è prettamente maschile, come la
semina, la potatura delle viti e la cura degli animali da lavoro; mentre alle donne sono riservate le
mansioni più banali e meno gratificanti, come portare da mangiare e da bere agli uomini, oppure si
affidano a loro i lavori agricoli più marginali come raccogliere i tralci potati dall’uomo. Il Pascoli
è consapevole di questa subalternità delle donne contadine e del loro faticoso lavoro, ma non
riesce ad andare al di là di un sentimento di compassione, come quello che mette in bocca a Rigo
(NP: La lodola, II):
Voi fate troppo, autunno verno estate.
Rosa, se non lavate, voi stendete!
Rosa, se non tessete, voi filate!
Per voi non c’è momento di quïete.
Tutto tenete lindo netto asciutto,
lustrate ogni solaio, ogni parete.
Parete un uccelletto, biondo, sdutto,
snello, che cala becca salta frulla
in un minuto. E sola fate il tutto!
Tra i lavori casalinghi uno dei più importanti e dei più complessi, per il sapere tecnico che
presupponeva e per la lunga procedura, era il bucato. Ad esso si dedicava periodicamente una
giornata apposita, perché occorreva scaldare abbondante acqua nel paiolo appeso al focolare,
preparare la conca (o bucatoio), un orcio di grandi dimensioni munito di un foro in basso, per lo
scarico dell’acqua. Dentro questo vaso si metteva la biancheria, si copriva il tutto con il
ceneraccio, un panno grosso di canapa, su cui si poneva della cenere fornita dalla brace del
focolare; su questa cenere si versava l’acqua bollente che, filtrando, ne assorbiva la potassa
necessaria a sgrassare e togliere lo sporco della biancheria. L’operazione si svolgeva più volte,
fino a che i panni non diventavano bianchi; dopo di che, sciacquati in acqua fresca e strizzati, essi
erano sciorinati sui cespugli intorno casa36
.
Il Pascoli a questa operazione dedica un intero poemetto (L’accestire, PP), suddiviso in
più parti, non dimenticando di appaiare alla descrizione dei procedimenti le vicende iniziali
dell’amore tra Rosa e Rigo. Anche qui notiamo l’accuratezza della terminologia e delle varie fasi
del lavoro, dalla raccolta delle foglie di alloro per profumare l’acqua di lavaggio fino alla stesura
della biancheria al sole. Ma l’operazione del bucato serve al Pascoli anche per raccontare la storia
dei panni: essi sono stati tessuti con la canapa che produce il podere ed è sulla coltivazione di
questa utile pianta che si sofferma il poeta (La canzone del bucato) e poi sulla sua lavorazione, la
sua tessitura, lavori del tutto femminili, fino a tornare di nuovo al luogo in cui la pianta cresce, il
canapaio.
Anche l’allevamento del baco da seta aveva un’enorme importanza nell’economia di una
famiglia contadina, perché integrava le scarse entrate del podere; si trattava di una attività
piuttosto rilevante dal punto di vista del tempo e delle energie occupate, che era svolta dalle
donne. E difatti, nel poemetto I filugelli, è Rosa, la maggiore delle figlie e già in età da marito,
che cura l’allevamento di questo animale. Tutti i procedimenti, dalla nascita dei bachi alla loro
trasformazione in bozzoli, dalla loro alimentazione alla produzione della seta, sono
accuratamente seguiti dal poeta, ma il suo scopo è quello di seguire Rosa (non senza qualche
atteggiamento da voyeur) in queste attività insieme con quello di usare nella descrizione una
terminologia puntuale (dialettale, ovviamente) e scientificamente corretta; dell’importanza
36 Si vedano i primi versi de La bollitura, PP.
15
15
economica dell’allevamento del baco da seta in una comunità, familiare o sociale, che si basava
sull’autosufficienza alimentare, ai limiti di una pura sussistenza, dell’esito commerciale del
prodotto, dell’eventuale rapporto con qualche socio esterno al mondo agricolo, nei versi del
Pascoli non c’è nessuna traccia37
.
4.3.2 - Lavori di bambini
Nelle interviste della fine degli anni ’70 del secolo scorso, molti ex-mezzadri riferivano
che il padrone o il fattore consigliavano ai capi di casa di non mandare a scuola i figli, ma di
mandarli a lavorare, magari a pascolare le pecore e i maiali, perché così avrebbero guadagnato
qualche soldo in più. Questo accadeva nelle famiglie mezzadrili, di cui il Pascoli non si occupa,
ma molti sono i bambini e i ragazzi rappresentati nella sua poesia mentre sono occupati in
qualche attività più o meno faticosa; tra di loro i fratelli minori di Rosa. Dobbiamo dedurre,
allora, che le condizioni di vita e di lavoro dei figli dei contadini piccoli proprietari erano
identiche a quelle dei figli dei mezzadri. E difatti i fanciulli che appaiono nei versi pascoliani
molto spesso lavorano e raramente si vedono giocare (come in Galline, MY), oppure godere di
un giorno di festa (Valentino); il più piccolo, Dore, ha il privilegio di essere scelto per
rappresentare simbolicamente la primavera:
Poi, nella selva, coi capelli al vento
Lungo il ruscello, il fanciulletto Dore
Col flauto verde annunzïò l’avvento
Dei fiori brevi e dell’eterno amore. (da Il pittiere, NP)
E poi ancora:
E passò l’acqua e risalì sul colle:
per tutti i poggi il sufolo selvaggio
schiudeva i bocci, apriva le corolle … (da Il solitario, NP)
Anche Viola lavora: già all’inizio dei PP la madre, rivolgendosi a Rosa, ci informa che
Viola è fuori con la mucca, via - per Ginestrelle, (Per casa); e poi la vediamo guardare le
mucche seduta all’ombra di un castagno, mentre si dedica ad altri lavori femminili, col
gomitolo, i ferri e un calzerotto (Il vecchio castagno). Portare al pascolo gli animali e lavorare a
maglia sono, quindi, i lavori assegnati alle ragazze. Alcuni lavori, invece, svolti dai ragazzi
sono elencati nel poemetto La morte del papa (parte VI), quando la bisnonna, rivolgendosi al
nipotino, dice che egli è pronto ad aiutare in tutti i lavori e
che va colle sue genti alle faccende,
anco alla ruspa dopo fatto appieno;
e ch’abbada alle pecore, e contende
se vanno a danno e poi che fa in Corsona
le vetrici e le monda e le rivende.
Bambini che lavorano sono presenti anche nei CC, come ne Il ritorno delle bestie, in cui
un fanciullo guida tre mucche verso la stalla, mentre la notte avvolge tutto nel silenzio e nelle
tenebre. Questa realtà infantile è vista dal Pascoli con grande realismo e anche con un
37 Questo silenzio è, comunque, comprensibile, perché una volta scelto di ritagliare un’immagine ideale della
famiglia contadina, il contorno è totalmente rimosso.
16
16
atteggiamento di profonda pietà e solidarietà; ma, nonostante ciò, accetta quella condizione di
sfruttamento minorile come un destino cui non ci si può sottrarre, come una condanna
esistenziale che riguarda anche il mondo infantile e adolescenziale.
4.4. – Gli attrezzi di lavoro.
Nessun lavoro può essere svolto senza l’aiuto di attrezzi adeguati. Nella realtà storica i
contadini trovavano nel podere, in dotazione, gli arnesi più importanti, poi acquistavano gli altri
nelle fiere periodiche dove accorrevano artigiani di ogni specie. In paese, invece, c’era il fabbro
che provvedeva, oltre a fornire attrezzi nuovi, a riparare quelli che l’uso aveva consunto o
deformato.
Quasi a conclusione dei PP il Pascoli inserisce un poemetto dal titolo Le armi, che gli
offre l’opportunità di descrivere la fucina del fabbro vista in piena attività e, lungo il viaggio di
Nando da casa all’officina, di illustrarci le varie coltivazioni di quella zona e le diverse attività
lavorative di quella stagione. Segue poi un’accurata descrizione degli attrezzi e delle loro
funzioni. Anche qui si nota la precisa terminologia degli arnesi e del loro uso. Il tutto compreso
nell’atmosfera del rito: difatti, come ha osservato Aymone, nel momento in cui Nando si accinge
a tornare a casa e si carica gli attrezzi sulle spalle, è come se ricevesse un’investitura. Da quel
momento egli è considerato uomo fatto, è inserito nella società degli adulti, è pronto ad usare le
sue “armi” non per una guerra, ma per un «lavoro pacifico dei campi»38
.
4.5.- Alimentazione
4.5.1 – Cibo quotidiano
Spesso, nell’illustrare la vita quotidiana della “sua” famiglia e quella di altri personaggi, il
Pascoli ha modo di accennare ai cibi consumati durante i pasti. Abbiamo visto, nel poemetto
riguardante la semina, le donne preparare il pranzo da portare sul campo ai seminatori. Un pranzo
poverissimo, fatto di pane azzimo, di polenta condita con erbe spontanee soffritte. La letteratura
agraria ottocentesca ci parla di mezzadri sobri nel mangiare e nel vestire, ma spiega questa
sobrietà come una virtù propria delle genti di campagna39
; la realtà storica, però, è molto diversa
da quella rappresentata da parte di chi voleva idealizzare la figura dei contadini e nascondere
dietro una bugia una verità piuttosto dura. C’erano sì, nelle zone pianeggianti, dei poderi che
rendevano molto e che permettevano alle famiglie coloniche un’esistenza non grama; ma la
maggior parte degli abitanti delle campagne, specie quelli delle zone disagiate e di quelle
montane, come erano quelle barghigiana e garfagnina, spesso soffriva la fame e generalmente si
nutriva di cibi poveri di proteine e di zuccheri. Nelle zone appenniniche del pistoiese e del
lucchese era diffuso un proverbio che indicava, metaforicamente e poeticamente, il cibo
quotidiano di quelle genti: pan di legno e vin di nugoli, ovverosia castagne ed acqua. Gli animali
da cortile, abbiamo visto nel brano di Valentino, servivano ad acquistare capi di vestiario e stoffe,
ma soprattutto a comprare il sale40
, il baccalà, i salacchini (pesce, come le alose e gli agoni,
conservati sotto sale), refe ed aghi per il rammendo, candele per l’illuminazione ecc.. . Era raro
pertanto che qualche pollo o qualche coniglio finissero sulla tavola, tranne nei giorni della
38 Ebani, cit, p. 385.
39 Si Veda per esempio J. C. De’ Sismondi, Della condizione degli agricoltori in Toscana, in Biblioteca
dell’economista, vol. II, Torino 1860, p. 555.
40 Si veda La morte del papa, parte V: Con l’ova abbiamo da comprare il sale.
17
17
trebbiatura. Ancor più raro il consumo di carne bovina, limitato comunque ad un po’ di lesso.
Nell’episodio narrato in Per casa abbiamo visto che genere di pranzo è approntato per i
seminatori che stanno nel campo fin dalle prime luci dell’alba: esso, certamente, ha un numero di
calorie inferiore a quello del fabbisogno di chi lavora la terra, ma ci pensa la massaia a rinforzare
il cibo spillando del vino buono (Il desinare, str. III):
Ma la pia madre altro pensò; discese;
spillò la botte d’un segreto vino.
In genere la bevanda quotidiana era l’acquarello, un vinello ottenuto aggiungendo acqua alle
vinacce già spremute, o il vino andato a male. Quando però si svolgevano dei lavori pesanti, allora
si distribuiva del vino buono messo da parte per l’occasione. E così era possibile raggiungere in
parte le calorie necessarie a sopperire al dispendio delle energie.
A proposito del cibo quotidiano, il Pascoli, sempre nel componimento Il desinare (PP), si
sofferma a descrivere, quasi con tecnica cinematografica, tutte le operazioni necessarie alla
preparazione della polenta e del condimento relativo.
Altri accenni sui cibi di ogni giorno troviamo nel poemetto La morte del papa; in questo caso
si tratta del ricotto, cioè latte cotto fino a farlo diventare cremoso e tale da poterlo trasportare in
una specie di cartoccio di foglie fresche di faggio.
Alla pianta del castagno, fornitore di cibo per tutti i giorni (dalle ballotte alla polenta, dal
castagnaccio ai necci), oltre che di legna per cucinare e riscaldarsi, sono dedicati due poemetti uno
in MY e l’altro, Il vecchio castagno, nei PP.
4.5.2 Cibo festivo
In tutta l’opera poetica pascoliana non ci sono mai scene di pranzi festivi, tranne una che si
trova nei Canti di Castelvecchio, La canzone del girarrosto. Ma qui l’ambiente non è contadino,
anche se la cucina, in cui si svolge la scena, rimanda ad un luogo campagnolo e probabilmente è
quella di casa Pascoli. E’ di domenica e in casa si prepara la pasta al sugo (la bionda matassa di
pasta) e l’agnello allo spiedo: è difficile che in casa di contadini, anche se allevavano un piccolo
gregge, la domenica si mangiasse l’agnello.
Poi ci sono, qua e là, riferimenti alle festività religiose41
, con qualche accenno a quelle
agrarie di primavera. Nel mondo contadino toscano le feste religiose non avevano un grande
rilievo, a parte la Pasqua, sentita come festa della primavera e del rinnovamento e celebrata il
lunedì dell’Angelo con una colazione piuttosto abbondante in cui si consumavano le uova sode,
benedette in chiesa, la torta salata cosiddetta di Pasqua e il capocollo. Le feste più sentite erano
quelle che avvenivano alla fine dei grandi lavori, come la trebbiatura, che si celebravano con la
benfinita, e i passaggi di status come il matrimonio. Al banchetto di nozze partecipavano parenti,
vicini di casa, amici in genere; esso era costituito da molte portate e da abbondanti piatti. Tra
l’altro, in molte zone il banchetto di nozze era duplicato: prima i convitati mangiavano a casa della
sposa e immediatamente dopo a casa dello sposo, sempre con lo stesso menu.
La mancanza dei momenti festivi nella rappresentazione pascoliana del mondo contadino
rappresenta ovviamente una scelta del poeta, che voleva una società sobria, dedita al lavoro e alla
famiglia, non distratta da situazioni che potevano traviarla; in questo senso il suo modo di vedere
il mondo contadino collima con quello del Sismondi e di coloro che per tutto l’Ottocento avevano
scambiato la povertà e a volte la miseria della vita dei contadini e soprattutto dei mezzadri come
una virtù da elogiare e custodire42
. Tra l’altro, in E lavoro (da La mietitura, NP) parlando del
41 In MY, (Festa lontana) si parla di una festa, di cui si sentono i rumori, gli scampanii e gli spari dei mortaretti,
ma i protagonisti della composizione possono solo immaginare l’evento e non viverlo.
42 Si veda la precedente nota in cui è citato il de Sismondi.
18
18
grano che cresce anche in terreni poveri e senza concimazione, al Pascoli sfugge un’affermazione
espressa come verità assoluta e non riferita soltanto al grano:
… Per tenere il capo ritto
giova la cara buona povertà.
Ora sembra ovvio che i proprietari terrieri e i loro intellettuali scrivessero certe cose,
nascondendo la realtà, ma il fatto che il Pascoli, pur di idealizzare la figura del contadino
proposta come modello di vita universale, abbia trascurato questo aspetto della condizione
campagnola appare contraddittorio con la sua descrizione del mondo agricolo così precisa e
veristica da rasentare a volte la pignoleria.
5.- La religiosità
Nei PP ricorrono due preghiere, tutte e due nella stessa giornata e a conclusione di un
lavoro molto importante come quello della semina: l’Angelus, a mezzogiorno, quando le tre
donne raggiungono i loro uomini nel campo, per portar loro il pranzo, e l‘Ave Maria, alla fine
della giornata lavorativa.
Gli studi sulla mezzadria e le inchieste sul campo degli anni 1970/80 evidenziano una
mancanza di religiosità di tipo cattolico: in grande maggioranza i contadini erano indifferenti ai
dettami della Chiesa e se la domenica frequentavano la Messa, se mandavano i loro figli alla
dottrina e se li facevano battezzare e cresimare era perché così imponeva il contratto colonico,
che in alcuni casi prevedeva delle sanzioni per chi si fosse sottratto a questi obblighi. Il Pascoli
era certamente consapevole di questa situazione tanto da non affrontare mai il tema della fede,
pur se diverse volte parla di suore, di santuari, di comportamenti religiosi (preghiere, segni di
croce, ecc.) dei personaggi che compaiono nei suoi versi. Anche l’immagine dell’Aldilà, per
esempio nel poemetto La morte del papa, è descritto così come lo immaginano i semplici che
hanno imparato a conoscerlo attraverso gli affreschi e le tele che si trovano nelle chiese, o, più
probabilmente, come viene rappresentato nelle immaginette della devozione popolare. Il
cattolicesimo, dunque, come religione “primitiva”, naturale e spontanea, in cui più che la fede
sono importanti le pratiche: la preghiera al momento opportuno, e gli eventi cruciali della vita,
come nascita, matrimonio e morte, suggellati dai riti celebrati in chiesa.
In questo modo la preghiera di mezzogiorno e quella della sera non appartengono alla
fede, a determinate credenze metafisiche; esse, oltre ad invocare la protezione sul grano che è
sepolto nei solchi, ed essere quindi formule apotropaiche, esprimono insieme la serenità di
coloro che chiudono la giornata di lavoro, consci di aver svolto il proprio dovere e avendo la
speranza di un buon raccolto.
6.- Il tempo, la natura e l’uomo
6.1 La scansione del tempo
L’intreccio fra ciclo dell’anno e ciclo della vita si fa molto più stretto nei NP, tanto che
la scansione del tempo e il racconto delle vicende di Rosa e Rigo si saldano fortemente. La
raccolta, infatti, si apre con nove componimenti raggruppati sotto il titolo La fiorita, in cui si
parla dell’arrivo della primavera e si raccontano le prime fasi dell’amore dei due giovani. I
componimenti sono a loro volta intitolati a volatili la cui comparsa nelle campagne coincide
con determinati periodi stagionali e determinati lavori agricoli43
. Si parte dal pettirosso (Il
43 Sul simbolismo degli uccelli in Pascoli si veda Nava, Introduzione a G. Pascoli, Canti, cit, p. 18, che a sua volta
19
19
pittiere), uccello tipico dell’inverno, il periodo in cui comincia la conoscenza tra i due giovani,
e si finisce, a primavera inoltrata, con il canto dell’usignolo che contrappunta la dichiarazione
d’amore di Rigo a Rosa.
C’è in questo intreccio dei due cicli la concezione pascoliana dell’uomo, (qui
rappresentato ovviamente dal contadino), la cui vita non può che seguire quella della natura,
perché ne è parte integrante, non solo nello scorrere delle stagioni e del tempo, ma anche nella
sua evoluzione biologica. Giuseppe Nava, a proposito della lingua pascoliana, dà al concetto di
“parola propria”, come inteso dal poeta, «una valenza magica», di una
magia come mentalità antropologica, secondo la ben nota definizione di Mauss, che
sente l’uomo indiviso dal mondo circostante, vegetale ed animale, da esso agito e su
di esso agente, in una trama di corrispondenze e relazioni empatiche od ostili44
.
Così ne La rondine l’arrivo della primavera astronomica coincide con il rinascere della
natura e lo sbocciare del sentimento amoroso tra i due giovani (L’albero ha il fiore, la rondine il
nido); alla rondine è associata l’immagine di Rosa che con Rigo darà vita ad una nuova
creatura. La primavera, i fiori (con il gioco dei nomi Rosa/rosa), e il bambino che nascerà
richiamano l’atmosfera delle cerimonie primaverili, come quella della Maggiolata, molto
diffusa in Toscana.
Ancora altri esempi possiamo trovare su questo rapporto inscindibile tra “natura – uomo
– animali”: ne abbiamo visto già uno leggendo la poesia Il torcicollo (NP); un altro riguarda il
brano Accestire, sempre compreso nei NP, in cui c’è un parallelo preciso tra la natura che si
prepara alla riproduzione del grano e l’innamoramento di Rosa e Rigo: ed identico è il processo
tra l’accestire del grano sottoterra e il formarsi della creatura nel grembo di Rosa.
6.2 La natura e l’uomo
Questo intreccio determina altresì una concezione dell’uomo molto diversa da quella che
l’antropologia, l’antica e la moderna, ci ha fatto conoscere: quella che vede l’essere umano
composto da due elementi, la natura e la cultura, che convivono, per dirla hegelianamente, in una
situazione di eterna dialettica. Nel Pascoli, però, questa dialettica non c’è, come si può vedere dal
Valentino dei CC, in cui nemmeno il vestito nuovo riesce ad allontanare il fanciullo dalla sua
“naturalità”, tanto che alla fine il poeta può paragonarlo a
l’uccello venuto dal mare,
che tra il ciliegio salta, e non sa
ch’oltre il beccare, il cantare e l’amare
ci sia qualch’altra felicità.45
Lo stesso Dore solo in alcuni momenti sembra appartenere al mondo umano, come
quando reca il mazzetto di alloro alla sorella Rosa, perché lo metta nell’acqua del bucato (PP,
L’alloro), per il resto, egli, come simbolo della primavera che ritorna, passa col suo zufolo da
un componimento all’altro, come una divinità mitologica, per segnare i vari momenti della
bella stagione. E pare di ritrovare in lui una qualche suggestione del Vico che vedeva nella
richiama un’osservazione di G. Barberi Squarotti.
44 G. Nava, Riflessione linguistica e studio del folklore in Pascoli, in La ricerca di Gastone Venturelli, «Lares»,
LXX, n. 2-3, maggio-Dicembre 2004, p. 389.
45 Anche per Giorgio Barberi Squarotti Valentino è la rappresentazione di uno stato di innocenza, pur se contaminato
dalla sua appartenenza all’umanità; egli sarebbe il simbolo della “condizione evangelica della natura”
(Interpretazioni della simbologia pascoliana in Simboli e strutture della poesia del Pascoli, D’Anna, Messina-
Firenze 1966, p. 25 e p. 31). La stessa Rosa, come abbiamo visto più sopra, è accostata alla rondine prima e poi
all’uccelletto che cala becca salta frulla.
20
20
fanciullezza dell’uomo quella dell’anno e quella del mondo.
In conclusione si può dire che nella concezione pascoliana c’è identità tra natura e
cultura perché tutte le attività umane, compreso il lavoro, sono viste come fatti naturali e non
culturali. Non solo tutti i processi di nascita crescita e morte dell’uomo appartengono alle
vicende naturali, ma anche i saperi del contadino, come arare, seminare, raccogliere, e le
capacità di utilizzare determinati attrezzi, e gli stornelli, i proverbi, di cui il poeta fa largo uso
nel comporre le sue opere, sono visti come aspetti della natura e dunque non costituiscono
“cultura” e non entrano in conflitto con i processi e gli eventi della natura. Il contadino, e
pertanto anche l’uomo, nella visione del mondo pascoliana è assimilato totalmente alla terra e
per questo le sue azioni, le sue attività e i suoi modi di esprimersi collimano con le vicende
astronomiche e con quelle degli animali che popolano la terra, soprattutto gli uccelli.
E’ sottinteso il pensiero del Pascoli, ma altrettanto evidente: per lui la cultura, e cioè la
dottrina che si impara sui libri, ci separa ed allontana dalla natura, per questo il poeta desidera
essere un contadino piuttosto che un letterato; al massimo la dottrina può servire per capire la
condizione fragile e misera dell’uomo rispetto all’universo, mentre la poesia si riduce a
risarcimento o a mera consolazione per questa miseria e questa fragilità esistenziale.
6.3 La diversità
Con la composizione Il cacciatore (PP) entra in scena Rigo, il futuro consorte di Rosa. Il
capoccio lo presenta come giovine assennato e figlio di un onesto uomo: sono queste le qualità
umane che si richiedevano in una società contadina. L’assennatezza significava precisione nel
lavoro e soprattutto dedizione alla vita agricola; l’onestà della famiglia garantiva la sobrietà con
cui occorreva affrontare una vita fatta di fatiche e priva di agiatezze. Rigo, dunque, è presentato
come un ideale capo di una futura famiglia.
Rispetto, però, ad altri giovani, eventuali pretendenti della ragazza, Rigo ci viene
presentato come cacciatore, come uno, quindi, che va girando di qua e di là, che quasi non ha
fissa dimora né famiglia. Egli tuttavia, praticando la caccia, è esperto del mondo animale, come
dimostra raccontando, durante la veglia, la leggenda del rigogolo o reattino (illustrata nella
composizione successiva La cincia); conosce profondamente la natura e ne sa svelare i significati
simbolici. Egli, infine, rappresenta l’avventura, contrapposta alla vita monotona e ripetitiva del
contadino: per questo Rosa si innamora di lui.
Il cacciatore, però, una volta sposatosi, finisce con il tornare contadino e noi lo vediamo
mentre con grande perizia pota le viti. In questo senso il padre di Rosa aveva visto giusto: il
giovane prometteva bene. Forse in questo episodio c’è un’altra reminiscenza vichiana: gli uomini
prima sono stati cacciatori, poi agricoltori. Così il giovane Rigo è cacciatore, poi diventa
contadino. E forse lo stesso percorso ha tenuto il padre di Rosa, prima cacciatore, poi bravo
agricoltore.
A proposito de La cincia, c’è da aggiungere che nel raccontare la favola di questo
uccellino Rigo non solo riecheggia i racconti delle veglie, ma nella enumerazione doviziosa di
nomi di animali e di piante assolve ad un’importante funzione della veglia, che non era solo un
modo per passare il tempo, perché le favole dovevano avere anche un aspetto pedagogico-
didattico sia quando se ne ricavava la “morale”, sia per le notizie e le cognizioni che potevano
essere trasmesse con la loro narrazione.
7.- Cultura ed espressività contadina
7.1 Stornelli e rispetti
21
21
Se molti aspetti della condizione materiale contadina trovano ampia trattazione
nell’opera del Pascoli, innumerevoli sono i riferimenti alla cultura orale; il poeta, oltre ad usare
una lingua molto vicina a quella parlata nella valle del Serchio, specie nelle parti in cui occorre
un linguaggio tecnico e specifico, coglie a piene mani modi di dire, proverbi, versi di canti,
brani di fiabe, preghiere, stornelli. Si tratta, come già osservato dal Santoli e da altri, di intarsi,
a volte preziosi, a volte stucchevoli, ma che testimoniano della simpatia che il Pascoli provava
per queste manifestazioni di espressività popolare e del profondo studio con cui guardò ad esse.
E’ soprattutto in Myricae che si trovano numerose citazioni tratte dalla cultura popolare,
quasi come se esse fossero un esercizio preliminare alle prove molto più impegnative dei Primi
e dei Nuovi Poemetti.
Le citazioni più numerose riguardano gli stornelli e i rispetti. I primi sono tra le più
semplici forme del canto popolare: in genere si tratta di una strofa di un quinario e due
endecasillabi, di cui il primo ripetuto due volte. Era un semplice canto, a volte improvvisato,
che si usava in molte occasioni, come durante i banchetti di nozze, durante le serate estive
passate sull’aia, o mentre si era al lavoro. Poco più sopra, infatti, abbiamo visto, a proposito de
La vendemmia, che i raccoglitori dell’uva si scambiavano stornelli. In questo caso il poeta
riporta tutti interi gli stornelli, mentre le altre volte si limita al verso iniziale, come Fiore di
spina (MY, Sera d’ottobre).
In Lavandare tutta la seconda strofa della lirica riporta quasi interamente uno stornello
marchigiano; il componimento è certamente uno dei capolavori del Pascoli che in questo caso
ha saputo fondere una forma di espressività popolare con la sua capacità di tradurre la realtà
degli oggetti (qui un aratro abbandonato in un campo lavorato a metà) in simboli, ottenendo un
risultato altamente poetico.
L’altra forma di canto è il rispetto, del quale il poeta riporta alcuni frammenti, o
prendendo un verso come spunto per iniziare una sua composizione: M’affaccio alla finestra e vedo il mare,
o per usare un distico per concludere una lirica, come in Ultimo canto (MY):
Amor comincia con canti e con suoni
e poi finisce con lacrime al cuore.
Ancora due distici di rispetto sono utilizzati per raccontare come si svolge la serenata
che un giovanotto va a portare davanti ad un casolare in cui abita una ragazza, forse la sua
“dama”46
. I due distici sono intarsiati dentro un sonetto, occupando il primo i versi 1-2 della
prima quartina (Sospira e piange, e bagna le lenzuola – la bella figlia, quando rifà il letto); il
secondo occupa gli ultimi due versi della seconda (e si rimira il suo candido petto – e le
rincresce avere a dormir sola). Si tratta di una raffinata tecnica compositiva che si può
riscontrare ogni qual volta il poeta costruisce questi intarsi eleganti, queste preziosità
alessandrine, come ebbe a scrivere il Santoli. Questa grande perizia metrica è messa
maggiormente in evidenza quando il Pascoli si mette ad imitare la struttura del rispetto che è
tecnicamente complessa, molto diversa da quella della semplice ottava, perché è formata da una
quartina con rima alterna ABAB (che costituisce la “testa”) e da due distici con rima baciata
CCDD (che costituiscono la “coda”); ma l’originalità della struttura metrica sta nel fatto che i
due distici della coda sono dei versi transformati, sono due versi paralleli in cui però c’è una
variazione nella desinenza (cuore / amore; canto / pianto)47
. Il Pascoli, inoltre, qui arricchisce e
collega più strettamente le parti della composizione con molte rime interne e aggiungendo ben
cinque riprese del titolo (lontana/ lontana; lontana /lontano /lontana) posizionate alla fine,
46 Lo stornello in MY.
47 Su questi problemi metrici del rispetto e dello stornello si veda A.M. Cirese, Ragioni metriche, Sellerio editore,
Palermo 1998, pp. 120-123.
22
22
all’inizio e all’interno dei versi, rendendo il rispetto ancora più complesso e più prezioso:
Cantare, il giorno, ti sentii: felice?
Cantavi; la tua voce era lontana.
Lontana come di stornellatrice
Per la campagna frondeggiante e piana.
Lontana, sì, ma io sentia nel cuore
Che quel lontano canto era d’amore.
Ma sì lontana, che quel dolce canto,
dentro, nel cuore, mi moriva in pianto (MY, Tristezze, Lontana)
7.2 Letture contadine
Parlando delle fonti del teatro popolare lucchese, Giovanni Giannini48
ebbe a scrivere:
Nei giorni di festa e la sera, quand’han terminato il lavoro, entrando nelle loro casupole
annerite dal fumo, non è raro di trovarli tutti assorti nella lettura di qualche libro (…)
come la Gerusalemme liberata, che molti sanno a memoria, ed anche l’Orlando
innamorato, il Furioso (… ). Più noti ancora e più diffusi sono gli antichi romanzi
cavallereschi, come i Reali di Francia e Guerrino il Meschino …
Queste letture, insieme con quella della Bibbia e di testi agiografici formavano la “cultura”
dei contadini49
, i quali, da esse traevano i nomi per i loro figli (Rizieri, Uliana, Orlando, Clorinda,
Armida, Assuero, Abigaille, ecc.) e prendevano spunto per i copioni delle loro forme teatrali (il
Maggio drammatico e il Bruscello, rispettivamente nel Nord e nel Sud della Toscana)50
.
L’eco di queste letture si trova in MY nel componimento Il vecchio dei campi, dove è
ricordato un personaggio dei Reali di Francia51
Racconta al fuoco (sfrigola bel bello
un ciocco d’olmo in tanto che ragiona),
come a far erba uscisse con Rondello
Buovo d’Antona.
8.- La socialità, la veglia
Nella prima stanza de La Poesia, che apre i CC, il Pascoli fa parlare la poesia,
simboleggiata da un lume che, appeso alla trave di una stalla, diffonde la sua luce su una veglia,
48 G. Giannini, Teatro popolare toscano, «Curiosità popolari tradizionali», XIV, Palermo 1885-1899, ora in ristampa
anastatica, Forni, Bologna 1968.
49 Queste letture appartenevano anche ai contadini e agli abitanti dei villaggi non solo toscani, come possiamo
vedere dall’ironica descrizione del sarto nei Promessi sposi del Manzoni.
50 Cfr. M. Fresta, Un sondaggio sull'onomastica a Montepulciano, «L’Uomo», VII, 1-2, Roma 1983 e poi
anche in
«LARES», L, 4, 1984; Vecchie segate ed alberi di Maggio, a cura di M. Fresta, Editori del Grifo, Montepulciano
1983.
51 Andrea da Barberino (ca. 1370 – ca. 1432) è l’autore di questo farraginoso romanzo cavalleresco il cui titolo
completo è: I Reali di Francia. La generazione degli Imperatori, Re, Principi, Baroni e Paladini e la storia di Buovo
d’Antona. Nuova edizione eseguita su quella purgata di Venezia del 1721, Bietti, Milano 1960. Il romanzo fu
composto tra la fine del 1300 e i primi del 1400.
23
23
cioè una riunione serale di contadini. La lampada illumina le donne che filano, i narratori di storie
di cronaca e di novelle, quelli che improvvisano stornelli d’amore, gli innamorati che bisbigliano
confondendo le loro voci con il lieve rumore dei fusi, i bovini che ruminano il cibo lentamente.
E’ una scena tipica delle serate invernali, quando per il troppo freddo la veglia avveniva
nella stalla, l’unico posto caldo di tutta la casa; se la veglia si svolgeva nelle grandi cucine
contadine, al centro di tutto c’era il focolare a dare un po’ di luce in più rispetto a quella prodotta
dalle candele o dal lume a petrolio, e a scaldare le persone, che magari finivano per appisolarsi e
sognare, come accade al capoccia in La veglia dei Primi poemetti.
Era generale abitudine che da novembre fino a marzo le famiglie contadine
organizzassero, a turno, veglie in cui convenivano persone del vicinato, corteggiatori delle
ragazze, amici del capoccia. Nelle veglie prendevano forma le situazioni descritte dal Pascoli, ma
non tutte insieme; diciamo che il poeta ha voluto darci un’idea complessiva di tutto quanto
poteva accadere in siffatte occasioni. In genere, durante una veglia, le donne filavano o tessevano
o rammendavano, gli uomini chiacchieravano, o giocavano a carte, o discutevano di problemi di
lavoro. Non in tutte le famiglie c’era la persona capace di intrattenere i presenti leggendo qualche
pagina della Bibbia o dei Reali di Francia (come il Vecchio dei campi, visto poco più su), o
raccontando barzellette, o cantando qualche “storia” sentita alla fiera da un cantastorie.
La stalla, dunque, o la cucina erano, durante le veglie, i luoghi deputati in cui circolavano
le notizie, in cui c’era lo scambio delle idee, in cui si giocava, si scherzava e si cantava; la stalla e
la cucina erano, inoltre, quasi gli unici luoghi di socializzazione per singoli e famiglie, costretti
per molti giorni dell’anno a restare isolati nei cascinali. La veglia, infine, oltre ad essere il
momento del passatempo, offriva anche le occasioni per la formazione culturale in senso lato e
per la preparazione alla vita dei ragazzi e dei giovani.52
Il Pascoli coglie l’importanza e la centralità della veglia nella comunità contadina ed è
proprio nella cornice delle riunioni serali che egli tratta i temi sentimentali relativi alla storia
d’amore tra Rosa e Rigo e soprattutto vi delinea la sua concezione del mondo e la sua filosofia.
Ne La cincia, infatti, il cacciatore Rigo racconta la fiaba del re che vorrebbe aver le ali per
volare e che una fata trasforma in reattino mentre i suoi cavalli e i suoi cani diventano
rispettivamente cinciarelle e cinciallegre; è una favola che incanta l’uditorio e soprattutto “la
fanciulla da’ capelli d’oro”. Nella stessa raccolta dei PP il titolo La veglia appartiene al ciclo
relativo al ritorno dai campi degli uomini, al loro riposo davanti al focolare, il cui tepore, dopo la
stanchezza della giornata faticosa, invita al sonno e al sogno. Ma dopo la cena, il Pascoli dà la
parola al capoccio che espone la sua filosofia di vita, fortemente legata alla sua esperienza di
contadino. Alla veglia partecipa anche Rigo. Ed è forse a lui che il ragionamento del capoccio si
rivolge, perché il giovane cacciatore possa imparare a diventare un buon agricoltore. E così nella
visione economica ed esistenziale del capo di casa, assume grande importanza il lavoro accurato
(Oh! Il campetto con siepe e fossetto) che garantisce il grano e il vino, cui si accompagnano l’olio
e i prodotti dell’orto. Il tutto si conclude con l’elogio della Siepe di cui si è parlato poco più
sopra.
L’altra veglia è rappresentata nel lungo componimento intitolato Il ciocco, pubblicato
nella raccolta dei Canti di Castelvecchio. Questo poemetto è senza dubbio uno dei più importanti
e forse quello centrale per capire la posizione del Pascoli nei confronti della società e che ci
permette di misurare, analizzando le sue stesse parole, la sua sincerità nell’assumere come
propria e come modello universale l’esistenza dei contadini.
Nella prima parte del poemetto, il Pascoli ci descrive una veglia, cui partecipano donne,
che svolgono i loro abituali lavori serali, e uomini che parlano dei loro lavori, degli effetti che
produce nei campi l’andamento stagionale; sono presenti anche il poeta e il suo fattore, il
52 Sulle veglie e sulle loro funzioni si veda F. Mugnaini, Le veglie: forme di sociabilità nella mezzadria toscana, in La Val d’Orcia di Iris. Storia, vita e cultura dei mezzadri, a cura di M. Fresta, Le Balze, Montepulciano 2003, pp. 137-167. Nell’opera pascoliana la veglia, oltre che
in La poesia, è rappresentata in La cincia e La veglia nei Primi Poemetti e ne Il ciocco nei CC. Anche in Notte di
MY e L’or di notte in CC è adombrata una situazione di veglia.
24
24
“salcigno zi’ Meo”. Poi l’attenzione viene attirata da un ciocco, un grosso pezzo di legno, che
arde nel focolare e in cui avevano fatto il nido delle formiche. La discussione si sposta, quindi, su
questi insetti, sulla loro organizzazione sociale, sui loro usi e costumi. Le considerazioni dei
partecipanti alla veglia sono piuttosto inusuali, visto che è molto difficile pensare che quei
contadini barghigiani potessero affrontare tali temi filosofici e sociologici. E’ quindi il Pascoli
che mette in bocca ai vegliatori ragionamenti funzionali alla sua opera pedagogica, che lo
convinceva a scegliere spesso il poemetto didascalico come suo strumento principale di
comunicazione poetica e di educazione civile, per realizzare, come annota il Nava, il «suo
ambizioso programma di fare della poesia la coscienza della scienza»53
.
C’è da aggiungere che a questa discussione così elevata non partecipa nessuna delle
donne; tuttavia, anche se i temi fossero stati meno alti e avessero toccato problemi di
organizzazione di lavoro, di rapporti col vicinato o con il proprietario e i suoi agenti, le donne
avrebbero mantenuto ugualmente il loro silenzio. Anche in questo caso il Pascoli si dimostra
attento osservatore della realtà agricola, negando, come nella realtà storica, qualsiasi intervento
delle donne in affari sentiti come espressamente maschili54
.
Poi la veglia finisce e il poeta e lo zi’ Meo tornano a casa. E’ questa la seconda parte del
poemetto, in cui il poeta, dopo aver guardato il cielo fittamente stellato, inizia una lunga serie di
considerazioni di ordine astronomico, filosofico ed esistenziale, che espone facendo largo uso di
nozioni scientifiche, di pensieri filosofici e di mitologia classica. Anche lo Zio Meo guarda il
cielo e da quella visione ricava una considerazione semplicissima, frutto della sua esperienza
priva di dottrina e fortemente legata alla vita materiale: Stellato fisso, domattina piove. Il Pascoli,
riportando e interpretando la frase del fattore, così la commenta: era andato alle porche il suo
pensiero. Ovverosia: lo zio Meo ha da poco seminato, il tempo è rimasto asciutto, ma ora occorre
che piova. Le previsioni meteorologiche, che lo zio Meo ha imparato a fare attraverso l’attenta
osservazione dei fenomeni celesti e atmosferici, gli dicono che la pioggia è in arrivo, per questo
se ne va contento a letto.
9.- Conclusioni
La conoscenza del mondo contadino in Pascoli è profonda e totale, sia per quanto
riguarda la vita quotidiana, i lavori grandi e piccoli, i rapporti familiari, sia per quanto attiene
alla lingua e alle varie manifestazioni dell’espressività. Nonostante questo, però, la
rappresentazione della famiglia di Rosa e di tutta la comunità contadina che via via appare nelle
sue poesie risulta paradossalmente falsa. Forse questa contraddizione tra il verismo dei dettagli
e l’immagine che viene delineata del mondo contadino è frutto, da una parte, della poetica del
“fanciullino” e, dall’altra, della stessa documentazione sulla cultura tradizionale che il Pascoli
ebbe tra le mani e che studiò profondamente.
La “poetica del fanciullino”, che il Pascoli perseguì con tenacia e assiduità, sta alla base
di tutta la sua produzione e quindi anche dei Primi e dei Nuovi poemetti. L’accettazione di
questa poetica comporta che il fanciullino e il poeta coincidano, obbligando quest’ultimo a
liberarsi da ogni stratificazione e incrostazione culturale e ad isolare gli oggetti, i gesti e le
parole dal loro contesto, se vuole scoprire l’essenza delle cose e giungere ad una pura
rappresentazione del reale. Sennonché questa rappresentazione pura racchiude il pericolo
dell’astrattezza, con il risultato che quello della campagna ci appare come un mondo che ha il
disegno e i colori dell’utopia.
53 G. Nava, commento ai Canti di Castelvecchio, cit. p. 139.
54 Su questo aspetto si veda M. Fresta, La memoria maschile, in Mirna Coppi – M. Fresta, Il passato nella memoria
contadina, in «Annali Cervi» n. 2, Il Mulino, Bologna 1980.
25
25
A conferire questa atmosfera di idealizzazione e di mito al mondo agricolo cantato nei
suoi versi furono anche le suggestioni che al Pascoli venivano da tutti gli studi della seconda
metà dell’Ottocento sulla mitologia comparata, e quelle, molto più importanti, che gli
derivavano dalle raccolte di canti, di proverbi, di usi e costumi del mondo contadino, che erano
state pubblicate dal Tommaseo, dal Tigri, dal Rubieri e da molti altri ricercatori. Noi sappiamo
che questi lavori del primo folklorismo italiano avevano la peculiarità di essere stati effettuati in
pieno romanticismo e che di quella temperie culturale erano impregnati sia nel bene che nel
male.
Il movimento romantico, infatti, trovò nell’espressività, negli stornelli e negli strambotti
particolarmente, delle classi sociali più basse e incolte, quella poesia spontanea, sentimentale,
semplice e “popolare” che andava ricercando e che voleva opporre a quella dotta, intrisa di
retorica e di inattuale mitologia, propria di coloro che Berchet chiamava “parigini”. Per i
romantici le genti che abitavano le campagne e soprattutto le montagne erano i portatori di una
fede religiosa genuina, di sentimenti puri e autentici, di una purezza espressiva e linguistica
ormai perduta dalle classi alte, tanto da poter essere indicate come le vere rappresentanti
dell’anima nazionale55
. La pastora e poetessa improvvisatrice Beatrice Bugelli di Pian degli
Ontani, nel pistoiese, scoperta dal Tommaseo, divenne il modello vivente di questa poesia e fu
oggetto di visite di illustri letterati, fra cui il giovane Pascoli56
.
Questo giudizio romantico passò dalla poesia a tutte le altre manifestazioni
dell’espressività e della vita delle genti campagnole e si accompagnò a quell’altra visione della
loro sobrietà e della loro semplicità tratteggiata da coloro che si erano occupati del mondo
agrario e della mezzadria, fin dagli anni ‘30 circa del sec. XIX, e che avevano avuto il capofila
nello svizzero de’ Sismondi. In questo modo il contadino, fosse esso mezzadro, affittuario o
piccolo proprietario, fu idealizzato e quasi sublimato, nascondendo dietro questa supposta
purezza un mondo fatto di fatiche, di privazioni, di miseria e di fame e, soprattutto, di
subalternità57
.
Probabilmente la famiglia di Rosa e tutti quelli che attorno ad essa girano derivano
anche da questa immagine romantica delle genti campagnole, ormai stereotipata, che il Pascoli
accoglie senza discuterla perché in fondo congeniale alla sua sensibilità sociale e alla sua
ideologia estetica e politica.
Così, nell’opera pascoliana il mondo contadino, pur essendo descritto e rappresentato
minutamente (il lavoro quotidiano, l’alimentazione, il linguaggio, l’espressività in genere; e le
speranze e i dolori dei membri di una famiglia presa a modello per tutta l’umanità) risulta a noi
lettori freddo e lontano; sentiamo che nel poeta c’è una solidarietà ideologica ma non umana.
Perché la campagna e i suoi abitanti sono visti in una luce ideale, in un rapporto, anch’esso
ideale, di armonia con la natura. Perché i mali sono soltanto quelli che la natura, inconsapevole,
impone agli uomini, non perché cattiva ma perché forse ignara (come in Leopardi)
dell’esistenza umana.
La solidarietà del poeta verso questo mondo è quella che nasce dalla pietas di una
55 Si vedano gli studi di A. M. Cirese, La poesia popolare, Palumbo, Palermo 1958; ma anche Clemente,
Letterati, mezzadri e padroni, cit.; e poi P.P. Pasolini, La poesia popolare italiana, in Id, Passione ed ideologia,
Garzanti, Milano 2009 (prima ed. 1960), pp. 151- 275.
56 Claudio Rosati, Beatrice Bugelli di Pian degli Ontani, Poetessa, Pastora, Brigata del Leoncino, Pistoia 2001, p. 5.
57 Questa idealizzazione riguarda le genti del contado, ma non le classi sociali basse della città, giudicate
molto negativamente come si può vedere in uno scritto di Renato Fucini il quale, dopo aver assistito ad una
rappresentazione di un Bruscello nella montagna pisana, chiudeva il suo articolo così: «E in tal modo gentile si
rallegrano i barbari abitatori di queste montagne, mentre nelle civili borgate della pianura, fra i bestiali bagordi
carnevaleschi, il popolaccio si scoltella ubriaco» (Il Bruscello della Serra, in Tutti gli scritti, Trevisini, Milano
s.d., pp. 782-790).
26
26
persona che vive gli stessi affanni esistenziali; né può essere altrimenti, giacché egli non si pone
i problemi della materialità della condizione contadina, né include questa condizione nel quadro
più generale della società in cui i rapporti umani e quelli di classe trovano una spiegazione ed
anche la possibilità di essere modificati.
Al poeta sono bastati l’esperienza giovanile con il socialismo bakuniniano e qualche
mese di carcere58
per cancellare dalla sua coscienza e dalla sua mente qualsiasi pensiero di
solidarietà politica. Crede di essere anche lui un contadino, ma se va a caccia, con l’hammerless
gun59
, se ne torna a casa senza avere sparato un solo colpo, perché per lui gli uccelli sono
manifestazioni della natura; il contadino-cacciatore, per il quale, invece, gli uccelli fanno parte
di un’alimentazione di sopravvivenza, spara senza alcun tentennamento60
. Il non voler chiedersi
il perché e il come della condizione di vita del contadino non gli consente poi di capire quali
sono i problemi veri dell’Italia di allora e di tutto il mondo agrario minacciato dall’imminente
industrialismo che avrebbe, nel giro di pochi decenni, devastato e annullato strutture
economiche e sociali che si erano perpetuate per secoli.
Il fatto è che manca in questa raffigurazione del mondo agricolo del Pascoli la presenza
della Storia: le sue campagne, i suoi personaggi, sono pure immagini chiuse dentro una
campana di vetro senza nessun legame con la realtà del loro tempo; anche la stessa lingua,
esemplata sul dialetto garfagnino e toscano non giunge mai alla rappresentazione realistica di
un Manzoni e tanto meno a quella veristica del Verga, perché essa «è sempre in funzione della
vita intima e poetica dell’io, e, quindi, della lingua letteraria, nel suo momento centralistico e in
definitiva ancora tradizionale»61
. Il risultato è che, oltre alla lingua, su cui pure si esercita a
lungo lo sperimentalismo del poeta, tradizionali rimangono i contenuti, nel senso che molte
volte la raffigurazione di paesaggi e personaggi tende pericolosamente a scadere nell’Arcadia.
Nel precedente paragrafo sulla Veglia è stato sintetizzato il contenuto del poemetto Il
ciocco. Non sappiamo se l’episodio, cui il poemetto si riferisce, sia dovuto alla finzione poetica
o sia stato ispirato da un fatto reale, comunque esso consente di formulare alcune ulteriori
considerazioni sul rapporto tra il Pascoli e il mondo contadino:
a) Nella seconda parte del componimento, i due amici escono dal luogo della veglia;
dopo aver guardato il cielo stellato, il Pascoli si dilunga in un ragionamento che tocca temi
esistenziali con riflessioni scientifiche, filosofiche, mitologiche, più o meno rifacendosi alla
Ginestra leopardiana. Anche lo zi’ Meo guarda il cielo, ma si limita a fare una considerazione
brevissima, racchiusa in un semplice proverbio tradizionale di carattere meteorologico: Stellato
fisso, domattina piove.
I due distinti comportamenti sono la prova che tra il poeta e lo zi’ Meo esiste una
enorme disparità culturale, che separa in modo insuperabile l’intellettuale, - in possesso di una
formazione dottrinaria che gli permette di spaziare dal mondo classico a quello moderno, dalla
poesia alla filosofia -, dal vecchio fattore in possesso solo di un’esperienza empirica e di una
filosofia della vita basata piuttosto sui proverbi e sulle sue speranze che su conoscenze di natura
intellettuale.
b) Il poeta cerca di immedesimarsi nel contadino e di far sua la concezione del mondo
e della vita della piccola comunità agraria di Barga, ma la differenza, tra il suo mondo e quello
agricolo, rimane ugualmente abissale: e forse egli sa che, in fondo, il vecchio fattore, nel vivere
secondo natura, ha ragione e che le sue riflessioni filosofiche sono solo un esercizio
intellettuale per dimostrare a se stesso la sua supremazia culturale. Se da una parte egli vuole
58 Su queste vicende giudiziarie del Pascoli si veda Ruggio, G. Pascoli, cit., pp. 44-48.
59 The Hammerless Gun, (Canti di Castelvecchio), dove il Pascoli racconta di essere andato a caccia per provare un
fucile senza cani, regalatogli da un amico, e di essere stato incapace di tirare un solo colpo.
60 Il Pascoli ne La cincia mostra Rigo cacciatore in azione, ma fa in modo che il giovane non riesca a premere
nemmeno il grilletto del fucile, perché gli uccellini scappano prima dello sparo.
61 P.P. Pasolini, Pascoli, in Passione e ideologia, pref. di A. Asor Rosa, Garzanti, Milano 2009 (prima ed. 1960), p.
300.
27
27
essere contadino o crede di sentirsi contadino, dall’altra non gli riuscirà mai di colmare questa
enorme disparità perché gli manca una precisa coscienza storica e una solidarietà col mondo
agricolo che non può essere solo quella dettata dalla bontà d’animo o da un’ideologia senza
legami col mondo reale.
Come, nonostante gli sforzi del poeta, tra il dotto umanista e il semianalfabeta fattore
del Ciocco non può esserci uguaglianza, così tra l’intellettuale borghese, benché intriso di
sentimenti umanitari, e il mondo contadino non può esserci alcuna solidarietà.
Negli ultimi anni, seguendo le indicazioni di una certa antropologia americana, che in
Italia è stata conosciuta, tra l’altro, per mezzo del volume I frutti puri impazziscono62, anche
qualche studioso italiano, come Pietro Clemente, si è avvicinato al mondo della poesia
vedendola non solo come «fonte, luogo di deposito di tracce documentarie … come fonte di
vere e proprie descrizioni etnografiche», ma accettando anche «l’idea che “il codice espressivo
e comunicativo della poesia divenga chiave della descrizione e della comprensione etnografica
(F. Dei, Fatti, finzione, testi: sul rapporto tra antropologia e letteratura, in «Uomo e cultura»,
pp. 45-52. 1993) 63
».
L’analisi di Clemente è stata condotta principalmente sul poeta molisano Eugenio
Cirese, ma si è rivolta anche al Pascoli, soprattutto ai componimenti dei Primi poemetti, per
verificare in quali modi la poesia restituisca la memoria che riguarda sia la vita nella sua totalità
e nei suoi singoli ed anche minuti aspetti, sia i rapporti tra generazioni diverse, i gesti
quotidiani, gli oggetti domestici e gli strumenti del lavoro, la geografia dei campi e dei villaggi,
i sentimenti vissuti. Il Pascoli, in effetti, rielabora nella sua memoria poetica le esperienze e le
conoscenze che ha potuto fare direttamente “sul campo”, osservando attentamente la vita
paesana e quella contadina di Barga e di altre località agricole. Egli è capace di restituirci
immagini, personaggi e cose che noi, oggi, non possiamo più conoscere direttamente perché
lontani da essi molte decine di anni.
La sua, difatti, è spesso una poesia etnografica, ma la ricostruzione integrale, reale e non
astratta, del mondo che dipinge si può avere solo se il lettore conosce, da un punto di vista
storico-sociale, quegli uomini e le loro condizioni. La preparazione della desina, per esempio, e
il pranzo consumato in mezzo al campo sono accadimenti che, per non essere intesi come fatti
strani e pittoreschi, hanno bisogno di essere inquadrati in precise condizioni di vita e di lavoro.
Per capirli bene non bastano i versi pascoliani e la puntualità del suo linguaggio costruito sul
dialetto garfagnino; occorre invece, per dirla con Umberto Eco64
, la cooperazione di un lettore
dotato di competenze storiche e in possesso di una specifica enciclopedia per capire fino in
fondo cosa il poeta volesse rappresentare.
«Le figure retoriche con cui lo sguardo candido del fanciullo altera la realtà non mirano ad
“abbagliare gli occhi altrui” ma ad “illuminare la cosa”, a rivelare l’essenza celata nel
fenomeno»65
. I personaggi, i loro gesti, gli oggetti, nel Pascoli, sono potentemente illuminati,
ma i contorni rimangono bui. E’ come ammirare la luccicante punta di un iceberg senza poter
vedere la sua immensa mole nascosta sott’acqua, oppure guardare la fotografia di una persona
che si staglia nitidissima su uno sfondo piatto, grigio e senza significato.
62 A cura di J. Clifford, Bollati Boringhieri, Torino1993.
63 P. Clemente, Penne di petto: antropologia, poesia, generazioni, in «Il gallo silvestre», n. 13, 2000, p.
(rispettivamente)121 e 119. Sul Pascoli poeta di villaggi e paesi, si veda, sempre di Clemente Paese/paesi, in I
luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, a cura di M. Isnenghi, Laterza, Bari 1997, pp. 23-28.
64 U. Eco, Lector in fabula, Bompiani, Milano 1985.
65 A. Battistini – E. Raimondi, Pascoli: la catarsi degli oggetti, in Retoriche e poetiche dominanti, Letteratura
Italiana (dir. A. Asor Rosa), vol. III.1 Le forme del testo, teoria e poesia, pp. 262-263, Torino 1984.
28
28
BIBLIOGRAFIA
A) Edizioni delle Opere del Pascoli
Myricae, a cura di G. Nava, Salerno Ed., Roma 1978.
Canti di Castelvecchio, introduzione e note di Giuseppe Nava, Bib. Univ. Rizzoli, Milano,
19892.
Primi poemetti, a cura di Nadia Ebani, Fondazione Pietro Bembo, Guanda Editore, Parma
1997.
Myricae, introd. di P. Vincenzo Mengaldo; note di Franco Melotti, B.U.Rizzoli, Milano
19989
Nuovi poemetti, a cura di Renato Aymone, Mondadori (Oscar classici), Milano 2003.
Poesie, Scelta dei testi e introduzione di Luigi Baldacci; note di Maurizio Cucchi, Garzanti,
Milano 2009 (1° ed. 1974).
B) Studi
BATTISTINI Andrea e RAIMONDI Ezio, Pascoli: la catarsi degli oggetti, in Retoriche e poetiche dominanti, in Letteratura Italiana (dir. Asor Rosa), Le forme del testo, Teoria e poesia, Einaudi, Torino 1984, pp.262-267. CIRESE Alberto Mario, Ragioni metriche, Sellerio, Palermo 1988
GIANNINI Giovanni, Le tradizioni popolari nella poesia pascoliana, in Lucca a G. Pascoli, Lucca 1924, p. 51 e sgg.
GIOVANARDI Stefano, Myricae di G. Pascoli, in Letteratura Italiana (Dir. A. Asor Rosa),
Le Opere, vol. III Dall’Ottocento al Novecento, Einaudi, Torino 1984, pp. 1066-1090.
NAVA Giuseppe, Pascoli e il folklore, in «Giornale storico della lett. Italiana», CLXI, 1984,
pp. 507/43
NAVA, Riflessione linguistica e studio del folclore in G. Pascoli, in La ricerca di Gastone Venturelli, Prima giornata, LARES, LXX, n. 2-3 – Firenze Maggio-Dicembre 2004.
NAVA G., Il mondo del folklore nei “Canti di Castelvecchio”, in M. Pazzaglia, Nel centenario dei “Canti di Castelvecchio”, Bologna, Patron, 2005, pp. 227/233.
POGGI SALANI Teresa, Sulla dialettalità del Pascoli, in “Studi di Grammatica Italiana”, vol.
XVIII, 1999, Le Lettere, Firenze 2000, pp. 91-112.
SANTOLI Vittorio, Pascoli e la poesia popolare, in Studi per il centenario della nascita, pubblicati nel cinquantenario della morte, a c. Commissione per i testi di lingua, Bologna
1962
TOSCHI Paolo., Pascoli e le tradizioni popolari, ivi.
TROPEA Mario, Pascoli, in G. Savoca-M. Tropea, Pascoli, Gozzano e i crepuscolari,
Laterza, Bari 1982.
VENTURELLI Gastone, Pensieri linguistici di Giovanni Pascoli, con un glossario degli elementi barghigiani della sua poesia, Accademia della Crusca, Firenze 2000.
29
29
C) Sulla mezzadria, l’agricoltura e il folklore in Toscana
CLEMENTE, COPPI, FINESCHI, FRESTA, PIETRELLI, Mezzadri, letterati e padroni, Sellerio Editore, Palermo 1980
CULTURA contadina in Toscana, voll. 2, Bonechi, Firenze 1983
GIORGETTI Giorgio, Linee di evoluzione delle campagne toscane contemporanee, in
Capitalismo e agricoltura in Italia, Editori Riuniti, Roma 1977
(La) VAL d’Orcia di Iris. Vita storia e cultura dei mezzadri, a cura di M. Fresta, Le Balze,
Montepulciano 2003.