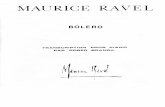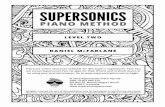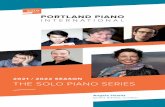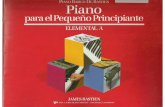Zelatores fidei, memorie federiciane ed imperium. Piano storico e piano ontologico nella lettura...
Transcript of Zelatores fidei, memorie federiciane ed imperium. Piano storico e piano ontologico nella lettura...
7zelatores fidei, memorie federiciane
zelatores fidei,memorie federiciane ed imperium.
Piano storico e Piano ontologico nella lettura della monarchia dantesca
in un importante saggio, d’ormai più di dieci anni fa, enrico fenzi offriva una documentata, lungimiran-te e solida analisi di quei luoghi testuali – tolti prin-cipalmente dalla commedia e dalla monarchia – in cui dante fa esplicito riferimento, o semplice allusione, al ruolo svolto dalla francia capetingia – grossomo-do duecentesca, da filippo augusto sino a filippo il Bello, coevo del poeta – in quel graduale processo d’esautorazione dell’impero, che coincide, d’altra par-te, con l’emersione della piena sovranità territoriale dei re francesi (1). È chiaro che all’interno d’un simile discorso ne vada, soprattutto, dei rapporti tra un in-sieme di iurisdictiones concorrenti, delle loro relazioni di sovra- o subordinazione reciproca. il triangolo giurisdizionale implicato è evidentemente composto da impero, papato e monarchia capetingia. tra gli schemi dell’orizzonte politico-filosofico dantesco la funzione della francia in quanto « contro-modello assoluto rispetto all’idea d’impero » (2) emerge visibil-mente, nella lettura di fenzi, lungo il canto XX del Purgatorio, e precisamente nella memoria della storia
(1) E. FEnzi, tra religione e politica: dante, il mal di francia e le “sacrate osssa” dell’esecrato san luigi (con un excursus su alcuni passi della monarchia), in « studi danteschi », 69 (2004), pp. 23-117.
(2) ibid., p. 86.
8 l. mainini
capetingia affidata al lungo discorso del fondatore, ugo capeto (3). sebbene nel suo contributo fenzi cerchi – e trovi – tracce, cascami testuali e ideologici che sappiano rivelare la presenza, altrimenti taciuta, di luigi iX il santo tra i re francesi condannati da dante e ricondotti alla « mala pianta » da cui deriva tutta la stirpe, gli esiti cui perviene la sua analisi sorpassano ampiamente i limiti del canto purgatoriale e s’aprono, invece, come lo stesso fenzi avverte ed esplora, ad una lettura complessiva del progetto po-litico dantesco, che investe chiaramente, e in primo luogo, il testo della monarchia.
soffermiamoci rapidamente sul contenuto dei versi in questione, al fine di vederne all’opera gli argomenti maggiori (4).
io fui radice de la mala piantache la terra cristiana tutta aduggia,sì che buon frutto rado se ne schianta.ma se doagio, lilla, Guanto e Bruggiapotesser, tosto ne saria vendetta; e io la cheggio a lui che tutto giuggia.chiamato fui di là ugo ciappetta:di me son nati i filippi e i luigiper cui novellamente francia è retta.(vv. 43-51)
mentre che la gran dota provenzale al sangue mio non tolse la vergogna,poco valea, ma pur non facea male.
(3) si veda di recente, per un panorama interpretativo ed un’illustrazione delle tematiche storico-politiche proprie di quel canto, M. GriMaldi, Politica e storia nel canto XX del purgatorio, in « nuova rivista di letteratura italiana », 15 (2012), pp. 9-25, ma si torni anche a r. MansElli, il canto XX del “Purgatorio”, in nuove letture dantesche, vol. iV, firenze 1970, pp. 307-25.
(4) leggiamo da dantE aliGhiEri, la commedia secondo l’an-tica vulgata, ed. G. PEtrocchi, 4 voll., firenze 1994 (ii ristampa riveduta).
9zelatores fidei, memorie federiciane
lì cominciò con forza e con menzogna la sua rapina; e poscia, per ammenda,pontì e normandia prese e Guascogna.carlo venne in italia e, per ammenda,vittima fé di curradino; e poi ripinse al ciel tommaso, per ammenda.tempo vegg’io, non molto dopo ancoi,che tragge un altro carlo fuor di francia,per far conoscer meglio e sé e’ suoi.(vv. 61-72) (5)
o avarizia, che puoi tu più farne,poscia c’ha’ il mio sangue a te sì tratto,che non si cura de la propria carne?perché men paia il mal futuro e ’l fatto,veggio in alagna intrar lo fiordaliso,e nel vicario suo cristo esser catto. (vv. 82-87)
ugo capeto ripercorre dunque i momenti dell’ascesa recente dei sovrani francesi, un’ascesa che è militare – e dunque geografica –, politica – e dunque giurisdi-
(5) nella prospettiva perseguita da fenzi – ovvero il tentativo di cercar tracce di san luigi in quest’articolato atto d’accusa alla dinastia capetingia – si potrebbe forse considerare, come del resto anche fenzi intuisce, l’anafora sarcastica « per ammenda », che accompagna l’elencazione dei misfatti commessi dai re di francia, come fosse un riferimento parodico alla devozione che ha caratte-rizzato l’immagine e il ruolo di molti sovrani francesi, e tanto più, ex silentio, la vita di luigi iX che nel prender la croce sino alla sua morte, da crociato appunto, fece della penitenza un attributo della sua sovranità; cfr. J. lE GoFF, saint louis, paris 1996, pp. 894-897. in particolare, il riferimento potrebbe investire il carattere “penitenziale” della religiosità tipica del re santo. nondimeno la preparazione della settima crociata – dal « caractère purement français » (r. GoussEt, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, 3 voll., paris 1936, vol. iii, p. 428) – offre notevoli spunti per osservarne la dimensione devozionale, se è vero d’altra parte che il « pattern » della religiosità che l’animò « was penitential » (W.c. Jordan, louis iX and the challenge of the crusade. a study in rulership, princeton 2015 [i ed. 1979], p. 195).
10 l. mainini
zionale. la dinastia capetingia, in definitiva, tramite una serie di campagne militari ed un’attenta strategia “patrimoniale”, espande l’ambito del suo dominio, si territorializza (e si giuridicizza) (6) oltre i confini origi-nari del regnum; la « mala pianta » estende i suoi rami. ragione del processo, vizio e colpa politica – estesa evidentemente a tutta la dinastia tramite la figura del fondatore –, è quell’« avarizia » del v. 82, che mosse, in prospettiva dantesca, l’ambizione capetingia alla conquista, militare o matrimoniale (la « gran dota provenzale »), di quei territori che dante elenca come a farne un crescendo d’abuso e di rapina; un’avarizia che, nondimeno, presiedette all’oltraggio d’anagni, quando filippo il Bello umiliò cristo e la chiesa nel-la persona del suo vicario terreno, Bonifacio Viii (7).
(6) si tenga presente, in tal senso, il rilevantissimo fenomeno – che attraversa gran parte del Xiii secolo francese – d’assunzione e ricezione del diritto romano nel nord capetingio, e della sua messa a profitto nei quadri della cultura giuridica consuetudina-ria, della prassi amministrativa e di governo. si tratta d’un tema filologico e storico-politico tutt’altro che esaurito, sia dal punto di vista testuale (la tradizione manoscritta francese del corpus giu-stinianeo, per cui possono vedersi i contributi di h. Biu, tra cui la somme acé. Prolégomènes à une étude de la traduction française de la “summa azonis” d’après le manuscrit Bibl. Vat., reg. lat. 1063, in « Bibliothèque de l’École des chartes », 167 (2010), pp. 417-464, e di chi scrive le versioni d’oïl del corpus iuris civilis. il caso della digeste vielle: manoscritti e prime analisi, in « studj romanzi », 9 (2013), pp. 93-154) sia dal punto di vista storico-giuridico, per cui ci limitiamo a segnalare alcuni importanti contributi di sintesi: a. Gouron, ordonnances des rois de france et droits savants, in académie des inscriptions et Belles-lettres. comptes-rendus des séances de l’année 1991, novembre-décembre, paris 1991, pp. 851-865, id., l’entourage de louis Vii face aux droits savants: giraud de Bourges et son ordo, in « Bibliothèque de l’École des chartes », 146 (1988), pp. 5-29, G. GiordanEnGo, ius commune et « droit commun » en france du Xiiie au XVe siècle, in « Études d’histoire du droit et des idées politiques », 3 (1999), pp. 219-247.
(7) la nuova umiliazione del cristo, oltraggiato nella persona di Bonifacio Viii, sarebbe una tipica manifestazione del “doppio
11zelatores fidei, memorie federiciane
si tratta d’un vizio che andrà colto più in chiave “tragico-faustiana” – ovvero desiderio di possedere ciò non ci appartiene – che à la molière. un’accusa d’avaritia che allora, sotto questa prospettiva, cade in una stagione politica all’interno della quale essa sem-bra costituire un argomento “requisitorio” condiviso, oltre il caso francese, nella formulazione dell’accusa, più complessiva, di mal governo: se ne veda la pre-gnanza negli affreschi senesi di lorenzetti (8), associata agli altri vizi tipici della tirannide, o nella polemica – stavolta in chiave antimperiale – sulla venalità degli offici vicariali, e le ovvie conseguenze fiscali sulla vita dei comuni italiani (9), o ancora il topos trobadorico intorno all’avarizia di carlo, primo angioino a scen-dere come governante verso il meridione, di francia e d’italia (10).
d’altra parte, il ruolo degli angiò, ramo cadetto della “pianta” capetingia, espressione o magari ramifi-cazione europea e mediterranea della politica francese fra Xiii e XiV secolo (11), non può essere in alcun
corpo” del potere regale, discusso a suo tempo da Kantorowicz (E. KantoroWicz, the King’s two Bodies. a study in medieval Political theology, princeton 1957) ma si veda pure, in contraddizione con questa lettura, o. caPitani, una “debita reverentia” per Bonifacio Viii? (Pg. XX, 85-93 e Pd. XXVii, 22-24), in id., da dante a Bonifacio Viii, roma 2007, pp. 81-93.
(8) r.M. dEssì, il bene comune nella comunicazione verbale e visiva. indagini sugli affreschi del ‘Buon governo’, in il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo. atti del XlViii convegno storico internazionale (todi, 9-12 ottobre 2011), spoleto 2012, pp. 89-130.
(9) r. rao, l’oro dei tiranni: i vicariati venali di enrico Vii e la signoria cittadina nell’italia padana, in « reti medievali », 15 (2014), pp. 89-105.
(10) cfr. P. Borsa, letteratura antiangioina tra Provenza, italia e catalogna. la figura di carlo i, in gli angiò nell’italia nord-occidentale (1259-1382), a c. di r. coloMBa, milano 2006, pp. 386-387 (pp. 377-433).
(11) cfr. per una discussione dei complessi rapporti angioino-capetingi all’epoca della conquista meridionale l. caPo, da andrea
12 l. mainini
modo esentato da una sua riconsiderazione in chiave dantesca, alla luce di quanto lo stesso ugo capeto afferma nel XX del Purgatorio. molto s’è detto sul va-lore semantico, scritturale, della metafora – la « mala pianta » –, che innerva il racconto dell’espansione capetingia (12); limitiamoci in questa sede ad osservare i nessi intertestuali ch’essa istituisce nel macro-testo dantesco. primo fra tutti quello, interno alla com-media, col canto Vii dello stesso Purgatorio, dove la metafora del seme e della pianta infruttuosa governa la presentazione dei principi negligenti che, com’è noto, non risparmia gli angioini, carlo i e carlo ii.
rade volte risurge per li ramil’umana probitate; e questo vuole quei che la dà, perché da lui si chiami,anche al nasuto vanno mie parolenon men ch’a l’altro, pier, che con lui canta,onde puglia e proenza già si dole.tant’è del seme suo minor la pianta,quanto, più che Beatrice e margherita,costanza di marito ancor si vanta.(vv. 121-129)
l’inferiorità della pianta rispetto al seme che l’ha generata – dell’erede rispetto al padre – proverebbe così, per dante, il destino degenerativo dei vari regni, dell’aragonese non meno dell’angioino nella successio-ne tra carlo i (il « nasuto ») e carlo ii. un progressivo svilimento che, del resto, potrebbe leggersi in sinossi col lungo discorso tenuto da quell’angioino “salvato”, carlo martello, che in Paradiso Viii illustra a dante
ungaro a guillaume de nangis: un’ipotesi sui rapporti tra carlo i d’angiò e il regno di francia, in mélanges de l’École française de rome. moyen Âge - temps modernes, 89 (1977), pp. 811-888.
(12) cfr. G. arnaldi, la maledizione del sangue e la virtù delle stelle. angioini e capetingi nella commedia di dante, in « la cultura », 30 (1992), pp. 47-74 e 185-216.
13zelatores fidei, memorie federiciane
i modi in cui si realizzano le differenti inclinazioni umane nel mutuo soccorso di natura e provvidenza (« (...) dunque esser diverse / convien de’ vostri effetti le radici », vv. 122-123) – una digressione fisico-teologica cosciente dei suoi esiti politici, con nuovo riferimento al destino “degenerante” degli angioini nella persona di roberto, fatto re ma degno piuttosto di « sermone » (vv. 145-148). la politicità della metafora vegetale tra-scende tuttavia i limiti della commedia. essa in effetti inaugura la monarchia, servendo da giustificazione alla volontà dantesca d’impegnarsi in una trattazione politica.
longe nanque ab offitio se esse non dubitet qui, pu-blicis documentis imbutus, ad rem publicam aliquid afferre non curat: non enim est “lignum, quod secus decursus aquarum fructificat in tempore suo” (...). (monarchia, i i, 2) (13)
chi, pur essendo esperto di cose pubbliche, s’esi- me dalle sue responsabilità politiche non assomi-glia a quel legno – evocato nei salmi – che rende i suoi frutti nella stagione propizia. ed ugualmente nell’epistola all’imperatore enrico Vii dante evoca i nemici dell’impero sotto la figura di quegli arbores da estirpare fin’alle loro radices (14). si tratta quindi d’una politicità e d’una storicità referenziale che lega, più o meno virtualmente, il discorso d’ugo capeto al ramo angioino della dinastia francese, e d’altra parte d’un’intertestualità che apre i versi della commedia al resto dell’opera dantesca. ulteriore – e diremmo defi-nitiva – prova della necessità di soppesare insiemi i di-versi brani è offerta dall’exemplum di quel fabrizio – il
(13) leggiamo da dantE aliGhiEri, monarchia, ed. d. QuaGlio-ni, in dantE aliGhiEri, opere, dir. M. santaGata, vol. ii, milano 2014, p. 902.
(14) dantE aliGhiEri, epistole, ed. c. Villa, in id., opere cit., p. 1470.
14 l. mainini
console romano che preferì la sua virtù alle ricchezze “avare” della corruzione – la cui memoria torna sia in monarchia ii V, 11 che nel XX del Purgatorio come anti-modello, positivo, degli avari cui appartiene ugo capeto. siamo dunque al cospetto d’un trama testuale e ideologica che si fa eco tra commedia e monarchia, « la cui attualità e forza polemica – scriveva fenzi – non può essere colta » se non la si legge nel quadro complessivo « dell’attacco che dante muove alla di-nastia capetingia » (15), un attacco che del resto non sembra isolabile nella pura polemica anti-francese – sia essa colta nel suo versante capetingio o in quello angioino – ma che invece si estende e « complica (...) la dialettica chiesa-impero » (16).
ciò detto, quel che ci tratterà in queste pagine co-stituisce un aspetto minimo, un dettaglio interpretati-vo, debitore d’una simile impostazione del problema; un dettaglio, però, che, se correttamente specificato, contribuirà ad ipotizzare un senso politico globale per la monarchia dantesca, radicato nei referenti storici implicati nella sua polemica – i sovrani franco-an-gioini – e nella loro funzione “universale”, una volta che essi verranno trasposti, com’è abitudine della ragione dantesca, dal livello storico-evenemenziale a quello normativo-ontologico.
sebbene contributi come quello di fenzi (17) di-mostrino un’alta capacità di contestualizzazione, e finalizzazione, del trattato politico dantesco, non è
(15) FEnzi, tra religione e politica cit., p. 98.(16) ibid., p. 110.(17) che tuttavia non andrà letto isolatamente ma invece nel
solco d’una precisa linea interpretativa: si veda almeno a. casadEi, sicut in Paradiso comedie iam dixit, in « studi danteschi », 76 (2011), pp. 179-197 e M. PalMa di cEsnola, monarchia. la datazione intrin-seca, in Questioni dantesche. fiore, monarchia, commedia, ravenna 2003, pp. 43-62.
15zelatores fidei, memorie federiciane
raro, soprattutto nei tentativi sintetici, rubricare la monarchia tra quegli esperimenti teorici « favorables à l’empire et hostiles à l’hégémonie pontificale » (18). lungi dal sostenere che quest’aspetto non costituisca un asse argomentativo del trattato dantesco, avver-tiamo più che altro il rischio che in un’immagine storiografica del genere – forse influenzata dalla prima “critica guelfa”, che nella minaccia alla chiesa scorgeva il pericolo principale dell’opera dantesca – vada persa l’articolazione interna al pensiero poli-tico espresso nella monarchia, un’articolazione che sorpassa senza indugi la logica binaria, oppositiva o conciliatoria, impero-chiesa, o che piuttosto la tema-tizza all’interno d’un discorso – storico, giuridico e filosofico – che ne aumenta la riserva di significato. del resto, già quest’antica “critica guelfa” segnalava l’eccedenza argomentativa della monarchia rispetto alla pura questione della giurisdizione papale, ed in effetti il trattato dantesco porta un titolo “eccentrico” – forse dato troppo per scontato – se confrontato al panorama della coeva pubblicistica de potestate Papae et imperatoiris. « dividetur autem illud scriptum prin-cipaliter in tres partes » (19), osservava Guido Vernani da rimini. e con lui anche i lettori più bendisposti – Boccaccio (20), ad esempio, o Bartolo da sassoferra-to (21) – reiteravano la constatazione, ovvia del resto, secondo la quale il trattato dantesco si componeva
(18) J. QuillEt, la monarchia de dante alighieri, in Pour dante. dante et l’apocalypse. lectures humanistes de dante, éd. B. Pinchard, paris 2001, pp. 25-37.
(19) il più antico oppositore politico di dante: guido Vernani da rimini. testo critico del “de reprobatione monarchiae”, ed. n. MattEini, padova 1958, p. 94.
(20) GioVanni Boccaccio, trattatello in laude di dante, a c. di p.G. ricci, in Giovanni Boccaccio, tutte le opere, a c. di V. Branca, vol. iii, milano 1974, p. 487.
(21) cfr. d. QuaGlioni, introduzione, in dantE aliGhiEri, monarchia cit., p. 813.
16 l. mainini
di tre quaestiones, suddivisibili secondo l’ordine dei tre libri: la prima riguardante la necessità ontologica della monarchia universale, in quanto strumento per la realizzazione etica e razionale del genere umano, la seconda intorno all’appartenenza de iure dell’impero a roma ed ai suoi moderni eredi, la terza sulla re-ciproca distinzione e sull’autonoma coesistenza delle due giurisdizioni, papale ed imperiale. Quest’osserva-zione prudenziale, come s’è detto, non vuole ridurre l’importanza della terza questione, ma solo ricordare che ad essa bisognerebbe pervenire sul filo delle due precedenti, giacché in definitiva essa costituisce solo un terzo del trattato, né le due precedenti possono in alcun modo ridursi ad una propedeutica storico-teorica in vista dell’ultima.
l’accesso che vorremmo tentare – si diceva – prende dunque le mosse da un dettaglio che, a nostro avviso, permetterà d’estendere l’analisi, per quanto parzialmente, ai tre problemi che tagliano trasversal-mente il testo dantesco: la questione è quella degli zelatores fidei, equidistante tanto dalla dimensione ontologica del trattato dantesco – quella che ricon-duce la multitudo umana all’unitas imperiale – quanto dall’urgenza storica – il declino politico-geografico dell’impero e la trasformazione del guelfismo in ideo-logia della teocrazia papale (22); un’equidistanza che permette dunque una discreta mobilità tra i principali temi del trattato.
apriamo dunque la monarchia al brano in que-stione (ii X, 1):
maxime enim fremuerunt et inania meditati sunt in ro-manum principatum qui zelatores fidei cristiane se dicunt; nec miseret eos pauperum cristi, quibus non solum
(22) r.M. dEssì, i nomi dei guelfi e ghibellini da carlo i d’angiò a Petrarca, in guelfi e ghibellini nell’italia del rinascimento, a c. di M. GEntilE, roma 2005, pp. 3-78.
17zelatores fidei, memorie federiciane
defraudatio fit in ecclesiarum proventibus, quinymo patrimonia ipsa cotidie rapiuntur, et depauperatur ecclesia dum, simulando iustitiam, executorem iustitie non admittunt.
il passo è noto, a maggior ragione perché evocato spesso nelle dispute intorno alla datazione del testo dantesco: in esso in effetti sembrerebbe alludersi a una situazione storica concreta, caratterizzata da una sollevazione antimperiale attiva ed operante – real-tà che si venne a produrre negli anni della discesa dell’imperatore enrico Vii in italia, con l’opposizio-ne del fronte angioino-papale e la resistenza di vari comuni (23) (1311-1313). Qualunque sia il contributo di questo brano alla datazione del testo, quel che ora importa è coglierne il significato. dante vi afferma che i più agguerriti oppositori dell’impero sono “coloro i quali si dichiarano zelatori della fede cri-stiana” – qui zelatores fidei cristiane se dicunt; costoro, tuttavia, – prosegue dante – sarebbero dei falsi amici della chiesa, giacché, simulando la giustizia – ma in realtà estromettendone l’unico effettivo esecutore (l’imperatore) –, essi depauperano e danneggiano la chiesa stessa. l’identificazione dei referenti acclusi all’espressione zelatores fidei, lungi dall’essere mera curiosità, è invece un nodo centrale nell’esegesi del trattato dantesco, giacché, da una parte, dante sem-bra reiterare, nella formula, una definizione corrente – che, probabilmente, gli stessi oppositori dell’impero assumevano come propria (se dicunt) –, e d’altra parte, se la monarchia è davvero un’opera a difesa dei diritti
(23) sebbene il tema affrontato in queste pagine sottenda spesso questioni cronologiche, non discutiamo in questa sede la datazione del testo dantesco. non possiamo negare, tuttavia, che le riflessioni svolte contribuiscaono a collocare la monarchia nelle vicinanze dell’esperienza enriciana in italia, o quantomeno pre-suppongono un simile contesto storico.
18 l. mainini
imperiali, avremmo qui additati i referenti polemici dell’intero testo. si capisce allora perché intono a mn ii X, 1 le letture si siano susseguite piuttosto nume-rose, pari almeno al numero delle maggiori edizioni del testo. « l’opzione tradizionale – espressa anche nei commenti di Vinay e nardi – è che qui dante attacchi i cattivi ecclesiastici, primi fra tutti i pontefici, e che dunque tutto vada ricondotto a quella che sarà la dialettica principale del terzo libro (...), il confronto fra il potere papale e quello imperiale (...). più di recente è stato ipotizzato che gli zelatores fidei vadano invece ricercati fra i potenti laici che si opponevano all’impero e che avevano buon gioco a mostrarsi protettori della chiesa: roberto d’angiò (...) o i re di francia (...). Questa seconda interpretazione appare plausibile: in tutta la monarchia dante non mostra mai un atteggiamento così violentemente antipapale come supporrebbe la prima ipotesi (...). se gli zelatores fidei che si oppongono più di tutti ai disegni divini, depauperando la chiesa e non riconoscendo l’autorità dell’impero, che ha titolo di executor iustitie, sembrano dunque i francesi, i cattivi ecclesiastici (i pastores che accrescono il patrimonio di famiglia, di cui si parla al par. 3 [ii X]) restano comunque colpiti dall’invetti-va » (24). ecco, dunque, tra monarchia e commedia e pro-prio intorno agli zelatores fidei, riapparire la “questione francese”, il ruolo svolto, in prospettiva dantesca, da una duplice dinastia – capetingia ed angioina – nello svilimento, territoriale e politico, dell’universalità im-periale, celato sotto una tutela della chiesa romana, tanto apparente quanto pericolosa.
(24) così nel commento di P. chiEsa e a. taBarroni a dantE aliGhiEri, le opere, vol. iV, monarchia, a c. di P. chiEsa e a. taBarroni con la collaborazione di d. EllEro, roma 2013, p. 140. per l’interpretazione volta ad angioini e capetingi si veda PalMa di cEsnola, monarchia cit. e FEnzi, tra religione e politica cit.
19zelatores fidei, memorie federiciane
il recente commento di Quaglioni tuttavia, assu-mendo in parte la seconda ipotesi esegetica, procede oltre, o meglio specifica in che misura sia possibile scorgere fra gli zelatores fidei evocati da dante non tanto un ceto d’ecclesiastici corrotti quanto invece una “fazione” politica, un preciso fronte d’opposizione antimperiale. « io credo – scrive Quaglioni (25) – che qui dante alluda al modo con cui il partito dei “guelfi ra-dicali” definiva se stesso in base ad un’etimologia tan-to falsa quanto carica di significati politico-religiosi, cioè guelfi, gelfi, zelfi da “zelatores fidei”. Questo modo doveva essere abbastanza diffuso, se una generazione più tardi Bartolo lo ricorda ancora nel suo tractatus de guelphis et gebellinis (...). non mi pare perciò che si debba ricercare (...) una specificazione più sotto, ii X, 3, dove si parla dei pastores; ché se specificazione occorre, essa va cercata più oltre, iii iii, 6, cioè nel luogo in cui dante enumera i tria hominum genera che si oppongono in modo diverso alla verità ». l’acquisi-zione del commento di Quaglioni è importante; essa infatti attesta l’uso dell’espressione dantesca nel dibat-tito politico-giuridico dell’epoca – alii vero adheserunt ecclesie et vocati sunt guelphi, quasi zelatores fidei (26) – , e crediamo pertanto che meriti d’essere esplorata nelle potenzialità esegetiche che dischiude. come lo stesso Quaglioni avverte, adducendo il passo bartoliano a sussidio della pagina dantesca, è nella magna discordia conseguente all’esperienza italiana di federico ii che le due fazioni – guelfi e ghibellini – sarebbero sorte, e con ciò anche i loro nomi sarebbero entrati nel dibattito politico (27).
(25) dantE aliGhiEri, monarchia, ed. d. QuaGlioni cit., pp. 1193-1194.
(26) ibid., p. 1194. (27) cfr. ancora dEssì, i nomi dei guelfi e ghibellini cit.
20 l. mainini
ora, sembra che le diverse prospettive fin qui riassunte possano quasi convergere: ciò che abbiamo chiamato “questione francese”, ovvero l’opzione an-timperiale capetingia ed angioina, la traccia “laica” e politica intorno agli zelatores fidei ed, infine, il peso storico e l’esemplarità dell’esperienza federiciana e delle sue conseguenze. in effetti, roberto d’angiò, terzo rex sicilie angioino dopo la sconfitta degli svevi – massimo referente politico della lega guelfa antim-periale contro enrico Vii, all’epoca in cui quest’ultimo scendeva in italia nel tentativo, sostenuto da dante, di riaffermare nella penisola l’autorità dell’impero –, rifiutando la condanna emessa contro di lui dall’im-peratore stesso, riallaccia pure il suo operato politico all’antico fronte d’opposizione agli ultimi svevi, già guidato dal suo avo carlo i, e riassumibile proprio nella figura, tanto simbolica quanto reale a questo punto, degli zelatores fidei. in una lettera del 1313 ro-berto d’angiò rievoca così la genealogia della crisi italiana alla venuta d’enrico Vii (28):
ab olim sparso pestifero semine per quondam frede-ricum imperatorem in italie partibus pululavit amara pestis dissensionis et odii contra orthodoxe fidei zelatores in arbores aspersas et mortiferas tunc conversa. (...) Verum quia negatum est superbis diu in cornu superbie residere, scriptura testante, qualiter divina iustitia eos pulsaverit, mediante potentia leonis invicti illustrissimi condam regis caroli avi nostri, qualiterque de pomerio fidei christiane succiderit arbores nedum infructuosas, sed etiam nefastas, manfredum scilicet et corradum ac etiam eorum complices et fautores, percesutores ecclesie et eiusdum fidelium, qualiterque sub iugo dominii fide-lium predictorum submiserit civitates et castra in parti-bus tuscie et lombardie ac alibi, novit manifestissime
(28) mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, iV/2, p. 991.
21zelatores fidei, memorie federiciane
totus orbis. attamen non eradicatis tunc ex toto radi-cibus produxerunt semina fructus malos, qui modernis temporibus per fas et nephas instigantes promotionem henrici lesomensis [sic, enrico Vii di lussemburgo] comitis, (...), ipsum henricum licet indignum imperio colorate et subdole prefici procurantes (...).
in prospettiva dantesca, il brano appare di pri-maria importanza, giacché in esso l’identificazione degli zelatores fidei col “partito ecclesiastico”, la fazione politica ostile a federico ii di svevia, passa pure per un utilizzo sistematico della metafora vegetale (emi-nentemente politica) – alberi, semi e radici, stavolta usati dagli angioini contro l’impero –, attraversa poi la rievocazione dell’antica lotta angioina, patrocinata dal papato (1264-1268), contro gli eredi dello stesso federico ii per il possesso del regnum sicilie e, se non bastasse, s’estende idealmente – e sintatticamente: at-tamen – al conflitto moderno tra la lega antimperiale, guidata dallo stesso roberto d’angiò, e l’ultima “rami-ficazione” della pianta federiciana, ovvero enrico Vii intento a ristabilire gli iura imperii nella penisola ita-liana. la lettera di roberto d’angiò sembra dunque far crollare nel significato degli zelatores fidei danteschi un insieme di temporalità storiche distinte – passato e presente, angioino ed imperiale – con le loro distinte progettualità politiche – l’eredità federiciana, la fine di quel progetto con la discesa in italia di carlo i d’angiò, fratello del re di francia luigi iX, l’attua-lità dell’opposizione anti-federiciana, a cinquant’anni di distanza, nella lotta moderna contro l’imperatore enrico Vii.
del resto, a collocare la semantica politica degli zelatores fidei nel cuore della memoria federiciana – attualizzata od osteggiata – sono gli stessi pontefici che dell’opposizione a federico ii, e al suo progetto imperiale sull’italia, fecero il principale tema politi-co, euro-mediterraneo, di metà duecento: fra tutti innocenzo iV, il pontefice del concilio di lione che
22 l. mainini
nel 1245 depose l’imperatore federico, colui il quale formulò la condanna e procedette all’expositio terrae, ovvero lo scioglimento del vincolo che legava i sud-diti al sovrano e la conseguente consegna delle terre avocate alla conquista d’un nuovo principe (29) – ciò che in vent’anni aprì le porte alla discesa angioina. nelle sue missive e nei documenti della sua cancel-leria innocenzo iV usa l’espressione zelatores fidei per definire, ancora una volta, un fronte politico o singoli individui che s’opposero alla politica federiciana in italia. Vos zelatores fidei orthodoxe, così il pontefice si rivolge, nel 1243, ad alcuni cives faventinos ristabilen-do questi ultimi nel possesso dei loro beni, usurpati dall’imperatore federico ii già scomunicato (30). Gli stessi zelatores fidei sono poi evocati da innocenzo iV nell’atto di restituire ad alberico da romano, meri-tevole d’aver abbandonato la pars sveva, i suoi diritti (1254) – già riconosciuti, durante l’interregno seguito alla morte di federico ii, dal pretendente all’impero (filo-papale) Guglielmo d’olanda, di cui in effetti il documento pontificio riproduce l’instrumentum:
(...) considerantes etiam nephandam malitiam et obs-tinatam rebellionem ezelini fratris tui, qui contemptor excellentie nostre ac conculcator ecclesiastice liberta-tis eo minus de fide habere connitiur, quo in ipsius orthodoxe fidei zelatores crudelius et inhumanius desevire probatur, qui etiam vilipensis ecclesie clavibus friderico quondam imperatori patenter assistens ad ecclesie gre-mium pertinaciter redire contempsit (...) (31).
(29) cfr. o. haGEnEdEr, il diritto papale di deposizione del prin-cipe: i fondamenti canonistici, in id., il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli Xii e Xiii, a c. di M.P. alBErzoni, milano 2000, pp. 165-211.
(30) mGh, epistulae saeculi Xiii e regestis pontificum romanorum selectae, ii, p. 27.
(31) mGh, epistulae saeculi Xiii e regestis pontificum romanorum selectae, iii, p. 252.
23zelatores fidei, memorie federiciane
un’attestazione, quest’ultima, piuttosto rilevan-te, giacché esprime, nel riconoscimento dei diritti d’alberico, l’abolizione e la revoca delle precedenti concessioni federiciane ad ezzelino, fratello eretico e pervicacemente filo-svevo dello stesso alberico. il ca-rattere locale e “fazioso” di queste occorrenze – ben visibile nel tentativo papale d’orchestrare i rapporti diplomatici tra l’uno e l’altro da romano, e con ciò di rompere il fronte federiciano in Veneto – mostra chiaramente come la formula zelatores fidei, fra Xiii e XiV secolo, potesse coprire un campo della semantica politica circoscrivibile nelle lotte italiane contro fe-derico ii, finendo per trattenere, nelle maglie d’una simile definizione, chiunque prestasse servizio contro l’espansione politica dello svevo.
se quindi nella pagina dantesca dovesse insistere davvero un tale precipitato di significati storico-politi-ci, ne risulterebbe, da un lato, avvalorata la proposta di Quaglioni – che legge negli zelatores fidei danteschi un riferimento polemico al guelfismo radicale – ma, d’altra parte, occorrerà comunque spiegare in che misura, per dante, la memoria federiciana agisse ancora nel conflitto “moderno”, ovvero, girato ormai il secolo, nella nuova rivendicazione degli iura imperii una volta tramontata l’opzione sveva, ormai affermata l’egemonia angioina in italia e stabilito, o in via di stabilizzarsi, l’asse preferenziale franco-pontificio. in definitiva bisognerà rispondere alla domanda seguen-te: se la formula zelatores fidei designa prioritariamen-te, sul piano storico, il fronte guelfo anti-federiciano attivo alla metà del Xiii secolo, in che modo dante può reiterarne ed intensificarne il significato a di-stanza d’almeno mezzo secolo dalla fine dell’espe-rienza sveva? in prospettiva dantesca, l’attualità della memoria federiciana, la sua pregnanza ben oltre i limiti cronologici dell’esperienza storica, sembra testi-moniata proprio dal suo carattere fallimentare, dal la-scito incompiuto che contraddistingue l’operato dello
24 l. mainini
svevo. se federico ii è davvero « ultimo imperadore delli romani » (convivio iV iii, 6), è chiaro allora che sarà l’intero progetto imperiale ad interrompersi col fallimento federiciano, e, di conseguenza, ogni nuovo discorso imperiale (32), ogni sua ripresa, dovrà per forza ricucire il filo là dove s’era spezzato: nel conflittuale avvicendamento svevo-angioino, per quel che spetta all’italia, e nella perdita d’universalitas da parte dell’impero, nella sua riduzione a mera autorità territoriale – una fra le altre –, per quel che spetta all’europa. in tal senso – si vedrà – la presenza dei sovrani francesi ed angioini fra coloro i quali si di-chiarano, pretestuosamente (33), zelatores fidei instrada il resto del ragionamento. tenendo ferma dunque questa presenza d’oltralpe, che nel 1268, con l’uccisio-ne dell’ultimo svevo, interrompe la vocazione italiana dell’impero, costringendo quest’ultimo a rincorrere, sul piano politico-geografico, l’espansione proto-na-zionale franco-angioina, si tratterà adesso d’esplorare, tra gli argomenti della monarchia, la funzione attiva della « componente federiciana » (34). una componente che trascende la dimensione evenemenziale e che,
(32) cfr. per un quadro generale F. FontanElla, l’impero romano nel convivio e nella monarchia, in « studi danteschi », 79 (2014), pp. 39-142.
(33) pretestuosamente, giacché, com’è ovvio, in prospettiva dantesca, la tutela francese ed angioina sulla chiesa è in realtà fonte di danno; in primo luogo per la chiesa stessa. e d’altra parte, contro i falsi sostenitori della chiesa, gli stessi imperatori – federico ii (mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, ii, p. 289) come enrico Vii (nel documento d’elezione, mGh, leges, ii, p. 490) – possono attribuirsi, più autenticamente, il titolo di zelatores fidei. sul rapporto tra chiesa e monarchia fran-cese convertito da dante in quello tra la “puttana” e il “gigante”, cfr. ancora FEnzi, tra religione e politica cit., pp. 110-117 e, per una lettura allegorizzante, l. PErtilE, la puttana e il gigante. dal cantico dei cantici al Paradiso terrestre, ravenna 1998, pp. 203-225.
(34) prendiamo l’espressione dall’importante saggio di a. Val-lonE, la componente federiciana della cultura dantesca, in dante e
25zelatores fidei, memorie federiciane
come ha spiegato Vallone, agisce in dante « per istinto e per meditazione » (35): essa costituiva, da una parte, la prova vivente che l’universalità imperiale, oltre che presupposto ontologico della natura umana, fosse pure visione politica effettivamente praticabile e, d’altra parte, nel suo sostanziare sapere e potere, l’esemplarità federiciana ricapitola quella « fermezza laica che rompe col papa, ma non con la chiesa », sciogliendo « i legami retorici alla letteratura e alla scienza » fino a renderle « vive e operanti » tra gli uomini (36).
in effetti, tornando a quanto si diceva sull’artico-lazione tematica del trattato dantesco, ad un sguardo quantitativo – che sappia in qualche modo pesare gli argomenti – appare ben più problematico il rap-porto imperium-regnum (franco-angioino) che quello impero-chiesa. del resto, la dialettica delle giurisdi-zioni imperiali e papali, seppur soggetta a progres-sive riformulazioni e tensioni repentine, seguiva un andamento piuttosto stabile, irreggimentato da un secolare dibattito giuridico-politico e da una prassi governativa ormai sedimentata da entrambe le parti. detto banalmente, lungo il Xiii secolo, la chiesa non ha mai contestato, alla radice, il diritto d’esistenza dell’impero – neppure con l’impennata teocratica d’innocenzo iV. essa piuttosto ha giocato sulla labile distinzione tra la sua plenitudo potestatis – ovvero una piena supremazia spirituale, tale da ricadere nel se-colo come ultima e maggiore istanza del potere – ed il suo effettivo governo temporale. si tratta dunque d’una relazione tendenzialmente verticale, nella misura in cui le contestazioni pontificie al potere imperiale
roma. atti del convegno di studi (roma, 8-9-10 aprile 1965), firenze 1965, pp. 347-369.
(35) ibid., p. 347.(36) ibid., p. 355.
26 l. mainini
pretendono di venire dall’alto, dal duplice gladio che dio ha conferito alla chiesa; ma comunque, anche in questa visione ormai radicalizzata, la legittima esisten-za dei due poteri, in linea con i principi generali del-la dottrina gelasiana, resta confermata: « christus (...) officia potestatis utriusque discrevit » (37). al contrario, una contestazione orizzontale – ovvero eminentemente “moderna”, geo-politica – della legittimità imperiale poteva venire dai regna, e da uno in particolare – il più “orizzontale”, esteso ed ambizioso –, la francia capetingia. È in gioco dunque una dialettica tra “ver-ticalizzazioni” teocratiche ed estensioni “orizzontali” proto-nazionali, tra longitudini e latitudini del potere, all’interno delle quali l’impero sembra catturato. ne rende parziale testimonianza un pontefice duecentesco a cui s’è soliti attribuire una certa moderazione nelle cose temprali (38). innocenzo iii distingue infatti la sua plenitudo spirituale, estesa sull’orbe, dalla latitudo tem-porale del suo potere, il governo effettivo, esercitato primariamente sul Patrimonium sancti Petri, che quindi rappresenterebbe l’orizzontalità – apparentemente cir-coscritta – dell’autorità papale nel secolo (39).
tuttavia, altrove, la vocazione orizzontale del po-tere – unita a pratiche sacrali che ne verticalizzano l’ascensione – appare meno contenuta. la lettera, datata 1312, che il re di francia filippo il Bello in-via all’imperatore enrico Vii è, allora, uno dei più chiari esempi della relativizzazione orizzontale cui è sottoposto l’impero, in quanto strategia politica della dinastia francese. il re di francia rifiuta in quell’oc-
(37) GElasii tomus de anathematis vinculo, pl, vol. 59, c. 109.(38) cfr. G. taBacco, teocrazia papale e rinnovamento dell’idea
gelasiana, in id., la relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al XiV secolo, a c. di l. GaFFuri, firenze 2010 (i ed. torino 1950), pp. 119-162.
(39) o. haGEnEdEr, il paragone sole-luna in innocenzo iii. tentativo d’una nuova interpretazione, in id., il sole e la luna cit., p. 50.
27zelatores fidei, memorie federiciane
casione le premesse politiche generali che enrico Vii accludeva alla sua enciclica. se l’imperatore affermava l’universalità del suo potere e ne derivava che « uni-versi homines distincti regnis et provinciis separatis uni principi monarche subessent » (40), il re francese, da parte sua, ricordava al sedicente unico monarca che « notorie namque et generaliter predicatur ab omnibus et ubique, quod a tempore christi citra regnum francorum solum regem suum (...) habuit, nullum temporalem superiorem cognoscens aut ha-bens, quocumque imperatore regnante » (41). si tratta, in definitiva, dell’exemptio ab imperio, rivendicata più volta dai sovrani capetingi (42). se dunque si presta attenzione all’economia tematica della monarchia, sarà difficile non constatare come fosse quest’ordine di problemi a muovere la riflessione dantesca (43), tanto più se si accetta, nella sua inequivocabile precisione, la definizione di monarchia che dante stesso elabora: « est ergo temporalis monarchia, quam dicunt “impe-rium”, unicus principatus et super omnes in tempore vel in hiis et super hiis que tempore mensurantur » (i ii, 2). l’impero che ha in mente dante non gareggia dunque con la chiesa sul terreno della « verticalità » atemporale, eterna, ma con tutti quei regna – e dun-que anche con la chiesa, nella misura in cui essa si secolarizza – che minacciano il suo potere orizzontale misurato nel mondo. a quest’impostazione si confor-ma tutto il trattato dantesco, anche quando, giunto alla
(40) mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, iV/2, p. 802.
(41) ibid., p. 813.(42) cfr. r. FEEnstra, Jean de Blanot et la formule ‘rex franciae
in regno suo princeps est’, in Études d’histoire du droit canonique dédiées à gabriel le Bras, 2 voll., paris 1965, vol. ii, pp. 885-895.
(43) Già de Vergottini ne segnalava la pregnanza, cfr. G. dE VErGottini, lezioni di storia del diritto italiano. il diritto pubblico italiano nei secoli Xii-XV, a c. di c. dolcini, milano 1993, pp. 94-95.
28 l. mainini
terza questione, affronterà la dialettica chiesa-impero. una più autentica dimensione tematica, quindi, che appare ancor più chiara se si confronta l’orizzonta-lità della prassi politica franco-angioina con ciò che la monarchia dantesca dice degli alii reges, ovvero di quei sovrani che non sottostanno all’impero: « reges et principes in hoc unico concordantes: ut adversen-tur domino suo et uncto suo, romano principi » (ii i, 3), una sollevazione, dunque, degli alii reges contro l’unico monarca, che sembra evocare – qualunque sia la datazione precisa del trattato dantesco – la politi-ca e la diplomazia antimperiale messa in atto dagli angioini in territorio italiano (44). Basti qui ricordare la lettera di roberto d’angiò rex sicilie al re d’ara-gona (1312): « item recepimus noviter nove de curia, qualiter rex francie et navarre ac alii fratres et filii in consistorio coram papa proposuerunt multum pro nobis favorabiliter, offerendo in subsidium nostrum personas regis et totum eorum posse et multa dixe-runt contra regem romanorum (...) » (45). ora veramen-te, da questa prospettiva, l’impero – quello storico come quello progettato da dante – trovava nella monarchia francese e nelle sue emanazioni angioine un limite estremo (46), il cui culmine potrebbe forse rintracciarsi, come del resto già suggeriva fenzi, non tanto nell’« esplicito comportamento antimperiale » dei sovrani francesi quanto invece nella loro « pura e semplice indifferenza » (47) all’idea d’impero. indiffe-
(44) da cui alcuni inferiscono il momento storico in cui la monarchia sarebbe stata composta: « che ciò, appunto storicamente, corrisponda al contesto creatosi in italia tra il 1311 e il 1312 non è dubitabile », casadEi, sicut in Paradiso cit., pp. 183-184.
(45) mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, iV/2, p. 1428.
(46) chi « al pubblico segno i gigli gialli / oppone (...) », Pd. Vi, vv. 100-101.
(47) FEnzi, tra religione e politica cit., pp. 86-87.
29zelatores fidei, memorie federiciane
renza che trova infine quell’estemporanea eccezione, capace di confermarne la regola: la candidatura fal-lita, nel 1273, di filippo iii l’ardito, allora già re di francia, al trono imperiale, e fortemente auspicata proprio dallo zio dell’interessato, carlo i d’angiò, re di sicilia (48). che il nipote capetingio concorresse al trono imperiale premeva a tal punto all’angioino che egli ne lasciò memoria scritta (49): il nuovo re di sicilia immaginava allora un impero “francese” radicalmente estraneo alla tradizione sveva, e ben conscio della profonda trasformazione che implicava. « li roiaumes de france ne est que uns roiaumes », eppure potrà ben essere il titolare d’un « ampire » finalmente uni-versale; carlo i elenca pertanto, con una certa dose di malizia, la rete matrimoniale francese già estesa a quasi tutta l’europa, « si que il n’i a que faire aliance à un poi d’alemans » per ambire pienamente al titolo. sarà allora un impero, quello dei francesi, finalmente sovraordinato alla sua perenne crisi italiana – « que il mette pais antre X lombards et Xl toqs » –, e tutto ciò a gloria d’un « servise deu », d’una lotta agli « annemis de la foi » (50), che ben spiega le future evoluzioni degli zelatores fidei.
(48) cfr. c. JonEs, “...mais tot por le servise deu” ? Phillippe iii le Hardi, charles d’anjou and the 1273/74 imperial candidature, in « Viator » 34 (2003), pp. 208-228, ma pure caPo, da andrea ungaro a guillaume de nangis cit. in particolare pp. 842-849 e G. zEllEr, les rois de france candidats à l’empire. essai sur l’idéologie impériale en france, in « revue historique », 173 (1934), pp. 273-311, 497-534. cfr. inoltre, in prospettiva più ampia e in sede di dibattito sto-riografico, G. taBacco, un presunto disegno domenicano-angioino per l’unificazione politica dell’italia, in « rivista storica italiana », 61 (1949), pp. 489-525.
(49) cfr. raisons du roi de sicile au sujet de la couronne impériale et de la candidature du roi Philippe le Hardi, in documents histori-ques inédits tirés des collections de la Bibliothèque royale, vol. i, éd. chaMPollion-FiGEac, paris 1841, pp. 655-656.
(50) ibidem.
30 l. mainini
V’è un luogo della monarchia dantesca in cui tutte le tracce fin qui seguite – l’ontologica universalità imperiale, la memoria federiciana e la coscienza delle minacce franco-angioine all’unità dell’imperium – po-trebbero convergere e poi crollare nella coerenza d’un nuovo discorso politico. si tratta della discussione intorno alla donatio constantini (monarchia iii X, 3 – iii Xi, 3).
Già nardi poggiava la sua lettura d’insieme del trattato dantesco sulla donazione pseudo-costantinia-na, il « celebre falso » (51), e i suoi esiti “moderni” – a dire il vero, per nardi più teologici che politici – nella conseguente conflittualità delle due giurisdizioni, papale ed imperiale. tuttavia ciò che in nardi sembra restare inesplorato è proprio la possibile “componente federiciana” e l’esemplarità, o valorizzazione ontolo-gica, di quest’ultima nel quadro della più generale teoria dantesca dell’imperium (52). nardi infatti arriva-va a proiettare il valore dantesco della donazione pseudo-costantiniana non oltre federico Barbarossa e la sua “civilistica” protesta contro la subordinazione dell’impero al papato (1154-1158). sebbene spesso sfiori, nelle sue argomentazioni, gli anni di federico ii e di manfredi, nardi in definitiva tratta la discussione dantesca intorno alla donatio come se la monarchia s’attenesse, più o meno disciplinarmente, al pensiero giuridico romanistico sorto intorno al Barbarossa ed
(51) B. nardi, intorno ad una nuova interpretazione del terzo libro della monarchia dantesca, in id., dal “convivio” alla “commedia” (sei saggi danteschi), roma 1960, p. 156.
(52) Già G. angiolillo tentò una comparazione tra alcuni brani della monarchia e il cosiddetto manifesto di manfredi, cfr. G. anGiolillo, il ‘manifesto’ di manfredi ai romani e il iii libro della ‘monarchia’ di dante, in Ead., tra ‘l vero e lo ‘ntelletto (vecchi e nuovi studi danteschi), napoli 1987, pp. 147-172. ma si veda pure la voce “manfredi re di sicilia”, stesa da a. FruGoni, in enciclopedia dantesca, vol. iii, roma 1984, pp. 802-804.
31zelatores fidei, memorie federiciane
eventualmente aggiornato dalle successive generazioni di maestri bolognesi ed orleanesi (53) – ciò che può ed anzi probabilmente sarà vero sul piano delle fonti, dirette od indirette, ma che non spiega molto del progetto dantesco iuxta propria principia, ovvero ciò che dante fosse disposto a fare delle “fonti” dislocate e riscritte nel suo trattato.
l’esperienza federiciana invece, se colta come sfondo semantico per l’identificazione degli zelatores fidei, andrà spinta oltre, giacché in essa s’innesta storicamente quell’aspirazione ontologica – quel naturale desiderio, potremmo dire col convivio (54) – d’unitas e d’universalitas a cui l’impero dantesco non può non tendere; mentre la conflittuale successione angioina e la consegna papale del regnum sicilie a carlo d’angiò ed ai suoi eredi ne rappresenta storicamente, per dante, l’altrettanto ontologica crisi. l’opposizione e il decadimento insito nelle due “epoche” che si susse-guono – quella sveva e quella angioino-aragonese che, dopo il Vespro, regnava bipartita nel mezzogiorno d’italia – è ben espressa già nel de vulgari:
sed hec fame trinacrie terre (...) videtur tantum in obproprium ytalorum principum remanisse, qui non he-roico more sed plebeio secuntur superbiam. siquidem illustres heroes, fredericus cesar et benegenitus eius manfredus, nobilitatem ac rectitudinem sue forme pan-dentes (...), humana secuti sunt, brutalia dedignantes (i Xii, 3-4) (55).
(53) B. nardi, dante il “buon Barbarossa”, ossia introduzione alla monarchia di dante, in dantE aliGhiEri, opere minori, t. ii, milano-napoli 1979, pp. 241-269.
(54) Vallone ha illustrato come il topos del “desiderio naturale” potesse giungere a dante tanto per via aristotelica quanto per mediazioni federiciane, cfr. la componente federiciana cit., p. 365.
(55) dantE aliGhiEri, de vulgari eloquentia, a c. di P.V. MEn-Galdo, padova 1968, p. 20.
32 l. mainini
chi fossero i principi italiani cui tornava ad onta la memoria federiciana – indegni dunque di quell’e-redità – è detto subito dopo: il “novissimo” federico d’aragona, carlo ii d’angiò ed altri “superbi plebei” d’italia (i Xii, 5). si tratta, del resto, degli stessi « principi e tiranni » additati ed accusati in convivio iV Vi, 20: « (...) e dico a voi, carlo e federigo regi, e a voi altri principi e tiranni ».
l’ipotesi che vorremmo avanzare ci spinge adesso a leggere in sinossi le lotte per la successione federi-ciana in italia e il rifiuto dantesco della donatio con-stantini – della sua validità giuridica, ovvero lo smem-bramento dell’impero, a favore del potere temporale ecclesiastico, ch’essa avrebbe comportato. l’eventuale giacenza d’una memoria federiciana nella discussione dantesca intorno alla donazione pseudo-costantiniana rivelerebbe infine il carattere tutt’altro che accessorio, “disputante” e scolastico, di molti temi evocati nella monarchia – dagli zelatores fidei alla reductio ad unum dell’umanità come scopo politico dell’impero, fino all’indivisibilità dell’imperium stesso. in definitiva, ci sembra che nella crisi dell’esperienza federiciana dante potesse scorgere l’uso più recente, e dannoso – il più vicino alla sua immediata esperienza storico-politica –, degli argomenti pseudo-costantiniani.
la natura del potere federiciano era, del resto, in se stessa problematica e si prestava bene alla polemi-ca. la sua ascendenza normanno-siciliana, per parte di madre, costanza d’altavilla, e svevo-imperiale, per parte di padre, enrico Vi, rendeva federico legittimo sovrano del regnum sicilie e al contempo imperatore, una volta risolte in suo favore le lotte tra filippo di svevia ed ottone iV (1198-1215) per la successione a enrico Vi. Già con l’imperium di quest’ultimo, e di nuovo nel confronto tra filippo e ottone, a fare problema, nei rapporti tra l’impero e la chiesa, era proprio il destino del regnum sicilie, che, se i sovrani normanni tenevano in feudo dalla chiesa,
33zelatores fidei, memorie federiciane
adesso, con l’unione matrimoniale normanno-sveva, scivolava pericolosamente verso i territori imperiali, sino a far temere, da parte pontificia, un’inaccetta-bile unio regni ad imperium. la questione storica e storiografica è gravosa – ne va, sul piano epocale, dell’opzione “mediterranea” o “tellurica” dell’europa moderna (56) – e supera di gran lunga le nostre capa-cità sia di dirimerne i nodi maggiori sia di dispie-garne l’intera problematicità. tuttavia, a differenza di chi, ponendosi sul piano dello ius, contesta agli svevi la legittimità, fosse pure ideologica, d’avocare all’impero il regno siciliano (57), noi guardiamo piut-tosto alla storicità reale d’una simile ideologia – ciò che permette d’osservare, legittime o no che fossero le pretese sveve, il ruolo effettivamente svolto dal problema dell’unio regni nella più generale dinamica dell’impero federiciano. da questa specifica prospet-tiva, non si potrà allora negare che cha dal giorno del matrimonio tra enrico Vi e costanza d’altavilla (58) sino a tutto il regno di federico ii, passando per le lotte tra filippo di svevia e ottone iV (59), i rapporti tra l’impero e la chiesa oscillarono in funzione delle promesse imperiali, mantenute o disattese – legittima-mente o illegittimamente –, di tener disgiunti regnum
(56) fernand Braudel parlava in tal senso di « telestorie », F. BraudEl, la storia, in il mediterraneo. lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, milano 2005, p. 105-108.
(57) si vedano, ad esempio di quest’approccio, le riflessioni di G. Galasso, una certa idea di federico ii, in id., medioevo euro-mediterraneo e mezzogiorno d’italia da giustiniano a federico ii, roma-Bari 2009, pp. 392-399 e con maggior profitto, nello stesso volume, “unio regni ad imperium”?, pp. 400-406.
(58) cfr. P. zErBi, Papato e regno meridionale dal 1189 al 1198, in Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). atti delle quinte giornate normanno-sveve (Bari-conversano, 26-28 ottobre 1981), Bari 1983, pp. 49-73.
(59) G. taBacco, impero e regno meridionale, ibid., pp. 13-48.
34 l. mainini
ed imperium. la casistica è in tal senso abbondante (60). la prospettiva dell’unio regni ad imperium, ovvero lo sforzo di portare stabilmente il mezzogiorno d’italia nell’orbita imperiale, restaurando al contempo gli iura imperii nel centro-nord della penisola, costituiva allora la prestazione specifica dell’« attività italiana e ten-denzialmente universale degli svevi (...): il dominium mundi a cui l’impero ideologicamente aspirava era il prolungamento tendenzialmente illimitato, fuori dei suoi confini territoriali, di un sistema di collegamenti già in vigore entro i suoi stessi confini » (61). risulta evidente in tale prospettiva quale fosse il peso del regnum sicilie, haereditas sveva per via normanna, nel momento in cui gli stessi svevi detenevano de iure l’impero; quel che s’apriva era allora un squarcio tra due diritti, il feudale per il mezzogiorno italiano, e il “collegiale” e “consacrato” per l’accesso all’im-pero, uno iato giuridico che, in prospettiva sveva, e federiciana in particolare, risultava colmabile solo per via politica. si capirà anche quale potesse essere l’opposizione della chiesa romana ad una soluzione politica della questione, tanto più quando la chiesa stessa si riteneva, giuridicamente, ultima istanza del regnum sicilie, fin lì tenuto in feudo, per suo conto, dai sovrani normanni. l’opposizione voluta da Ga-lasso tra ius e ideologia (62), tra dimensione giuridica del problema e dimensione storiografica – dove solo la prima sarebbe quella corretta ed oggettiva –, si rivela dunque, da questo punto di vista, “faziosa” quanto l’approccio che vorrebbe confutare, giacché scegliere le parti dello ius, in questa vicenda, significa
(60) raccolta e discussa da G. BaaKEn, ius imperii ad regnum. Königreich sizilien, imperium romanum und römisches Papsttum vom tode Kaiser Heinrichs Vi. bis zu den Verzichtserklärungen rudolfs von Habsburg, Köln-Weimar-Wien 1993.
(61) taBacco, impero cit., pp. 23-24. (62) Galasso, “unio regni ad imperium” cit.
35zelatores fidei, memorie federiciane
tendenzialmente scegliere una delle parti in campo, la chiesa romana. in effetti, di fronte al diritto feudale invocato dalla chiesa, il tentativo svevo d’accludere stabilmente la pars italie e il mezzogiorno all’impero, che comportava in linea teorica anche la fine d’ogni rapporto vassallatico dei sovrani siciliani (e in questo caso imperatori) col papato, non poteva che svilup-parsi su un piano eminentemente politico, e con ciò ideologico (63). « ideologie e strutture – come scriveva tabacco (64) – si confortavano (...) reciprocamente ».
ora è chiaro che con il regnum e l’imperium di federico ii la questione si acuisce fino ad implode-re. un esito, del resto, prevedibile e previsto, se nel 1209, quando ancora era dubbio il titolo imperiale per federico ii, ottone iV, pretendente allo stesso onore, rivolgendosi ad innocenzo iii, enumerava tutte le possessiones italiane che egli era disposto a riconoscere ed attribuire stabilmente alla chiesa, riservando un paragrafo a parte per il regnum sicilie: « adiutores etiam erimus ad rettinendum et defendendum eccle-sie romane regnum sicilie ac cetera iura que ad eam pertinere noscuntur » (65). analoga promessa – disattesa – fece, com’è noto, più volte lo stesso federico ii, ed ancora nel 1220: « (...) promittimus et concedimus (...), postquam fuerimus imperii coronam adepti, regnum sicilie (...) relinquamus (...) ab ecclesia romana tenen-dum, sicut nos illud ab ipsa sola tenemus » (66). come si vede, è qui lo stesso federico ii a riconoscere la
(63) assume importanza in questa prospettiva la “geografia mobile” della corte federiciana e la mappatura del suo “governo”, cfr. c. Brühl, l’itinerario italiano dell’imperatore 1220-1250, in federico ii e le città italiane, a c. di P. touBErt e a. ParaVicini BaGliani, palermo 1994, pp. 34-47
(64) taBacco, impero cit., p. 22. (65) mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum,
ii, p. 37.(66) ibid., p. 82.
36 l. mainini
dimensione giuridico-feudale favorevole alla chiesa, che tuttavia politicamente egli non assecondò e che, anzi, rinviò, ormai esasperata e forse insolvibile, alla generazione seguente dei suoi figli (corrado iV e manfredi) e nipoti (corradino), dimostrando in tal modo come ormai il problema del regnum meridio-nale tendesse a divenire tutt’uno con l’eredità svevo-imperiale. per quanto fossero unite in federico stesso – che cadenza la sua titolatura in romanorum imperator augustus, rex sicilie e rex ierusalem –, si può dire, a posteriori, che le due dimensioni del potere svevo simul stabunt simul cadunt, come effettivamente avvenne e come del resto già si paventava intorno ad enri-co Vi, primo imperatore svevo a vivere direttamente, nel sangue, la criticità del problema siculo-germanico, quando si pose la questione dell’ere ditarietà dell’im-pero, fin lì irrisolta nella tradizione tedesca (67). al ri-guardo, da una parte, la chiesa non poteva che rilevare il pericolo d’una trasformazione dell’impero in senso ereditario (68), dall’altra, fonti imperiali sanno cogliere espressamente la relazione tra la questione ereditaria e quella meridionale:
imperator siquidem, quia heredem susceperat de regina, unde ei terre supradicte [apulia, sicilia e cala-bria] attinebant, cupiens efficere, ut communi assensu omnium principum imperii imperium ad proximum heredem quasi hereditario iure transiret, et ad hoc inducere omnium consensum principum, ut electioni, que semper habita et habenda est, substitueretur ius hereditarium (69).
(67) cfr. taBacco, impero cit., pp. 29-30.(68) cfr. M. Bloch, l’empire et l’idée d’empire sous les Hohen-
staufen, in id., mélanges historiques, 2 voll., paris 1963, vol. i, in particolare pp. 534-539.
(69) mGh, scriptores rerum germanicarum (nova series), V, pp. 113-114.
37zelatores fidei, memorie federiciane
si tratta tuttavia d’un progetto che la stessa Historia de expeditione friderici dà per fallito. emergo-no così più chiaramente l’universalità, l’unitarietà e l’indivisibilità cui almeno provvisoriamente, o proget-tualmente, dovette ambire l’impero svevo (70).
ciò detto, quel che interessa in chiave dantesca è il ruolo della donatio constantini nelle polemiche che accompagnarono la crisi dell’esperienza federiciana, la fine del suo progetto universalistico e l’avvicenda-mento angioino nel mezzogiorno d’italia. il concilio di lione, presieduto da innocenzo iV, che nel 1245 depose federico ii, nell’elencare le colpe e i peccati che avevano reso lo svevo « imperio et regnis (...) indignum » (71), si sofferma lungamente, com’è ov-vio che sia, sulla promessa disattesa di disgiungere dall’imperium quel regno siciliano « quod est – dice il pontefice – speciale patrimonium beati petri », ovvero dominio temporale della chiesa romana, inglobato alle terre ricevute con la donatio pseudo-costantiniana. l’indegnità di federico autorizza alla sua deposizione, le cui conseguenze politiche prevedranno, da parte imperiale, l’elezione d’un nuovo imperator e, per quel che spetta al regno meridionale, una gestione discre-zionale da parte della chiesa stessa: « illi autem, ad quos in eodem imperio imperatoris spectat electio, eligant libere succesorem. de prefato vero sicilie regno providere curabimus cum eorundem fratrum nostrorum consilio, sicut viderimus expedire » (72).
(70) sono queste, del resto, le premesse per la costruzione del mito di federico ii in quanto imperatore “unificante”: colui il quale viene a chiudere i tempi, d’oriente e d’occidente, secon-do la profezia tiburtina, testo pseudo-profetico, parte integrante dell’ “armamentario” storiografico europeo fra Xii e Xiii secolo, cfr. F. dEllE donnE, federico ii: la condanna della memoria, roma 2012, in particolare pp. 18-25.
(71) mGh, epistulae saeculi Xiii e regestis pontificum romanorum selectae, ii, p. 141.
(72) ibid., p. 94.
38 l. mainini
il diritto feudale sul regnum siciliano si riconosce in definitiva conseguenza del Patrimonium Petri esteso fino al mezzogiorno d’italia – ciò che autorizza la chiesa romana a disporne, una volta deposto fede-rico, come d’una propria possessio. il documento eger cui lenia (1245) – prodotto o dallo stesso innocenzo iV o comunque dal suo milieu politico (73) – è in tal senso ancora più esplicito. si tratta d’un “libello” in cui si confermano e si specificano dal punto di vista ideo-logico le ragioni della condanna e della deposizione di federico ii. non è il caso d’osservare le tangenze tematiche tra gli argomenti ierocratici dell’eger cui lenia e la confutazione delle tesi teocratiche nella mo-narchia dantesca, giacché si tratta, in definitiva, d’un repertorio d’argomenti piuttosto condiviso in tutte le fasi della controversia tra chiesa e impero (l’unzione, il vicariato di cristo, gli exempla biblici, lo “sciogliere” e il “legare” petrini). ciò che invece conta rilevare è come l’eger cui lenia introduca apertamente la dona-zione pseudo-costantiniana nel cuore della polemica anti-federiciana, usandola, per giunta, non come sem-plice avallo agli iura ecclesie sul territorio del Patrimo-nium Petri ma, di più, come un diritto sovraordinato all’imperium. alle proteste di federico che considerava inaccettabile esser rimosso dalla sua piena sovranità, sull’impero e sul regno, per mano d’un concilio – « (...) contra deum et iustitiam (...) iurisdictionem et auctoritatem usurpant instituendi et destituendi seu removendi ab imperio, regnis, principatibus et hono-ribus suis imperatores, reges et principes (...) » (74) –,
(73) per un panorama del contesto ideologico e pubblicistico cui appartiene il documento in questione cfr. F. dEllE donnE, il Papa e l’anticristo. Poteri universali e attese escatologiche all’epoca d’innocenzo iV e federico ii, in « arnos. archivio normanno-svevo », 4, 2013/2014, a c. di E. d’anGElo e F. dEllE donnE, pp. 17-43.
(74) mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, ii, p. 370.
39zelatores fidei, memorie federiciane
il documento di parte papale opponeva l’autorità del romano pontefice « super gentes et regna » (75), un’au-torità che a questo punto non è neppure “concessa” da costantino ma che piuttosto tornava alla chiesa per mezzo di costantino – « constantinus (...) ecclesie resignavit » (76) – giacché il « principatum (...) prius erat naturaliter et potentialiter apud eam » (77). ne conse-gue che la « materialis potestas gladii apud ecclesiam est implicata, sed per imperatorem, qui eam inde recipit, explicatur, et que in sinu ecclesie potentialis est solummodo et inclusa, fit, cum transferetur in princi-pem, actualis » (78). l’impero, in quest’ardita prospettiva teocratico-aristotelica, sarebbe l’atto d’una potenza che di per sé risiede nella chiesa. sarebbe interessante fermarsi ad osservare come quest’imperium definito atto d’una potenza che appartiene all’ecclesia somigli – pericolosamente – al suo identico-opposto, ovvero alla nozione dantesca dell’imperium come atto della multitudo umana, ma s’apri rebbe qui una discussione sul carattere radicalmente “ecclesiologico” – più che semplicemente averroistico – della multitudo dantesca e del suo intellectus possibilis, che trascende i limiti di queste pagine (79). Guardiamo invece a come lo stesso nodo psuedo-costantiniano, il diritto ecclesiastico sul regnum meridionale, permanesse, a distanza d’oltre mezzo secolo, nella disputa italiana tra enrico Vii e roberto d’angiò, il quale già vedeva – come s’è det-
(75) P. hEdEr, ein Pamphlet der päpstlichen Kurie gegen Kaiser friedrich ii. von 1245/46 (‘eger cui lenia’), in « deutsches archiv für erforschung des mittelalters », 23 (1967), p. 519 (pp. 468-538).
(76) ibid., p. 521.(77) ibid., p. 520.(78) ibidem.(79) si veda tuttavia per un’impostazione del problema, al di
là dei suoi fini danteschi, c. dolcini, “eger cui lenia” (1245/46): innocenzo iV, tolomeo da lucca e guglielmo d’ockham, in « rivista di storia della chiesa in italia », 29 (1975), pp. 127-148.
40 l. mainini
to – nel suo conflitto col nuovo imperatore un esito moderno dell’antica lotta angioina contro federico ii ed i suoi eredi. il dossier del confronto giuridico-politico, emerso visibilmente negli anni il 1312-1313, fra enrico Vii e roberto d’angiò è in tal senso ricco d’indicazioni. ciò che trapela è la coscienza, ormai esplicitata nel fronte imperiale, che l’imperatore po-tesse ambire al regnum meridionale non tanto per ragioni dinastiche – giacché con enrico Vii la con-tinuità normanno-sveva s’era ormai interrotta – ma per il carattere intrinseco dell’impero che non tolle-ra riduzioni, così come vuole anche dante, alla sua aspirazione unitaria ed universalistica (80). Gli eventi della primavera 1312 – con l’imperatore che giunge a roma, ignorando le richieste papali e pressando sul fronte politico angioino e su roberto stesso, che sentì minacciato il suo regno e le sue prerogative nelle province centro-settentrionali – dimostrano forse che la vocazione italiana dell’impero era sul punto di riaccendersi. tuttavia, la legittimità di quest’estremo tentativo, come si diceva, non stava più nell’ “equivo-cità” dell’ascendenza federiciana, ma nella perentoria affermazione dell’universalitas imperiale: « totus enim mundus imperatoris est (...), imperator est dominus mundi », e dunque anche il « regnum sicilie et spe-cialiter insula sicilie sicut et cetere provincie sunt de imperio » (81). l’argomento, radicale e perentorio come neanche federico ii mai formulò, dev’essere stato comunque valutato in campo ecclesiastico, se la
(80) rinviamo alla relazione la “monarchia”, l’ideologia imperiale e la cancelleria di enrico Vii tenuta da d. Quaglioni in occasione del convegno enrico Vii, dante e Pisa. a settecento anni dalla morte dell’imperatore e dalla monarchia (pisa, 24-26 ottobre 2013). ringra-ziamo l’autore per averci concesso la lettura del contributo prima della sua pubblicazione.
(81) mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, iV/2, p. 1315.
41zelatores fidei, memorie federiciane
risposta d’un “memoriale” pontificio recita così: « (...) opponitur [quod] imperator est dominus mundi (...). ad hoc respondeo (...) locum haberent leges, que po-nunt limites imperii (...). et habet hec allegatio locum maxime in provinciis et terris ecclesie romane, quas imperator [costantino] voluit et discrevit a terris imperii fore distinctas, ut in palea sepius allegata ‘constanti-nus’, nec in illis imperator terrenus aliquam obtinet potestatem » (82). l’elaborazione di queste tesi avveniva a ridosso della sentenza emessa da enrico Vii contro roberto d’angiò, ed è chiaro dunque che la posta in gioco teorica fosse la liceità imperiale di condanna-re un sovrano, l’angioino, sul quale, in prospettiva papale, enrico non aveva alcuna potestà, giacché, in quanto re di sicilia, roberto dipendeva dallo ius della chiesa, di cui il regnum era « nobile pomerium (...) et ortus irrigus », che qualsiasi sovrano « a domino papa et ecclesia (...) tenet in feudum » (83). immutato nei suoi presupposti teorici si ripresenta dunque, a distanza d’oltre mezzo secolo, il conflitto, già federiciano, tra la legittimità giuridica, avanzata dalla chiesa, e la vo-cazione universalistica politico-ideologica dell’impero. la politicità, più che la giuridicità, della prospettiva imperiale è additata del resto dalla documentazione filo-angioina che, ricostruendo le vicende degli anni 1310-1313, colloca enrico Vii al centro d’una “rete” ghi-bellina all’interno della quale sarebbe stata ben radi-cata ormai l’idea dell’imperator dominus mundi intento a progettare la conquista di quel « regnum siclie » senza il quale « nunquam poteris hebere plenum dominium (...), sicut habuit quondam imperator federicus » (84).
ora, come sappiamo, enrico Vii non arrivò mai a mettere in opera un’invasione del mezzogiorno
(82) ibid., p. 1339.(83) ibid., p. 1315.(84) ibid., p. 1371.
42 l. mainini
d’italia, tutt’al più un tentativo d’alleanza con fe-derico d’aragona che, dopo i Vespri, teneva l’isola siciliana. ciò che conta, tuttavia, sono gli argomenti del confronto: l’avocazione del regnum meridionale alle possessiones ecclesiastiche del Patrimonium beati Petri – ciò che autorizzava la chiesa a disporre del regnum come meglio preferiva, dandolo in feudo agli angiò – e, d’altra parte, l’affermazione, certamente labile, da parte imperiale d’un universalismo cresciuto gradualmente con gli svevi.
torniamo finalmente a dante. se negli zelatores fidei andava scorto un riferimento al fronte guelfo franco-angioino e alla normatività – da ambo le parti, imperiale ed ecclesiastica – del momento fede-riciano, in quanto spartiacque nella definizione delle fisionomie politiche, adesso la proiezione di questi dati sui i giorni della discesa in italia d’enrico Vii porta a compimento la tensione politica, concettuale e semantica accumulata negli ultimi cinquant’anni del secolo Xiii. del resto, se gli zelatores danteschi sono accusati d’essere falsi amici della chiesa, perché in realtà usurpano i beni che la chiesa dovrebbe de-stinare ai pauperes christi, nella condanna di roberto d’angiò enrico Vii muove al suo ribelle la medesima accusa: « perturbationem prosperitatis ecclesiastice » (85). tuttavia, come s’è detto, l’effettiva portata dell’antico problema federiciano risalta ancor più chiaramente nelle pagine dantesche consacrate alla serrata discus-sione della donatio pseudo-costantiniana. al riguardo sembra che la critica si sia tendenzialmente sforzata di leggerne il significato all’interno del più vasto proble-ma riguardante il rapporto di dipendenza o indipen-
(85) mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, iV/2, p. 988.
43zelatores fidei, memorie federiciane
denza delle due giurisdizioni, papale ed imperiale (86) – atteggiamento storiografico indotto e autorizzato, del resto, dallo stesso dante che, effettivamente, al fine d’affermare la libertà dell’impero rispetto alla chiesa argomenta lungamente sui loro rapporti di sovra- o subordinazione. eppure, la questione intorno alla pseudo-donazione si apre nel testo dantesco, e si chiude, su una notazione – un movente, diremmo – più circoscritto e al tempo stesso storicamente più ri-levante. « dicunt adhuc quod constantinus imperator (...) imperii sedem, scilicet romam, donavit ecclesie cum multis aliis imperii dignitatibus. ex quo arguunt dignitates illas deinde neminem assummere posse nisi ab ecclesia recipiat, cuius eas esse dicunt » (monarchia, iii X, 1-2). in definitiva, in questo preambolo alla sua trattazione, dante individua come tema scatenante del conflitto non tanto l’unzione, il duplice gladio attri-buito alla chiesa o la consacrazione – che piuttosto sono manifestazioni successive del problema –, quanto invece il fatto che, tramite la pseudo-donazione, la chiesa avrebbe acquisito degli iura – un’orizzonta-lità storica – su dei territori specifici che, da quel momento in poi, nessuno avrebbe potuto governare senza prima riceverli – in feudum, diremmo – dalla chiesa che ne aveva la legittimità giuridica. È solo per confutare questa circostanza storico-giuridica che dante s’adopera nella sua più vasta trattazione della donatio. alla luce di quanto abbiamo fin qui detto, sembra dunque ragionevole supporre che soggiacesse a questa precisa impostazione del problema dantesco non tanto la questione generica – pur rilevante e certo implicata – dell’indipendenza imperiale rispetto al pontefice, ma quella specifica degli iura temporali di cui la chiesa, tramite la pseudo-donazione, poteva
(86) si torni in tal senso a B. nardi, la “donatio constantini” e dante, in id., nel mondo di dante, roma 1944, pp. 109-159.
44 l. mainini
disporre: saranno in effetti gli iura specifici, romani, italiani e meridionali – dignitates illas, dice dante –, a fare problema, giacché, come insegna la vicenda sici-liana, svevo-angioina, e la sua ripresa sotto enrico Vii – i casi politici che dante aveva certamente sott’oc-chio –, « nec est roma communis patria (...) cum sit ecclesie eius dominium ex donatione constantini » (87), né l’imperatore aveva diritti sul regnum meridionale e su roberto d’angiò in particolare, poiché il pontefice era l’« ordinarius [iudex] regis roberti (...) quia in suo territorio, scilicet regno, habet domicilium » (88), né tantomeno, nella prospettiva auspicata dagli angioini, l’imperatore « Ytalie partes attingat » (89).
tenendo ferme quest’evidenze, si capirà meglio anche il valore politico, dirimente, del finale di mo-narchia iii X, laddove dante afferma che il pontefice, semmai costantino gli avesse effettivamente donato qualcosa, non poteva comunque ricevere il “dono” « tanquam possessor, sed tanquam (...) dispensator » (iii X, 17). la distinzione giuridica – possessor-dispen-sator –, efficacemente evidenziata e discussa da una parte della critica (90), sembra sottendere ancora una volta – come già avveniva in apertura del capitolo – il nodo irrisolto della memoria federiciana e della sua moderna esemplarità politica. in effetti, è di nuovo con la deposizione di federico ii, l’avocazione del regnum sicilie alla chiesa e la sua offerta ai sovrani europei, e agli angiò in particolare, che i pontefici rivelarono il loro animus possidendi. la sicilia, o meglio
(87) mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum, iV/2, p. 1330.
(88) ibid., p. 1336.(89) ibid., p. 1372.(90) cfr. al riguardo il commento di Quaglioni, dantE aliGhiEri,
monarchia, ed. QuaGlioni cit., pp. 1350-1352. ma sulla questione della possessio/proprietà si vedano pure le note di Vinay, cfr. dantE aliGhiEri, monarchia, a c. di G. Vinay, firenze 1950, p. 254.
45zelatores fidei, memorie federiciane
il mezzogiorno d’italia, come possessio ecclesiastica è difatti un concetto antico. Già ai tempi del primo intervento normanno contro l’impero d’oriente nel meridione d’italia, la presenza bizantina nel mezzo-giorno offendeva la chiesa, « cuius regnum sicilie pro-pria possessio erat » (91). ma nell’arco temporale che più c’interessa – quello che costituirà il referente storico della teoria politica dantesca – sono i pontefici che gestirono la transizione svevo-angioina a riaffermare, con più affinati strumenti giuridici, uno ius possidendi sul regnum meridionale. urbano iV, nello stabilire con carlo d’angiò le conditiones super negotio regni sicilie (1263), afferma i diritti papali anche di fronte ai futuri signori del regno: « pro toto generali censu isporum regni et terre duo milia unciarum auri ad pondus ro-manum (...) ipsi romano pontifici et romane ecclesie annis singulis presolventur » (92), invitando il futuro re a prestare giuramento sul seguente articolo: « papatum romanum et regalia sancti petri tam in regno sicilie et terra predictis quam alibi existentia adiutor eis ero ad retinendum et defendendum ac recuperandum et recupe-rata manutenendum contra omnem hominem ». in definitiva quel che si prefigura tra il pontefice ed il sovrano angioino sembra un rapporto quasi modulato sulla distinzione tra lo ius possidendi, il diritto pontificio alla proprietà, e lo ius possessionis di chi “mantiene” il regno e ne ha la tutela e il godimento. ciò che, del resto, urgeva ai pontefici, come esprimerà bene clemente iV, era evitare un nuovo accerchiamento imperiale intorno al diretto patrimonio petrino, sven-tare in definitiva il rischio d’una nuova unio regni ad imperium: nel 1265 il papa francese specificherà infatti che chiunque sia eletto « regem vel imperatorem
(91) mGh, scriptores, XXii, p. 497(92) mGh, epistulae saeculi Xiii e regestis pontificum romanorum
selectae, iii, p. 512.
46 l. mainini
romanorum, (...) regem theutonie vel dominum lombardie seu tuscie sive maioris partis earum (...) nullatenus possessionem eorundem regni sicilie et terre nanciscatur et habeat » (93).
ciò detto, l’animus possidendi della chiesa romana, svolto nell’esercizio dei suoi iura pseudo-costantiniani, rappresenta uno dei maggiori ostacoli a quell’univer-salitas e a quell’unitas cui l’impero dantesco – come pure ideologicamente lo svevo – miravano. se doves-simo quindi guardare alla cronaca due e trecentesca, quell’unitas imperiale che « divisionem non patitur » (monarchia iii X, 16) aveva subito perdite, in tempi re-centi, proprio sul fronte meridionale ed in virtù d’una chiesa che possedeva invece d’amministrare e dispen-sare. sembrerebbe allora sussistere un filo rosso tra la genealogia degli zelatores fidei, colti nella loro origine anti-federiciana, e gli esiti successivi dell’argomentazio-ne dantesca, giacché, come si diceva, l’esperienza degli ultimi svevi rappresenta agli occhi di dante l’ambizione storica a quell’unità ontologica che contraddistingue la sua idea d’impero. e tuttavia neanche questo sembra bastare ad una piena comprensione dell’esemplarità federiciana nella monarchia dantesca.
in effetti, il modello offerto dell’esperienza fede-riciana continua ad agire e a complicare la soluzione del problema imperiale. i pontefici duecenteschi av-vertivano il rischio d’un’espansione imperiale in italia, d’un’unitas imperiale nella penisola, nei termini d’una possibile confusio tra chiesa e impero che si sarebbe prodotta qualora federico ii o i suoi eredi avessero congiunto il regnum sicilie all’imperium. significativa da questo punto di vista è la constatazione d’inno-cenzo iii: se infatti il congiungimento si fosse attuato – argomentava il pontefice – « per hoc regnum sicilie uniretur imperio et ex ipsa unione confunderetur eccle-
(93) ibid., pp. 645-646.
47zelatores fidei, memorie federiciane
sia » (94). l’argomento d’innocenzo iii apre a una di-mensione “condizionale” della storia, che tuttavia an-drà colta nella sua effettività ideologica. si tratterebbe infatti d’una confusio che – come attesta la formula « unio vel confusio » (95) – non ha nulla di morale o psicologico; essa invece definisce la precisa, e temibi-le, prospettiva politica d’una con-fusione, ovvero d’un assorbimento della chiesa dentro i confini dell’impe-ro, fin dentro la sua giurisdizione, come conseguenza dell’estensione territoriale di quest’ultimo. per quanto la fonte possa risultare tendenziosa, lo stesso rischio sarà intravisto, più tardi, dal fronte angioino nella po-litica italiana d’enrico Vii, tra il 1310 e il 1313: « unde cum imperatori dicatur per aliquas scripturas, quod ipse est super omnes reges et habet sub se omnes naciones et regimen romane ecclesie, statim quod est coronatus, erigitur in fumum superbie et credit se esse non solum parem domini papae, sed eciam maiorem » (96). così come il documento papale introduceva ad una dimensione storica “condizionale”, questo brano d’un “memoriale” angioino immette nella dimensione della pubblicistica ideologica – aliquas scripturas – che con-tribuì, più o meno efficacemente, alla definizione d’un programma imperiale e di cui, almeno sotto ludovico il Bavaro – stante Boccaccio (97) –, fece parte pure la monarchia dantesca. foss’anche sul piano delle pure ipotesi o delle teorizzazioni politiche, esisteva dun-que l’evenienza che l’universalitas imperiale arrivasse a confondere ed inglobare la chiesa stessa; estremo esito di quel problema federiciano che ci è apparso
(94) miscellanea Historiae Pontificiae, vol. Xii, regestrum innocen-tii iii pape super negotio romani imperii, ed. F. KEMPF s.J., roma 1947, p. 79.
(95) ibid., p. 131.(96) mGh, constitutiones et acta publica imperatorum et regum,
iV/2, p. 1371.(97) Boccaccio, trattatello cit., pp. 487-488.
48 l. mainini
tagliare trasversalmente la dimensione storica e quella ontologica del progetto dantesco.
ora, tuttavia, sulle implicazioni ultime di questa paventata confusio tra chiesa e impero la posizione dantesca dovrebbe vivere le sue criticità maggiori. ed in effetti sul rapporto finale delle due giurisdizioni – ossia intono a monarchia iii, XVi, 15-18 – anche l’esegesi dantesca incontra le esitazioni maggiori. dopo aver dimostrato l’indipendenza dell’imperatore rispetto al pontefice, dopo aver affermato che l’im-pero deriva il suo potere direttamente da dio senza intermediazione alcuna, dopo aver ricostruito le ra-gioni dell’universalità e dell’unità imperiali che non tollerano limitazioni, dante chiude così: « Que quidem veritas ultime questionis non sic stricte recipienda est, ut romanus princeps in aliquo romano pontifici non subiaceat, cum mortalis ista felicitas quodammodo ad immortalem felicitatem ordinetur » (iii XVi, 17). non si creda dunque che l’imperatore sia completamente sciolto da qualsivoglia rapporto col pontefice, giacché in realtà la felicità terrena – competenza dell’impe-ro – è in ogni caso subordinata alla felicità eterna – competenza della chiesa; ciò che impone al primo la reverenza del secondo: « (...) reverentia cesar utatur ad petrum » (iii XVi, 18). a questo punto, potrebbe deludere alcuni il fatto che il discorso politico dante-sco, così radicale nel derivare conseguenze ontologi-che dall’analisi storica e scritturale, si chiuda su una reverentia dell’impero alla chiesa che parrebbe assu-mere le forme quasi fattizie d’un accomodamento or-mai impossibile (98). eppure, l’aver seguito una traccia federiciana, a nostro avviso, permette di comprendere
(98) si ricordi quanto scriveva Vinay. « mettiamo dunque di fronte questo imperatore e questo papa: al limite a cui siamo giunti, qualunque interferenza cessa di essere un problema: diventa un’irrealtà », G. Vinay, interpretazione della ‘monarchia’ di dante, firenze 1962, p. 73.
49zelatores fidei, memorie federiciane
meglio il senso finale di questa reverentia che l’impero deve alla chiesa. per dante, infatti, a differenza di quella vox ghibellina riportata dal “memoriale” angio-ino, l’impero non avrà mai il regimen romane ecclesie, non deterrà i diritti del “governo della chiesa”, i due poli non si con-fonderanno, e l’impero dantesco resta ben lungi dal cesaropapismo. crediamo infine che l’urgenza d’evitare una simile confusio fosse av-vertita razionalmente da dante, e che l’aver fermato l’impero ad un passo dall’inglobare la chiesa – per quanto si tratti sempre e solo di teoria politica – ri-sponda a un’esigenza profonda del pensiero dantesco, laico sì, universalistico, storico-ontologico, ma pure, e coerentemente, “ecclesiale”, nella misura in cui l’ecclesia è forma storica d’una communitas che, come l’impero, anzi con l’impero, tende strutturalmente al “mondo”, alla trasformazione, mai esauribile, della multitudo umana in totalità (99). in linea con la cultura giuridica romanistica, dante ritiene che l’impero sia indivisibile; dividerlo equivarrebbe a ridurlo, privarlo della sua unitas ontologica ovvero annientarlo nei suoi presupposti: « ergo scindere imperium [est] destruere ipsum » (iiii X, 9). si tratta, com’è stato rilevato (100), d’una applicazione intensiva del tema romanistico augustus ab augeo, etimologia che “obbligava” l’im-peratore alla sua più intima essenza, ovvero quella d’aumentare l’impero e non diminuirlo. e tuttavia, in chiave dantesca, l’augmentatio dell’impero, forma e manifestazione storica della sua unitas ontologica, non può procedere oltre la reverentia dovuta alla chiesa e al suo pontefice.
(99) si torni a r. MansElli, dante e l’ “ecclesia spiritualis”, in dante e roma cit., pp. 115-135. al di là della “questione francesca-na”, in questa sede quel che conta rilevare è il nesso tra ecclesia e humana civilitas (ibid., p. 127).
(100) cfr. dantE aliGhiEri, monarchia, ed. QuaGlioni cit., p. 1336.
50 l. mainini
Questo limite, tutt’altro che fattizio, è invece l’ele-mento che distingue il progetto dantesco dalla visione pseudo-imperiale elaborata dai royalistes francesi, agli inizi del secolo XiV, sotto filippo il Bello. spesso s’è confrontata, e a ragione, la monarchia dantesca con testi francesi, quali il de potestate regia et papali di Jean de paris (101), osservando come le tesi royalistes del domenicano francese, nel confutare la supremazia pontificia sui re capetingi, interagiscano talvolta con quelle elaborate da dante per confutare la supremazia papale sull’imperium. e tuttavia, alla luce di quanto s’è fin qui detto, sarà chiaro che sostituire il re di francia all’imperatore è un’operazione, storica, filologica e storiografica, tutt’altro che neutra, anche ai fini d’una corretta lettura dantesca. dante era ben cosciente che quest’idea serpeggiasse nello spirito del secolo, che qualcuno avesse in animo di sostituire i « gigli gialli » al « pubblico segno »; e il suo trattato è difatti innervato d’una radicale opposizione a quest’ipo tesi politica, dannosa – in chiave dantesca – sia per l’im-pero, ovviamente, che per la chiesa stessa – vittima dei suoi stessi zelatores. in tal senso, le tesi politiche del più fervente royaliste d’inizio trecento, quel pierre dubois autore, tra l’altro, del trattato de recuperatio-ne terre sancte, costituiscono il contraltare perfetto per cogliere il senso del limite che dante pone, e vuole porre, alla sua idea d’impero. con dubois, infatti, l’ideo logia capetingia, cresciuta gradualmente nel corso del secolo Xiii, ormai sperimentata nella ramificazione angioina e nella lotta anti-sveva, si ri-vela in quelle che erano le sue ambizioni implicite, agevolata ormai da una chiesa, con clemente V, già quasi avignonese. dubois, com’è noto, teorizza la con-fisca dei beni temporali ecclesiastici e la costituzione
(101) edito e discusso in J. lEclErcQ, Jean de Paris et l’écclesio-logie du Xiiie siècle, paris 1942.
51zelatores fidei, memorie federiciane
d’una pax christiana sotto l’egida capetingia – versio-ne radicale, in definitiva, del progetto abbozzato un trentennio prima da carlo d’angiò nella speranza di consegnare l’imperium a filippo l’ardito. poiché il pontefice dovrà attendere alla sua missione spirituale – argomenta dubois –, i frutti, i proventi e gli oneri del suo dominio temporale andranno trasferiti « alicui magno regi seu principi (...) in perpetuam amphiteo-sim » (102) – anche qui dunque una forma politica franco-pontificia “contrattualizzata” in termini di diritti reali. eliminando, in tal modo, le guerre e le discordie generate dal Patrimonium Petri, « per hanc provisionem (...) respublica totius sancte religionis christicolarum in sua intentione finem unum sibi prefiget, illum queret, omnes operationes ad illud diriget, ordinabit et disponet (...). nam, ut ait philospohus: mondus est unus, sicut exercitus est unus » (103). può quasi risultare inquietante leggere nel giurista capetingio lo stesso ordine d’argomenti – sostenuti per altro dalla mede-sima auctoritas aristotelica – che troviamo in dante, salvo essere usati dal primo a sostegno d’un’ideologia royaliste, mentre in dante restano alte prove dell’onto-logia imperiale. la comparazione, del resto, insegna che solo una semantica storica dei concetti politici qui discussi, ovvero una filologia, può mostrare come un medesimo repertorio d’argomenti fosse sostegno d’una tesi e del suo opposto. affermare la reverentia dell’impero nei confronti della chiesa rappresentava, dunque, per dante l’unico dispositivo atto ad evitare quella confusio – quel commercio tra la puttana e il gigante (Pg. XXXii) – a cui invece l’opzione royaliste non sapeva, o non voleva, sottrarsi.
(102) de recuperatione terre sancte. traité de politique générale par Pierre dubois, éd. ch.V. lanGlois, paris 1891, p. 33.
(103) ibid., p. 36.
52 l. mainini
Giustamente, allora, Quaglioni rifiuta alla monar-chia un carattere utopico (104); essa contiene infatti un progetto politico ambizioso, storicamente intellegibile e di vastissime dimensioni, non un’utopia. il realismo che la contraddistingue – e la allontana tanto dal genere utopico, peraltro piuttosto sconosciuto al me-dioevo occidentale, quanto dagli estremismi royalistes – emerge proprio in quel suo sapersi arrestare sulle so-glie d’una chiesa tuttavia ancora da de-secolarizzare, in quella reverentia alla quale anche l’imperatore più universalista, per la comune ascendenza divina, saprà e dovrà sottostare (105), onde evitare la confusio di chie-sa e impero. il finale della monarchia, con la sua per alcuni improvvisa “ritrattazione”, il suo avventizio e tardivo recupero della dignità papale, in realtà non ha nulla d’improvviso, avventizio e tardivo; fermare il potere laico ed universale, con la sua scienza, al cospetto della dignità ecclesiale, con la sua sapienza, è la cifra del realismo politico dantesco e del suo cristianesimo. non utopia, dunque; tutt’al più un’op-zione politica minoritaria e sconfitta, ma che, come tutte le sconfitte, permane storicamente in quanto rimosso, problema irrisolto dei vincitori.
lorEnzo Mainini
(104) QuaGlioni, introduzione cit., pp. 838-860.(105) nell’incapacità di conformarsi pienamente a questa reve-
rentia finale, e dovuta, andrà forse intravista una delle ragioni per la condanna infernale di federico ii. di più, il fatto che l’anima dannata dello svevo venga presentata a dante dal ghibellino fa-rinata apre ad una lettura che sappia tematizzare, insieme, eresia ed agire politico, cfr. l. azzEtta, canto X. Politica e poesia tra le arche degli eretici, in lectura dantis romana. cento anni per cento canti. i. inferno. 1. canti i-XVii, a c. di E. Malato e a. Mazzucchi, roma 2013, pp. 311-342.