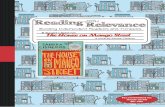Bibiografia critica di Achille Mango
Transcript of Bibiografia critica di Achille Mango
Il volume è finanziato dal Dipartimento di Letteratura, Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Salerno.
ISBN 88-901256-6-7Grafica e impaginazione: by Crati
a1 Edizione 2004
In copertina: P. Aretino. L’Ipocrito. 1542.
INDICE
7 INTRODUZIONE
43 BIBLIOGRAFIA CRITICA DI ACHILLE MANGO
9 Teatro come storia. Teatro come pensiero
45 Nota alla bibliografia47 Libri 48 Scritti in qualità di “coautore”49 Scritti in collaborazione, atti di convegni, annali e
studi in onore57 Introduzioni e presentazioni59 Articoli e interventi pubblicati su periodici91 Dispense92 Inediti
5
TEATRO COME STORIA TEATRO COME PENSIERO
“(…) Amo il teatro, lo amo perché è vivo per le suggestioni di ordine anche biologico che sa indi-carmi per il potere che ha di gettarmi nelle braccia di una condizione spirituale mia nel momento in cui ricevo le impressioni immediatamente dopo trasferentesi sui miei vicini quelli che mostrano le necessità mie stesse e gli altri insensibili. Questo te-atro vado cercando nei piccoli locali nelle caves in mezzo alla gente e nel deserto ogni volta che rico-nosco di averne trovato sia pure una parte scatta un meccanismo la ricerca va ancora avanti sulla via del risultato più compiuto come per il biologo è la scoperta di un qualcosa che sostanzia meglio la vi-ta di un organismo”
(Il teatro dell'esperimento, l'esperimento del teatro, “Mar-catre”, luglio/agosto/settembre 1968).
9
Una dichiarazione esplicita, articolata e quasi del tutto libera dai vincoli sintattici della punteggiatura, può facilitare l'avvicinamento alla personalità eclettica e complessa del suo auto-re. Achille Mango possiede del teatro una concezione totale e spe-rimentale in senso assoluto, in un valore che si definisce e si tra-sforma nel corso della sua attività di studioso che copre l'arco di tempo compreso tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Novanta.
La carriera di teorico, critico e docente universitario è testimo-niata dalla copiosa e varia produzione scientifica che tocca i più di-versi campi di indagine all'interno dei principali aspetti e delle te-matiche fondamentali del teatro in quanto forma d'arte e della Storia del Teatro nella sua accezione disciplinare. Saggi, monogra-fie, scritti in collaborazione con altri autori, interventi a convegni, articoli su quotidiani, riviste, documenti epistolari, scritture teatra-li, delineano meglio di qualsiasi altra testimonianza il profilo dello studioso.
All'interno del corpus bibliografico di Achille Mango esiste un rapporto molto intenso tra l'evoluzione intellettuale contenuta nei testi monografici e la parallela attività critica espressa nell'estesa quantità di articoli e recensioni di cui Mango è autore. Ciò che rap-presenta la riflessione dello studioso sul teatro e la sua natura, indi-pendentemente dagli ambiti storici e dagli argomenti trattati, è da ricercarsi sostanzialmente nel nucleo delle monografie, ma si com-pleta in maniera imprescindibile con la parte relativa alla sua car-riera di critico.
L'elaborazione tematica contenuta nei testi monografici proce-de di pari passo, all'interno dell'attività giornalistica, al contatto vi-tale con il dato concreto della forma spettacolare e soddisfa l'esigenza di spaziare ad ampio raggio in ambiti culturali limitrofi al teatro. Per tale motivo all'interno degli scritti è possibile individua-
10
re delle fasi che riflettono specifiche inclinazioni teorico-metodologiche che, prediligendo determinati settori di indagine, ne assumono il linguaggio e la tecnica speculativa anche quando non si riferiscono ad essi in maniera diretta. Alla luce di un'analisi condotta con tali premesse emerge un percorso che da un lato con-duce all'evoluzione teoretica di Achille Mango e alla sua personale idea di teatro, dall'altra suggerisce alcune riflessioni sullo sviluppo della storiografia teatrale in Italia negli ultimi decenni.
Come per altri pionieri dell'insegnamento di Storia del Teatro in Italia, l'approdo all'ambiente universitario di Achille Mango non segue un iter accademico paragonabile a quello attuale. Negli anni Cinquanta conduce l'attività di bibliotecario presso la Biblioteca Nazionale di Roma, dove sviluppa l'inclinazione filolo-gica e l'esperienza necessaria per individuare e utilizzare i docu-menti bibliografici più adatti per affrontare lo studio del teatro da una corretta prospettiva storica. Di lì a poco intraprende l'attività parallela di critico teatrale su quotidiani e riviste di arte e spettaco-lo, mentre alla fine degli anni Sessanta ottiene la libera docenza in Storia del Teatro e comincia ad avere i primi contatti con le univer-sità. Nel 1969 è professore incaricato in Storia del Teatro e dello Spettacolo alla Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Salerno, dove maturerà e concluderà la sua carriera accademica. Dal 1971 al 1976 ottiene in contemporanea l'incarico nella stessa disciplina presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Bari. La permanenza nell'Ateneo sa-lernitano lo vede ricoprire nel tempo i ruoli di professore ordina-rio di Storia del Teatro e dello Spettacolo, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte e poi di preside della Facoltà di Magistero nel pe-riodo di incarico dal 1979 al 1997.
La carriera accademica, tuttavia, assume un aspetto particolar-mente interessante quando è abbinata all'attività esercitata da
11
Mango nel campo specifico della didattica. Gli ambiti scientifici, e soprattutto metodologici, oggetto delle sue ricerche confluiscono nel rapporto con le platee studentesche alle quali cerca di trasmet-tere lo studio della storia del teatro secondo una modalità interdi-sciplinare. L'organizzazione di convegni, tavole rotonde, incontri con artisti e docenti di materie affini, nonché una particolare at-tenzione al documento “spettacolo”, costituiscono i fondamenti del suo approccio con l'insegnamento universitario.
La Storia del Teatro, come materia specifica, viene inserita uffi-cialmente nei piani di studio universitari solo all'inizio degli anni Sessanta quando comincia a svincolarsi dall'ampio ed eterogeneo ambito degli studi letterari. Vito Pandolfi è tra i primissimi docenti della nuova disciplina, singolare figura di studioso, regista e uomo di teatro nella sua accezione globale, che gioca un ruolo fonda-mentale nelle scelte professionali di Achille Mango agli albori della
1sua carriera.
È la metà degli anni Cinquanta, periodo che segue agli spetta-coli “socialisti” di Pandolfi, troppo innovativi rispetto a quanto l'Italia dell'epoca potesse accogliere. Anche i rapporti con le istitu-zioni si impongono come difficili da gestire se non a patto di com-promessi che, se accettati, finirebbero con il condizionare le scelte registiche. Il rifiuto a cedere alle logiche di botteghino conduce Pandolfi a una “pausa teatrale” colmata dall'attività di saggista, dal-lo studio e dalla ricerca nei territori “irregolari” del teatro dalla commedia dell'arte all'avanguardia. Ma più di ogni altra cosa, tale periodo è segnato dall'attività di critico di sinistra, per ideologia e militanza, in una maniera chiara e leale che non lascia dubbi sulla vi-sione dell'arte e della cultura.
1 Per un profilo biografico e professionale di Vito Pandolfi vedi Andrea Mancini (a cura di), Vito Pandolfi. Teatro da quattro soldi, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1990; Dario Evola, L'utopia propositiva di Vito Pandolfi, Roma, Bulzoni, 1991.
12
Proprio in questo periodo inizia il rapporto di Mango con Pandolfi, un rapporto favorito dalle affinità culturali e soprattutto politiche, in cui la preparazione scientifica del bibliotecario intera-gisce con l'esperienza empirica dell'uomo di spettacolo. Pandolfi è il tramite per i primi contatti con giornali e riviste specializzate, rappresentando uno stimolo prezioso per l'approdo di Mango alla scrittura. Di lì a poco Pandolfi sarà autore della prefazione ai primi due testi che sanciscono il percorso futuro nell'ambito degli scritti teatrali di Mango: Il teatro siciliano (1961) e La commedia in lingua nel
2Cinquecento (1966).Entrambi i testi si pongono come il risultato della prima fase
dell'iter formativo di Achille Mango nel campo degli studi teatrali, in quanto traducono la conoscenza e l'abilità maturate come bi-bliofilo nell'indagine operata su un vasto ed eterogeneo blocco di reperti che si inseriscono rispettivamente nel discorso generale sul teatro dialettale italiano e nel complesso quadro dello spettacolo ri-nascimentale.
Nel secondo caso la ricerca non si limita a una catalogazione dei materiali rinvenuti ma traccia un itinerario geografico-editoriale dei testi riferiti alla commedia “in lingua” del '500 italia-no, per la quale non appare più possibile impiegare la definizione di commedia erudita. “Da questo principio - chiarisce Mango - par-te il riferimento del libro alla commedia in lingua e non più alla comme-dia erudita, termine abbastanza equivoco, che si presta ad interpre-tazioni diverse e rientra nell'ordine delle categorie sistematiche,
3non da oggi soltanto piuttosto recisamente rifiutato”. Sulla base di studi già esistenti sull'argomento e sollecitando ulteriori contri-buti, l'autore arricchisce il repertorio con la schedatura di esempi
2 Achille Mango (a cura di), Il teatro siciliano, Palermo, Edizioni E.S.A., 1961; La commedia in lingua nel Cinquecento, Milano, Lerici, 1966. 3 Achille Mango, La commedia in lingua nel Cinquecento, cit., pag. 7.
13
meno noti o addirittura ancora ignorati in quegli anni, in base a un criterio linguistico (la lingua italiana) che costituisce l'elemento de-terminante per la scelta dei materiali catalogati.
Nonostante l'autore non si soffermi su argomentazioni teori-che e si concentri piuttosto sul percorso della commedia del Rinascimento italiano alla luce della sua diffusione a stampa, è da questo testo che parte e si inserisce il contributo di Achille Mango all'interno del generale clima di riformulazione degli studi teatrali.
Il campo della ricerca specifica sullo spettacolo conosce, infat-ti, un vero e proprio movimento rinnovatore a partire dalla fine de-gli anni '60 e produce una serie di apporti teorici fondamentali che hanno, ancora oggi, il merito di aver capovolto l'impostazione de-gli studi tradizionali sul teatro tanto nelle tematiche quanto nella
4struttura. Fino a questo momento il teatro non possiede un'autentica storiografia essendo relegato a sinonimo di letteratu-ra drammatica e inglobato in una generale impostazione culturale
5che non prevede un'autonomia concettuale e disciplinare. L'esigenza di taluni studiosi di settorializzare le ricerche di argo-mento teatrale, produce una serie di testi che progressivamente si svincolano dalla componente letteraria per concentrarsi sull'elemento spettacolo individuato soprattutto nei suoi statuti (at-tore, testo, scenografia, pubblico) che di volta in volta si presenta-no come realtà disparate e contraddittorie. Tale intuizione capo-volge l'approccio tradizionale degli studi dal momento che l'indagine non considera più in via preliminare il testo drammatico come documento ufficiale, ma parte dalla materia riconoscibile co-me teatrale, dal “concreto” rappresentativo per risalire all'ambito culturale di appartenenza ed eventualmente procedere ad analisi e
4 Claudio Meldolesi, Il primo Zorzi e la “nuova storia del teatro”, “Quaderni di Teatro”, a. VII, n. 27, febbraio 1985.5 Cfr. Guido Davico Bonino, Perché non esiste una storia del teatro, “Sipario”, n. 307, dicembre 1971.
14
6 classificazioni.Ed ecco che i campi privilegiati dal nuovo atteggiamento scien-
tifico si concentrano soprattutto sui periodi che hanno determina-to cambiamenti radicali nella storia dello spettacolo, puntando a momenti epocali di passaggio quali il Rinascimento italiano e il Novecento. Dalla commedia erudita all'evoluzione delle pratiche sceniche del '500, dal Naturalismo alla post avanguardia, una parte sostanziale degli studi che da questo momento si riconoscono co-me teatrali evidenziano la rivoluzione culturale operata in quelli che appaiono secoli particolarmente densi di trasformazioni nel concetto e nelle forme del teatro. Al di là di evidenti differenzia-zioni di ordine storico, entrambe le epoche presentano uno spetta-colo composito che ingloba in sé vari campi dell'arte e ne utilizza i linguaggi, evolvendo la concezione teatrale in senso generale dall'assetto scenografico a quello strettamente drammaturgico. Ciò induce anche ad una più attenta riflessione sui rapporti tra spet-tacolo e pubblico all'interno delle forme di rappresentazione pre-senti nelle diverse epoche storiche.
In questa direzione si impongono come testi chiave scritti di ar-gomento teatrale che concorrono alla formulazione di un atteg-giamento scientifico inedito che parte dall'oggetto spettacolo e dal-le sue manifestazioni per poi elaborare argomentazioni teoriche, analizza, cioè, il materiale documentario per risalire in seconda istanza alle tematiche.
Nel corso degli anni Sessanta e Settanta la concentrazione degli studi sul Cinquecento si è focalizzata, ad esempio, sulla festa rina-scimentale come espressione spettacolare polisemica che ingloba in sé diverse forme teatrali (ufficiali e minori) come la commedia o la farsa e che fonde nella drammaturgia la prassi dello spettacolo
6 Cfr. Fabrizio Cruciani, Storia e storiografia del teatro: saggio bibliografico, “Teatro e Storia”, n. 1, dicembre 1984.
15
col ritrovamento degli antichi. “Il modello - spiega Fabrizio Cruciani - si configura nelle città italiane inserendo l'imitazione dell'antico all'interno di uno spettacolo complesso che unisce le forme espressive acquisite e il progetto culturale della corte, visua-
7lizzato nell'immagine ideale dello spazio urbano”.Il concetto di festa riunisce una pluralità di sguardi e prospetti-
ve che, oltre ad allargare il campo di indagine, modificano in ma-8niera sostanziale gli approcci tradizionali. La dimensione storio-
grafica tiene così conto di discipline scientifiche e tradizioni cultu-rali, che vanno dall'antropologia all'iconologia, dalle processioni ri-tuali al nascere della commedia. La pluridisciplinarietà necessaria agli studi sul teatro rinascimentale si avvale dell'apporto di musi-cologi, storici dell'arte, dell'architettura che guardano allo spetta-
9colo dai loro settori specifici.7 Fabrizio Cruciani, Op. cit., p. 24. 8 Cfr. ad esempio, Fabrizio Cruciani, Il teatro del Campidoglio e le feste romane del 1513, Milano, Il Polifilo, 1968; Il teatro a Roma nel Rinascimento, Roma, Bulzoni, 1969; Per una epistemologia del teatro rinascimentale: la festa, “Biblioteca Teatrale”, n. 5, 1972; Linvenzione del teatro, “Biblioteca Teatrale”, n. 15-15, 1976; Cesare Molinari, Le nozze degli dei: un saggio sul grande spettacolo italiano nel Seicento, Roma, Bulzoni, 1968; Ludovico Zorzi, Teatro. Ruzante, Torino, Einaudi, 1967; Roberto Alonge, Il teatro dei Rozzi di Siena, Firenze, Leo Olschki, 1967. Progressivamente gli studi sul Rinascimento puntano alle interrelazioni fra spazio teatrale e ordine sociale con una fitta bibliografia che trova la sua sintesi in Ludovico Zorzi, Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana, Torino, Einaudi, 1977.9 Tra le varie raccolte vanno segnalate almeno Lingua e struttura del teatro italiano del Rinascimento, “Quaderni del Circolo Filologico di Padova”, Padova, Bulzoni, 1970; Il teatro classico italiano nel '500, “Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei”, Roma, Bulzoni, 1971; Ferruccio Marotti, Lo spettacolo dall'Umanesimo al Manierismo, Milano, Feltrinelli, 1974; L'architettura teatrale in Italia dall'età greca al Palladio, “Bollettino del centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio”, XII, Vicenza, 1975; Nino Pirrotta - Elena Povoledo, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, Torino (1969). Anche i trattati sulla messa in scena assumono una importanza diversa come dimostra Ferruccio Marotti (a cura di), Leone de' Sommi. Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche, Milano, Il Polifilo, 1968.
16
Parallelamente la riflessione sul Novecento offre contributi al-trettanto interessanti e inaugura una nuova metodologia di studio del fatto teatrale: la ricostruzione dello spettacolo come interpre-tazione e creazione del regista. Secondo tale intuizione lo studio della direzione teatrale (utopia o inquietudine) è inteso da un lato
10come poetica, dall'altro come evento da ricostruire.Questa prima fase degli studi sul Rinascimento e sul
Novecento apre definitivamente la strada alla produzione saggi-stica di argomento teatrale dei decenni successivi in cui le ricerche puntano a sviluppare l'impianto metodologico proposto negli an-ni immediatamente precedenti. La lucida riflessione operata da al-cuni studiosi sulle questioni riguardanti nello specifico la situazio-ne e lo sviluppo della storiografia teatrale in Italia, genera la neces-sità di organizzare i materiali a disposizione per l'inquadramento e la ricostruzione di un determinato fenomeno in modo tale che sia eluso il rischio di una generica valutazione delle manifestazioni tea-trali. Nella ferma convinzione che le arti dello spettacolo costitui-scono un complesso sistema di elementi che contraddice tutte le definizioni che vorrebbero contenerlo, gli studi si dirigono verso la considerazione di “eventi” spettacolari da ricostruire e analizza-re caso per caso con l'ausilio di ricerche settoriali e indagini parti-
10 Cfr. Ferruccio Marotti, Amleto o dell'oxymoron. Studi e note sull'estetica della scena moderna, Roma, Bulzoni, 1966; Angelo Maria Ripellino, Il trucco e l'anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento, Torino, Einaudi, 1965; Umberto Artioli, Teorie della scena dal naturalismo al Surrealismo, Firenze, Sansoni, 1972. Su singole figure del teatro contemporaneo è necessario citare almeno Fabrizio Cruciani, Jeacques Copeau: studio di una poetica, Roma, Bulzoni, 1969 e il successivo Jeacques Copeau o le aporie del teatro moderno, Roma, Bulzoni, 1971; i numerosi studi di Ferruccio Marotti su Appia e Craig tra i quali si ricordano Edward Gordon Craig, Bologna, Cappelli, 1961; Appia e Craig: le origini della scena moderna, “La Biennale”, n. 50/51, Venezia, 1963; La scena di Adolphe Appia, Bologna, Cappelli, 1966 e le edizioni di Craig Il mio teatro, Milano, Feltrinelli, 1971 e di Appia Attore, musica e scena, Milano, Feltrinelli, 1975.
17
colareggiate fornendo, solo in una fase successiva, un giudizio di ti-11po interpretativo .
In linea con questo nuovo atteggiamento scientifico, Achille Mango si orienta in maniera naturale all'analisi dello spettacolo da punti di vista differenti, avendo come riferimento prospettive teo-riche che si trasformano e si modificano nel corso degli anni. In Teorie della recitazione (1971) la formulazione del nucleo tematico parte dall'attore e dalla sua potenzialità creativa e compie un excur-sus specifico sulla recitazione dal '500 al '900, attraverso l'esame de-gli scritti teorici fondamentali che nell'epoca moderna e contem-poranea segnano l'evolversi dell'interpretazione attorica, dal trat-tato di Andrea Perrucci alle posizioni di Eugenio Barba e Jerzy
12Grotowski. Oggetto della dissertazione è l'aspetto più sfuggente ed evanescente del teatro, che esiste solo per la durata dell'azione scenica eppure si pone come assolutamente esclusivo dell'arte rap-presentativa. Un percorso storico sulla recitazione assunta come parametro che connota il teatro nella sua peculiarità più intrinseca: è il tentativo di raccontare la storia del pensiero sulla recitazione che affida allo statuto dell'attore il compito di stabilirne le evolu-zioni epocali.
Contemporaneamente, e secondo una scelta speculativa e me-todologica analoga, Mango sviluppa una serie di studi che si riferi-scono alle forme spettacolari che si affermano tra Cinquecento e Seicento. In questa direzione si muove uno studio sulla commedia dell'arte che, considerando il fenomeno come momento privile-giato del mutamento storico dell'attore sia da un punto di vista arti-
11 Cfr. Storia e Storiografia del Teatro, oggi . Per Fabrizio Cruciani, “Culture Teatrali”, n. 7/8, autunno 2002 - primavera 2003.12 Achille Mango, Teorie della recitazione, Salerno, Libreria Internazionale, 1970/1971. Il testo rappresenta la pubblicazione delle lezioni tenute a Salerno presso la Facoltà di Magistero durante il corso di Storia del Teatro e dello Spettacolo previsto per l'a.a. 1970-1971.
18
stico che sociale, prosegue l'indagine sulla recitazione puntando sull'elaborazione che di essa viene fatta da parte delle compagnie professioniste. Cultura e storia nella formazione della commedia dell'arte (1972) evidenzia quanto la commedia dell'arte si presenti come la forma più vicina alle istanze novecentesche per ragioni che si rife-riscono soprattutto all'autonomia estetica del genere, uno spetta-colo compiuto che in un certo senso si accosta a ciò che nel XX se-
13colo si identifica idealmente come teatro. L'attinenza è da ricer-carsi nella libertà rappresentativa tanto dei comici dell'arte quanto degli sperimentatori del XX secolo, nell'esplorazione delle possi-bilità della scena oltre i vincoli della tradizione, nonché nell'attenzione dedicata alle capacità attoriche.
Al centro della dissertazione vi sono le questioni dell'improvvisazione e delle maschere che in questo studio Mango affronta attraverso un approccio metodologico in rapporto dialet-tico con le tesi di Benedetto Croce . Il riferimento è a quanto Croce
14sostiene in Poesia popolare e poesia drammatica dove il filosofo defini-sce spontanea la natura della commedia dell'arte e la formazione delle compagnie negando ogni valore poetico al genere. La posi-zione di Mango condivide l'intuizione crociana circa la spontanei-tà di questa particolare manifestazione teatrale, ma si concentra sui legami con le espressioni popolari attraverso le evoluzioni del-lo spettacolo dei comici dell'arte. L'assenza della “poesia dramma-tica” non è, secondo tale interpretazione, pregiudiziale per la con-siderazione dell'“improvvisa” come forma d'arte legittima e auto-noma, ma sostituisce alla forma scritta un più complesso e ricco materiale artistico.
Un'attenzione particolare è dedicata alla scomposizione
13 Achille Mango, Cultura e storia nella formazione della commedia dell'arte, Bari, Adriatica Editrice, 1972.14 Benedetto Croce, Poesia popolare e poesia drammatica, Bari, Laterza, 1932.
19
dell'unità sociale della città in epoca rinascimentale, ovvero al si-stema pluriclassista che crea una sensibile dicotomia tra cultura erudita e cultura popolare, pubblico cortigiano e pubblico cittadi-no. La commedia dell'arte supera per certi versi questa opposizio-ne, e per altri la complica, per la coesistenza di generi all'interno del-la sua struttura capace di assorbire caratteristiche appartenenti alla cultura accademica e altre attinte da quella popolare.
Tale ipotesi è contenuta anche negli interventi che definiscono e completano il periodo di più attenta riflessione di Achille Mango sulla commedia dell'arte. Il teatro italiano in Francia alla fine del Cinquecento (1973-1974) e Il teatro italiano in Francia durante il regno di Luigi XIII (1974) analizzano le modalità italiane di far teatro e di or-ganizzare l'evento rappresentativo in Europa, concentrando l'attenzione principalmente sulla coesistenza all'interno dell' “im-provvisa” di modelli di estrazione erudita e di espressioni ricondu-
15cibili ai generi minori. E proprio ad una forma teatrale non accademica Achille
Mango dedica nel 1973 uno studio particolareggiato pubblicando 16la raccolta Le farse cavaiole. La compilazione rileva l'importanza del-
le componenti regionali nella ricostruzione del quadro storico del-la cultura teatrale nazionale. Le farse prodotte a Cava de' Tirreni nel corso del Cinquecento rappresentano un esempio particolar-mente significativo di un simile fenomeno che Mango affronta, su di un piano filologico, analizzando soprattutto le questioni lingui-stiche caratterizzate dalla ibridazione della matrice dialettale napo-letana con espressioni irpine, calabre e lucane tipiche del mondo contadino. Tali contaminazioni linguistiche confermerebbero,
15 Il teatro italiano in Francia alla fine del Cinquecento, in Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Bari, nuova serie, 4-5, 1973-1974; Il teatro italiano in Francia durante il regno di Luigi XIII, “Quaderni del Seicento Francese”, Bari Adriatica, Parigi Nizet, n.1, 1974.16 Achille Mango, Le farse cavaiole, Roma, Bulzoni, 1973, 2 voll.
20
nell'interpretazione di Mango, l'importanza dei legami culturali che uniscono Napoli ai territori circostanti, generando in essi un'autonoma specificità teatrale.
Il particolare modello teatrale che emerge dai testi del reperto-rio drammatico rinvenuto nella città campana, fornisce un singo-lare contributo alla definizione del complesso mosaico costituito dallo spettacolo rinascimentale. Ciò rappresenta una ulteriore te-stimonianza della nuova sensibilità sviluppatasi intorno agli studi teatrali dal momento che, secondo una scelta storica e metodolo-gica, l'indagine conoscitiva è affrontata attraverso l'analisi di tutte le componenti che la costituiscono. Un processo che elimina ogni pregiudizio culturale nella considerazione di espressioni artistiche spesso valutate come “minori” rispetto alla tradizione ufficiale. Lo scopo è quello di offrire un'immagine composita, e il più possibile esauriente, della cultura teatrale definita anche nelle sue diversità sociali.
A partire dalla metà degli anni Settanta gli scritti di Achille Mango presentano una tessitura più articolata dei precedenti, nel senso che non è possibile individuare dei nuclei tematici circoscrit-ti. La produzione critica è caratterizzata piuttosto da una sorta di sincretismo scientifico che mentre si concentra su alcuni aspetti te-orici strettamente inerenti alla storia del teatro, non tralascia di ap-profondire motivi e problemi appartenenti a discipline affini che stabiliscono una relazione con lo specifico teatrale. È questo il ca-so soprattutto della storia dell'arte e della sociologia che concorro-no a formulare una visione dello spettacolo come espressione arti-stica multiforme, rete di linguaggi vari e mutevoli in rapporto dia-lettico tra loro. E in tal senso un'attenzione privilegiata è rivolta al contemporaneo, soprattutto alle forme più estreme della speri-mentazione teatrale cui lo studioso dedicherà uno spazio sempre maggiore di analisi ponendosi, in qualche caso, tra i principali teo-
21
rici delle nuove tendenze.Mentre partecipa al convegno di Salerno dal titolo
17Incontro/Nuove Tendenze/Teatro Immagine, Achille Mango intra-prende una serie di studi di natura sociologica inaugurati dall'introduzione a Le ombre collettive (1974) di Jean Dauvignaud e
18culminati in Verso una sociologia del teatro (1978). Sebbene apparen-temente distanti, i due momenti si rivelano come aspetti comple-mentari di una medesima percezione della realtà contemporanea sottoposta a un radicale e inevitabile cambiamento.
L'intervento di Mango al convegno di Salerno è, peraltro, inse-rito in Verso una sociologia del teatro e sottolinea la crisi dello spetta-colo destinato, ormai, a subire sensibili modifiche grazie all'integrazione sulla scena delle espressioni linguistiche proprie delle varie arti. Cambia, così, la concezione dello spettacolo libe-rando la rappresentazione teatrale da ogni forma di dipendenza verbale e restituendo all'azione un'autonomia figurativa con netta prevalenza dell'immagine sulla parola. Grazie anche alle sugge-stioni straniere, che da più parti contribuiscono al cambiamento della concezione dell'opera teatrale, il lavoro svolto dai nuovi grup-pi identifica nel corpo dell'attore una componente fondamentale della struttura linguistica dello spettacolo. In tal senso la ricerca ar-tistica procede da un lato a liberare sulla scena l'energia propria del-
17 Achille Mango, La crisi del prodotto, in Uso, modalità e contraddizioni dello spettacolo immagine, Pollenza - Macerata, Altro/La Nuova Foglio Editrice, 1975, atti del Convegno di Studi Incontro/Nuove Tendenze/Teatro Immagine tenutosi a Salerno l'8 giugno 1973. Presente anche in Achille Mango, Verso una sociologia del teatro, Palermo, Celebes, 1978.18 Achille Mango, introduzione a Jean Dauvignaud, Le ombre collettive. Sociologia del teatro, Roma, Officina Edizioni, 1974; Verso una sociologia del teatro, Palermo, Celebes, 1978; L'attore come operatore politico, introduzione a Jean Duvignaud, Sociologia dell'attore, Milano, Sergio Ghisoni Editore, 1977, presente anche in L'operatore Teatrale, “Quaderni del Laboratorio Teatrale Universitario”, Palermo, giugno 1981.
22
la fisicità dell'interprete, dall'altro a sottolinearne l'azione attraver-so l'intervento creativo di luci, colori e materiali scenici.
Nondimeno la riflessione sociologica si concentra sulla natura mutevole dell'esperienza teatrale, momento esclusivo del rappor-to tra atto creativo e società. Solo dalla consapevolezza di tale rela-zione, sostiene Mango, può partire l'analisi che individua i segni che di volta in volta esprimono un rapporto tra le parti visto come fattore in continua variazione. La constatazione della crisi del pro-fessionismo ad esempio, e il conseguente cambiamento estetico dello spettacolo, è da intendersi come una naturale evoluzione dell'espressione artistica di una classe, la borghesia, ora in pieno de-terioramento morale. Richiami diretti a studi antropologici e poli-tici sostengono la posizione di Mango sulla valenza sociale del tea-tro, che viene inteso per sua natura dominato da un'ansia di conti-nuo rinnovamento espressa in uno stato di “rivoluzione perma-nente” che fisiologicamente segna l'evoluzione culturale.
Spazio, attore e linguaggio sono gli elementi dell'arte teatrale nei quali riconoscere il legame intrinseco con la società. Tale rela-zione, al di là della risonanza complessiva esercitata sulla collettivi-tà, può produrre il suo effetto anche sulla sfera individuale inve-stendo la natura più profonda dell'esperienza interiore tanto dell'interprete quanto dello spettatore. In particolare il linguaggio scenico, legame tra il momento estetico e il suo riflesso in ambito comportamentale, è lo statuto sul quale Mango concentra la sua at-tenzione riconoscendolo come il dato più importante e significati-vo dell'attività di ricerca. Esempi emblematici sono quelli forniti dai gruppi italiani che, tra gli anni Sessanta e Settanta, hanno fatto della ricerca la propria dimensione privilegiata: partendo dall'esempio di Dario Fo, Mango rivolge il suo sguardo alla scuola romana di Simone Carella, Giuliano Vasilicò, Memè Perlini, per giungere fino alle giovani formazioni del Carrozzone, Gaia
23
Scienza, Linea d'Ombra, Gruppo Teatro.Il termine che in questi scritti Mango mette in luce è quello del
rapporto tra forma artistica e società, letto nell'ottica dell'avanguardia che tende ad un superamento del dato contingen-te del prodotto estetico e aspira ad una scomparsa dell'ambito spe-cifico dell'arte. In questa sua analisi Mango si rifà al concetto “mo-derno” della morte o della sublimazione dell'arte sostenendo che ipotizzare il superamento della forma artistica richiederebbe l'eliminazione delle condizioni che hanno determinato e resa ne-cessaria la sua stessa esistenza: “si deve cioè realizzare una condi-zione di esistenza in cui esistere è arte, esistere è teatro, in cui qual-
19siasi atto della vita è comportamento creativo”. Quello che invece si può fare, ed è preciso compito della ricerca, è modificare il lin-guaggio secondo le esigenze imposte da un sociale che di volta in volta si trasforma modificando, a sua volta, le ragioni linguistiche del teatro.
Il Carrozzone, la Gaia Scienza, Falso Movimento, sono le com-pagnie emergenti su cui Mango ferma particolarmente la sua at-tenzione in quanto utilizzano le componenti dello spettacolo (spa-zio, attore, lingua, gesto) non come elementi del linguaggio ma co-
20me linguaggio nella sua accezione autonoma. L'arte concettuale interviene in questo processo azzerando gli statuti del teatro, rivi-sitandoli e riscoprendoli con una valenza diversa, svincolando l'oggetto rappresentativo dai rapporti convenzionali tra produzio-ne e fruizione. Si delinea così la fase del “teatro analitico esisten-19 Achille Mango, L'attore come operatore politico, in introduzione a Jean Dauvignaud, Sociologia dell'attore, cit., pag. 19; presente anche in L'operatore Teatrale, cit., pag. 39.20 Cfr. Silvana Sinisi, Dalla parte dell'occhio. Esperienze in Italia 1972-1982, Roma, Ed. Kappa, 1983, p. 41; Oliviero Ponte di Pino, Il nuovo teatro italiano. 1977-1988, Firenze, La casa Usher, 1988, p. 16; Franco Quadri, L'avanguardia teatrale in Italia, 2 voll., Torino, Einaudi, 1977, vol. I, p. 113; Rino Mele; Falso Movimento '77-'82, Salerno, Taide, 1985, p. 5.
24
ziale”, sviluppata in un libro che Achille Mango scrive insieme a Lorenzo Mango e Giuseppe Bartolucci. La collaborazione con quest'ultimo è particolarmente significativa di tutto il periodo che intercorre tra gli anni Settanta e Ottanta, in quanto segna una fase molto intensa di elaborazione teorica sul teatro contemporaneo svolta a fianco di una delle figure più rappresentative della rifles-sione sulla cultura post moderna.
Per un teatro analitico esistenziale (1980) muove dal presupposto che un determinato tipo di sperimentazione può essere comunica-ta solo a chi è in grado di vivere quella ricerca, giacché l'analisi par-te dal grado zero della scrittura scenica per spingersi fino al tentati-
21 vo di definizione degli elementi primari della sua struttura. Nella modalità con la quale Achille Mango articola la sua posi-
zione teorica, contenuta nel contributo dal titolo Commensurabilità dell'esistere, confluisce la tecnica speculativa maturata dall'autore negli studi di sociologia teatrale, soprattutto nella determinazione scientifica delle categorie del teatro e dei suoi segni distintivi. L'analisi punta ad identificare il comportamento creativo come partecipazione, valore “materiale” che facilita un'appropriazione dello spazio “totale” del teatro. La questione verte su quella che Mango definisce la “falsa” politicizzazione del teatro, un processo storico che per lungo tempo ha prodotto l'illusione di inglobare e coinvolgere il pubblico nel percorso creativo e rappresentativo dando vita a “prodotti teatrali” ad uso e consumo della classe bor-ghese, ma distanti anni luce dalla verità scenica.
Tale teoria completa e definisce la sua forma in Morte della parte-cipazione (1980) che insiste sulla consapevolezza del fallimento del-
21 Giuseppe Bartolucci, Lorenzo e Achille Mango, Per un teatro analitico esistenziale, Torino, Studio Forma , 1980. Nel testo si parla spesso di “scrittura scenica” senza che la definizione sia argomentata dal momento che la nozione trova la sua paternità, più di un decennio prima, proprio in Giuseppe Bartolucci.
25
le tradizionali relazioni del teatro con le componenti storiche e so-ciali, denunciando soprattutto l'inadeguatezza del rapporto rap-
22presentazione-pubblico. Riprendendo la “terza generazione” del teatro di ricerca con gli esempi di teatro analitico-esistenziale, Mango si concentra sulla necessità (utopistica e provocatoria) di eliminare la presenza degli spettatori al fine di cancellare la valenza rappresentativa del teatro e ricondurlo ad un'essenza.
Le tesi riguardanti i rapporti imprescindibili fra teatro e società contenute negli scritti di carattere sociologico sembrano, in questa fase, contraddette e rinnegate. In realtà la questione riguarda le modalità imposte dall'esterno a tale relazione e non la sua sostan-za. L'attenzione si concentra sul luogo scenico, sugli attori i quali possono generare l'unica azione politica possibile al cospetto di spettatori “voyerurs”: la messa in scena si realizza nell'esibizione di una “differenza” del comportamento scenico degli attori non as-similabile ad esperienze passate né condivisibile dal pubblico. Il te-atro, tradizionalmente inteso come rappresentazione, subisce del-le modifiche sostanziali che rifiutano lo spettacolo in nome di un teatro che si risolve tutto nell'idea progettuale sulla scia di quanto prodotto, nell'ambito delle arti visive, dalle esperienze concettuali. Tale cambiamento renderebbe superflua la presenza del pubblico che non è eliminata in termini concreti, ma in termini simbolici che si traducono nell'assenza di una volontà rappresentativa da par-te dell'attore che mostra, in maniera provocatoria, la sua indiffe-renza nei confronti degli spettatori.
In questa operazione di recupero dell'autenticità del teatro Mango assume un atteggiamento di denuncia nei confronti delle sperimentazioni degli anni precedenti, responsabili di aver solo ac-cennato a un processo risoltosi in una nuova omologazione: “Gli errori commessi - si legge nel testo - sono stati almeno due: ritene-
22 Achille Mango, Morte della partecipazione, Roma, Bulzoni, 1980.
26
re che interventi del genere potessero essere compiuti indiscrimi-natamente; credere che fosse sufficiente uscire dai luoghi deputati dello spettacolo teatrale per aver rotto un rapporto e una dimen-
23sione di tipo teatrale”. Il teatro come spettacolo è, secondo tali premesse, visto con sospetto nei confronti di un teatro che si con-figura, in maniera sempre più imponente nella concezione dello studioso, come “idea”.
La riflessione sul teatro contemporaneo da parte di Achille Mango non si ferma, però, alle posizioni del teatro analitico (no-nostante resti il fenomeno sperimentale più vicino alla sua sensibi-lità) ma si rivolge alle trasformazioni che avvengono sulla scena ita-liana e in particolare alla Nuova Spettacolarità. A tale definizione sono ricondotti quegli esperimenti che trasferiscono all'interno dello spazio scenico gli elementi caratteristici dell'esperienza con-temporanea della metropoli (fiction, fumetto, televisione…).
Tra le numerose occasioni di incontro/confronto sulla nuova suggestione estetica predisposte in varie parti di Italia, si inserisce il convegno organizzato da Mango nel 1978 a Padula intitolato
24Teatro/Spazio/Ambiente. Il meeting evidenzia che il teatro analiti-co-esistenziale ha esaurito la sua funzione, in quanto espressione temporanea di quella rivoluzione permanente che in un certo mo-mento storico ne aveva determinata la nascita. L'interesse si sposta verso l'esplorazione dei mezzi tecnologici che la società propone
23 Achille Mango, La morte della partecipazione, cit., p. 19.24 Il convegno non ha prodotto la pubblicazione degli atti. La definizione di “Nuova Spettacolarità” è, però, formulata nel 1981 alla rassegna curata da Giuseppe Bartolucci Paesaggio metropolitano/Teatro-Nuova Performance/Nuova Spettacolarità cui partecipa anche Achille Mango. La rassegna si svolge alla Galleria d'Arte Moderna di Roma dall'8 febbraio al 1 marzo 1981 in occasione del convegno Arte e metropoli nella società post-moderna. Il tema del convegno muove dalla considerazione degli studi socio-filosofici di Lyotard e Baudrillard, identificando la post-avanguardia come ulteriore sviluppo della cultura post-moderna.
27
in ogni campo, utilizzati attraverso un processo di “ritribalizzazio-ne” e combinati nei modi immediati dello spettacolo che ne utiliz-za le potenzialità linguistiche.
L'attenzione verso la nuova evoluzione estetica del teatro di ri-cerca si mantiene costante attraverso la segnalazione degli eventi che appaiono più rappresentativi nel processo di trasformazione in corso del teatro sperimentale (spettacoli, incontri, installazioni) secondo un percorso di indagine che Mango traduce soprattutto attraverso strumenti più immediati di elaborazione critica come le pubblicazioni periodiche e gli interventi a tavole rotonde. Appartiene a questo periodo anche la collaborazione a volumi mi-scellanei a fianco di autori che, come lo stesso Mango, hanno se-gnato la storia critica del teatro italiano di ricerca a partire dagli an-ni Sessanta accompagnando la crescita professionale dei principali
25gruppi protagonisti.È questo un periodo di elaborazione critica particolarmente in-
tenso nel percorso scientifico di Achille Mango che non trascura, come il carattere attuale dei suoi oggetti di indagine potrebbe sug-gerire, approfondimenti teorici su argomenti classici della storia
26 del teatro. Un'attenzione particolare è dedicata all'universo sha-kespeariano interpretato come un caleidoscopio nel quale si in-
25 Cfr. tra gli altri Achille Mango, La macchina e la tecnologia in Giuseppe Bartolucci, Mario Pisani, Giulio Spinucci (a cura di), Paesaggio Metropolitano, Milano, Feltrinelli, 1982; Il linguaggio (im)possibile, in Anna Santoro e Bruno Tramontano (a cura di), Centauri, farfalle e appassionatamente tutti gli altri (indagine sui linguaggi poetici), Napoli, Colonnese, 1986. Tra gli interventi ai convegni vanno segnalati almeno L'analfabeta del 2000 ignorerà il linguaggio dei calcolatori, in Semiotica della rappresentazione a cura di Renato Tomasino, Palermo, Flaccovio Editore, 1984; La tecnologia mentale, in Teatro Oriente/Occidente, Roma, Bulzoni, 1984.26 Cfr. ad esempio Artaud e il teatro della crudeltà, in Filiberto Menna (a cura di), Studi sul Surrealismo, Roma, Officina Edizioni, 1977; Funzione della didascalia negli atti unici, in Stefania Milioto (a cura di), Gli atti unici di Pirandello, Edizioni del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, Agrigento, Caos, 1978.
28
trecciano istanze rappresentative e momenti di autentico pensiero teatrale, in un susseguirsi di immagini che compongono il testo scritto. Lungi da ogni considerazione egemonica del testo in ambi-to rappresentativo Mango individua, tuttavia, all'interno della scrittura shakespeariana i tratti ideologici dell'operazione artistica dell'autore nonché i segni potenziali dell'avventura spettacolare. L'analisi testuale delle commedie e delle tragedie del drammaturgo inglese rivela, in tal senso, la presenza di elementi concettuali che affiancano i momenti puramente rappresentativi. Il testo è, quindi, trattato prima e oltre che come motore dell'azione scenica, come tramite di un pensiero teatrale.
Teatro della follia. Teatro del teatro, scritto in collaborazione con Lorenzo Mango, dimostra come il tema ricorrente della pazzia sia uno dei pretesti per condurre un discorso sull'arte rappresentativa illustrando le caratteristiche teatrali che la malattia tradisce, non già gli aspetti che condurrebbero a un discorso patologico e socia-
27le. Al di là di quelli che possono essere gli esempi in cui Shakespeare applica tale ragionamento con valenza socio-politica, la similitudine follia-teatro appare chiara e immediata proprio nel-la dimensione della rappresentazione. Teatro e follia si riconosco-no analoghi, secondo Mango, nella forma del loro manifestarsi. Entrambi, infatti, presentano una struttura esteriore del compor-tamento che è precisamente riconoscibile e, per molti versi, so-stanzialmente formalizzata ma che non risolve, in sé, le ragioni di tale comportamento. Come la follia trova la sua identità più vera in un complesso quadro di motivazioni fisiche e psichiche che sfug-gono ad un approccio superficiale con la patologia, così il teatro nella sua essenza piena è contenuto all'interno dell'architettura te-stuale e non già nella rappresentazione. Ciò che è racchiuso nella
27 Achille e Lorenzo Mango, Teatro della follia. Teatro del teatro, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1984.
29
scrittura poetica costituisce un livello superiore a quanto si rende esplicito nella messa in scena giacché il testo si pone come veicolo espressivo di istanze profonde, incisive, dense e complesse, che fanno del testo drammatico una realtà non riducibile alle sue appli-cazioni rappresentative.
La riflessione dominante, che accompagna tutti gli scritti di Achille Mango dalla metà degli anni Ottanta in poi, riguarda qual-cosa che potremmo definire come l'essenza del teatro ovvero quel “momento” che contiene in sé l'atto creativo e la sua elaborazione. I canoni della sperimentazione scenica portata avanti dai gruppi della post avanguardia, con l'azzeramento e la sovversione dell'assetto tradizionale degli elementi costitutivi dello spettacolo, alimentano e raffinano una visione del teatro in perenne ricerca del suo momento privilegiato di verità poetica. In tal senso il testo, anche quando è riferito a forme universalmente riconosciute di drammaturgia, assume una valenza più ampia ed emblematica che arricchisce la sua natura verbale per articolarsi in mappa polisemi-ca che contiene in sé il modello teatrale (lo spazio, la scena, l'interpretazione) e quello che Mango definisce un modello di pen-siero. Shakespeare, Pirandello, ma anche gli esperimenti di Simone Carella, Federico Tiezzi, Mario Martone, Giorgio Barberio Corsetti, sembrano così delineare una contrapposizione tra la fase progettuale del teatro e la sua effettiva realizzazione. L'“essenza” del teatro, non riferita più integralmente al momento spettacolare ma non risolta neanche nel puro fattore letterario, sembrerebbe ri-siedere, secondo quanto scrive Mango, nel difficile, complesso, im-possibile rapporto tra i due termini.
Ne L'arte del teatro Mango, allora, individua un “prima” e un “do-po” il teatro che si identificano con il pensiero e la sua applicazio-ne: nello spazio tra l'immaginazione dello spettacolo e la riflessio-
28ne su di esso si colloca il teatro. La natura occasionale della messa
30
in scena finisce spesso per schiacciare questa essenza invalidando, quindi, la forza del pensiero teatrale allo stato puro.
Shakespeare e Pirandello sono in tal senso esempi supremi per-ché resistono e sopravvivono ad ogni tentativo di interpretazio-ne, grazie alla forza e alla completezza contenuta nella forma scritta. Anche nel caso di versioni “sperimentali”, frutto di un lun-go percorso di ricerca, il testo dei grandi autori supera ogni possi-bilità di rappresentazione destinata ad essere espressione parziale e traditrice della verità poetica.
L'interesse di Mango verso capisaldi della cultura teatrale quali Shakespeare e Pirandello potrebbe sembrare, in prima istanza, in contraddizione con la predilezione per le esperienze della posta-vanguardia. In realtà c'è un legame tra le due espressioni tanto lon-tane eppure per certi versi analoghe, tra l'opera letteraria dei grandi autori e la negazione assoluta di essa nell'esperienza teatrale con-temporanea. Nei due drammaturghi il testo letterario è progetto di pensiero teatrale, mentre nella postavanguardia il teatro come pro-getto concettuale si fa testo, in un'accezione ampia che ingloba in sé tutte le componenti dello specifico teatrale.
Del resto, sostiene Mango in polemica con i falsi sperimentali-smi, ogni violazione o rivoluzione tende a ripristinare o generare un nuovo ordine delle cose, una nuova omologazione che con-traddice la natura del termine primario. L'unica forma di trasgres-sione possibile è, pertanto, il pensiero che nella finzione scenica ha carattere dinamico poiché contiene in sé la nozione intrinseca di azione: ciò che Achille Mango sintetizza è che lo spettacolo senza
28 Achille Mango, L'arte del teatro, quaderno n. 5, Demetrio Cuzzola Editore, Salerno, 1986. Il fascicolo è composto da due scritti: Prima e dopo il teatro e Pensiero come trasgressione. Il secondo intervento è presente in Atti del Convegno di Studi Ibsen/ Strindberg/Pirandello, tenutosi al Palazzo Reale di Torino dal 18 al 20 maggio 1985 e inserito poi in Alle origini della drammaturgia moderna, Genova, Costa e Nolan, 1987.
31
pensiero è pura immobilità, il pensiero privo della messa in scena è comunque “movimento”, dunque il pensiero è l'unico e autentico protagonista del teatro e la sperimentazione, come incessante ri-cerca di linguaggi espressivi, è la strada per giungere a tale risultato nell'epoca elisabettiana quanto nell'ambito teatrale italiano degli ul-timi decenni.
La riflessione teoretica di Achille Mango diventa, alle soglie de-gli anni Novanta, sempre più estrema e sviluppa le posizioni enun-ciate nel dibattito espresso in due importanti convegni organizzati a Salerno: Teatro come pensiero teatrale (1987) e Prima e dopo il teatro
29(1990). Come in altri momenti della sua carriera, la formula del convegno rappresenta per lo studioso la possibilità di avere un con-fronto sul campo con esperti del settore sulle problematiche più in-cisive del suo percorso teorico, l'occasione per affiancare diverse competenze intorno a un nucleo tematico. In maniera particolare i due seminari di studio rappresentano un momento di elaborazio-ne scientifica per la scrittura degli ultimi due testi monografici che rappresentano la punta più estrema dell'astrazione teoretica ri-spetto al teatro, una messa in campo delle forze che saranno di-spiegate e organizzate in quelli che si possono considerare i testa-menti teorici della concezione teatrale di Achille Mango.
I due convegni confermano il valore conferito al teatro nella sua forma concettuale, la purezza individuata nello stadio inter-medio tra l'idea e la prassi scenica, e arricchiscono la discussione su quali siano le ragioni della sua sopravvivenza nella società attua-le e quale sia la natura più autentica del teatro su di un piano teori-
29 Cfr. Achille Mango, A Filiberto Menna, introduzione a Rosa Meccia (a cura di) Il teatro come pensiero teatrale, Napoli, ESI, 1990, atti del Convegno di Studi svoltosi all'Università degli Studi di Salerno il 14, 15 e 16 dicembre 1987; e Teatro senza teatro, in Rosa Meccia (a cura di) Prima e dopo il teatro, Brescia, Edizioni L'obliquo, 1991, atti del convegno di Studi organizzato dall'Università degli Studi di Salerno, 27, 28, 29 marzo 1990, in collaborazione con l'ETI di Salerno .
32
co, se non quasi filosofico. La figura in cui il pensiero teatrale espri-me al meglio la sua essenza è probabilmente il sogno, nel suo stret-
30to rapporto con la fantasia e l'immaginazione. Dentro il teatro svi-luppa tale nozione assimilando teatro e sogno nelle caratteristiche peculiari che li definiscono: entrambi non aderiscono alle coordi-nate spazio-temporali in senso ordinario, sono evanescenti e non possono essere riprodotti due volte. La realtà psichica dell'individuo e la realtà artistica dell'attore sono, in tal senso, irri-producibili poiché costituite di una materia che lascia traccia solo in chi sogna e in chi adopera la finzione ed esiste solo nella mente dei suoi artefici. Si tratta di manifestazioni prive di concretezza ep-pure tanto vere e, nel caso dello spettacolo, il racconto del teatro costituisce un enorme malinteso poiché ubbidisce a un'esigenza tanto ossessiva quanto fuorviante di rappresentazione del pensie-
31ro.Questa immagine prende corpo attraverso una singolare meta-
fora scientifica: l'esplosione unica e irripetibile di NGC 1667, un asteroide distante 250 milioni di anni luce dalla nostra galassia. Ciò che sappiamo di questo avvenimento è l'eco che attraverso lo spa-zio giunge fino a noi, non il fatto in sé; ciò che conosciamo del tea-tro è il suo apparire nelle forme della messa in scena, non il suo es-sere. Achille Mango individua in tali forme una serie di “percorsi impossibili” in un viaggio che vede il testo (scena, pubblico, inter-
30 Achille Mango, Dentro il teatro, Salerno, Edizioni 10/17, 1989. Il testo contiene inoltre gli interventi Before and after the theatre , presente anche in Omaggio alla Gaia Scienza, Roma, Centro Odradek, 1987; e NGC 1667, contenuto anche in “Accademie e Biblioteche d'Italia”, a. LV, n. 3, 1987.31 Anche in questo caso la tesi è suffragata da esempi illustri di drammaturgia nei quali il sogno e la realtà, l'essere e l'apparire, diventano termini del discorso sul teatro che si cela dietro le immagini suggerite dal testo: il confine tra sogno e messa in scena della Tempesta e le visione del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, il limite tra il nulla e l'eternità dei Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, le suggestioni oniriche di Ibsen, ed altro.
33
preti, parola) compiere quello che può definirsi un “falso movi-mento”, una sorta di immobilismo artistico che conferma l'irrealizzabilità dell'impresa rappresentativa. Mantenendo costan-te l'interesse verso le ultime generazioni di artisti del teatro italia-no, la riflessione si concentra sul senso della cosiddetta “ricerca”: il teatro sperimentale, nell'accezione comune del termine, non esi-ste, in quanto non è indirizzato alla scoperta di elementi e concetti oggettivamente valutabili, quelle che in altri momenti della storia (vedi Craig) erano state definite le leggi del teatro, ma risponde semmai alle esigenze espressive dei suoi protagonisti.
La questione teorica sul teatro è ribadita e sistemata in maniera risolutiva in Dentro la finzione, ultimo dei testi monografici lasciati da Achille Mango che mostra una coerenza estrema nella defini-zione del discorso complessivo sull'arte rappresentativa annuncia-
32to in precedenza. La prospettiva di indagine assume il teatro co-me “discorso sul teatro” all'interno del quale vengono analizzati i rapporti esterni con la storia e la società e le necessarie contrappo-sizioni interne fra il testo, la scena, il pubblico, gli attori.
Come già espresso in precedenza, Mango conferisce allo statu-to testuale un valore speculativo che interviene sulla forma e sulla essenza del teatro, mentre nega tale natura allo spettacolo di per sé sfuggente, inafferrabile, intrinsecamente legato all'effimero tem-porale. Ciò che si aggiunge a tale posizione è la centralità dell'attore, la creatività visiva e psicologica dell'interprete in rap-porto con gli elementi della finzione scenica. Esempi estremi co-me Carmelo Bene, Leo De Berardinis, Sandro Lombardi, inter-vengono in maniera significativa nel discorso presentando modelli teatrali in grado di definire la rappresentazione in termini concre-tamente artistici nel rapporto assoluto fra testo e messa in scena, nella realizzazione di letture teatrali piuttosto che di spettacoli.
32Achille Mango, Dentro la finzione, Roma, Kepos Edizioni, 1993.
34
Mango allude in particolar modo all'interpretazione di importanti testi drammatici da parte di tali artisti i quali, sebbene attraverso espressioni sceniche differenti, sanciscono la possibilità di azzera-re lo spettacolo come fatto scenico e rappresentativo teso all'interpretazione, usando il testo come evento poetico e trattan-do le parole come un universo teatrale assoluto. Si tratta di opera-zioni teatrali che, nate da una sensibilità affine a quella di Mango, realizzano una nuova modalità di vivere l'esperienza teatrale: in al-ternativa ad un interprete che amplifica la propria presenza realiz-zando il suo momento nella forma spettacolo si propone un attore
33“che dice sulla scena ma non è sulla scena”.E allora la questione che da tempo serpeggia nelle argomenta-
zioni teoriche di Achille Mango sulla reale esistenza del teatro, tro-va qui una risposta positiva che tende a trovare anche una nuova giustificazione alla valenza artistica dello spettacolo: il teatro esiste a patto che si rivedano i termini che lo costituiscono, scindendo nel rapporto identificativo fra realtà e finzione ciò che esiste da ciò che non è, l'idea dallo spettacolo, il testo dalla rappresentazione. Il metateatro rappresenta la chiave in cui il testo teatrale rivela la più autentica sostanza, dal momento che ciò incarna in maniera per-fetta la sperimentalità intrinseca all'esperienza drammatica che si realizza in maniera autonoma e indipendente dallo spettacolo. Gli esempi di Shakespeare e Pirandello ricorrono con forza anche in tale discorso: nel primo (soprattutto riguardo a un esempio meta-teatrale non dichiarato esplicitamente come La tempesta) il testo contiene in sé gli elementi della sua realizzazione scenica, nel se-condo (soprattutto riferito alla trilogia del “teatro nel teatro”) il me-tateatro rappresenta l'unica rappresentazione possibile per la veri-tà scenica.
Ovviando ad eventuali accuse di astrazione in questa personale
33 Achille Mango, Dentro la finzione, cit., pag.13.
35
visione dell'esperienza teatrale, Achille Mango completa la sua po-sizione teorica riprendendo le argomentazioni sul rapporto im-prescindibile fra teatro e storia nella sua valenza sociale e ideologi-ca. Anche in esempi “visionari” apparentemente avulsi dal conte-sto storico, quali quelli suggeriti da una parte della sperimentazio-ne teatrale, questa relazione permane in maniera forte e incisiva non come scambio tra una forma che simula la vita e la vita stessa, ma come confronto tra la materia del racconto e la forma di questo racconto. “Il vero artista è certamente legato al suo tempo, ma con-temporaneamente ne è distante, nel senso che egli è lontano dalla storia perché non intende assolutamente raccontare le vicende e lo
34spirito; le è vicino nella misura in cui tende a ripetere le forme”.Le posizioni maturate nel corso di tutta la carriera scientifica di
Achille Mango si articolano e si sintetizzano, quindi, in uno scritto che sembra tracciare un percorso a ritroso nell'iter speculativo del-lo studioso, un cammino che parte dallo spettacolo per ritornare al teatro. In realtà le posizioni raggiunte sono il risultato di una matu-razione intellettuale che, attraverso un ampio arco di tempo, ha analizzato il fenomeno teatrale nei suoi diversi aspetti teorici e rap-presentativi in una prospettiva scientifica che non ha trascurato le inevitabili relazioni disciplinari. E allora le incursioni nei territori della storia dell'arte, delle scienze sociologiche, della tecnologia, so-no strumenti di indagine per decodificare il fenomeno teatrale nel-la sua natura composita senza per questo perdere di vista il nucleo del suo significato più puro. La funzione registica è così riferita so-lo alla fase rappresentativa, allo spettacolo in quanto tale e non alla forma pura del teatro che si risolve compiutamente nel modello te-stuale, in un'accezione che supera i limiti verbali e si pone come sin-tesi di tutti i linguaggi possibili e realizzabili sulla scena.
L'individuazione di questa essenza come elemento primario e
34 Achille Mango, Dentro la finzione, cit., pag. 37.
36
irrinunciabile dell'esperienza drammatica definisce un concetto più articolato di storia del teatro come storia delle teorie teatrali, delle idee indipendenti dai momenti della drammaturgia e della rappresentazione. L'intuizione del testo come nucleo del pensiero teatrale, come materia prima di tale essenza, induce alla considera-zione della storia del teatro come la storia delle teorie che nel corso del tempo hanno definito l'idea di teatro.
La riflessione sviluppata attraverso anni di ricerca, di insegna-mento, di studio, si completa con la partecipazione attiva nei terri-tori concreti dello spettacolo testimoniata dall'attività esercitata da Mango in qualità di critico teatrale espressa in una grande quantità di articoli prodotti per numerose testate giornalistiche. Tale aspet-to assume un significato particolare all'interno della carriera di Achille Mango completando il profilo scientifico dello studioso tracciato dai testi teorici fondamentali.
L'attività di critico si affianca in maniera costante all'approfondimento speculativo di stampo più scientifico, assu-mendo dei significati differenti nel corso degli anni. Dalla sempli-ce attività di recensore, la presenza di Mango sulla stampa quoti-diana e periodica prende ben presto connotazioni politiche preci-se che caratterizzano il taglio e lo stile degli interventi per trovare, nel corso del tempo, spazi giornalistici di carattere più generica-mente culturale che favoriscono la scrittura di articoli di natura più strettamente teorica e saggistica. Col tempo, infatti, per ragioni che sono da imputare soprattutto al modificarsi delle condizioni della vita politica e della cultura della sinistra italiana, l'impegno si trasforma in militanza artistica sempre connessa a una precisa ideologia che non farà mai mistero di se stessa, ma che sarà subli-mata all'interno delle questioni teoriche. Tale evoluzione si riscon-tra in tre nuclei sostanziali individuabili all'interno della copiosa produzione giornalistica costituita dagli scritti pubblicati su “Mon-
37
do Nuovo”, “Il Ponte” e “Il Giornale di Napoli”.Negli anni '60 Achille Mango partecipa all'avventura di “Mon-
do Nuovo”, organo ufficiale del P.S.I.U.P., collaborando dal 1964 fino all'ultimo numero nel 1972, anno che segna la chiusura defini-tiva della testata e il successivo ingresso del critico nella Commissione Teatro del Partito Comunista Italiano. Il corpus di “Mondo Nuovo” è costituito da circa duecento interventi tra re-censioni, riflessioni e dibattiti che si uniscono ad articoli pubblicati negli stessi anni in altri organi di carattere politico come “Il Calendario del Popolo” e “Il Cannocchiale”. Su questa linea la col-laborazione più significativa resta, tuttavia, quella intrapresa con “Il Ponte” che ricopre l'arco di tempo che va dal 1960 al 1996.
La presenza in un quotidiano politico come “Mondo Nuovo” impone al critico una funzione differente da quella richiesta da un giornale come “Il Ponte” che, nonostante precise tendenze ideo-logiche, si presenta come rivista di cultura (tra l'altro a scadenza
35mensile e non quotidiana) piuttosto che come organo di partito. Ciò si riflette nella diversità dello stile degli articoli pubblicati sui due periodici e anche nella qualità dei soggetti trattati dove l'immediatezza della scrittura del primo predilige la recensione e l'argomento teatrale come evento socio-politico, mentre la natura saggistica del secondo favorisce la dissertazione storica e teorica alimentata da una certa lunghezza concessa agli scritti.
Negli articoli su “Mondo Nuovo” l'opinione sull'evento teatra-le si pone spesso come pretesto per sferrare attacchi diretti alle ina-dempienze delle istituzioni, all' indole borghese di taluni spettaco-li, alla sperequazione dei finanziamenti per le diverse realtà teatrali, mentre la maggior parte dei servizi si occupa dei fenomeni più inte-ressanti della scena italiana. Nonostante la diversità dettata dal ca-
35 “Il Ponte” è descritto in copertina come “Rivista mensile di politica e letteratura fondata da Piero Calamandrei”.
38
rattere delle testate, gli interventi pubblicati su “Mondo Nuovo” e “Il Ponte” presentano degli aspetti similari almeno per il periodo in cui Achille Mango vi scrisse in contemporanea. In entrambi so-no rinntracciabili, infatti, segnalazioni e discussioni sui fenomeni che proprio in quegli anni hanno la loro diffusione in Italia: il tea-tro di Peter Weiss, il Living Theatre, Grotowski, la rilettura di Brecht, ma anche fenomeni nazionali come il dibattito sulla scrit-tura scenica e le dirompenti azioni teatrali di Dario Fo oggetto, com'è noto, di accese controversie.
Verso la fine degli anni '80 la partecipazione a “Il Ponte” si in-terseca con la collaborazione di Achille Mango a “Il Giornale di Napoli” per il quale scrive fino al 1992. Ma proprio negli anni - tra il 1983 il 1991 in cui la collaborazione con il giornale napoletano diventa più intensa, il rapporto con “Il Ponte” subisce una pausa. Sul quotidiano partenopeo Mango non interviene negli spazi ri-servati alla cronaca degli spettacoli, ma in quelli della “terza pagi-na”, all'interno della quale trovano giusta collocazione ampi saggi nei quali traspaiono le riflessioni che confluiscono negli ultimi te-sti teorici.
Esiste poi un'attività di collaborazione con artisti del teatro che si sviluppa in diversi momenti, come testimonia una lettera inviata a Dario Fo nella quale è suggerita una lunga lista di riferimenti let-terari e teatrali da esaminare in vista della preparazione di Mistero Buffo, spettacolo diventato ben presto il simbolo del teatro di Fo nonché uno degli esempi più significativi del repertorio italiano de-
36gli anni della contestazione.E non si tratta di un esempio isolato. Esistono delle tracce di
scrittura concepita per la scena composte in collaborazione con 37Carlo Quartucci a Carla Tatò, nonché un copione manoscritto
36 La lettera, datata 30 gennaio 1967, è pubblicata su Internet all'indirizzo corrispondente all'archivio storico-artistico di
Dario Fo e Franca Rame. Il documento è archiviato con una tipologia che www.archivio.francarame.it
39
mai rappresentato e composto per la compagnia salernitana Teatro Gruppo, classificato dall'autore come segue: “Regole per atto-ri. Atto unico per attori e marionette di Achille Mango”.
Il testo, che presenta le caratteristiche di uno scenario, è una ver-sione ironica delle “Regole per gli attori” di Goethe, guidato da un per-sonaggio grottesco che assume le sembianze esasperate dello scrittore tedesco nell'atto di impartire le sue leggi agli attori (uomi-ni e marionette) con il carattere di un tiranno, o meglio, di un doma-tore di fiere esasperato fino al punto da impartire dure punizioni fi-siche. Il tutto è costellato, nella struttura e nel contenuto, da cita-zioni tratte dall'intera storia del teatro occidentale dagli albori fino a Grotowski e il Living Theatre: “Il canovaccio” - spiega il copione in una didascalia iniziale - “è una carrellata sulla storia del teatro, dalla fase in cui la cosiddetta civiltà costringe lo spettacolo nella scatola chiusa del luogo teatrale a quella in cui lo spettacolo ricon-
38quista la sua libertà e ritorna al luogo originario, la strada”.
L'analisi comparata degli scritti di Achille Mango delinea dun-que il rapporto intenso e partecipato dello studioso con il teatro, af-
dichiara il ruolo assunto dalla lista bibliografica per la genesi del testo dello spettacolo: “Lettera di Achille Mango a Dario Fo in cui gli propone una lista da esaminare, prima che si incontrino in vista della stesura di Mistero Buffo”. Fatta eccezione per pochi titoli, l'elenco bibliografico proposto si compone di brani tratti dal repertorio non ufficiale: canovacci, lazzi, frammenti, tenzoni, reperti apocrifi e quant'altro lascia trasparire una competenza archivistica non comune associata a una acuta sensibilità rappresentativa.37 Carlo Quartucci e Carla Tatò sono tra i maggiori esponenti del teatro di ricerca degli anni '60 spesso citati come esempi da Achille Mango nei suoi studi sull'avanguardia e sulla post avanguardia. Mango ha, inoltre, collaborato ad una trasmissione per RAITRE dal titolo I linguaggi della comunicazione: l'avanguardia teatrale. Viaggio intorno ad un'idea di teatro, progetto in cinque puntate ideato e diretto da Carlo Quartucci nell’aprile del 1987.38 Achille Mango, “Regole per gli attori”, atto unico per attori e marionette, m.s., s.d., pag. 6.
40
frontato e analizzato in tutti i suoi aspetti linguistici e secondo va-rie prospettive metodologiche. Come dimostrano le prime mono-grafie, la produzione intellettuale di Mango si inserisce, per epoca e scelta speculativa, nella pionieristica fondazione di una autentica storiografia teatrale in Italia. Gli ambiti di studio e le scelte meto-dologiche nell'indagine sullo specifico teatrale rivelano una sensi-bilità nuova, rispetto agli studi tradizionali sul teatro condotti fino agli anni '60, che persiste in tutta la produzione scientifica.
Dalla cronaca degli spettacoli all'indagine storiografica, dalla militanza politica all'analisi sociologica, dalla valutazione stretta-mente testuale fino all'attività congressuale e alla collaborazione drammaturgica, l'opera di Achille Mango tocca diversi periodi sto-rici e complesse questioni riguardanti lo specifico teatrale. Ma gli scritti che si impongono all'interno del corpus bibliografico sono, probabilmente, quelli riguardanti il teatro contemporaneo con spe-ciale riferimento all'avanguardia e alla post avanguardia, della qua-le può essere considerato come uno dei promotori e teorici fonda-mentali.
Ma ciò che caratterizza a pieno il profilo dello studioso, all'interno della varietà degli ambiti selezionati, è l'eclettismo so-stenuto inoltre, da uno stile di scrittura creativo nutrito di sugge-stioni filosofiche e in taluni casi addirittura criptico. La capacità di spaziare all'interno dei territori del teatro, nelle sue epoche stori-che, nei suoi generi e protagonisti, nonché l'abilità di toccare disci-pline complementari all'arte rappresentativa, caratterizza con for-za la natura speculativa di Achille Mango.
Una riflessione più approfondita rivela però una coerenza di in-tenti che veicola l'eclettismo verso la definizione di un'idea perse-guita nel corso dell'intera carriera: identificare il teatro con il pen-siero teatrale. Un assunto che fa da sfondo e organizza l'eteroge-neo materiale teorico dal momento che tutte le incursioni negli am-
41
biti affini definiscono una personale idea di teatro: una visione che ridimensiona la componente spettacolare e registica in virtù di un'autonomia concettuale che risiede nell'atto creativo allo stato puro, completo, assoluto, inafferrabile quanto necessario.
La carriera di studioso di Achille Mango si è interrotta con un sogno irrealizzato che, alla luce del suo percorso intellettuale, sa-rebbe risultato il naturale approdo delle sue riflessioni sul teatro: scrivere un libro su Antonin Artaud, la più enigmatica e complessa figura del teatro contemporaneo il quale, non a caso, ha consegna-to le sue geniali intuizioni all'attività speculativa e non all'azione scenica operando la forma più autentica di trasgressione, quella af-fidata esclusivamente all'elaborazione intellettuale, al pensiero.
42
NOTA ALLA BIBLIOGRAFIA
La ricerca bibliografica su Achille Mango ha presentato non po-chi problemi data la quantità del materiale prodotto e la scarsità dei reperti conservati nella biblioteca privata dello studioso. Un aiuto prezioso sull'indicazione delle possibili fonti da ricercare mi è sta-to fornito da Lorenzo Mango, al quale vanno i miei più sinceri rin-graziamenti.
Il ritrovamento degli scritti è stato, quindi, condotto anche at-traverso il contatto diretto con le personalità più significative sul territorio nazionale con le quali Mango ha collaborato nel corso della sua produzione scientifica. Per la parte strettamente giornali-stica, i risultati più consistenti sono stati prodotti dallo spoglio dei fondi esaminati a Napoli e a Roma. A Napoli gran parte del materiale è stato rinvenuto alla Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, alla Biblioteca della Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi “Federico II”, all'Istituto “Be-nedetto Croce”, all'Emeroteca dell'Ordine dei Giornalisti “A. Tuc-ci” per la raccolta integrale de “Il Giornale di Napoli” e all'Istituto Campano per la Storia della Resistenza dove è conservata gran par-te della collezione de “Il Ponte”.
A Roma, invece, ho potuto ritrovare numerosi articoli e scritti presso la biblioteca di arte e spettacolo del “Burcardo”, la Bibliote-ca Nazionale e la Biblioteca della Fondazione “Lelio Basso” che conserva l'intera collezione del quotidiano “Mondo Nuovo” sulla quale Mango ha pubblicato circa duecento articoli.
Nonostante la quantità dei titoli reperiti, l'eclettismo dell'intero
45
corpus suggerisce la reale possibilità che la ricerca effettuata non sia del tutto esauriente. Sulla base del materiale raccolto, tenuta sal-va l'eventualità di ulteriori documenti, è stato comunque necessa-rio un ordine che ha accorpato gli scritti in base al genere biblio-grafico.
La classificazione adottata è la seguente:- libri- scritti in qualità di “coautore”- scritti in collaborazione, atti di convegno, annali, studi in
onore- introduzioni e presentazioni - articoli e interventi pubblicati su periodici- dispense
Conclude la suddivisione un'ultima sezione denominata “inediti” nella quale confluiscono alcuni scritti conservati da Mango e mai pubblicati.
46
LIBRI
Il teatro siciliano, (a cura di Achille Mango), Palermo, Edizioni E.S.A., 1961.
La commedia in lingua nel Cinquecento, bibliografia critica con introdu-zione di Vito Pandolfi, Milano, Lerici, 1966.
Le teorie della recitazione, Salerno, Libreria Internazionale, 1970/1971.
Cultura e storia nella formazione della commedia dell'arte, Bari, Adriatica Editrice, 1972.
Farse cavaiole, Roma, Bulzoni, 1973, 2 voll.
Verso una sociologia del teatro, Palermo, Celebes Editore, 1978.
La morte della partecipazione, Roma, Bulzoni, 1980.
L'arte del teatro, quaderno n. 5, gennaio 1986, Demetrio Cuzzola 1Editore, Società Dante Alighieri, Comitato Provinciale di Salerno.
Dentro il teatro, Salerno, Edizioni 10/17, 1989.
Dentro la finzione, Roma, Kepos Edizioni, 1993.
1 Il quaderno è costituito da due articoli: Prima e dopo il teatro e Pensiero come trasgressione. Quest'ultimo, presentato al Convegno Ibsen/Strindberg/Pirandello svoltosi al Palazzo Reale di Torino il 18, 19 e 20 aprile 1985, è inserito in Alle origini della drammaturgia moderna, Genova, Costa e Nolan, 1987.
47
SCRITTI IN QUALITÀ DI “COAUTORE”
Achille Mango, Maria Rosaria Lombardi, Le origini della commedia dell'arte, dispense del corso di lezioni tenuto presso la Facoltà di Ma-gistero dell'Istituto Universitario di Salerno nell'a.a. 1969/70. In appendice: scelta antologica da L'arte rappresentativa premeditata e all'improvvisazione di A. Perrucci. Salerno. Libreria Internazionale Editrice, (San Giorgio a Cremano, Istituto Grafico Italiano), 1970.
Giuseppe Bartolucci, Achille e Lorenzo Mango, Per un teatro anali-tico esistenziale, Torino, Studio Forma, 1980.
Achille e Lorenzo Mango, Teatro della follia. Teatro del teatro. Saggi su Shakespeare, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1984.
48
SCRITTI IN COLLABORAZIONE, ATTI DI CONVEGNI, ANNALI E STUDI IN ONORE
La “teatralità” nei sonetti, in G. Gioachino Belli (1791 - 1863). Miscella-nea per il centenario, Roma, Edizioni Palatino, a. VII, parte II, n. 8 - 12. 1963.
Vincenzo Braca e la farsa cavaiola, in Annali di Storia del Teatro e dello Spettacolo, a. I, 1966.
La crisi del prodotto, in Uso, modalità e contraddizioni dello spettacolo imma-gine, Pollenza - Macerata, Altro/La Nuova Foglio Editrice, 1975. Atti del Convegno di Studi Nuove Tendenze/Teatro Immagine te-
2nutosi a Salerno l'8 giugno 1973.
Artaud e il teatro della crudeltà, in Filiberto Menna (a cura di), Studi sul Surrealismo, Roma, Officina Edizioni, 1977. Atti del Convegno di Studi promosso dall'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università de-gli Studi di Salerno, marzo-maggio 1973.
Il teatro italiano in Francia alla fine del Cinquecento, in Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Bari, nuova serie, 4 - 5, Bari, Adriatica Editrice, 1973/74.
Cinema: industria o arte totale?, in Giovanni Dotoli (a cura di), Ricciotto Canudo, Fasano, Grafischena, 1978. Atti del Congresso Interna-
3zionale nel centenario della nascita svoltosi a Bari.
2 Presente anche in “Quaderni del CUT di Bari”, n. 13, maggio 1974 e poi inserito in Achille Mango, Verso una sociologia del teatro, Palermo, Celebes, 1978.3 Articolo pubblicato anche ne “Il Ponte”, a. XXXIV, n .5, maggio 1978.
49
Funzione della didascalia negli Atti unici, in Stefano Milioto (a cura di), Gli Atti unici di Pirandello, Edizioni del Centro Nazionale di Studi pi-randelliani, casa natale di Luigi Pirandello, Villaseta, Caos, Agri-gento, novembre 1978. Testi del V Convegno Nazionale su Luigi Pirandello.
Un “Intermedio” di Vincenzo Braca nella Biblioteca Nazionale di Napoli, in Letteratura e Società, Scritto di Italianistica e di Critica Letteraria per il XXV anniversario dell'insegnamento universitario di Giu-seppe Petronio, vol. I, Palermo, Palumbo, 1979.
Potere dell'Immagine, Immagine del potere, in Rapporto tra mezzi audiovisi-vi ed età evolutiva, Atti del Convegno tenutosi nel corso del 33° Festi-val Internazionale del Cinema di Salerno, 22-26 ottobre 1980, edi-zioni del Festival del Cinema di Salerno.
Dal teatro al teatro, in Lorenzo Mango (a cura di), La macchina del tem-po: dal teatro al teatro, Perugia, Editrice Umbra Cooperativa, 1981.
Prima della tecnologia, in Il suono del teatro, Atti del Convegno di Studi tenutosi a Palermo il 19 e 20 ottobre 1981.
La macchina e la tecnologia, in Giuseppe Bartolucci, Mario Pisani, Giu-lio Spinucci (a cura di), Paesaggio metropolitano, Milano, Feltrinelli, 1982 .
Benedetto Simonelli. Sine nomine, in Giuseppe Bartolucci, Mario Pisa-ni, Giulio Spinucci (a cura di), Paesaggio metropolitano, Milano, Fel-trinelli, 1982 .
Teatro sperimentale e di avanguardia, in Mario Verdone (a cura di), Tea-tro contemporaneo, vol. I, Roma, Lucarini, 1982.
50
La critica teatrale, la cultura e la società di massa, in Critica e società di mas-sa, Trieste, Edizioni LINT, 1983. Atti del Convegno tenutosi a Trieste.
Attualità e inattualità di Ibsen, in Enzo Puglia (a cura di) Atti del Con-vegno su Enrik Ibsen, Sorrento, 1983.
“La teoria del teatro” di Simon Maria Poggi, in Scritti in onore di Giovanni Macchia, Milano, Mondadori, 1983.
L'analfabeta del 2000 ignorerà il linguaggio dei calcolatori, in Renato To-masino (a cura di), Semiotica della rappresentazione, Palermo, Flacco-vio Editore, 1984. Atti del Convegno di Studi organizzato dalla cat-tedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo della Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo (20-21 novembre 1980).
Presentazione a La cultura italiana negli anni 1930-1945, Napoli, E.S.I., tomo I, 1984. Atti del Convegno di Studi svoltosi a Salerno dal 21 al 24 aprile 1980.
La morte dell'attore, in La cultura italiana negli anni 1930 -1945, Napoli, E.S.I., tomo II, 1984. Atti del Convegno di Studi svoltosi a Saler-
4no dal 21 al 24 aprile 1980.
Teatro e arti visive nello spettacolo medievale, in Studi di Storia delle Arti, Università degli Studi di Genova, Istituto di Storia dell'Arte, 1984.
La tecnologia mentale, in Teatro Oriente/Occidente, Roma, Bulzoni 1984. Atti del Convegno di Studi.
L'arte è un modo meraviglioso per dimenticare la vita, in Atti del Convegno Mondiale di sociologia del teatro, Roma, Bulzoni, 1986.
4 Presente anche in “Quarta Parete” n. 7/8, luglio 1983.
51
Dalla commedia all'improvviso alla commedia letteraria, in Maria Chiabò e Federico Doglio (a cura di), Teatro comico fra Medio Evo e Rinasci-mento: la Farsa, Roma, Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rina-scimentale, 1986. Atti del Convegno di Studi tenutosi a Roma dal 30 ottobre al 2 novembre 1986,
Dioniso nel mondo contemporaneo, in Maurizio Grande (a cura di), Pro-getto Dioniso. Il convito di Dioniso, Roma, Bulzoni, 1986.
Il linguaggio (im)possibile, in Anna Santoro e Bruno Tramontano (a cura di), Centauri, farfalle e appassionatamente tutti gli altri (indagine sui linguaggi poetici), Napoli, Colonnese, 1986. Atti del Convegno di Stu-di promosso dall'Istituto Grenoble di Napoli il 23-24-25 ottobre 1986.
La premeditazione dell'intelligenza, in Scritti in memoria di Pasquale De 5Lisio, Napoli, Esi, 1986.
Tradizione e novità nel teatro di Giovan Battista Della Porta, in Giovan Bat-tista Della Porta nell'Europa del suo tempo, Napoli, Guida, 1986. Atti del Convegno di Studi tenutosi all'Istituto Suor Orsola Benincasa.
Before and after the theatre, in Omaggio alla Gaia Scienza, Centro Odra-dek, Roma, 1987.
Pensiero come trasgressione, in Alle origini della drammaturgia moderna. 6Ibsen, Strindberg, Pirandello, Genova, Costa & Nolan, 1987. Atti del
Convegno Internazionale di Studi tenutosi al Palazzo Reale di Tori-no il 18-19-20 aprile 1985.
5 Articolo inserito poi in Letteratura fra centro e periferia, Napoli, ESI, 1987.6 Presente anche in L'arte del teatro, quaderno n. 5, gennaio 1986, Demetrio Cuzzola Editore, Società Dante Alighieri, Comitato Provinciale di Salerno.
52
Sperimentazione e non: il linguaggio (im)possibile, in Le forze in campo, Mo-dena, Mucchi, 1987. Atti del Convegno di Studi tenutosi a Modena il 24 e 25 maggio 1986.
Il dionisismo nel mondo contemporaneo, in Maurizio Grande (a cura di), Studi sul dionisismo, Roma, Bulzoni, Biblioteca Teatrale (51), 1988.
Interpretare e rappresentare, in Carlo Quartucci, Verso Temiscira, Mila-no, Ubulibri, 1988.
Immagini teatrali nelle poesie tursitane, in Rosa Meccia (a cura di) Il tran-sito del vento: il mondo e la poesia di Albino Pierro, Napoli, E.S.I., 1989. Atti del Convegno di Studi svoltosi a Salerno dal 2 al 4 ottobre 1985.
La manipolazione della memoria, in Teatro e drammaturgia a Napoli nel Novecento: Bracco, Viviani, Eduardo De Filippo, Patroni Griffi. Napoli
7 città teatrale, Napoli, Conte, 1989.
Pensiero in forma di poesia, in Rosa Meccia (a cura di) Il transito del ven-to: il mondo e la poesia di Albino Pierro, Napoli, E.S.I., 1989. Atti del Convegno di Studi svoltosi a Salerno dal 2 al 4 ottobre 1985.
“Que los suenos, suenos son”, in Laura Dolfi (a cura di) L'imposible/posible di Gederico Garcìa Lorca, Napoli, E.S.I., 1989. Atti del Convegno di Studi svoltosi a Salerno il 9 e 10 maggio 1988.
San Francesco e il teatro rinascimentale, in Silvio Pasquazi (a cura di) San Francesco e il Francescanesimo nella letteratura italiana dal Rinascimento al Romanticismo, Roma, Bulzoni, 1989. Atti del Convegno Nazionale tenutosi ad Assisi dal 18 al 20 maggio 1989.
7 Si tratta di un numero monografico di “Misure Critiche” a. XIX, n. 70/71, 1989.
53
Lo spettacolo della morte: le esecuzioni capitali, in Paolo Bosisio (a cura di), Lo spettacolo nella rivoluzione francese, Roma, Bulzoni, Biblioteca di Cultura 387, 1989. Atti del Convegno Internazionale di Studi te-nutosi a Milano il 4-5-6 maggio 1989.
Visioni, in Società Raffaello Sanzio, Il teatro iconoclasta, a cura di Ti-ziana Colosso, Ravenna, Edizioni Essegi, 1989.
Una metafisica in atto, in Franco Carmelo Greco (a cura di), Pulcinella maschera nel mondo. Pulcinella e le arti dal Cinquecento al Novecento, Napo-li, Electa, 1990.
A Filiberto Menna, in Rosa Meccia (a cura di) Il teatro come pensiero tea-trale, Napoli, ESI, 1990. Atti del Convegno di Studi svoltosi all'Università degli Studi di Salerno il 14, 15 e 16 dicembre 1987.
Introduzione al Convegno, in Rosa Meccia (a cura di) Il teatro come pen-siero teatrale, Napoli, ESI, 1990. Atti del Convegno di Studi svoltosi all'Università degli Studi di Salerno il 14, 15 e 16 dicembre 1987.
Ruzante e la forma della rappresentazione, in Giovanni Calendoli (a cu-ra di), III Convegno Internazionale di Studi sul Ruzante, Padova, Società Cooperativa Tipografica, 1990.
Trasparenza e non trasparenza della parola, in Luigi Reina (a cura di) Hu-manitas e Poesia. Studi in onore di Gioacchino Paparelli, Salerno, Pietro Laveglia Editore, vol. II, 1990. Atti del Convegno di Studi organiz-zato dall'Istituto di Lingua e Letterartura Italiana dell'Università degli Studi di Salerno.
Diabolus sive Dia-bolus, in Laura Dolfi (a cura di), Tirso da Molina: im-magine e rappresentazione, Napoli, ESI, 1991. Atti del II Convegno Internazionale di Studi dal titolo L'opera di Tirso da Molina organiz-zato dall'Università degli Studi di Salerno nel 1989.
54
Note per un'antropologia dell'attore, in Silvana Sinisi (a cura di), Scritti in onore di Filiberto Menna, Roma, Bulzoni, 1991.
Pirandello e la riflessione sul teatro, in Enzo Zappulla (a cura di), Thea-tralia. Scritti in onore di Mario Giusti, Maimone, Catania, 1991.
Scene di conversazione, in Carlo Quartucci (a cura di), La Zattera di Ba-bele. 1981/1991. Dieci anni di parola, immagine, musica e teatro, Firenze, Tipografia Press 80, 1991.
Il teatro è un bene culturale?, in Lamberto Trezzini (a cura di), Il patri-monio teatrale come bene culturale, Roma, Bulzoni, 1991. Atti del Con-vegno di Studi promosso dall'Associazione Docenti Universitari Italiani di Teatro e svoltosi a Parma il 24 e 25 aprile 1990.
Teatro senza teatro, in Rosa Meccia (a cura di) Prima e dopo il teatro, Bre-scia, Edizioni L'obliquo, 1991. Atti del Convegno di Studi orga-nizzato dall'Università degli Studi di Salerno, Fisciano, 27, 28, 29 marzo 1990.
Wagner o della contraddizione, in Silvana Sinisi, Miti e figure dell'immaginario simbolista, Genova, Costa e Nolan, 1992. Atti del Convegno Internazionale di Studi promosso dall'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università degli Studi di Salerno il 27-28-29 settem-bre 1991.
Lo spazio come essenza di teatro, in Paola Cabibbo (a cura di), Lo spazio e le sue rappresentazioni: stati, modelli, passaggi, Napoli, E.S.I., 1993. Atti del Convegno di Studi svoltosi a Salerno dal 5 al 7 marzo 1990.
Impegno e teatralità nelle commedie di Luigi Squarzina, in Passione e dialet-tica della scena, Studi in onore di Luigi Squarzina, Roma, Bulzoni, 1994.
55
Gli esuli di Joyce, in Franca Ruggieri (a cura di), Oltre il romanzo: da Ster-ne a Joyce, Napoli, ESI, 1995. Atti del Convegno di Studi tenutosi a Salerno il 24 e 25 marzo 1992.
Il cielo può cadere sulla nostra testa, in Umberto Todini (a cura di), Paso-lini e l'antico. I doni della ragione, Napoli, E.S.I., 1995. Atti del Conve-gno di Studi tenutosi a Salerno nel 1994.
Finzione o falsità?, in Rosa Maria Grillo (a cura di), La poetica del falso: Max Aub fra gioco e impegno, Napoli, ESI, 1995. Atti del Convegno di Studi svoltosi a Salerno il 14 e 15 marzo 1994.
Lo spettacolo della piazza, in Marina Vitale e Domenico Scafoglio (a cura di), La piazza nella storia: eventi, liturgie, rappresentazioni, Napoli, E.S.I., 1995. Atti del Convegno di Studi svoltosi a Salerno nel di-cembre 1992.
56
INTRODUZIONI E PRESENTAZIONI
Introduzione a Jean Duvignud, Le ombre collettive. Sociologia del teatro, Roma, Officina Edizioni, 1974.
L'attore come operatore politico, introduzione a Jean Duvignaud, Socio-8logia dell'attore, Sergio Ghisoni Editore, Milano, 1977.
Introduzione a Geppino Cilento, La scena neapolitana alla rovescia: ico-nografia solare di un carnevale in fabbrica, Napoli, Società Editrice Na-poletana Stampa, 1978.
Introduzione a Barbara de Miro d'Ajeta, Sulla derivazione degli Atti unici di Pirandello dalle novelle, Manfredonia, Atlantica, 1979. Introduzione a Il teatro italiano: dall'impegno pubblico alla sperimentazio-ne, catalogo della mostra tenutasi a Perugia dal 12 novembre all'11 dicembre 1981, Perugia, Eurocoop (Editrice Umbra Cooperati-va), 1981.
La forma è il pensiero, presentazione dello spettacolo David Copper-field del Teatro Studio di Caserta, Roma, 1984.
Presentazione a Crepino gli artisti, di Tadeusz Kantor, programma di sala, Mercato San Severino (SA), Teatro A, 27/28 gennaio 1988.
8 Presente anche in L'operatore teatrale, “Quaderni del Laboratorio Teatrale Universitario”, Palermo, giugno 1981.
57
Somnio ergo sum, programma di sala dello spettacolo dei Magazzini Criminali Divina Commedia, marzo 1991.
Presentazione a Qui non ci torno più, di Tadeusz Kantor, programma di sala, Salerno, Teatro Capitol, 15/16 maggio 1990.
Presentazione a Barbara de Miro d'Ajeta, Marina Guerritore, Anna Maffei, Rosanna Spirito, Franco Tozza, La scena del tempo. Mo-menti dell'evoluzione di un'arte, Salerno, Edisud, 1980.
58
SCRITTI E INTERVENTI PUBBLICATI SU PERIODICI
“Accademie e Biblioteche d'Italia”
La biblioteca di Bragaglia Studioso, a. XXXV, n. 3, 1967.
La commedia dell'arte alla luce del folclore, a. XVLI, n. 3-4, maggio - ago-sto1978.
NGC 1667, a. LV, n.3, 1987.
“Acquario”
La napoletanità non esiste, n. 1, dicembre 1982, marzo 1983.
Essere capaci di una passione e non realizzarla, significa trovarsi incompleti e limitati, n. 6, marzo 1986.
“Art Dimension”
Achille e Lorenzo Mango, Spazio e spettacolo, spazio o spettacolo, spa-zio/spettacolo, n. 13, marzo 1978.
59
“L'Astrolabio”
Decentramento teatrale e disservizio pubblico, a. XV, n. 5, 14 marzo 1977.
Ossigeno DC ai baroni del palcoscenico, a. XV, 28 maggio 1977
“Biblioteca Teatrale”
Theatre and mind, N.S., n.4, 1986.
Luigi Pirandello: il personaggio, N.S., n. 8, 1987.
Amleto, testo metateatrale, N.S., n. 13-14-15, 1989.
Un passo divide il teatro dalla realtà, “Biblioteca Teatrale”, N.S., nume-ro monografico su La scrittura scenica di Giuseppe Bartolucci, n. 48, ot-
9tobre - dicembre, 1998.
“Il Caffè”
Il Fuggilozio, testo critico satirico sulla traduzione dell'Iliade per lo spettacolo di Giancarlo Sbragia sul poema omerico, a. XX, nn. 2-3, serie IV, luglio/agosto 1973/74.
Il forzato sogghigno di Carrafone, presentazione di un brano della Farsa de lo mastro de scola, una farsa della fine del Cinquecento di Vincenzo Braca, contenuta in un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli, a. XX, serie VI, nn. 4-5-6, settembre/ottobre/novembre 1973/1974.
9 Presente anche in Giuseppe Bartolucci, Mario Pisani, Fulvio Spinucci (a cura di), Paesaggio metropolitano, Milano, Feltrinelli, 1982.
60
“Il Calendario del popolo”
L'Istruttoria di Peter Weiss, a. XXIII, n. 272, giugno 1967.
Nuove strutture per il teatro, a. XXV, n. 292, 1969.
Il rovescio della medaglia, a. XXV, n. 295, maggio 1969.
Un teatro all'avanguardia, a. XXV, n. 298, agosto 1969.
La letteratura al servizio del popolo, n. 298, agosto 1969.
Teatro politico: due buone prove, a. XXVIII, n. 338, dicembre 1972.
Shakespeare e il teatro elisabettiano: un'analisi provocatoria, a. 31, n. 377, aprile 1976.
La satira e il teatro, a. 31, n. 378, maggio 1976.
“Il Cannocchiale”
Gli scrittori e il teatro, n. 3 - 4, agosto 1965.
1965: il teatro, nuova serie, n. 1 - 3, 1966.
“Dark Camera”
Il cielo può sempre cadere sulla nostra testa, n. 3, 1988.
61
“Il Dramma”
“Nembo” di Massimo Bontempelli, a. 34, n. 263/264, ago-sto/settembre 1958.
“La donna al balcone” di Ugo von Hofmansthal, a. 34, n. 263/264, agosto/settembre 1958.
Il teatro drammatico di tutto il mondo, a. 36, n. 281, febbraio 1960.
Lo spettacolo della piazza, a. 36, nuova serie, n. 287/288, ago-sto/settembre 1960.
Il politico Gustavo Modena, a. 37, n. 294, marzo 1961.
Giulia Calame tra quinte e barricate, a. 37, n. 299/300, ago-sto/settembre 1961.
Dalla commedia dell'arte all'arte rappresentativa e all'improvviso, a. 38, n. 306, marzo 1962.
Il diavolo e il teatro, a. 38, n. 308, marzo 1962.
Primo docente in Storia del Teatro e dello Spettacolo Vito Pandolfi, n. 308, marzo 1962.
Nasce il teatro stabile a Roma, a. 39, n. 317, febbraio 1963.
Perché gli italiani che nella vita sono mimi nati non amano la pantomima né per professarla né per gustarla?, a. 40, n. 330/ 331, marzo/aprile 1964.
Teatro e scuola, a. 40, n. 334/335, luglio/agosto 1964.
Il teatro e i giovani, a. 41, n. 345/346, giugno/luglio 1965.
62
L'opera creativa di Vincenzo Braca, a. 41, n. 349, ottobre 1965.
“Figure”
La Biennale di Venezia. Divagazioni di un sogno di mezza estate, I, n. 2-3, 1982.
“Il Giornale di Napoli”
Ritratto di barbaro, 3 marzo 1989.
Giù a ritroso nella memoria, 28 marzo 1989.
La macchina del tempo, 13 aprile 1989.
E ognuno ha la legge che si merita, 16 maggio 1989.
Tragedia e commedia di un diavolo zoppo, 30 maggio 1989.
1989: la smania delle celebrazioni, 8 giugno 1989.
Quando il pensiero libera le energie, 27 giugno 1989.
Spettacolo della memoria. Conservare o dimenticare?, 6 luglio 1989.
Quando Shakespeare si spinge oltre il teatro, 24 agosto 1989.
Dimensioni costruite sull'effetto di un' idea, 5 settembre 1989.
Itinerari dell'immaginario, 13 settembre 1989.
Sfuggenti suggestioni dell'immagine creativa, 21 settembre 1989.
63
Quella verità che non esiste, 26 ottobre 1989.
Sperimentazioni ed espressività, 8 novembre 1989.
Travolti da un turbine di forze superiori, 21 dicembre 1989.
Parole senza Atti, 4 gennaio 1990.
Il teatro esiste ancora?, 11 gennaio 1990.
Ma il re non può morire, 20 febbraio 1990.
10Prima e dopo il teatro, 15 marzo 1990.
L'umorismo involontario, 6 aprile 1990.
Il grande meccanismo, 10 aprile 1990.
A Parma, in un giorno di aprile, 23 maggio 1990.
Toh, il dottor Frankstein è anche tra noi, 3 luglio 1990.
Le baruffe televisive, 8 agosto 1990.
Immagini persuasive e subdole interazioni, 20 ottobre 1990.
L'attore, rivoluzionario e grande sognatore, 14 novembre 1990.
Il linguaggio che si arresta alle soglie della storia, 21 dicembre 1990.
La fabbrica dei sogni, 1 febbraio 1991.
10 Articolo presente già in Achille Mango, L'arte del teatro, Quaderno n. 5, Salerno, Demetrio Cuzzola Editore, 1986.
64
La grande conquista dell'immagine poetica, 22 febbraio 1991.
Quei suggerimenti dal palcoscenico, 8 maggio 1991.
A Napoli, dopo Eduardo, 4 luglio 1991.
In scena c'è l'io, 11 luglio 1991.
Se i miracoli esistono, 24 luglio 1991.
Musica digestiva e divertimento, 3 settembre 1991.
Portatore di una verità, 26 ottobre 1991.
Oggetti malinconici, 9 novembre 1991.
Illusioni perdute, 15 gennaio 1992.
Angeli e diavoli nella casa delle tentazioni, 4 marzo 1992.
“Il Giornale di Sicilia”
Dentro il gioco degli inganni, 26 febbraio 1985.
“Marcatre”
Il teatro dell'esperimento, l'esperimento del teatro, n. 43, 44, 45, lu-glio/agosto/settembre 1968.
65
“Misure Critiche”
A proposito del Goldoni di Mangini, a. I, n.1-2, 1971-1972.
Pier Paolo Pasolini uno e due, a. IX, n. 31-32, 1979.
11La manipolazione della memoria, a. XIX, n. 70/71, 1989.
Il teatro è il cavallo di legno per prendere la città, a. 28, n. 105-108, genna-12io/dicembre 1998.
“Mondo Nuovo”
La montagna e il topolino, a. VI, n. 39, 4 ottobre 1964.
La stagione teatrale, a. VI, n. 40, 11 ottobre 1964.
Il Candelaio di Bruno, a. VI, n. 42, 25 ottobre 1964.
Puzza di stantio, a. VI, n. 43, 1 novembre 1964.
La caduta di Miller, a. VI, n. 44, 8 novembre 1964.
Teatro per coppie inquiete, a. VI, n. 48, 1 novembre 1964.
L'Italia alla berlina, a. VI, n. 49, 13 dicembre 1964.
Oh! Che bella giornata, a. VI, n. 51, 27 dicembre 1964.
Tre sorelle, a. VII, n. 6, 7 febbraio 1965.
11Numero monografico della rivista. 12 Di fatto l'articolo è uscito postumo nel 2001.
66
La coscienza e la strage, a. VII, n. 8, 21 febbraio 1965.
Bianca o nera: America agghiacciante, a. VII, n. 12, 20 marzo 1965.
La galera dei “marines”, a. VII, n. 15, 11 aprile 1965.
La Venexiana a Spoleto, a. VII, n. 28, 11 luglio 1965.
La crisi del teatro estivo, a. VII, n. 33, 22 agosto1965.
Ritornano i Nô: il mito si ripete, a. VII, n. 38, 26 settembre 1965.
La stagione teatrale a Roma, a. VII, n. 40, 10 ottobre 1965.
Strepitoso successo, a. VII, n. 41, 17 ottobre 1965.
Un normale amore tra due minorenni, a. VII, n. 42, 24 ottobre 1965.
Un Cechov senza didascalie, a. VII, n. 43, 31 ottobre 1965.
Napoli senza folclore, a. VII, n. 44, 7 novembre 1965.
“Il dilemma” una scelta incomprensibile, a. VII, n. 46, 21 novembre 1965.
Il regista e la critica, a. VII, n. 47, 28 novembre 1965.
Corona e pochi intimi dettano la nuova legge, a. VII, n. 48, 5 dicembre 1965.
Processo al potere, a. VII, n. 49, 12 dicembre 1965.
La sconfitta del malvagio, a. VIII, n. 6, 6 febbraio 1966.
67
Dietro la facciata il vuoto, a. VIII, n. 7, 13 febbraio 1966.
La vecchia colpa d'esser diavolo, a. VIII, n. 9, 27 febbraio 1966.
Organismi senza politica, a. VIII, n. 11, 13 marzo 1966.
Tendenze da evitare, a. VIII, n. 12, 20 marzo 1966.
Azienda per i “borghesi illuminati”, a. VIII, n. 13, 27 marzo 1966.
La sconcertante follia dell'Occidente, a. VIII, n. 14, 3 aprile 1966.
La crisi del teatro è nel sistema, a. VIII, n. 19, 8 maggio 1966.
Emmetì, a. VIII, n. 20, 15 maggio 1966.
Arriva l'uomo del ghiaccio, a. VIII, n. 21, 22 maggio 1966.
Motivo di scandalo, a. VIII, n. 24, 12 giugno 1966.
Una incerta presa di coscienza, a. VIII, n. 25, 19 giugno 1966.
Il cabaret, a. VIII, n. 26, 26 giugno 1966.
La prosa a Spoleto, a. VIII, n. 31, 31 luglio 1966.
Romanzo teatrale, a. VIII, n. 32, 7 agosto 1966.
La stagione romana, a. VIII, n. 34, 28 agosto 1966.
Teatro grottesco, a. VIII, n. 35, 4 settembre 1966.
Il momento nuovo del teatro, a. VIII, n. 38, 25 settembre 1966.
68
Poesia e storia nel Riccardo II?, a. VIII, n. 40, 9 ottobre 1966.
I limiti della commedia d'intreccio, a. VIII, n. 41, 16 ottobre 1966.
Gli aculei spuntati del porcospino, a. VIII, n. 43, 30 ottobre 1966.
Danni incalcolabili alla Biblioteca Nazionale, a. VIII, n. 46, 20 novem-bre 1966.
La Medea di Alvaro, a. VIII, n. 47, 27 novembre 1966.
Paradosso o crudeltà?, a. VIII, n. 48, 4 dicembre 1966.
Il riso della giovinezza, a. IX, n. 4, 22 gennaio 1967.
Avanguardie su due binari, a. IX, n. 7, 12 febbraio 1967.
Le canzoni di Gorizia, a. IX, n. 9, 26 febbraio 1967.
La cattiva coscienza del mondo, a. IX, n. 11, 12 marzo 1967.
L'inammissibile prova di Arbasino, a. IX, n. 12, 19 marzo 1967.
Foscolo allo specchio, a. IX, n. 13, 26 marzo 1967.
Le generose avventatezze del cabaret di Ligini, a. IX, n. 15, 9 aprile 1967.
Fo castiga i mostri sacri della piccola borghesia, a. IX, n. 16, 16 aprile 1967.
Crudeltà e provocazione del “Living Theatre”, a. IX, n. 18, 30 aprile 1967.
69
Una buona interpretazione di un mediocre Pirandello, a. IX, n. 19, 7 mar-zo 1967.
La dolce fine degli arrabbiati, a. IX, n. 20, 14 maggio 1967.
Furore e concentrazione, a. IX, n. 23, 4 giugno 1967.
Antagonismo dialettico, a. IX, n. 26, 25 giugno 1967.
Il disimpegno programmatico, a. IX, n. 27, 2 luglio 1967.
Fare della Nazionale di Firenze il centro degli Studi in Italia, a. IX, n. 27, 2 luglio 1967.
La Nazionale di Firenze diventi un moderno centro di ricerche, a. IX, n. 28, 9 luglio 1967.
La tecnica dell'arrembaggio, a. IX, n. 29, 16 luglio 1967.
La costanza del Principe, a. IX, n. 30, 23 luglio 1967.
Le marionette di Pirandello, a. IX, n. 31, 30 luglio 1967.
Il gioco dell'amore, a. IX, n. 32, 6 agosto 1967.
Una scelta mancata, a. IX, n. 33, 13 agosto 1967.
MacBird come Macbeth, a. IX, n. 36, 10 settembre 1967.
Una morale rivoluzionaria, a. IX, n. 39, 1 ottobre 1967.
All'insegna del formalismo, a. IX, n. 40, 8 ottobre 1967.
70
Senza titolo, in 50° della rivoluzione (numero monografico), a. IX, n. 43, 29 ottobre 1967.
Un esperimento positivo, a. IX, n. 44, 5 novembre 1967.
Il simbolo e la realtà, a. IX, n. 46, 19 novembre 1967.
In principio era il corpo, a. IX, n. 47, 26 novembre 1967.
Le parole e le immagini, a. IX, n. 48, 3 dicembre 1967.
Il Marat-Sade di Peter Weiss, a. IX, n. 49, 10 dicembre 1967.
La platea e la vita, a. IX, n. 50, 17 dicembre 1967.
I dialoghi del Ruzante, a. IX, n. 52, 31 dicembre 1967.
Teatro, a. IX, n. 52, 31 dicembre 1967.
Il mito del denaro, a. X, n. 3, 21 gennaio 1968.
Concerto a tre voci, a. X, n. 5, 4 febbraio 1968.
Fra storia e psicoanalisi, a. X, n. 6, 11 febbraio 1968.
L'essenza del potere, a. X, n. 7, 18 febbraio 1968.
Traduzione e creazione, a. X, n. 8, 25 febbraio 1968.
Il vecchio e il nuovo, a. X, n. 9, 3 marzo 1968.
Il fattaccio Matteotti, a. X, n. 10, 10 marzo 1968.
La lotta per il potere, a. X, n. 11, 17 marzo 1968.
71
L'hanno ridotto male, a. X, n. 12, 24 marzo 1968.
I burocrati al bagno, a. X, n. 13, 31 marzo 1968.
Discorso sul Vietnam di Peter Weiss, a. X, n. 13, 31 marzo 1968.
Il passato e il presente, a. X, n. 15, 14 aprile1968.
Sull'orlo della crisi, a. X, n. 18, 5 maggio 1968.
La poetica canonizzata, a. X, n. 21, 26 maggio 1968.
Una occasione mancata, a. X, n. 22, 2 giugno 1968.
Fra canto e dramma, a. X, n. 23, 9 giugno 1968.
Il coraggio delle scelte, a. X, n. 24, 16 giugno 1968.
Contestazione e spettacolo, a. X, n. 28, 14 luglio 1968.
Alla scoperta del nuovo, a. X, n. 32, 11 agosto 1968.
La disputa sul teatro, a. X, n. 39, 6 ottobre 1968.
Teatro in minore, a. X, n. 44, 10 novembre 1968.
Divertire sproblematizzando, a. X, n. 45, 17 novembre 1968.
Una inutile ripresa, a. X, n. 46, 24 novembre 1968.
Fra teatro e televisione, a. X, n. 48, 8 dicembre 1968.
Al di là delle parole, a. XI, n. 2, 12 gennaio 1969.
72
Ricerca dei valori poetici, a. XI, n. 4, 26 gennaio 1969.
Capitalismo e fascismo, a. XI, n. 6, 9 febbraio 1969.
Valori poetici e linguaggio teatrale, a. XI, n. 9, 2 marzo 1969.
Una tragedia contemporanea, a. XI, n. 11, 16 marzo 1969.
Il rovescio della medaglia, a. XI, n. 15, 13 aprile1969.
I vantaggi dell'imbecillità, a. XI, n. 19, 11 maggio 1969.
Le cinque giornate di Genova, a. XI, n. 25, 22 giugno 1969.
Quattro domande sul teatro italiano, a. XI, n. 29, 20 luglio 1969.
La vita teatrale, a. XI, n. 33, 24 agosto 1969.
Il teatro di Grotowski, a. XI, n. 37, 21 settembre 1969.
Un teatro al servizio della società, a. XI, n. 40, 12 ottobre 1969.
Un eccitante gioco scenico, a. XI, n. 43, 2 novembre 1969.
La ragion d'essere del teatro, a. XI, n. 46, 23 novembre 1969.
Alle origini del teatro popolare, a. XI, n. 47, 30 novembre 1969.
Dario Fo, il teatro e l' “Unità”, a. XI, n. 47, 30 novembre 1969.
L'inesistente “stabile” romano, a. XI, n. 49, 14 dicembre 1969.
La paura della verità, a. XII, n. 1, 4 gennaio 1970.
73
La ricerca del teatro perduto, a. XII, n. 2, 11 gennaio 1970.
Un dadaista inconsapevole, a. XII, n. 4, 25 gennaio 1970.
L'arte dell'attore, a. XII, n. 7, 15 febbraio 1970.
Digressioni sistematiche, a. XII, n. 10, 8 marzo 1970.
Un teatro all'italiana, a. XII, n. 13, 29 marzo 1970.
La scienza e il potere, a. XII, n. 14, 5 aprile 1970.
Il sistema degenerato, a. XII, n. 15, 12 aprile 1970.
Spettacolo di consumo, a. XII, n. 16, 19 aprile 1970.
L'arte dell'attore, a. XII, n. 17, 26 aprile 1970.
Il Rabelais di J.L. Barrault, a. XII, n. 19, 10 maggio 1970.
Spettacolo rivoluzionario?, a. XII, n. 20, 17 maggio 1970.
Un invito a pensare, a. XII, n. 21, 24 maggio 1970.
Il prezzo della fama, a. XII, n. 22, 31 maggio 1970.
Tra finzione e realtà, a. XII, n. 23, 7 giugno 1970.
Esperimento di comunicazione, a. XII, n. 24, 14 giugno 1970.
Celebrazione e tecnica, a. XII, n. 25, 21 giugno 1970.
Il teatro teatrale, a. XII, n. 26, 28 giugno 1970.
74
Esclusione del pubblico, a. XII, n. 27, 5 luglio 1970.
L'arte dell'attore, a. XII, n. 28, 12 luglio 1970.
Il mestiere del pubblico, a. XII, n. 29, 19 luglio 1970.
Il teatro in piazza, a. XII, n. 30, 26 luglio 1970.
La sfida ai prepotenti, a. XII, n. 31, 2 agosto 1970.
Il ruolo dell'autore, a. XII, n. 32, 9 agosto 1970.
Palcoscenico contestato, a. XII, n. 33, 16 agosto 1970.
Il teatro politico, a. XII, n. 34, 23 agosto 1970.
Il teatro popolare, a. XII, n. 35, 30 agosto 1970.
La critica oggi, a. XII, n. 36, 6 settembre 1970.
Il teatro di strada, a. XII, n. 37, 13 settembre 1970.
Un bonario divertissement, a. XII, n. 38, 20 settembre 1970.
Il teatro a Londra, a. XII, n. 39, 27 settembre 1970.
Joaquim Murieta di Pablo Neruda, a. XII, n. 42, 18 ottobre 1970.
La scenografia teatrale, a. XII, n. 43, 25 ottobre 1970.
Avanguardia in ritardo, a. XII, n. 44, 1 novembre 1970.
La dimensione di Brecht, a. XII, n. 45, 8 novembre 1970.
75
La funzione del regista, a. XII, n. 46, 15 novembre 1970.
Teatro e società, a. XII, n. 47, 22 novembre 1970.
I circuiti alternativi, a. XII, n. 48, 29 novembre 1970.
F. Ewen, Bertolt Brecht, a. XII, n. 49, 6 dicembre 1970.
Decentramento teatrale, a. XII, n. 50, 13 dicembre 1970.
La legge del tempo, a. XII, n. 51, 20 dicembre 1970.
Attore e società, a. XII, n. 52, 27 dicembre 1970.
La dialettica della storia, a. XIII, n. 1, 3 gennaio 1971.
La parabola di Giovanna, a. XIII, n. 1, 3 gennaio 1971.
Difesa dei classici, a. XIII, n. 3, 17 gennaio 1971.
Per un teatro di classe, a. XIII, n. 4, 24 gennaio 1971.
Fra documento e creazione, a. XIII, n. 5, 31 gennaio 1971.
Il padre del realismo, a. XIII, n. 6, 7 febbraio 1971.
Infermieri del teatro, a. XIII, n. 7, 14 febbraio 1971.
Letteratura non teatro, a. XIII, n. 8, 21 febbraio 1971.
Possibile un teatro epico, a. XIII, n. 9, 28 febbraio 1971.
Balletto o dramma, a. XIII, n. 10, 7 marzo 1971.
76
La scuola a teatro, a. XIII, n. 11, 14 marzo 1971.
Esperimento coraggioso, a. XIII, n. 14, 11 aprile 1971.
Il “vecchio” Brecht, a. XIII, n. 15, 18 aprile 1971.
Il segreto del teatro, a. XIII, n. 16, 27 aprile 1971.
Il primo Brecht, a. XIII, n. 19, 16 maggio 1971.
Il caso Rosemberg, a. XIII, n. 20, 23 maggio 1971.
Moralismo in libertà, a. XIII, n. 21, 30 maggio1971.
Dov'è questa guerriglia?, a. XIII, n. 22, 6 giugno 1971.
Forma ed “avanguardia”, a. XIII, n. 25, 27 giugno 1971.
Per un vero rapporto con la scuola, a. XIII, n. 26, 4 luglio 1971.
Lettura e scrittura scenica, a. XIII, n. 22, 22 agosto 1971.
Due metodi a confronto, a. XIII, n. 23, 29 agosto 1971.
Attori a Convegno, a. XIII, n. 24, 5 settembre 1971.
Il teatro in Cina oggi, a. XIII, n. 26, 19 settembre 1971.
Espressione artistica e “modello” sociale, a. XIII, n. 46, 28 novembre 1971.
Solo problema di gestione?, a. XIII, n. 47, 5 dicembre 1971.
Fantasia e storia, a. XIII, n. 48, 12 dicembre 1971.
77
Chi comanda nel teatro italiano, tavola rotonda con Franco Cuomo e Bruno Greco, a. XIII, n. 49, 19 dicembre 1971.
A proposito del Bertolt Brecht di Puntila, a. XIII, n. 50, 26 dicembre 1971.
Nel segno dell'equivoco, a. XIV, n. 1, 2-9 gennaio 1972.
Il decentramento non è un mito, a. XIV, n. 2, 16 gennaio 1972.
Televisione e repressione, a. XIV, n. 3, 23 gennaio 1972.
8 settembre: il difficile cammino della verità, a. XIV, n. 6, 6 febbraio 1972.
Un conveniente servizio politico, a. XIV, n. 7, 13 febbraio 1972.
Quando è politico?, a. XIV, n. 8, 20 febbraio, 1972.
Le vicende dell'oggi nella storia di ieri, a. XIV, n. 10, 5 marzo 1972.
13Compagno Gramsci, a. XIV, n. 11, 12 marzo 1972.
Psicologia del fascismo, a. XIV, n. 13, 26 marzo 1972.
La lezione della storia, a. XIV, n. 19, 7 maggio 1972.
Lettura scenica di Bulgakov, a. XIV, n. 24, 4 giugno 1972.
14Giorni di lotta con Di Vittorio, a. XIV, n. 1, 25, 11 giugno 1972.
13 Presente anche in “Sipario”, n. 311, luglio 1972.14 Presente anche in “Sipario”, n. 314, luglio 1972.
78
Lo scambio dialettico fra palcoscenico e platea, a. XIV, n. 26, 25 giugno 1972.
Un poeta e la vita, a. XIV, n. 28, 9 luglio 1972.
“Il Ponte”
Recensione a Vito Pandolfi, Isabella Comica Gelosa. Storia di avventu-re e di maschere, a. XVI, n.8/9, agosto/settembre 1960.
Recensione a Eduardo De Filippo, Cantata dei giorni pari, a. XVI, n. 10, ottobre 1960.
Recensione a Ezio Franceschini (a cura di), Teatro latino medioevale, a. XVII, n. 5, maggio 1961.
Recensione a Federico Doglio, Il teatro tragico italiano, a.XVII, n. 10, ottobre 1961.
Recensione a Arthur Adamov, Tutti contro tutti - Intimità - Paolo Paoli, a. XVIII, n.1, gennaio 1962.
Teatro sovietico d'oggi, a. XVIII, n.7, luglio 1962.
Recensione a Francis Fergusson, Idea di un teatro, a. XVIII, n. 10, 1962.
Recensione a Nino Borsellino (a cura di), Commedie del Cinquecento, a. XIX, n. 1, gennaio 1963.
“Nuova Corrente” su Brecht, a. XIX, n. 1, gennaio 1963.
Recensione a Arnold Wesker, Trilogia, a. XIX, n. 2, febbraio 1963.
79
Recensione a Angelo Leone De Castris, Storia di Pirandello, a. XIX, n. 3, marzo 1963.
Recensione a A. Bronner, Giorni con Bertolt Brecht, a. XIX, n. 4, apri-le 1963.
Recensione a Peter Szondi, Teoria del dramma moderno, a. XIX, n.12, dicembre 1963.
Recensione a Bertolt Brecht, Scritti teatrali, a. XIX, n.12, dicembre 1963.
Roma senza teatro, a. XIX, n.12, dicembre 1963. Inizio di stagione a Roma, a. XX, n.1, gennaio 1964.
Teatro Uno, a. XX, n. 2, febbraio 1964.
Recensione a Lamberto Trezzini, Teatro in Polonia, a. XX, n. 2, feb-braio 1964.
Gli spettacoli a Roma, a. XX, n. 5, maggio 1964.
Il teatro nella società italiana, a. XX, n. 5, maggio 1964.
Gli spettacoli estivi a Roma, a. XX, n.10, ottobre 1964.
Gli spettacoli a Roma, a. XXI, n. 2, febbraio 1965.
Recensione a Luciana Stegnana Picchio, Storia del teatro portoghese, a. XXI, n. 2, febbraio 1965.
Convegno ad Asti sul teatro e i giovani, a. XXI, n. 5, maggio 1965.
80
Lunga vita al teatro italiano, a. XXI, n. 6, giugno 1965.
Divorzio scrittori-teatro, a. XXI, n.7, luglio 1965.
Storia del teatro drammatico, a. XXI, n. 8/9, agosto/settembre 1965.
Ottimo avvio del teatro stabile di Roma, a. XXI, n.10, ottobre 1065.
L'esempio di Dario Fo, a. XXI, n.10, ottobre 1965.
I teatri stabili a Roma, a. XXI, n.11, novembre 1965.
Il teatro sacro a Firenze, a. XXI, n.11, novembre 1965.
La ricca stagione romana, a. XXII, n.1, gennaio 1966.
Tre fisici a Torino, a. XXII, n. 1, gennaio 1966.
Ritorno di Brusati, inizio di Zurlini, a. XXII, n. 4, aprile 1966.
Mauri Bene Squarzina, a. XXII, n. 5, maggio 1966.
I pifferi di montagna, a. XXII, n. 7, luglio 1966.
Spoleto: l'eccezione Bellow, a. XXII, n. 8/9, agosto/settembre 1966.
Recensione a I conti in tasca allo spettacolo, Bologna, Centro d'arte e di cultura, 1966, a. XXII, n. 10, ottobre 1966.
Recensione a Giorgio Guazzotti, Teoria e realtà del Piccolo Teatro di Milano, Torino, Einaudi, 1965, a. XXII, n. 10, ottobre 1966.
Recensione a Niccolò Machiavelli, La Mandragola per la prima volta restituita alla sua integrità, a cura di Roberto Ridolfi, Firenze, Leo
81
Olschki, 1965, a. XXII, n. 10, ottobre 1966.
Dal tuo al mio, a. XXIII, n.1, gennaio 1967.
Recensione a Emo Marconi, Dottrina e tecnica del teatro, a. XXIII, n. 2, febbraio 1967.
Teatro d'urto a Roma, a. XXIII, n. 3, marzo 1967.
15La cattiva coscienza del mondo, a. XXIII, n. 4, aprile 1967.
Recensione a Augusto Frassineti, Il cubo e il tubo, a XXIII, n. 4, apri-le 1967.
Recensione a Nino Borsellino (a cura di), Commedie del Cinquecen-to, a. XXIII, n. 9, settembre 1967.
Prima stagione romana, a. XXIV, n. 1, gennaio 1968.
Peter Weiss, “Marat Sade”. Storia e dialettica della forma, a. XXIV, n. 3, marzo 1968.
“Der Drache” di Schwarz Besson, a. XXIV, n. 4, aprile 1968.
Il critico viaggiante, a. XXIV, n. 4, aprile 1968.
A Praga, di agosto, a. XXIV, n. 9, settembre 1968.
Il cecoslovacco “Divladlo za Branou”: alla ricerca del teatro totale, a. XXIV, n. 11/12, novembre/dicembre 1968.
15 Presente anche in “Mondo Nuovo”, a. IX, n. 11, 12 marzo 1967.
82
A proposito di scritture. Punto e daccapo, a. XXV, n. 6 - 7, 30 giugno - 31 luglio, 1969.
Com'aquila vola, a. XXV, n. 8/9, agosto/settembre 1969.
Il comune di Roma si diverte, a. XXV, n. 10, ottobre 1969.
Avanguardia e repechage, a. XXVI, n. 2, febbraio 1970.
Rabelais, Slaveship, Macbeth, a. XXVI, n. 6, giugno 1970.
Gli ultimi del Premio Roma, a. XXVI, n. 7, luglio 1970.
Teatro: di nuovo le strutture, a. XXVI, n. 8/9, agosto/settembre 1970.
L'inutile “Hair”, a. XXVI, n. 11, novembre 1970.
Sui modi del circuito alternativo, a. XXVII, n. 1/2 , gennaio/febbraio, 1971.
La disinvolta operazione di Patroni Griffi. Brecht - Mahagonny a Spoleto, a. XXVIII, n. 8/9, agosto/settembre 1972.
Teatro a Venezia. Una inutile parata, a. XXIX, n.1, gennaio 1973.
Pezze a colori e palcoscenici d'oro, a. XXIX, n. 11, novembre 1973.
Per Vito Pandolfi, a. XXX, n. 4, aprile 1974.
Quattro mesi di stagione romana. Teatro sperimentale: due strade, a. XXX, n. 4, 30 aprile1974.
Recensione a Silvana Sinisi (a cura di) Variété. Prampolini e la scena, a. XXX, n./78, luglio/agosto 1974.
83
Teatro Avanguardia Pubblico, a. XXX., n. 9, 30 settembre 1974.
Cabaret: revival o de profundis ?, a. XXXI, n. 5, maggio 1975.
Alla ricerca del teatro rozzo. “Non commettere Atti spuri”, a. XXXI, n. 7/8, luglio/agosto 1975.
Teatro d'avanguardia come una tela rinascimentale, a. XXXI, n. 10, otto-bre 1975.
Consorzi regionali. Gli idoli medievali del teatro , a. XXXII, n. 6, 30 giu-gno 1976.
Della ricerca teatrale, ossia del teatro, a. XXXII, n. 7/8, luglio/agosto 1976.
Aspettando il teatro fuori centro, a. XXXII, n. 10, ottobre 1976.
Festival, quasi epitaffio per un sistema, a. XXXIII, n. 7, luglio 1977.
Della biblioteca Nazionale di Roma, ovvero delle cose di piccolo conto, a. XXXIII, n. 10, ottobre 1977.
Recensione a Anna Barsotti, Pier Maria Rosso di San Secondo, a. XXXV, n. 9, settembre 1977.
16Cinema: industria o arte totale, a. XXXIV, n. 5, maggio 1978.
Il risveglio dal sogno della vita, a. XXXVIII, n. 7-8, luglio agosto 1982.
16 Presente anche in Giovanni Dotoli (a cura di), Ricciotto Canuto, Grafischena, 1978. Atti del Congresso Internazionale nel centenario della nascita svoltosi a Bari.
Fasano,
84
Recensione a Riccardo Scrivano, Finzioni teatrali. Da Ariosto a Pi-randello, a. XXXIX, n. 69, giugno/settembre 1983.
Guerrafondai, guerre, guerrieri, a. XLVII, n. 3, marzo 1991.
Tradurre il teatro, a. XLVIII, nn. 8-9, agosto - settembre 1992.
Teatro. Intorno a un corpo malandato, XLIX, nn. 8/9, ago-sto/settembre 1993.
Da Pirandello a De Berardinis: l'interminabile gioco degli specchi, a. L, n. 6, giugno 1994.
Meglio il cartellone 1993/1994, a. L, n. 7, giugno 1994.
Teatro fra arte e mercatura, a. L, n. 8/9, agosto/settembre 1994.
Un piccolo libro bianco, a. L, n. 10, ottobre 1994.
Nostra stagione teatrale. Per finirla con l'atletica della nostalgia, a. LI, n. 5, maggio 1995.
Teatro e spettacolo, due credibili parallele, a. LII, n. 3, marzo 1996.
Teatro. Di ritorno l'autonomia del testo, a. LII, n. 4, aprile 1996.
“Prima Fila”
Lo specchio del tempo, n. 3, 1995.
La caduta dei miti, n. 5, 1995.
85
“Problemi”
Wellerismi e farsa cavaiola, 1968.
Teatro aperto e teatro chiuso, 1969.
“Il Punto”
Beatrice Cenci di Moravia, 26 aprile 1958.
Spettacoli classici a Siracusa, 21 giugno 1958.
“Quaderni del Centro Teatrale Italiano”
Commento all'indagine, in Inchiesta sul pubblico, “Quaderni del Centro Teatrale Italiano”, Roma, n. 11, 1966.
“Quaderni del CUT” Bari
Teatro come partecipazione, n. 11, novembre 1972.
17La crisi del prodotto, n. 13, maggio 1974.
Lo spazio del teatro, n. 15, dicembre 1975.
17 Già presente in Uso, modalità e contraddizioni dello spettacolo immagine, Macerata, Altro/La Nuova Foglio Editrice, 1975, Atti del Convegno di Studi Nuove Tendenze/Teatro Immagine tenutosi a Salerno l'8 giugno 1973. Inserito poi in Achille Mango, Verso una sociologia del teatro, Palermo, Celebes, 1978.
Pollenza -
86
“Quaderni del Laboratorio teatrale Universitario”
18L'attore come operatore politico, Palermo, giugno 1981.
“Quaderni del Seicento Francese”
Il teatro italiano in Francia durante il regno di Luigi XIII, in Il teatro al tem-po di Luigi XIII, “Quaderni del Seicento Francese”, Bari - Adriati-ca, Parigi - Nizet, n. 1, 1974.
“Quaderni di Basilicata / 3”
Esperienza negativa dei Teatri Stabili, Basilicata Editrice, Roma - Mate-ra 1976.
“Quadrangolo”
Tra esistenza e analisi, a. 5, n. 10/11, aprile 1977/aprile 1979.
“Quarta Parete”
19La morte dell'attore, n. 7/8, luglio 1983.
Il conflitto evitabile, n. 7/8, luglio 1983.
18 Presente anche nell'introduzione a Jean Duvignaud, Sociologia dell'attore, Milano, Sergio Ghisoni Editore, 1977.
19 Presente anche in Atti del Convegno di Studi La cultura italiana dal 1930 al 1945, Napoli, ESI, 1985.
87
“Rassegna Storica Salernitana”
Gli intrichi d'amore, n. 23, giugno 1995.
“Ricerche Filosofiche”
Il teatro di Sartre: pensiero e dramma, a. XXXI, fasc. I e II, Roma, 1963.
“Rinascita”
Teatro, 17 maggio 1986.
“La scrittura scenica. Teatroltre”
La macchina e la tecnologia, n. 24, 1982.
L'uso della tecnologia a teatro, n. 27-28, 1983.
20“La Sera”(di Roma)
Zona grigia di Calendoli al Teatro Valle, 18 aprile 1958.
Novità italiane al Pirandello, 7 agosto 1958.
20 Critico teatrale de “La Sera” (di Roma) fu Vito Pandolfi. Esistono tuttavia alcuni articoli anonimi ed altri firmati con lo pseudonimo di Palageno oppure di Vice. Non si hanno notizie circa l'uso di pseudonimi, ma nel caso di Vice potrebbe trattarsi di Mango indicato così quale seconda firma rispetto a quella ufficiale di Pandolfi. Non essendo sicura la paternità si è preferito non segnalare tali articoli all'interno della bibliografia dal momento che l'attribuzione di essi vaga nel campo delle probabilità.
88
L'Edipo Re apre il XV ciclo di rappresentazioni siracusane, 13 giugno 1958.
Il vivo successo di “Medea” a Siracusa, 13 giugno 1958, II edizione.
“Sipario”
Hamlet, n. 302, luglio 1971.
Don Giovanni, n. 306, novembre 1971.
21Compagno Gramsci, n. 311, aprile 1972.
22Giorni di lotta con Di Vittorio, n. 314, luglio 1972.
La conversazione continuamente interrotta, n. 315-316, agosto-sttembre 1972.
L'educazione parlamentare, n. 320, gennaio 1973.
“Studi Germanici”
Il teatro sperimentale e Brecht, Roma, nuova serie, a. XXXIII, n. 2/3, 1995.
“Studi Goldoniani”
Lettura scenica di Goldoni, quaderno n.3, Venezia, 1973.
21 Già presente in “Mondo Nuovo”, a. XIV, n.11, 12 marzo 1972.22 Già presente in “Mondo Nuovo”, a. XIV, n. 25, 11 giugno 1972.
89
“Teatro Valle. Stagione 1989/90”
Frammenti di una biografia teatrale, “Teatro Valle. Stagione 1989/90”, Napoli, ESI, 1989.
“La Voce”
Amore e disamore del teatro, in Benedetto Croce, la storia e la libertà, edi-zione de “La Voce”, numero speciale, n. 6, Roma, luglio 1967.
90
DISPENSE
Le origini della commedia dell'arte, corso di lezioni tenute presso la Fa-coltà di Magistero, Istituto Universitario di Salerno, a.a. 1969/70. La dispensa, scritta in collaborazione con Maria Rosaria Lombar-di, è pubblicata dalla Libreria Internazionale Editrice, Salerno (San Giorgio a Cremano, Istituto Grafico Italiano), 1970. In ap-pendice: scelta antologica da L'arte rappresentativa premeditata e all'improvviso di Andrea Perrucci.
Appunti delle lezioni di Storia del Teatro e dello Spettacolo tenute presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Bari nell'a.a. 1971/72. (Teatro medievale)
Appunti delle lezioni di Storia del Teatro e dello Spettacolo tenute presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Bari nell'a.a. 1972/73. (Avanguardie storiche)
Appunti delle lezioni di Storia del Teatro e dello Spettacolo tenute presso la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Salerno nell'a.a. 1972/73. (N.B. Avanguardie Storiche in generale. Artaud e Brecht)
(Altre dispense fornitemi da Rosanna Spirito, sua allieva e poi ricercatrice presso la cattedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo all'Università degli Studi di Salerno, non recano notizie sufficienti per identificare l'anno di corso o la facoltà nei quali i corsi furono tenuti. Tali scritti presentano, tuttavia, un taglio più saggistico che didattico, soprattutto un fascicolo riferito a Luigi Pi-randello)
91
INEDITI
Regole per gli attori, atto unico per attori e marionette di Achille Man-go scritto per la compagnia salernitana “Teatro Gruppo” mai rap-presentato.
Può un'opera scritta trasformarsi in spettacolo?, saggio.
92
“Bibliografia Critica di Achille Mango”di Annamaria Sapienza
Finito di stamparenel mese di marzo 2004
* * * * *DELTA 3 Edizioni
del dott. Silvio SallicandroVia Valle 89/91
83035 Grottaminarda (Av)Telefax 0825.426151www.delta3edizioni.com
Printed in Italy - Stampato in Italia