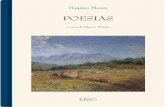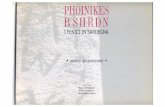Incontro fra ipogeismo e megalitismo nel territorio del Barigadu (Sardegna, Italia)
Caravaggio, il caravaggismo e la Sardegna
-
Upload
accademiadipalermo -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Caravaggio, il caravaggismo e la Sardegna
CARAVAGGIO E I CARAVAGGESCHILA PITTURA DI REALTÀ
CARA
VAGG
IO E
I CA
RAVA
GGES
CHI
LA
PITT
URA
DI R
EALT
À
3
CARAVAGGIO E I CARAVAGGESCHILA PITTURA DI REALTÀ
mostra a cura di
VITTORIO SGARBI
catalogo a cura di
VITTORIO SGARBIANTONIO D’AMICO
5
Comune di SassariNicola Sanna, SindacoMonica Spanedda, Assessora alle Politiche per lo sviluppo locale, programmazione, cultura e turismo
Gianni Carbini, Vicesindaco con delega alle Politiche agro-ambientali e verde pubblicoAmalia Cherchi, Assessora alle Politiche finanziarie, bilancio e tributi, patrimonio e contrattiOttavio Sanna, Assessore alle Politiche abitative, lavori pubblici e manutenzioni, decoro e arredo urbanoLuca Taras, Assessore alle Politiche per le infrastrutture della mobilità urbana e rurale, polizia municipale e protezione civile Alessio Marras, Assessore alle Politiche per la pianificazione territoriale, attività produttive ed edilizia privata Maria Grazia Manca, Assessora alle Politiche sociali, pari opportunità e partecipazione democratica Maria Francesca Fantato, Assessora alle Politiche educative, giovanili e sport Luigi Polano, Assessore alle Politiche per l’innovazione, affari generali, affari legali, servizi informativi, personale e Punto Città
Settore Sviluppo Locale: Cultura e Marketing turisticoNorma Pelusio, DirigenteMariangela Valentini, Responsabile servizi culturali e turismoSupervisione della mostra per il Comune di Sassari
Settore Lavori Pubblici e manutenzioniPier Felice Stangoni, DirigenteSalvatorica Sanna, Responsabile servizio manutenzione edifici storici Cristina Alicicco, Direttore lavori
Sassari RinascimentoGiovanni Nurra, Presidente
Mostra a cura diVittorio Sgarbi
Direzione, coordinamento e ricercheAntonio D’Amico
Coordinamento organizzativoLuciano Serra
Conservazione delle opere e restauriGianfranco Mingardi
Progetto espositivo e cura dell’allestimentoAntonio D’AmicoCon la collaborazione diGiovanni Marongiu
Campagna di comunicazione della mostra e copertina del catalogoGavino Sanna
AllestimentoLuciano Sini, Restauro monumenti e scavi archeologici
Impianti di sicurezza e di illuminazioneArt Elettric sas di Alessandro Sanna
Trasporti
AssicurazioniReale Mutua Assicurazioni
Ufficio stampaPasquale ChessaGiuseppe ContiRoberta GalloGianbernardo Piroddi
CARAVAGGIO E I CARAVAGGESCHiLA PITTURA DI REALTA’
SASSARI, PALAZZO DUCALE26 GIUGNO – 30 OTTOBRE 2015
Enti promotori
Comune di Sassari
Sassari Rinascimento
In collaborazione con
Con il fondamentale contributo di
6
Addetto stampa Comune di SassariAndrea Bazzoni, Portavoce del Sindaco
Sito internet e social media
Video in mostraAntonello CarboniCon musiche diAntonello Manca
Si ringraziano i prestatori
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Marica Mercalli, Dirigente del Servizio II della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio
Giovanna Damiani, Direttore per il Polo Museale della Sardegna
Francesca Casule, Soprintendente ad interim per le Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro
Fra Giovanni Atzori, Ministro Provinciale Frati Minori Cappuccini di Sardegna
Fra Isidoro De Michele, Parroco della Parrocchia San Francesco d’Assisi, Sassari
Maria Paola Dettori, Direttore della Pinacoteca Mus’a al Canopoleno, Sassari
Galleria d’Orlane, Casalmaggiore
Alessandro, Cecilia, Cristina, Marco Molinari Pradelli
Bianca Maria Radaelli Molinari Pradelli
e tutti gli altri prestatori che hanno voluto mantenere l’anonimato
Crediti fotograficiGianfranco Carta, SassariIlisso Edizioni, NuoroG. e L. Malcangi, MilanoStudio Pavarani, SassariCarlo Vannini, Reggio Emilia
Catalogo a cura diVittorio Sgarbi Antonio D’Amico
SaggiLuigi AgusGianluca BocchiAntonio D’AmicoVittorio Sgarbi
SchedeGianluca BocchiPaola CarettaRoberto ContiniMaria Paola DettoriDavide DottiRiccardo LattuadaGiorgio LeoneSilvia ProniDaniela Scaglietti Keith SciberrasVittorio SgarbiNicola Spinosa
Stampa del catalogo e grafica di mostraNuova Stampa Color, Muros (SS)
TraduzioniRoanna Weiss
RingraziamentiAntonello Alberti, Massimo Dolcini, Maria Fiori, Caterina Fresu, Anna Maria Piras, Costantino Piras, Antonello Piredda, Felice Pirro, Daniela Scudino
Un ringraziamento particolare all’Assessora Amalia Cherchi per il suo prezioso contributo alla realizzazione della mostra
13
SOMMARIO
VITTORIO SGARBICARAVAGGIO QUI E ORA
GIANLUCA BOCCHILA PITTURA DI NATURA MORTA A ROMA NEL SEICENTO E LA LEZIONE DI CARAVAGGIO
ANTONIO D’AMICOL’OMBRA DEL NATURALISMO CARAVAGGESCO IN SARDEGNA
REPERTORIO CARAVAGGESCO IN SARDEGNA
LUIGI AGUSCARAVAGGIO, IL CARAVAGGISMO E LA SARDEGNA
OPERE IN MOSTRA
SCHEDE DELLE OPERE
BIBLIOGRAFIA
15
23
33
37
47
55
117
147
36
1. Anonimo romano Cristo alla colonna
ante 1611Cagliari, Cattedrale
Aula del Capitolo
2. Anonimo sardo Cristo alla colonna secondo quarto del XVII secolo Ploaghe, Pinacoteca
4. Anonimo sardo Ecce Homo primo quarto del XVII secolo Ploaghe, Pinacoteca
3. Anonimo sardo Ecce Homo
primo quarto del XVII secolo
Alghero, Cattedrale
37
5. Giuseppe Marullo, ambito di, San Girolamo, terzo quarto del XVII secolo, Ploaghe, Pinacoteca
6. Orazio de Ferrari, Martirio di San Lorenzo1634-1639 circa, Cagliari, Pinacoteca
7. Orazio de Ferrari, San Sebastiano curato da Santa Irene 1634-1639 circa, Cagliari, Chiesa di sant’Antonio da Padova dei Cappuccini
38
9. Orazio de Ferrari, Crocifissione e santi 1640-1641 circa, Quartu Sant’Elena, Chiesa di sant’Agata
8. Orazio de Ferrari, Crocifissione e santi 1639-1640 circa, Cagliari, Pinacoteca
39
10. Domenico Fiasella, Giuseppe venduto dai fratelli, 1640-44 circa Cagliari, Pinacoteca
11. Anonimo sardo, Morte di San Giuseppe, secondo quarto del XVII secolo, Sassari, Chiesa di santa Caterina
40
12. Alessandro Tiarini, ambito di, Sant’Agata curata da San Pietro 1630-1640 circa, Cagliari, Cattedrale, Aula del Capitolo
13. Alessandro Tiarini, ambito di, Cristo al Pretorio1630-1640 circa, Cagliari, Cattedrale, Aula del Capitolo
41
16. Anonimo romano, San Girolamo nello studio 1630-1640 circa, Cagliari, Pinacoteca Nazionale
14. Fra Raffaele Romano, Santa Maria Maddalena, terzo quarto del XVII secolo, Cagliari, Chiesa Collegiata di sant’Anna
15. Fra Raffaele Romano, San Girolamo penitente, terzo quarto del XVII secolo, Cagliari, Chiesa Collegiata di sant’Anna
42
17. Francesco Fracanzano, Sant’Onofrio 1630-1650 circa, Mores, Parrocchiale
18. Anonimo sardo, San Sebastiano, terzo quarto del XVII secolo Mores, Parrocchiale di santa Caterina
43
20. Juan Rizi, ambito di, San Raimondo di Peñafort terzo quarto del XVII secolo, Cagliari, Pinacoteca
19. Juan Rizi, ambito di, San Brunoneterzo quarto del XVII secolo, Cagliari, Pinacoteca
45
CARAVAGGIO, IL CARAVAGGISMO E LA SARDEGNALuigi Agus
Dovendo tracciare un percorso dell’influsso caravaggesco in Sardegna, non si può non far cenno alla coincidenza degli eventi storici che coinvolsero le due principali diocesi sarde, quella di Sassari e quella di Cagliari, che a partire dalla fine del Cinquecento intrapresero una vera e propria campagna propagandistica sul primato dell’una sull’altra, culminata con gli scavi per la ricerca dei corpi dei Santi Martiri, prima sotto la basilica turritana di san Gavino e poco dopo sotto quella cagliaritana di san Saturnino nel 1614. Una tale sentita e frenetica concorrenza tra le due diocesi, ebbe un forte impatto anche sullo sviluppo delle arti, coinciso con la costruzione della cripta della cattedrale cagliaritana, voluta fortemente dall’arcivescovo Francisco Desquivel, nominato presule il 20 giugno 1605 nel concistoro tenuto da papa Paolo V Borghese1. L’importante opera fu ultimata nel giro di pochi anni nel 1618, nella sua prima fase, e nel 1634 nella seconda, su progetto del pittore romano Francesco Aurelio, che si servì dello scultore Antonio Zelpi, originario di Casasco d’Intelvi2. Si trattò di un evento fondamentale che vide, forse per la prima volta nella capitale sarda, pittori, scultori, e architetti uniti nel realizzare quello che potrebbe definirsi il primo capolavoro di un protobarocco appena nascente nell’isola. La ricchezza dei marmi policromi, degli stucchi, la volta ribassata a cassettoni decorati in oro e soprattutto il bel dipinto raffigurante lo stesso arcivescovo Desquivel che presenta i martiri cagliaritani al Crocifisso – forse opera dello stesso Aurelio presente a Cagliari almeno dal 1611 quando è citato come “Francesco Romano”3
– rappresentano l’introduzione nell’isola di un rinnovato gusto fortemente debitore dell’arte romana, ivi incluso il naturalismo più drammatico di stampo caravaggesco da cui pare dipendere
anche la tela della cripta cagliaritana. In tale ambito di rinnovamento del gusto promosso dall’arcivescovo Desquivel, si inquadra perfettamente lo splendido Cristo alla Colonna dell’aula capitolare della cattedrale di Cagliari (fig. 1). Il dipinto più che a Guido Reni4, al Tiarini5, o ad anonimo caravaggesco di area ispano�fiamminga6, andrebbe ricondotto ad un pittore di area romana vicino a Caravaggio, ma non immune da influssi emiliani. Un profilo che si attaglierebbe bene a pittori come Borgianni o Manfredi, vista soprattutto l’alta qualità dell’opera, oggetto fin da subito d’imitazione, come dimostra la replica poco più tarda della Pinacoteca di Ploaghe (fig. 2), realizzata quasi certamente da un autore sardo, o quella di Pasquale Ottino, passata all’asta nel 2008, ritenuta esito formale maturo del pittore veneto dopo il suo soggiorno romano7. Non è da escludere, a questo punto, che il dipinto cagliaritano sia stato realizzato a Roma su commissione del Desquivel per tramite dell’Aurelio prima del 1611, per poi essere replicato dall’Ottino successivamente, magari attraverso qualche incisione o disegno, date le ridotte dimensioni di quest’ultima opera dipinta su lavagna (44x33 cm), che portano a ritenerla opera destinata alla devozione privata. Se le supposizioni non sono mendaci, il dipinto cagliaritano sarebbe una delle prime opere caravaggesche importate nell’isola direttamente da Roma, senza quindi mediazioni stilistiche indirette napoletane, liguri o iberiche, che caratterizzeranno la produzione locale o d’importazione del resto del secolo. Proprio ad artista locale, appena influenzato del primo naturalismo romano, va restituita la tela raffigurante un Ecce Homo della cattedrale di Alghero (fig. 3), restaurata ed esposta nel 2007. Il dipinto algherese, infatti, presenta qualche accento caravaggesco che si va a sovrapporre perfettamente a un sostrato ancora manierista. Non a caso l’iconografia risulta essere una replica del medesimo soggetto dipinto da Correggio attorno al
46
1526�30, ora alla National Gallery di Londra, per tramite di una incisione in controparte di Agostino Carracci del 1587. Da Correggio è tratta l’iconografia, fatta eccezione per la catena che pende dal collo di Cristo, la canna insanguinata, i toni bruni e l’aspetto quasi caricaturale e grottesco di Pilato e del soldato sulla destra che danno alla scena un accento melodrammatico, restituendoci in questo modo una inedita interpretazione caravaggesca di Correggio, altrimenti assente nelle altre tre repliche note, tutte databili tra Cinquecento e Seicento, una delle quali attribuita ad Annibale Carracci8. Al medesimo ambito locale, ma a diverso autore, andrebbe restituito l’Ecce Homo a figura intera della Pinacoteca di Ploaghe (fig. 4), forse dipinto dallo stesso anonimo artista che realizzò la citata replica del Cristo alla Colonna dell’aula capitolare di Cagliari, viste anche le identiche dimensioni (170x125 cm), la medesima resa formale e la provenienza delle due tele dall’acquisto fatto dal canonico Demurtas nel 17849. Dalla stessa raccolta Demurtas, ma di diversa mano, è il San Girolamo (fig. 5) (anch’esso di 170x125 cm), che pur presentando echi reniani, risulta aderente alla corrente caravaggista napoletana, debitrice di Ribera, da un lato, e di Giuseppe Marullo dall’altro. Autore, quest’ultimo, a cui potrebbe accostarsi il dipinto sardo, che pur presentando alcune evidenti cadute, dovute forse al restauro del 182910, risulta comunque di elevata qualità tecnica ed espressiva.Grande importanza ebbe nell’isola la presenza genovese e più in generale ligure, soprattutto dopo l’accordo segreto tra Carlo V e Andrea Doria con il quale quest’ultimo otteneva la franchigia nei porti spagnoli. Lo sviluppo dei rapporti tra le città sarde e Genova ebbe un crescendo per tutto il Cinquecento, tanto che all’inizio del Seicento i mercanti di origine ligure si organizzarono a Cagliari in una arciconfraternita, tutt’ora attiva, intitolata ai santi Giorgio e Caterina, la cui chiesa venne
edificata in quel medesimo lasso di tempo. Un tale intreccio fitto di rapporti, intensificato dai prestiti che i banchieri genovesi concedevano alla nobiltà locale e alla difesa dell’isola, garantita dalle loro navi, ebbe un ruolo fondamentale anche nelle arti figurative, soprattutto per la scultura, ma anche per la pittura, tanto che già alla fine del XVI secolo si registrano presenze di artisti provenienti dalla Liguria, come Girolamo Ferra autore di un affresco, rinvenuto di recente dietro la cappella pisana del duomo cagliaritano, raffigurante la carta geografica della Sardegna. Col passaggio al nuovo secolo la presenza di pittori genovesi si intensifica. Abbiamo notizia di Lazzaro Costa nel 1611, di un non meglio identificato Pau nel 1632 e Pantaleone Calvo, residente nell’isola tra il 1631 e il 1664, del quale restano diverse opere, come il San Carlo Borromeo in adorazione del Crocifisso (1631) e il Martirio di Sant’Andrea (1635), entrambi nel santuario di Valverde ad Alghero, gli scomparti del ratablo del transetto sinistro del Sant’Agostino Nuovo (1646), la Madonna d’Itria della Pinacoteca, la pala con le Anime Purganti della chiesa di san Francesco di Paola (1664) e gli scomparti dello smembrato retablo del Rosario del san Domenico a Cagliari11, tutte segnate da gamme cromatiche chiare, superfici planari e nitide, che inquadrano la sua produzione in ambito distante rispetto al filone caravaggesco.Diverso il caso delle numerose opere importate nell’isola dalla Liguria, in particolare quelle di Orazio de Ferrari e Domenico Fiasella, entrambi protagonisti del caravaggismo genovese più maturo e consapevole, con esiti del tutto simili. Del primo, nato a Voltri nel 1606 dove fu allievo dell’Ansaldo assieme all’Assereto, si registrano al momento quattro opere riconosciute e ormai attestate. Si tratta di due Crocifissioni con santi, una presso la Pinacoteca di Cagliari, ma proveniente dalla chiesa di Sant’Antioco a Villasor, e l’altra nella chiesa di sant’Agata a Quartu Sant’Elena, a cui si aggiunge un Martirio
47
di san Lorenzo, sempre alla Pinacoteca di Cagliari, e un San Sebastiano curato da Sant’Irene nella chiesa di Sant’Antonio da Padova dei Cappuccini, entrambe provenienti dalla chiesa di san Benedetto, del capoluogo sardo, giunte là forse per tramite del potente mercante genovese Benedetto Nater, fondatore di quella chiesa nel 164312. Al primo periodo genovese, tra il 1634 e il 1639, andrebbero assegnate le due tele provenienti dalla chiesa di san Benedetto, il Martirio di San Lorenzo (fig. 6) e San Sebastiano curato da Sant’Irene (fig. 7), che trovano pieno riscontro con le tre versioni dell’Ecce Homo, rispettivamente a Brera, nella Raccolta Borromeo dell’Isola Bella e nella quadreria di Palazzo Torriglia a Chiavari, questa accompagnata dal Cristo Portacroce. Tutti dipinti impensabili senza che De Ferrari avesse avuto piena coscienza della tesa drammaticità raggiunta contemporaneamente dall’Assereto, che in quegli stessi anni resta il suo punto principale di riferimento. Una produzione evolutasi attraverso più sperimentazioni sul formato orizzontale, di cui troviamo traccia in un’altra tela certamente sua che riporta il medesimo soggetto del San Sebastiano curato da Sant’Irene di Cagliari, ora in ubicazione sconosciuta e visibile solo attraverso una foto d’archivio custodita presso la Fondazione Zeri di Bologna, dov’è inopportunamente attribuita ad anonimo napoletano del XVII secolo (scheda 51182), forse per analogia con un’altra tela rappresentante un San Sebastiano in collezione privata, sempre assegnata ad anonimo napoletano, anch’essa da ricondurre alla produzione del De Ferrari, anche se leggermente più tarda, forse databile dopo il 1639 (scheda 51088), anno del suo probabile viaggio a Napoli.Certamente, dopo il 1639, in quanto densa di citazioni caravaggesche e reniane, con talune affinità con Cavallino, è la grande Crocifissione e quattro Santi, oggi in deposito presso la Pinacoteca di Cagliari e proveniente da Villasor (fig. 8), a
cui è collegata strettamente quella quartese (fig. 9), dove la testa del Cristo, per la sua posa e la conformazione anatomica, risulta strettamente relazionata con quella del Cristo della Flagellazione di san Domenico Maggiore a Napoli. Una dipendenza, seppur indiretta, che importa in quanto “senza questa immissione che stacca Orazio dagli altri, la Crocifissione di Cagliari sarebbe impensabile, poiché la sua densa tragicità nasce dalla realtà individuale, dalla sostanza drammatica specifica, dalla solitudine quasi di ciascuno dei personaggi e dal fatto che la luce li scandisce ognuno in una dimensione di spazio che è insieme concreta e spirituale”13. La Crocifissione della Pinacoteca di Cagliari, assieme a quella di poco successiva di Quartu, rappresenterebbe quindi il punto di svolta più marcato in senso caravaggesco napoletano del De Ferrari, mutuato certamente dal Ribera, scelta che coincide con l’abbandono definitivo dei riferimenti all’Ansaldo e a Van Dyck, ancora perfettamente ravvisabili nella drammatica Crocifissione della chiesa dei Cappuccini di Pontedecimo, forse di poco anteriore14.Sempre alla mediazione o all’interesse diretto del mercante Nater, che certamente ebbe un ruolo anche per la commissione delle due Crocifissioni, si deve, presumibilmente, l’arrivo di altre due tele, sempre provenienti dalla chiesa cappuccina cagliaritana di san Benedetto, raffiguranti Giuseppe venduto dai fratelli (fig. 10) e Rebecca ed Eliezer al pozzo, entrambe alla Pinacoteca cittadina. Se per la prima si concorda nell’assegnarla a Domenico Fiasella, con una datazione ai primi anni Quaranta, per analogia con il medesimo soggetto da lui dipinto nel Palazzo Durazzo�Pallavicini di Genova, che segna il suo passaggio dalla pittura chiaroscurale a quella prevalentemente di colore, più problematica risulta essere la proposta di assegnargli l’altra tela15, certamente non sua, perché strettamente legata alla produzione veneziana di Bernardo Strozzi della seconda metà degli anni Trenta, trovando analogie
48
soprattutto per l’impaginato della scena con la Guarigione di Tobia del Metropolitan di New York, anche se non sono assenti reminiscenze del suo precedente periodo genovese ravvisabili nelle analogie con l’Agar e l’Angelo dell’Art Museum di Seattle, databile intorno al 1617. Altrettanto distante dalla produzione di Fiasella sono le due tele raffiguranti il Riposo dalla fuga in Egitto e la Morte di Giuseppe (fig. 11) della chiesa di santa Caterina a Sassari, opere che andrebbero ricondotte ad artista isolano affascinato dal protocaravaggismo lombardo dei Campi e da Gherardo delle Notti, soprattutto per la presenza – nella Morte di Giuseppe – della fonte luminosa interna al quadro, soluzione che lo stesso anonimo artista, in epoca sicuramente precedente, visto l’approccio più ingenuo, propose nel medesimo soggetto raffigurato in una tela dell’aula capitolare cagliaritana, già ricondotta al cosiddetto Maestro del Capitolo16.Nella stessa aula capitolare del Duomo di Cagliari erano collocate quattro tele, una delle quali perduta, assegnate dallo Spano a Gherardo delle Notti17. Le tre tele superstiti raffigurano Sant’Agata curata da San Pietro (fig. 12), Cristo al Pretorio (fig. 13) e una Maddalena Penitente, mentre in quella irrintracciabile vi era Cristo schernito alla presenza di Erode. Delle tre la più interessante pare essere la Sant’Agata curata da San Pietro, essendo replica di una identica composizione custodita nella Pinacoteca di Montserrat in Catalogna, senza fondamento attribuita ad Artemisia Gentileschi18. Non solo, la tela catalana, così come quella cagliaritana, è identica a un altro esemplare che proviene dalla chiesa di san Francesco a Ragusa, oggi presso il Museo dei Cappuccini di Caltagirone. Quest’ultima versione attribuita al senese Francesco Rustici, detto il Rustichino (attribuzione con la quale fu presentata alla mostra dedicata ad Agata santa, a Catania nel 2008), sembra databile intorno al 1630, proprio come l’esemplare sardo, mentre la tela spagnola sembrerebbe di poco precedente. La similitudine iconografica e la
resa pressoché identica dei tre modelli dipinti su tutte e tre le tele, lascia intendere che siano derivazioni, di autori diversi, ricavate da un originale al momento non rintracciabile, verosimilmente databile intorno al primo decennio del Seicento. Il soggetto di queste opere, appare come una rilettura della tela di omonimo soggetto di Giovanni Lanfranco della Galleria Nazionale di Parma, realizzata tra il 1613 e l’anno successivo, di cui è nota un’altra versione autografa presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Corsini a Roma, datata 1615 circa, ossia pochi anni dopo il suo rientro nella città eterna. Tale composizione è poi mutuata da alcuni passaggi successivi, come quello di Jacopo Vignali, che, nel 1623, ripropone la stessa scena in controparte sostituendo la fonte luminosa della finestra con una candela retta dall’angelo, per la Spezieria del convento fiorentino di san Marco (oggi al Museo di san Marco), o quella di solo un anno successiva di Simon Vouet (ubicazione sconosciuta), a cui la versione sarda appare strettamente collegata. La relazione con le opere di Vignali e soprattutto Vouet, sommata a talune notazioni dipendenti strettamente dalla lezione reniana dei dipinti gemelli di Cagliari, e Montserrat e Caltagirone, rinviano all’ambiente emiliano, più che a quello napoletano, probabilmente alla scuola di Alessandro Tiarini, con una datazione tarda compresa negli anni Trenta, per analogia con simili esiti compositivi, cromatici e stilistici ravvisabili, ad esempio, nella Cleopatra che scioglie una perla in una coppa di vino della Collezione Colnaghi di Londra, nell’Adorazione dei Pastori di Palazzo Pitti a Firenze o soprattutto nel Cristo mostrato al popolo del Museo della Santa Casa di Loreto.I rapporti tra la Sardegna e Roma, già intensi e prolifici, come abbiamo visto, nelle prime due decadi del Seicento, si intensificarono nei decenni successivi, per culminare, alla fine del secolo, nell’importazione diretta di opere di Carlo Maratti e della sua cerchia (Madonna degli Stamenti della
49
cattedrale di Cagliari, Martirio dei Santi Cosma e Damiano e Annunciazione ai Santi Gioacchino e Anna della Cattedrale di Sassari) o di Giuseppe Ghezzi (Pala delle anime purganti dell’oratorio del Purgatorio di Tempio Pausania). In tale ottica dovettero avere certamente un ruolo importante i pittori locali Giovanni Sanna – un frate francescano originario di Sassari poi attivo a Roma, dove morì nel 1622 e del quale è nota una sola opera in collezione privata ad Ozieri19 – e Giacomo Murgia – originario di Cagliari e forse fratello dello scultore e pittore Gabriele, documentato nella capitale sarda dal 1631 al 166320 – attivo a Roma dal 1637 fino agli anni Settanta nella cerchia di Pietro da Cortona. Murgia, oltre a partecipare alla decorazione ad affresco del Quirinale, dove realizzò il Combattimento tra Davide e Golia della Galleria di Alessandro VII nel 1657, entrò a far parte dell’Accademia di San Luca e della Congregazione dei Virtuosi del Pantheon, di cui divenne rispettivamente camerlengo (1661) e reggente (1660)21. In tale fitta rete di rapporti, ma in senso inverso – cioè da Roma a Cagliari – si innestano le due tele raffiguranti la Maddalena penitente (fig. 14) e San Girolamo (fig. 15) della chiesa collegiata di Sant’Anna a Cagliari, firmate da un altrimenti sconosciuto Raffaele Romano, frate cappuccino. La coppia di dipinti, pur debitori della carica trasgressiva e naturalista del primo caravaggismo romano, mutuato da Orazio Gentileschi, risentono dell’influsso dei bolognesi, presentando nel contempo qualche accento transalpino – francese per la nitidezza e pulizia nei contrasti, fiammingo per l’accuratezza nel rendere la tangenza delle luci sugli oggetti – tanto da farne uno degli episodi più interessanti e maturi di questo genere nell’isola. Alla medesima temperie culturale, se non ad un artista assai prossimo e di altrettanto mestiere rispetto a Raffaele Romano, andrebbe ricondotto il San Girolamo nello studio della Pinacoteca Nazionale (fig. 16), proveniente dal san Francesco di
Stampace sempre a Cagliari22, il quale più che trovare tangenze con Ribera23, si offre come esempio elevato e intenso della ricerca caravaggesca in bilico tra Orazio, Artemisia Gentileschi e Simon Vouet, con esiti comunque tutti risolti a Roma entro gli anni Trenta del secolo.Del tutto differente è il caso delle due tele custodite nella parrocchiale di santa Caterina a Mores, raffiguranti rispettivamente Sant’Onofrio (fig. 17) e San Sebastiano (fig. 18). Il primo dipinto, assegnato a Francesco Fracanzano24, va ritenuto come uno degli esempi maturi e intensamente drammatici del caravaggismo napoletano presenti in Sardegna, da una parte debitore del Ribera e dall’altra quale anticipatore degli esiti più alti di Salvator Rosa, soprattutto per l’espediente dell’utilizzo di tonalità terrose uniformi, quasi monocrome, e per la sicurezza del tratto con il quale risolve il contrasto tra luci e ombre in chiave espressionista. Più problematica pare essere la questione per la tela del San Sebastiano, per la quale vale quale primo riferimento iconografico Ludovico Carracci o Guido Reni25, interpretati tuttavia in chiave partenopea, secondo un ben consolidato approccio caravaggesco che trova pieno riscontro con il San Sebastiano di Ludovico Caracci del Fogg Art Museum di Cambridge in Massachusetts, datato al 1620�1630 circa o quello di Luca Giordano della Pinacoteca Nazionale di Palazzo Mansi di Lucca, datato al 1650�1653.Per chiudere questa breve rassegna, che vuole essere un primo approccio all’impatto del caravaggismo in Sardegna, non si possono non menzionare le problematiche tavole raffiguranti i mercedari San Brunone (fig. 19) e San Raimondo di Peñafort (fig. 20), provenienti dal convento di Nostra Signora di Bonaria – dove costituivano forse parte di un retablo – ora presso la Pinacoteca cagliaritana26. Se da una parte si deve rifiutare la vicinanza con Francisco Zurbarán e il suo ambito, avanzata
50
dal Maltese e dalla Serra e poi ribadita dalla Scano27, si deve ammettere la matrice ispanica di questi due scomparti, più prossimi ai modi di Juan Rizi o qualcuno che conosceva bene la produzione di Diego Velázquez, facendo proprie le istanze dello Spagnoletto, Ribalta, Orrente e Cano, che risultano pienamente assorbite verso la direzione del senso più maturo del naturalismo del pieno barocco iberico.
NOTE
1. Virdis 2006, p. 91. 2. Agus 2012, pp. 151�152.3. Agus 2009, pp. 255, 258.4. Spano 1861, 565. Delogu 1933, p. 29, n. 10. 6. Scano 1991, pp. 53, 557. Sgarbi 2005, pp. 158�159. 8. Auneddu in Casula 2012, pp. 130�132.9. Paris 1999, 17.10. Paris 1999, 56.11. Scano 1991, pp. 104, 114�115.12. Scano 1991, pp. 106, 110�111.13. Pesenti 1986, p. 440.14. Donati 1997, p. 74.15. Scano 1991, pp. 107�108.16. Scano 1991, pp. 50�51.17. Spano 1861, p. 56.18. Scano 1991, p. 136.19. Agus 2009, p. 56.20. Virdis 2006, pp. 78�81.21. Scano 1991, p. 117�120.22. Pano 1861, p. 182.23. Scano 1991, p. 135.24. Scano 1991, pp. 133�13525. Scano 1991, p. 128.26. Scano 1991, p. 192.27. Maltese Serra 1969, p. 379; Scano 1991, p. 192.