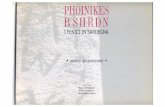Verbale valutazione titoli selezione per l ... - ATS Sardegna
Sardegna e Sede Apostolica nel Medioevo. Recensione a M. SANNA, Onorio III e la Sardegna. In...
-
Upload
univ-corse -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Sardegna e Sede Apostolica nel Medioevo. Recensione a M. SANNA, Onorio III e la Sardegna. In...
359
CORRADO ZEDDA
LA SARDEGNA GIUDICALE E LA SEDE APOSTOLICANEL MEDIOEVO
Spunti di riflessione dalla lettura di M. G. Sanna, Papato eSardegna durante il pontificato di Onorio III (1216-1227),
Aonia Edizioni, Raleigh 2012, pp. I-CI; 1-193
Dopo la pubblicazione, ormai dieci anni fa della pregevole edizione delle let-tere relative ai rapporti fra papa Innocenzo III e la Sardegna (1198-1216)1, Sanna propone ora, con questa pubblicazione in versione digitale e a stampa on demand, un altro strumento atteso da decenni da tutti gli studiosi interessati ad approfondire la natura dei rapporti fra la Sardegna giudicale e la Sede Apostolica romana duran-te il XIII secolo. Come recita l’introduzione al libro:
L’epistolario di Onorio III (1216-1227) con la Sardegna è uno strumento importante per la storia della Chiesa e dell’isola; costituisce la maggioranza delle fonti disponibili per il periodo ed è ricco di informazioni sulla politica pontificia. Nella penuria docu-mentaria che caratterizza questa fase, gli 88 documenti sopravvissuti consentono di ricostruire gli avvenimenti del decennio del suo pontificato che altrimenti resterebbero nell’oblio. Cogliamo la progressiva e inarrestabile penetrazione pisana in Sardegna e ricostruiamo i rapporti che intercorrevano tra Roma, la Sardegna e Pisa. Le lettere con-sentono di seguire la politica di riaffermazione della sovranità della Sede apostolica sull’isola. Onorio prosegue nello scontro con Pisa che dopo aver abbracciato la causa imperiale, si è trasformata in una pericolosa nemica. Nonostante l’energia profusa, il pontefice non riesce a rovesciare la posizione di forza dei Pisani, raggiunta durante quasi due secoli di intensi rapporti con l’isola.
L’opera si presenta dunque interessante e portatrice di nuove e sostanziali ac-quisizioni sul tema oggetto di trattazione. La sua analisi ha il pregio di una precisa descrizione del materiale documentario pervenutoci, proveniente in massima parte dall’Archivio Segreto Apostolico Vaticano, in numero minore da archivi italiani e dalle Archives Départementales des Bouches-du-Rhône di Marsiglia2, infine, in
1 Innocenzo III e la Sardegna edizione critica e commento delle fonti storiche, a cura di M. G. Sanna, Cagliari 2003.
2 Sanna presenta una sola lettera di Onorio III proveniente dall’archivio marsigliese (M. G. San-na, Papato e Sardegna cit., doc. 97, p. 104, già pubblicata peraltro in C. Zedda – R. Pinna, Fra San-ta Igia e il Castro Novo Montis de Castro. La questione giuridica urbanistica a Cagliari all’inizio del XIII secolo, in «Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari», Nuova Serie, n° 15 (2010-2011), pp. 125-187, n. 4, pp. 179-180) ma in realtà a questa se ne possono aggiungere almeno altre due. La prima
[1]
360 CoRRado Zedda
una piccola ma importante sezione, dalla Biblioteca Universitaria di Cagliari, il cosiddetto “quaderno di Santa Maria di Cluso”3. Per tale materiale Sanna rende conto delle diverse collocazioni, delle stime su quello scartato in archivio e ancora della quantità percentuale di documenti sopravvissuti anno per anno, tutti dati che l’autore ripropone in fine volume attraverso delle efficaci tabelle riassuntive. Le trascrizioni, infine, sono impeccabili e anche questo rappresenta un deciso passo avanti, se si tiene conto che finora si doveva fare riferimento a trascrizioni non sempre affidabili, inserite in opere ormai lontane nel tempo, quando i criteri scien-tifici erano diversi da quelli odierni.
Come aveva fatto nel precedente volume su Innocenzo III, Sanna propone, insieme all’edizione dei documenti pervenutici, anche una ricostruzione ideale di quelli oggi perduti ma il cui contenuto è desumibile da quanto ci dicono i do-cumenti sopravvissuti, secondo la metodologia a suo tempo seguita da Kehr. In virtù di questa scelta metodologica il numero dei documenti “virtuali” accresce notevolmente la quantità di quelli sopravvissuti e presentati nel volume.
Forse con troppo ottimismo, esaminando le caratteristiche della documen-tazione studiata, Sanna rileva che essa non presenta particolari problemi di da-tazione, cosa che però non sempre è così, come nel caso del giuramento di Be-nedetta di Cagliari a Innocenzo III (da Sanna retrodatato al 1214, rispetto alla sua precedente proposta del 1215, presentata nel volume su Innocenzo III e la Sardegna) o di alcuni documenti sugli arcivescovi Torgotorio de Mur (Arbo-rea)4 e Mariano (Cagliari), conservati nel quaderno di Santa Maria di Cluso.
è l’originale pontificio della copia di registro presentata da Sanna nella sua raccolta (Archives Départe-mentales des Bouches-du-Rhône de Marseille [in seguito ADMar.], Fondo Saint-Victor, 1. H. 103, 505, con copia in 1. H. 630, cc. XLVIII-LI; cfr. con la copia dei Registri Vaticani pubblicata in M. G. San-na, Papato e Sardegna cit., doc. 32, pp. 49-51). La seconda, piuttosto importante per i suoi contenuti, è una lettera inviata da Onorio III a Pietro, priore di San Saturno con la quale il pontefice conferma la sentenza emanata dal suo legato pontificio Rolando, che aveva proibito ai pisani residenti nel Castel-lo di Castro di edificare una chiesa al suo interno, accogliendo così la supplica presentata al legato dal priore (ADMar., 1. H. 631, f. XXXIIIv, 1220 febbraio 19, Viterbo). Ringrazio vivamente l’amica e col-lega Rossana Rubiu, con la quale ho potuto condividere e verificare i materiali dell’archivio marsiglie-se, provenienti dalle nostre reciproche esplorazioni per le Università di Cagliari e della Corsica. Per i dati della collega rimando alla sua tesi dottorale: M. R. Rubiu, La Sardegna e l’Abbazia di Saint-Vic-tor di Marsiglia - le fonti negli Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, Dottorato di ricerca in Fonti scritte della civiltà mediterranea, 18o Ciclo, docente guida Luisa D’Arienzo, Cagliari 2006.
3 Biblioteca Universitaria di Cagliari, Carte Baille, S.P. 6bis 4.7. Materiali già esaminati da P. MaRtini, Storia ecclesiastica di Sardegna, Cagliari 1839, I, Libro Quinto, pp. 305-307.
4 Sanna fornisce una datazione più corretta dell’elezione di Torgotorio (il 1223, cfr. M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 122, pp. 130-131) rispetto a quella del 1224 proposta da M. Vidili, Crono-tassi documentata degli arcivescovi di Arborea dalla seconda metà del secolo XI al concilio di Trento, Oristano-Roma 2010, p. 21, ma non per il fatto che la lettera in questione sia datata secondo l’Incar-nazione pisana, come sostiene lo studioso ma, più semplicemente, perché essa, datata 1224 nell’unica versione che possediamo, contenuta in copia nel quadernetto manoscritto di Santa Maria di Cluso, è in realtà datata secondo l’anno del pontefice, al quale i copisti cagliaritani, diversi anni dopo, al momento della redazione del quadernetto, avevano aggiunto il 1224, probabilmente per non essere riusciti a con-, probabilmente per non essere riusciti a con-
[2]
361la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
Al termine di questa introduzione descrittiva e metodologica, Sanna si adden-tra nell’analisi specifica del contesto ricostruibile dall’analisi dei documenti e dalla bibliografia conosciuta. Si entra qui in un campo complesso e controverso; infatti il dibattito sulla natura dei giudicati sardi e sui rapporti fra il mondo sardo, la Sede Apostolica e i potentati territoriali del tempo è ancora oggi particolarmente vivo e acceso per la quantità dei contributi proposti e per le tesi spesso molto differenti a-vanzate dai diversi studiosi, in campo locale, nazionale e anche internazionale. La padronanza della vasta bibliografia rimane dunque un prerequisito fondamentale al momento di accingersi a intervenire sul tema.
***
Sono tre i nodi chiave da tenere presenti al momento di avviare una seria ri-flessione storiografica di cosa fu la realtà giudicale sarda nei secoli XI-XIV, nel suo nascere, nel suo svilupparsi e nel suo spegnersi alle soglie dell’Età Moderna5:
1) Individuare la natura del potere dei giudici sardi.2) Riconoscere il reale legame fra giudicati e Sede Apostolica romana.3) Comprendere appieno il contesto storico, politico e geografico in cui si col-
locano i giudicati e il loro rapporto con le altre entità territoriali con le quali furono in contatto.
Sul primo punto gli studiosi si sono espressi in un ventaglio di posizioni che vanno dalle teorie sui “regoli” senza alcun potere effettivo fino alle interpretazioni statalistiche di Francesco Cesare Casula, tutte, però, tendono a non collegare appie-no la natura del potere dei giudici e il suo legame con la Chiesa di Roma. Si tratta, questo, del secondo nodo chiave della storiografia sulla Sardegna giudicale e sul quale solo da poco si è cominciato a produrre una bibliografia di un certo spessore, in particolare grazie agli studi di Raimondo Turtas6 e ora dello stesso Sanna.
testualizzare la datazione originale. L’anno di pontificato di Onorio è l’ottavo e calcolando che il pon-tefice iniziò a governare nel 1216, quale successore di Innocenzo III, è facile di primo acchito somma-re a questa data altri otto anni e arrivare così al 1224. In realtà, gli anni di pontificato di Onorio vanno computati a partire dal mese di luglio, quando il pontefice venne dapprima eletto, quindi consacrato nella carica. Ne risulta che il 30 ottobre dell’ottavo anno di pontificato corrisponde in realtà al 30 otto-bre 1223, sono cioè trascorsi appena 3 mesi dall’inizio del suo ottavo anno di pontificato, mentre per trovarci nel 1224 avremmo dovuto trovare la dizione: “pontificatus nostri anno nono”. Si cade nell’er-rore perché l’“anno di grazia 1224” che segue l’indicazione dell’anno di pontificato è un’aggiunta del copista del quadernetto di Santa Maria di Cluso. Difatti tale indicazione, come può rilevarsi dall’esame dall’originale dell’intero corpus dei Registri di Onorio III ma anche di altri pontefici, non è usata in al-cuna occasione nei mandati apostolici dell’epoca, come si può agevolmente verificare dai regesti del pontificato di Onorio III, cfr. Regesta Onorii III papae, I-II, a cura di P. PReSSutti, Roma 1888-1895.
5 Per un primo approccio rimando a C. Zedda, Sardinia and the Mediterranean in the Middle Ag-es: a reconsideration of the historiography and new perspectives in research, in Hand-book of Medi-eval and Modern Sardinia, Edited by M. HobaRt, Brill, Leiden 2013.
6 R. tuRtaS, Storia della Chiesa in Sardegna. Dalle origini al Duemila, Roma 1999.
[3]
362 CoRRado Zedda
Dai primi due punti ne discende il terzo, sul quale, in particolare, Sanna pren-de una posizione abbastanza esplicita, in linea con quelle della storiografia più diffusa, ritenendo che Pisa abbia sempre avuto il monopolio delle rotte da e verso la Sardegna e il controllo di fatto dell’isola fin dall’inizio della storia dei giudica-ti7. Una convinzione dalla quale personalmente dissento, in quanto la più recente storiografia sul Tirreno medioevale sta evidenziando come il mondo italiano degli inizi del XII secolo era qualcosa di ancora diverso rispetto al panorama politico che si affermerà verso il terzo-quarto decennio, dopo il passaggio cruciale segnato dall’incoronazione di Ruggero re di Sicilia nel 1130 e in seguito alla risoluzione dello scisma all’interno della Chiesa, fra Anacleto II e Innocenzo II (1130-1138)8. In particolare, riguardo ai legami fra Pisa e la Sardegna, sta emergendo che fino alla spedizione delle Baleari e anche oltre, Pisa non sembra avere avuto il mono-polio delle rotte tirreniche9. L’ancoraggio delle posizioni di Sanna a quelle della storiografia più diffusa traspare da diversi passi della sua dissertazione, in partico-lare quando si riferisce al ruolo della Sede Apostolica nelle vicende che interessa-no i giudicati e il comune di Pisa:
Onorio III, che come si dirà non sentirà il bisogno di ribadire assiduamente i propri diritti, continua nella politica di opposizione a Pisa e nello specifico a Ubaldo e Lam-berto Visconti (p. XV).
Va detto che, dalla lettura dell’epistolario, emerge che in realtà Onorio ribadisce spesso i diritti della Sede Apostolica sulla Sardegna e sulla Corsica, specialmente quando si rivolge all’arcivescovo pisano, ma mi sembra che, nonostante l’analisi approfondita proposta dallo studioso, nell’opera emerga un equivoco di fondo.
7 Cfr. il dibattito sui caratteri dei giudicati sardi, sviluppatosi n seguito allo studio di a. MaStRuZ-Zo, Un “diploma” senza cancelleria. Un “re” senza regno? Strategie documentarie di penetrazione coloniale in Sardegna, in «Bollettino Storico Pisano», LXXVII [2008], pp. 1-32; C. Zedda, In margine a “Un diploma senza cancelleria” di Antonino Mastruzzo, in «Bollettino Storico Pisano», LXXVIII (2009), pp. 155-168 e sullo stesso volume, a. MaStRuZZo, Una postilla sarda, pp. 168-171; a. Soddu, Iudices atque reges. Riflessioni su un saggio di Antonino Mastruzzo, in corso di stampa su �Bolletti-�Bolletti-Bolletti-no Storico Pisano».
8 Rimando agli atti di prossima uscita del convegno: Framing Anacletus II (Anti) Pope, 1130-1138, Congresso Internazionale di Studi, Roma, 10-12 aprile 2013 e alla rassegna da me curata in cor-so di pubblicazione.
9 P. SkinneR, Family Power in Southern Italy: the duchy of Gaeta, 850-1139, Cambridge 1995 (seconda edizione 2003); Challenging the Boundaries of Medieval History. The Legacy of Timothy Reuter, a cura di P. SkinneR, Turnhout, Brepols 2009; G. a. loud, Church and society in the Norman Principality of Capua, 1058-1197, Oxford 1985; V. beolCHini – P. deloGu, La nobiltà romana altome-dievale in città e fuori. Il caso di Tusculum, in La nobiltà romana nel Medioevo, a cura di S. CaRoCCi, École Française de Rome 2006, pp. 137-169; u. SCHwaRZ, Amalfi nell’alto Medioevo, Amalfi 2002 (I edizione Salerno-Roma 1980); L. CaRRieRo, La città medievale. Insediamento, economia e società nei documenti napoletani del X secolo, Raleigh 2012.
[4]
363la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
Non si tratta tanto, da parte di Onorio, di perseguire una politica “antipisana” come sembra intendere Sanna, quanto di ribadire e proteggere i diritti della Sede Aposto-lica sulla Sardegna. Su questa differenza si gioca la difficoltà interpretativa sulla storia dei rapporti fra Sardegna giudicale, Sede Apostolica e potentati territoriali, rapporti che sono stati a mio parere ben evidenziati da John Clare Moore in alcune sue opere10, che però non hanno mai convinto eccessivamente gli studiosi di temi sardi11. Tale difficoltà si manifesta al momento di riconoscere appieno il mutamen-to dei rapporti fra Sede Apostolica e Chiesa pisana nel XIII secolo, durante i lun-ghi anni del magistero dell’arcivescovo Vitale e conduce lo studioso a conclusioni problematiche, come nel caso delle sue considerazioni sul diritto di legazìa per la Sardegna e la Corsica, di cui godettero gli arcivescovi pisani nei secoli XII-XIII. Tali diritti furono “bloccati” da Onorio III durante il suo pontificato, come attesta la documentazione dell’epistolario; Sanna però così interpreta:
Nell’insieme i legati in Sardegna ricevono 20 missive, ma tra queste rientrano an-che le 7 all’arcivescovo di Pisa Vitale, che di fatto non esercita mai i suoi privilegi né viene incaricato di svolgere alcun compito connesso ad essi (p. XVI).
Credo che in questo caso non sia stato inteso il senso profondo del mutamento di indirizzo politico della Sede Apostolica nei confronti della legazìa verso le isole di Sardegna e Corsica. Infatti, non è che Vitale “non eserciti mai i suoi privilegi” ma è proprio Onorio che decide con asprezza che Vitale non debba più godere di quei privilegi, perché l’arcivescovo è ormai diventato una parte in causa nel disastro a cui il comune di Pisa sta conducendo la situazione sarda, dopo l’invasio-ne del giudicato di Cagliari, vassallo della Sede Apostolica, operata nel 1216 dal podestà di Pisa, Ubaldo Visconti, insieme a suo fratello Lamberto e ai numerosi membri della loro consorteria12.
Una parte in causa, quella dell’arcivescovo, che sempre più favorirà negli anni la politica comunale pisana riguardo la Sardegna, consentendo la rielezione di U-baldo Visconti a podestà, contro tutte le ingiunzioni del pontefice per impedire tale
10 Si vedano J. C. MooRe, Pope Innocent III, Sardinia, and the Papal State, in «Speculum», Vol. 62, No. 1 (Jan., 1987), pp. 81-101; id, Pope Innocent III (1160/61-1216): to root up and to plant, Brill, Leiden and Boston 2003.
11 Cfr. lo stesso Sanna, Innocenzo III cit., p. XLIV, nota 102: “Non sembra quindi condivisibile l’affermazione di Moore […] che dice che �Innocent’s first involvement in Sardinia was quite restrai-ned and did not result from his own initiative», ritenendo che il pontefice sperasse ancora, in questa fase, in una sottomissione della Toscana e dei Pisani alla Sede apostolica e che perciò non volesse �an-an-tagonize» la città contendendole le posizioni acquisite in Sardegna”.
12 Inizialmente, confidando nella fedeltà di Vitale, il pontefice aveva confermato come consue-tudine i privilegi al nuovo arcivescovo pisano, cfr. M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 25, pp. 42-45.
[5]
364 CoRRado Zedda
mossa politica13 e, addirittura, non impedendo che parte delle rendite della camera arcivescovile fossero trattenute da Ubaldo e Lamberto Visconti per finanziare le loro imprese sarde14.
E le iniziative di Onorio in proposito furono dure e senza precedenti, se andia-mo a leggere senza pregiudizi il contenuto delle sue lettere. Nel settembre 1223 Onorio III scriveva all’arcivescovo di Pisa, ricordandogli le gravissime colpe e responsabilità da lui avute nel trascinare il suo popolo nella confusione e nel pec-cato, favorendo le azioni di Ubaldo Visconti, “figlio del demonio”. Gli ordinava allora di pubblicare immediatamente le sentenze di scomunica che il pontefice aveva ripetutamente emanato nei confronti di Ubaldo e dei suoi seguaci. Infine, gli ordinava di presentarsi entro un mese davanti a lui per discolparsi delle sue azioni; nel frattempo l’arcivescovo avrebbe dovuto considerarsi sospeso dagli uffici pon-tificali e sacerdotali15.
Tre anni dopo, in seguito alle ennesime giravolte dell’arcivescovo pisano, che continuava a favorire le azioni di Ubaldo Visconti, Onorio III scriveva un’altra durissima lettera al nuovo podestà e al popolo pisani, in cui, per l’ultima volta, ingiungeva loro di abbandonare la condotta peccaminosa che li aveva portati ad allontanarsi dalla fede cristiana e dall’obbedienza alla Sede Apostolica. Ordinava, ancora, di fare eseguire le sentenze di scomunica nei confronti di Ubaldo Visconti e dei suoi seguaci. Comunicava quindi che tutte le sentenze emanate dai giudici pisani e dai tabellioni cittadini erano destituite di ogni valore giuridico e, infine, assicurava che se i suoi mandati non fossero stati prontamente eseguiti, egli avreb-be provveduto a togliere alla Chiesa pisana la dignità metropolitica:
Ceterum, cum in contestatione quam fecimus adiectum fuerit litteris supradictis, quod privaremus vos, si noletis acquescere, metropolitica dignitate, et id solum cum iam processerimus ad alia restet agendum, pro constanti tenere potestis quod hoc idem, si apud vos non sic forsitan profecerimus, faciemus16. Una decisione di una gravità inaudita e quasi senza precedenti, quella del pon-
tefice, che probabilmente non ebbe il tempo materiale di porre in atto, per la sua morte di lì a qualche mese e che da sola basterebbe a spiegare le ragioni della Sede
13 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 120, pp. 126-130, 1223 agosto-settembre. 14 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 117, pp. 124-125, 1223 settembre 2: “Hii autem
propter tante temeritatis excessum de feudis que de Camera Archiepiscopatus Pisani tenebantur, fue-runt a quadriennio defrodati”. Dall’esame del documento si deduce che, oltre ad aver avuto finanziatori a Massa Marittima e probabilmente Siena, Ubaldo e Lamberto hanno svuotato le casse dell’arcivesco-vado pisano per quattro anni e con l’assenso dell’arcivescovo.
15 Il già ricordato documento pubblicato in M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 120, in par-ticolare p. 130.
16 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 132, pp. 142-145, 1226 giugno 11.
[6]
365la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
Apostolica e la difesa strenua dei suoi diritti sulla Sardegna. Un “errore tattico” dei pontefici, già compiuto a Modena intorno al 1145/1150 ma non ripetuto da Gregorio IX con Lucca, privata il 28 marzo 1231 della dignità diocesana per avere occupato la Garfagnana, che aveva giurato fedeltà al papa. Il raffronto Lucca/Pisa e Garfagnana/Sardegna è a mio parere molto pertinente perché riesce a sprovincia-lizzare il dibattito e a far capire come la Sede Apostolica difendesse strenuamente i suoi diritti ovunque si trovassero e non solo quelli sulla Sardegna17.
È interessante osservare come la reiterazione della minaccia a Pisa di togliergli la dignità metropolitana, fatta da Gregorio IX, tragga le sue radici da questa prima minaccia. Insomma, rileggendo l’epistolario dei pontefici della prima metà del XIII secolo, viene fuori un quadro sicuramente stimolante e ricco di connessioni ad ampio raggio territoriale, che, grazie anche al lavoro di Sanna, permette di for-mulare nuovi quesiti e trovare risposte diverse sulla politica pontificia riguardo al fronte tirrenico e alla Sardegna in particolare.
***Nella sezione II Sanna sceglie di strutturare l’introduzione per temi, invece di
seguire un metodo esclusivamente cronologico, una scelta valida e condivisibile e altrettanto opportunamente Sanna avvisa di non voler cadere nel facile determini-smo al momento di esaminare e interpretare i fatti storici. Bisogna dire, però, che tale intento gli riesce solo parzialmente, anche perché lo studioso si pone all’inter-no di una corrente storiografica decisamente predominante che ritiene non debba essere oggetto di un rinnovato dibattito la verifica della subalternità della Sardegna giudicale alle politiche di Pisa e Genova. Al contrario, i principali studi sul tema propongono un mondo giudicale molto semplificato e appiattito attraverso la vi-sione di una realtà a parte, fatalmente destinata a una brutale colonizzazione.
In questo senso, risulta problematica da accogliere l’interpretazione di Sanna del precoce inserimento della Gallura all’interno del sistema di controllo pisano nel XII secolo e del ruolo di Guglielmo di Massa a cavallo tra XII e XIII. Per il primo esempio, molti dubbi su come fosse organizzata la struttura del potere nel giudicato e su chi vi regnasse effettivamente negli anni Venti-Trenta del XII seco-
17 Tale azione ha le sue radici giuridiche nelle novità introdotte da Gregorio VII, per il quale “non può esserci niente di fissato für ewig, tranne le prerogative della Sede Apostolica. Le situazioni pos-sono essere sempre variate �si necessitas vel utilitas maior exegerit», e le condizioni di necessitas e di utilitas sono vagliate e istituite proprio dalla Sede Apostolica. La Sede Apostolica può persino deci-dere di cambiare la situazione, ma certo non senza una ratio: �antiqua sanctorum patrum, quibus licet indigni et longe meritis impares in administratione huius sedis succedimus, vestigia, in quantum divina dignatio permittit, imitari desiderantes», come recita l’arenga del privilegio che stabilisce la primazia della Chiesa di Lione” (G. M. CantaRella, La «Modernità» in Gregorio VII, in Il Moderno nel Medio-evo, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo [Nuovi Studi Storici, n. 82], a cura di a. de VinCentiiS, Roma 2010, pp. 33-46, in particolare p. 44).
[7]
366 CoRRado Zedda
lo vengono da un documento che costituirebbe la prova dell’ingresso pisano nel giudicato. Si tratta del giuramento del giudice Costantino di Gallura, prestato stra-namente ad Ardara, nel giudicato di Torres, in favore di Chiesa e Comune di Pisa e sicuramente connesso al generale progetto di Innocenzo II per la Sardegna, la Corsica e l’intero spazio tirrenico18. Il 26 giugno 1132, diversi mesi prima del pri-vilegio metropolitico sulla Corsica concesso a Genova, Comita Spanu rinnovava, sottoscrivendo un breve recordationis, il suo giuramento di fedeltà, già prestato all’arcivescovo di Pisa Ruggero ed ai consoli della città e si impegnava a versare all’Opera di Santa Maria di Pisa per dieci anni una libbra d’oro e a cedere alla stessa la metà delle miniere d’argento che fossero state eventualmente scoperte nel territorio gallurese.
A mio avviso possediamo degli elementi per riconsiderare la tradizionale in-terpretazione accolta anche da Sanna. Che nel giuramento del 1132 ci si trovi di fronte non al giudice di Gallura effettivamente regnante ma a un pretendente rifugiatosi nel giudicato di Torres (alleato di Pisa), sembra dedursi dal cognome del giudice: Spanu e non Gunale, come i predecessori e i successori attestati dalla documentazione pervenutaci. Inoltre, la larghezza e la genericità delle concessioni promesse sembra riferirsi a beni che non sono effettivamente controllati ma che si spera di controllare. Il fatto che Comita Spanu debba realizzare lontano dal suo regno un documento così importante per l’esistenza del suo giudicato e specifichi che proteggerà gli interessi pisani da eventuali rappresaglie, delinea infine un qua-dro di forte problematicità e di insicurezza su chi stesse effettivamente regnando in Gallura, dando più che altro l’idea che ci si trovi di fronte a un personaggio privo di potere, che deve chiedere aiuto a Pisa, pur di recuperare od occupare il regno, accettando di accondiscendere a quanto Innocenzo II ha stabilito per la Chiesa pi-sana19. Infatti, l’ingresso della Chiesa pisana in Gallura sarà il compenso per quella città che tanto aveva dato e fatto per il pontefice in cerca della legittimazione universale durante lo scisma che lo oppose ad Anacleto II ma, allo stesso tempo, i pisani vollero da subito un acconto dal pontefice, preparando il loro ingresso in Gallura fin dal 1131-1132, con la sottoposizione di un pretendente al trono giudi-cale ai voleri di Innocenzo e attraverso di questi all’arcivescovo pisano.
Si ricordi che tutti questi avvenimenti si svolgono nel periodo in cui Innocenzo
18 ASP, Diplomatico Coletti, Pergamene sub anno 26 giugno 1133, trascritto da o. SCHena, Civita e il giudicato di Gallura nella documentazione medioevale. Note diplomatistiche e paleografiche, in Da Olbìa ad Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea. Atti del Convegno internazionale di Studi, Olbia 12-14 maggio 1994, a cura di G. Meloni e P. F. SiMbula, vol. II, Sassari 1996, pp. 97-112 (trascrizione a p. 112 e foto riproduzione del documento a p. 108, tavola 4).
19 Andrà riesaminata pure la situazione del giudicato turritano, il cui giudice, Gonnario, nel 1130 aveva prestato per Sanna un giuramento simile allo stesso Comune di Pisa, ma che in realtà venne pre-stato solamente all’arcivescovo di Pisa, cfr. P. tola, Codex Diplomaticus Sardiniae, Torino 1861, vol. II, XII secolo, doc. XL, pp. 206-207, in particolare p. 207.
[8]
367la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
si trova a Pisa, dove insieme all’arcivescovo Ruggero può rendersi conto da vicino delle implicazioni connesse alla situazione sardo-pisana, e studiare le strategie più efficaci per la risoluzione del nodo tirrenico a vantaggio di Pisa20. Il giuramento di Comita Spanu, in definitiva, pare essere un’azione guidata in sinergia dalla curia pontificia residente a Pisa, dall’arcivescovo Ruggero e dai principali rappresen-tanti dei ceti dirigenti cittadini, che convergono tutti insieme sulla decisione di puntare su un pretendente al titolo giudicale, in quel momento più disponibile a un’apertura della Gallura agli interessi pisani, comunque rappresentati nel ter-ritorio dalla presenza della Chiesa cittadina, sia pure una presenza precaria e da difendere da tentativi, anche violenti, di metterne in discussione il ruolo, come appare dalla documentazione di quegli anni21. Dunque, una Gallura problematica per Innocenzo II e per Pisa, giacché non sappiamo chi governasse effettivamente nel giudicato in quegli anni e sarà proprio la risoluzione dello scisma a fare da spartiacque fra la storia giudicale degli esordi e quella dei secoli XII-XIII.
Analogo modo di argomentare è condotto da Sanna per commentare la vicen-da di Guglielmo, marchese di Massa e giudice di Cagliari (1187-1214), laddove lo studioso accoglie la visione classica di un Guglielmo manovrato da Pisa per promuovere un complicato progetto di controllo dell’isola per interposta persona. Anche la vexata quaestio sull’identità del padre di Guglielmo (l’inesistente Oberto di Massa) appare trattata con una certa rapidità e probabilmente avrebbe giovato esaminare più approfonditamente la recente proposta di Raimondo Pinna, che ha sicuramente il pregio della chiarezza22.
Approfondendo invece l’interessante interpretazione sui giuramenti alla Sede Apostolica data da Sanna nel suo libro23, credo che la differenza fra i giuramenti ante e post Innocenzo III costituisca la prova a sostegno della tesi di Moore del passaggio a una concezione di patrimonialità della sovranità pontificia sulla Sar-degna, rispetto alla generica richiesta di ubbidienza in cambio della legittimità a governare concessa dai pontefici nelle epoche precedenti24.
20 Si consideri che il documento di Comita Spanu è paleograficamente molto simile ai documen-ti emanati dalla curia pontificia dell’epoca, cfr. o. SCHena, Civita e il giudicato di Gallura cit., p. 105.
21 Si rimanda sempre ad a. MaStRuZZo, Un “diploma” senza cancelleria cit. 22 R. Pinna, Santa Igia. La città del giudice Guglielmo, Cagliari 2010, pp. 223-233. Per Pinna,
che riprende una vecchia intuizione di C. deSiMoni, Sui marchesi di Massa in Lunigiana e di Parodi nell’Oltregiogo ligure nei secoli XII e XIII, in «Archivio Storico Italiano», anno 1882, tomo X, pp. 324-349, il padre di Guglielmo futuro giudice di Cagliari sarebbe l’omonimo Guglielmo Corso.
23 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., pp. LXIX-LXX.24 Certo, risulta ancora oggi difficile definire l’ambito di estensione del principio secondo il quale
la Sede Apostolica avrebbe potuto giudicare sia nel campo spirituale sia in quello temporale, ma co-me sintetizza efficacemente Tommaso di Carpegna Falconieri: “È una acquisizione storiografica certa […] come la Curia romana, attraverso i suoi membri e i suoi organi di governo e amministrazione, ab-bia costituito il motore per l’affermazione del centralismo romano e del primato petrino. La differenza tra alto e basso medioevo non si valuta solamente esaminando il grado di coscienza che aveva di sé la Chiesa romana dichiarando il suo primato: certo, i Dictatus pape o la bolla Unam sanctam non sono
[9]
368 CoRRado Zedda
Ed è questo uno dei motivi per cui il comune di Pisa impose ai giudici di Ca-gliari di giurargli fedeltà: un conto era il giuramento del giudice all’arcivescovo pisano, in quanto primate di Sardegna e quindi rappresentante del papa; un conto, invece, è che lo stesso pontefice decidesse di saltare la catena e richiedesse ai giu-dici di effettuare il loro giuramento direttamente a lui: questo atto dovette essere visto come un vero e proprio casus belli agli occhi della classe dirigente pisana, specialmente quando alla podesteria del comune salì Ubaldo Visconti, al quale non bastò più il giuramento di un marchese di Massa a Pisa in quanto suo cittadino. Infatti, ciò che differenzia il giuramento a Pisa di Benedetta da quello dei suoi avi è il fatto che, al contrario del padre, del nonno e del bisnonno, la giudicessa non era mai stata una cittadina pisana e non aveva ritenuto di dover giurare al comune. A mio parere, questa è una importante chiave interpretativa da tenere presente.
Nella sua pur attenta interpretazione, Sanna preferisce invece separare la que-stione del matrimonio tra Benedetta e Barisone da quella del giuramento impo-stole dal Comune di Pisa concentrando la sua esegesi della lettera di Benedetta ad Onorio III del 1217 sui caratteri “privati” della stessa, ossia sul fatto che lei avesse scelto liberamente di sposare Barisone, salvo aver consultato i grandi del regno, e che il fare cenno, nella lettera a Onorio, a eventuali screzi tra lei e Barisone fosse l’automatica motivazione che tali screzi non fossero mai esistiti. Trovo però diffi-cile che non possa considerarsi “politico” il comportamento tenuto da Benedetta nel non averne fatto cenno nella lettera ad Onorio, in quanto quegli screzi non dovevano essere rivelati proprio al pontefice per non mostrare le debolezze interne alla dinastia regnante. Il matrimonio, al contrario, fu celebrato per ragioni politi-che molto stringenti e convenienti per la giudicessa cagliaritana, che sposando il suo prigioniero Barisone, poteva di fatto controllarne il giudicato, in modo che, una volta nati gli eredi, si sarebbe potuto passare da una unione personale a una dinastica e politica a tutti gli effetti. Secondo Sanna, invece:
Barisone d’Arborea, a propria volta, ha buoni motivi per sposarla, dato che, pre-
tendente al trono arborense, può diventare giudice senza dover passare per complesse
altomedievali, ma la teoria delle due spade risale al V secolo, e il Constitutum Constantini era stato forgiato già nel secolo VIII. La differenza tra alto e basso medioevo, dunque, passa anche attraverso la capacità reale che ebbe la Chiesa romana di affermare il proprio primato. E questa capacità le venne data proprio dalla formazione di un apparato efficiente, che naturalmente era la Curia romana: in pri-mo luogo e soprattutto con l’istituzione dei legati apostolici” (t. di CaRPeGna FalConieRi, La Curia ro-mana tra XI e XIII secolo: a proposito di libri già scritti e di libri che mancano ancora, in A Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu – The Church and the Portuguese Clergy in the European Con-text – La Chiesa e il Clero Portoghese nel Contesto Europeo – L’ Église et le Clergé Portugais dans le Contexte Européen (Atti del Colloquio internazionale, Roma-Viterbo, 4-8 ottobre 2004), Lisboa, Cen-tro de Estudos de História Religiosa, Universidade Católica Portuguesa 2005, pp. 195-203, il passo è a p. 196). Sul ruolo e l’attività dei legati pontifici rimando al recente M. P. albeRZoni - C. Zey (a cura di), Legati e delegati papali. Profili, ambiti d’azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII, Mila-no 2012, che rappresenta un importantissimo strumento metodologico per lo studio di questa tematica.
[10]
369la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
e rischiose operazioni che forse includerebbero anche iniziative militari. Egli sa cosa ciò significhi, dato che ha sperimentato sulla propria pelle la violenta aggressività sia di Genova, sia soprattutto dei Pisani, proprio per mano del defunto suocero (p. XXV).
Si potrebbe anche dire, conoscendo i retroscena degli avvenimenti, che il pri-mo buon motivo per Barisone fosse quello di poter passare dalla galera a un trono giudicale. Difficilmente dalla sua reclusione avrebbe potuto organizzare le com-plesse e rischiose operazioni ipotizzate da Sanna.
***Lo studioso dedica poi una nota di quasi tre pagine, piuttosto atipica nell’impo-
stazione del suo volume, a una fonte contenuta nel Breviloquium di Boncompagno da Signa, che Pinna ha valorizzato e proposto per la prima volta nel suo studio, sui caratteri dell’unione fra Benedetta e Barisone e sulla fine violenta di questa unio-ne. Boncompagno riferisce di un invito del pontefice, probabilmente non rivolto direttamente a lui, per intercedere presso la giudicessa riguardo le sue intemperan-ze nei confronti del suo sposo, Barisone di Arborea:
Iniunxit nobis apostolica celsitudo, ut A. filiam olim marchionis et iudicis Caleri-tani deberemus inducere propensius et monere, quod ad virum suum P. iudicem Arbo-nensem regredi non permitteret. Sed antequam ad nos apostolice littere pervenirent, illa sicut mulier que animo libenter indulget, illum fecerat a suis amatoribus iugulari25.
Sanna non ignora questa fonte, ma pare concentrarsi soprattutto sulla possibi-lità che ad essa non debba essere assegnata una forte rilevanza storica26. Sulla base del parere degli specialisti di ars dictandi, il Breviloquium sarebbe stato composto nel 1203, prima degli avvenimenti relativi a Benedetta e Barisone ma lo studioso ammette, allo stesso tempo, che il testo potrebbe aver subito delle varianti succes-sive, che poterono comprendere il passo relativo alla giudicessa cagliaritana.
A mio parere, la validità storica della fonte di Boncompagno trova una in-volontaria conferma nel tentativo di Sanna di considerare come avvenuto un pre-sunto matrimonio tra Ubaldo Visconti e la giudicessa Benedetta. L’ipotesi di un matrimonio fra i due, in seguito alla vedovanza della giudicessa, ci dà conto delle strategie di lignaggio perseguite dai Visconti, volte a ottenere l’ingresso nella dina-stia regnante cagliaritana in piena legittimità, attraverso le politiche matrimoniali.
Per Sanna il matrimonio fra Benedetta e Ubaldo dovrebbe essere stato succes-
25 bonCoMPaGno da SiGna, Breviloquium Boncompagni 16 De inceptionibus illorum, quibus cau-se committuntur 16.7, in S. M. WiGHt, Medieval Diplomatic and the “Ars Dictandi”, Opera omnia Boncompagni (1194-1243), Los Angeles 1998.
26 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., nota 147, pp. LVII-LIX.
[11]
370 CoRRado Zedda
sivo a quello celebrato col suo fratello Lamberto e la possibilità gli è suggerita da un passo di una lettera di Onorio al suo legato Bartolomeo:
Lambertus et Ubaldus cupientes absolvi a vinculo excommunicationis quo tenentur astricti prestare volebant duodecim milium librarum quod mandatis nostris preci-se parerent pignoraticiam cautionem quas parati erant Senis vel alibi deponere ut dicebant. Nuper autem iidem, te procurante ac apud nos suppliciter interceden-te pro eis, nobis scripserunt quod parati erant pecuniam ipsam camere nostre per-solvere si eos et complices ipsorum absolvi et matrimonium inter predictum Ubaldum et nobilem mulierem donnicellam Benedictam contractum nuntiari legitimum faceremus. In hoc quidem non astutus sed insipiens potes merito reputari, nisi forsan ex maiori astutia insipientia processerit simulate, quod credebas ut conditiones tam enor-mes, tam abusivas quasi amore illecti pecunie admittere deberemus27.
La notizia del matrimonio fra Benedetta e Ubaldo troverebbe un sostegno in un altro documento dell’epistolario di Onorio, dell’agosto 1218, in cui il pontefice ordina ai suoi legati per la Sardegna, Ugone e Rolando, di sciogliere la giudicessa Benedetta dall’illecito giuramento verso Pisa, che prevedeva, fra le altre cose, di sposare Ubaldo Visconti:
iuramento firmare quod prefactum Ubaldum in virum reciperet 28.
Queste notizie creano un grosso problema di interpretazione. Sappiamo infatti che Benedetta e Lamberto Visconti furono sposati successivamente alla morte di Barisone d’Arborea, a partire almeno dal 1220, se non prima, e che questo matrimo-nio fu ritenuto legittimo dai vertici del potere giudicale ed ecclesiastico nel giudicato cagliaritano29. Sappiamo inoltre che Lamberto morirà nel 1224, per cui, accogliendo l’ipotesi di un nuovo matrimonio con Ubaldo nel 1221, dovremmo ipotizzare un divorzio fra la giudicessa e Lamberto, che avrebbe dovuto letteralmente “passare” la moglie al fratello, quasi si trattasse di un oggetto senza volontà. Tutto ciò avrebbe però costituito un impedimento invalicabile dal punto di vista canonico e del quale avremmo dovuto sicuramente trovare delle tracce nell’epistolario di Onorio.
Va poi detto che la lettera di Onorio non sembra riferirsi a un matrimonio ef-
27 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 102, pp. 107-109, 1221 settembre 17. I corsivi so-no miei.
28 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 40, p. 59, 1218 agosto 23.29 Su questi aspetti cfr. C. Zedda, Le Carte Volgari cagliaritane: prime acquisizioni da un riesame
comparativo, in «Notiziario dell’Archivio Storico Diocesano di Cagliari», Anno X (Giugno 2012), pp. 8-14. Nello studio espongo come attraverso l’esame comparato dei sigilli delle Carte Volgari Cagliari-tane sia possibile ottenere nuove e sostanziali acquisizioni sulla famiglia di Benedetta, sui suoi matri-moni e su chi effettivamente regnò nel giudicato fra il 1218 e il 1224.
[12]
371la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
fettivamente celebrato (e consumato) ma alla possibilità da parte del pontefice di approvare un matrimonio solamente contrattato. E che la giudicessa non fosse un oggetto nelle mani dei suoi controllori lo si comprende quando, nel 1220, chiede al pontefice di non dare validità al suo matrimonio con lo stesso Lamberto per via dei legami di consanguineità che legavano le dinastie cagliaritana, gallurese e viscontea. Il 9 aprile di quell’anno, infatti, Onorio III comunicava a Marsuchino, vescovo di Luni, e al canonico pisano Guglielmo che Lamberto Visconti, scomu-nicato per gravi ingiurie alla Santa Sede intendeva far ratificare il suo matrimonio con Benedetta, come saputo da una lettera inviatagli dalla stessa giudicessa dal suo luogo di reclusione. Tutto ciò malgrado che lo stesso Lamberto avesse tenuto a battesimo una sua figliola e che Lamberto “etiam uxorem habuerit, que in primo genere ac secundo gradu affinitatis dictam nobilem contigebat”. Il pontefice ag-giungeva infine che la donnicella si era rivolta a lui, supplicandolo di annullare il matrimonio essendo tali gli impedimenti per cui “esset non possit matrimonium inter eos”, tanto più che Lamberto “super hoc violenter ac illicite attemptavit” 30. Vi è da riflettere, vista la rilevanza degli impedimenti canonici che si sarebbero dovuti superare da parte degli interessati, su come avrebbe potuto pretendere U-baldo, qualche anno dopo, di far sposare il figlio (Guglielmo) di quella che avreb-be dovuto essere sua moglie o ex moglie (Benedetta) con una sua figlia avuta nel frattempo da un’altra unione che sostituiva quella con la giudicessa e sulla cui evidente stranezza Sanna non si pronuncia.
A questo punto dobbiamo pensare a due ipotesi. La prima è che nel 1221, quan-do secondo Sanna sarebbe dovuto avvenire il matrimonio fra Benedetta e Ubaldo, ci si stia riferendo a notizie ricevute dal pontefice nel 1220, quando nulla ancora era stato deciso riguardo a un matrimonio di Benedetta. Va però osservato che, in questo caso, Onorio nella sua lettera al legato Bartolomeo non fa cenno alcuno alla evidente pregiudiziale canonica del matrimonio precedentemente contratto fra la giudicessa e il fratello di Ubaldo, né tantomeno il pontefice cita la sua lettera del 1220, che avrebbe dovuto a ragione essere da lui ricordata e utilizzata per non approvare il nuovo matrimonio.
La seconda ipotesi, invece, che francamente appare la più semplice e con-vincente, presuppone che vi sia stato in realtà uno scambio di nomi fra Ubaldo e Lamberto, operato dal copista in fase di trascrizione dell’originale nel registro di cancelleria. Un errore non infrequente nei registri vaticani, come pure testimonia il caso di un registro di Innocenzo III, dove il copista confonde il giudice di Gal-lura con il giudice di Cagliari, confusione che è stata ben segnalata e chiarita dallo stesso Sanna nella sua edizione del documento31.
30 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 58, pp. 74-75, 1220 aprile 9.31 Innocenzo III cit., doc. 12, pp. 19-23, il passo corretto da Sanna è a p. 22.
[13]
372 CoRRado Zedda
Tutto ciò non contraddice però la notizia dell’agosto 1218, sul progetto di fare sposare inizialmente Benedetta a Ubaldo, anzi, tutto il contesto avvalora, a mio parere, la fonte di Boncompagno da Signa (che andrà comunque interpretata per quanto riguarda le reali intenzioni della giudicessa) sul fatto che a uccidere il giu-dice Barisone fossero stati gli “amanti” di Benedetta, intendendo con essi i due fratelli Visconti che, come doveva essere noto, puntarono praticamente da subito a sposarla per raggiungere i loro obiettivi, secondo una strategia concordata che mirava a introdurre legittimamente la famiglia nella linea dinastica dei giudici cagliaritani, una volta soppresso Barisone. Chi dovesse sposarla era quasi un det-taglio ma probabilmente il primo progetto, non realizzatosi, di un matrimonio fra Ubaldo e Benedetta era dovuto al fatto che in quel momento Lamberto doveva ancora essere sposato con Elena, ereditiera gallurese della quale di lì a poco si per-deranno le tracce. Con la scomparsa di Elena Lamberto poté mettere in pratica la strategia familiare per l’ingresso legittimo della sua famiglia nella linea dinastica dei giudici cagliaritani.
Da questa breve analisi emerge con tutta evidenza la necessità per i due Vi-sconti di operare una separazione delle loro attività politiche e militari su tutto il fronte d’azione. Per Ubaldo e Lamberto era necessario esercitare la medesima azione diretta sia a Pisa che in Sardegna, se si voleva ottenere il successo di tutto il progetto di conquista nell’isola, punto sul quale concorda anche Sanna32. Ma non era possibile svolgere una simile politica da parte di una sola persona che risiedesse in uno solo di questi centri d’azione: l’uno era complementare all’altro e lo rafforzava. Chi stava a Pisa non poteva agire efficacemente in Sardegna, dove era indispensabile esercitare un ferreo e diretto controllo militare. Per chi si occu-pava del fronte di terraferma occorreva invece stare a Pisa, per tenere in mano la situazione su più fronti, tutti molto delicati: dentro la città, dove i Visconti e i loro sodali vivevano una comunque difficile condizione di scomunicati e dovevano per questo guardarsi dagli avversari interni (perché la politica nei confronti della Sardegna non ebbe mai un’adesione plebiscitaria dentro il comune); nei rapporti con i pericolosi vicini (Lucca e Firenze); con l’imperatore che stava scendendo in Italia; ma, soprattutto, chi restava a Pisa doveva gestire, anche in sinergia con l’ar-civescovo, i delicatissimi rapporti con la Sede Apostolica, che stava impiegando tutte le sue energie per fermare il progetto visconteo. Viceversa, chi stava in Sar-degna non poteva permettersi di stare a Pisa, perché a Cagliari serviva una figura costantemente presente e visibile, che agisse sia da giudice che da capo militare degli interessi comunali e familiari.
Se, dopo il 1218, Ubaldo dovette tornare a Pisa, per consolidare l’egemonia della sua fazione in città e continuare a investire finanziariamente nel progetto sardo, ecco che egli semplicemente non poteva permettersi di sposare Benedetta
32 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., pp. LXVII-LXVIII, nota 183.
[14]
373la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
di Massa e diventare giudice di Cagliari, come pensato inizialmente, perché ciò avrebbe significato per lui risiedere in Sardegna in pianta stabile. Le congiunture politiche portarono così Lamberto, maggiormente radicato nell’isola rispetto al fratello, a farsi carico della “parte sarda” del progetto visconteo. Un modo di pro-cedere che funzionò bene durante i primi anni, grazie al legame di ferro tra Ubaldo e Lamberto, basato sulla reciproca e totale fiducia nel seguire una comune strate-gia a Pisa e in Sardegna. La controprova di questo ragionamento è data dal fatto che, negli anni successivi, dopo la morte di Lamberto, ogni volta che uno dei due fronti, sardo e toscano, presentò dei problemi, Ubaldo dovette farsi carico da solo della situazione, recandosi a Pisa o in Sardegna per consolidarla e causando però un pericoloso squilibrio sul fronte lasciato temporaneamente scoperto. D’altronde l’allargamento dell’area di interessi nell’isola sulla quale si innestavano ormai le più generali politiche di Pisa nel suo insieme, non permise al figlio di Lamberto, Ubaldo II, di garantire la stessa efficacia politica e militare assicurata da suo pa-dre, anche per il visibile deficit di carisma di un personaggio vissuto e formatosi nel limitante panorama sardo che lo relegò di fatto a un’evanescenza politica a Pisa, dove gli equilibri interni cominciavano a mutare a sfavore della consorteria viscontea.
***Quanto detto finora ci porta a proporre delle riflessioni che riguardano la situa-
zione generale dello scacchiere isolano durante gli anni dell’invasione di Ubaldo e Lamberto Visconti. Secondo Sanna, infatti:
Comita [di Torres] riuscirà a conquistare metà del giudicato d’Arborea (doc. 61, 1220, aprile 10, Viterbo) e a mantenerlo (doc. 74, 1220, novembre 17, Laterano 17); cfr. infra testo corrispondente alle note 197-198. Si noti di passaggio che, nonostante lo stretto legame instaurato tra i regnanti di Torres e Genova, nel trattato non si parla della prestazione di un giuramento di fedeltà al Comune da parte dei due giudici, che si facessero salvi o meno i diritti domini pape (p. XXVIII).
L’interpretazione è problematica, sia per la confusione fra le politiche attuate dai giudici turritani Comita e il suo successore Mariano (in realtà i documenti dicono solamente che prima del 1219 Comita controllava parte dell’Arborea), sia per gli esiti del trattato di Noracalbo del 1219, che portarono a mutamenti pro-fondi per la Sardegna settentrionale, interessando infatti l’equilibrio dei giudicati d’Arborea, di Torres e di Gallura. Vale la pena di soffermarsi nuovamente sulla Gallura, per via di una serie di problemi interpretativi che non trovano una solu-zione convincente neppure nella pur interessante dissertazione di Sanna. Questo giudicato fu di fatto in buona parte controllato dai giudici turritani ai danni di
[15]
374 CoRRado Zedda
Lamberto Visconti, marito di Elena di Gallura. Per Sanna questo controllo durò almeno sino al 1211 e lo si evincerebbe da una lettera di Innocenzo III che intima al giudice turritano:
de terra vero Galluri, quam tenes, nullum cum Pisanis vel aliis sine nostro speciali mandato contractum inire presumas33.
Quel che sembra emergere è che il giudice di Torres dovette controllare, oltre che alcuni territori dell’Arborea, anche parte della Gallura, se non tutta, fino al 1219 e Lamberto Visconti non poté prenderne possesso fino a che non sconfisse Mariano imponendogli il trattato di Noracalbo, il quale portò Pisa e i Visconti a diventare i padroni totali della politica sarda di quegli anni34.
Riguardo al vero e proprio trattato e alla sua natura, va osservato che non si tratta di un accordo fra due signori; a parlare e ad agire è solo un personaggio, Mariano di Torres, che si riconosce sconfitto e cede e riconsegna una serie di beni e territori. Il principale territorio che Mariano restituisce a Lamberto è, evi-dentemente, il giudicato di Gallura, che il giudice turritano deteneva da tempo. Lamberto, nonostante avesse sposato Elena di Gallura e si fosse così impadronito del titolo di giudice gallurese, non era riuscito ancora a occupare di fatto né quel giudicato né tantomeno a farsi riconoscere giudice dai pontefici romani, giacché sia Innocenzo III che Onorio III lo menzioneranno sempre col solo titolo di civis pisanus.
Sarà utile a questo punto riflettere sull’intero contesto del matrimonio di Elena, prendendo spunto dalle importanti considerazioni portate da Constance Rousseau, in uno studio, che si dimostra molto utile per stabilire alcuni punti fermi che trove-ranno spiegazione nella documentazione successiva alle vicende del 1206-120735.
Per Rousseau alla base della scelta di Innocenzo III di far sposare Elena a suo cugino Trasamondo dei Segni (matrimonio poi non consumato per l’improvviso arrivo di Lamberto Visconti) vi era il fatto, abbastanza scontato in tutte le interpre-tazioni storiografiche, che troppi interessi legavano il pontificato sia ai pisani sia ai genovesi e, inoltre, il pontefice doveva cercare di tenere equidistanti i giudici di Cagliari (Guglielmo) e Torres (Comita), entrambi detentori di fatto di parte della Gallura. Così Innocenzo:
33 Innocenzo III cit., doc. 132, pp. 141-142.34 Il trattato è conservato in Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico San Frediano in Cestello,
18 settembre 1220 stile dell’Incarnazione pisana, quindi 1219, edito da C. PiRaS, Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Frediano in Cestello dell’Archivio di Stato di Firenze, in «Archivio Storico Sardo» XLV (2008-2009), pp. 9-142, in particolare doc. I, pp. 53-56.
35 C. M. RouSSeau, A papal matchmaker: principle and pragmatism during Innocent III’s pontifi-cate, in «Journal of Medieval History», vol. 24, n° 3 (1998), pp. 259-271.
[16]
375la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
probably concluded that peace and order could only be restored if Elena was married to someone who was neither a local nor Pisan candidate and who would not be held in suspicion by the Sardinian judici36.
Ma sono oltremodo interessanti le considerazioni sugli aspetti canonistici del matrimonio contrattato ma non consumato (con Trasamondo) e di quello effettiva-mente celebrato e consumato (con Lamberto):
The pope could and did punish Elena’s disobedience and trasgression of her oath by excommunicating her but he could not dissolve her valid marriage to Lambert since this would have contravened canon law37.
Innocenzo, insomma, poteva punire la disobbedienza di Elena e la trasgressio-ne del suo giuramento con la scomunica, ma non poteva sciogliere il matrimonio dell’ereditiera gallurese con Lamberto, in quanto ormai valido; facendolo avrebbe egli stesso violato il diritto canonico e sarebbe stato questo lo stesso scoglio con-tro il quale si sarebbe trovato a cozzare Onorio III col matrimonio fra Benedetta e Lamberto.
Come dimostrano i documenti degli anni successivi, la strada scelta da Inno-cenzo e anche da Onorio fu quella di non considerare più i due sposi come titolari di diritti sul giudicato gallurese (e per Lamberto anche su quello cagliaritano). Per i pontefici Lamberto sarebbe rimasto per sempre solamente un “civis Pisanus” ed Elena una semplice “mulier”. Per la Sede Apostolica la questione sul giudicato gallurese, almeno fino a Gregorio IX, era da considerarsi chiusa.
Poniamo a questo punto a confronto le lettere di Innocenzo e di Onorio che riguardano Lamberto Visconti. Quelle di Innocenzo III in cui è nominato esplici-tamente Lamberto, sono tre38: nella prima lettera il Visconti è chiamato “cittadino pisano”; nella seconda “pisano”; nella terza (inviata al podestà ai consiglieri e al popolo pisani) “concivem vestrum”. Nel resto dell’epistolario innocenziano Lam-berto non è più ricordato. Anche Onorio III si comporterà analogamente, quando darà mandato al suo legato in Sardegna, il cappellano Bartolomeo, di impedire il matrimonio fra Adelasia di Torres e Ubaldo II, figlio di Lamberto Visconti ed Elena di Gallura. Il pontefice chiama Lamberto semplicemente “civis Pisanus”, in opposizione al titolo che assegna a un giudice pienamente riconosciuto dalla Sede Apostolica, quello turritano, che chiama “nobilis vir judex turritanus”:
Cum inter filiam nobili viri Judicis Turritani et filium Lamberti civis Pisani infra etate
36 Ibidem, p. 268.37 Ibidem, p. 270.38 Innocenzo III cit., docc. n. 113, pp. 122-125; n. 115, pp. 125-126; n. 116, pp. 126-128.
[17]
376 CoRRado Zedda
legitima sponsalia facta dicantur in apostolice sede iniuriam et totius Sardinie detrimentum presentium tibi auctoritate mandamus quatenus sub debito fidelitatis et pena excomunica-tionis inhibeat judici memorato ne prefatam filiam suam tradere filio dicti Lamberti presu-mat39.
Questo modo di chiamare Lamberto sarà utilizzato da Onorio in tutto il suo epistolario, a conferma di come la posizione pontificia, rispetto a Lamberto e al giudicato di Gallura, fosse ben chiara e per nulla mutata rispetto agli anni di In-nocenzo III. A riprova di questa interpretazione vi è proprio il modo in cui viene menzionata Elena di Gallura nell’unica volta in cui compare nella documentazio-ne. Ella viene infatti menzionata col semplice titolo di “uxor”, nemmeno di nobile o principessa o ereditiera gallurese, come accadeva nell’epistolario innocenziano prima che il pontefice comminasse la scomunica a Elena e a sua madre, Odolina, per via del tradimento del 1206-120740. E si capisce perché: se Lamberto, quale cittadino pisano poteva ancora essere in qualche modo “utile” e perdonato, previe le sue scuse e il pagamento di un tributo al pontefice41, non altrettanto doveva accadere con le due ereditiere galluresi, poiché, una volta scomunicate, avrebbero perduto automaticamente i diritti sul giudicato gallurese, lasciandone legittima-mente la potestà e il controllo alla Sede Apostolica, che si sarebbe riservata una sua politica particolare riguardo ai destini della Gallura, per questo motivo Elena e Odolina, a quanto ne sappiamo e a differenza di Lamberto, non furono mai per-donate da Innocenzo III.
***
L’ultimo aspetto sul quale desidero soffermare la mia attenzione, prendendo spunto dal volume di Sanna, riguarda il giuramento di Benedetta e di suo marito Barisone al pontefice e la sua stretta connessione con l’arrivo di Ubaldo Visconti a Cagliari. Come accennato poco fa, nel volume su Innocenzo III e la Sardegna Sanna aveva datato al 1215 questo giuramento ma nel volume su Onorio III lo retrodata al 1214.
La nuova proposta di Sanna si basa sul fatto che, poco tempo dopo il giura-mento alla Sede Apostolica, la coppia giudicale fu costretta a prestarne un altro al comune di Pisa, che di fatto negava il precedente. In questa occasione la giu-dicessa prestò il suo giuramento al Consul Pisanorum, che per lo studioso è da
39 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 60, pp. 77-78, 1220 aprile 9.40 Il già menzionato documento pubblicato in M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 58, pp.
74-75, 1220 aprile 9.41 Ma il Visconti sarebbe comunque incorso in una seconda scomunica dieci anni dopo, in seguito
all’invasione del cagliaritano, operata col fratello Ubaldo.
[18]
377la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
intendersi in uno dei quattro consoli che governarono Pisa fino al 21-29 marzo 1215, data dell’avvento di Ubaldo Visconti alla carica di podestà, quindi il giura-mento alla Sede Apostolica risalirebbe al novembre 1214. Tale proposta potrebbe essere corretta, anche mettendo in stretta connessione temporale il giuramento con la concessione, da parte di Innocenzo III, della dispensa matrimoniale alla coppia giudicale, per via di un loro legame entro il quarto grado di parentela. Ma essa pre-senta anche una serie di criticità molto forti, che pongono lo studioso di fronte ad ulteriori riflessioni, per cui, a fianco dell’ipotesi di Sanna, comunque da tenere in attenta considerazione, credo che se ne possano suggerire delle altre, alternative, che presentano lo stesso grado di plausibilità. Cominciamo dal primo giuramento, quello prestato alla Sede Apostolica.
Va osservato, preliminarmente, che nel giuramento è indicato l’Anno Domini, senza che venga specificato quale stile si stia effettivamente utilizzando, se l’Anno Dominice incarnationis e, nel caso, se quello al modo pisano o quello fiorentino, in uso spesso anche presso la curia pontificia. La differenza è dirimente, visto che a seconda dello stile usato ci si può spostare avanti o indietro fra il 1214 e il 1215. Per tali ragioni credo che resti difficile dimostrare che lo stile utilizzato sia effettivamente quello pisano (che riporterebbe al 1214), anche perché abbiamo testimonianza di come nel giudicato cagliaritano del XIII secolo gli stili variasse-ro: l’anno dell’incarnazione pisana di alcune carte volgari cagliaritane si affianca all’anno dell’incarnazione fiorentina per atti stesi da esponenti del clero cagliarita-no o da inviati del pontefice, come sembra essere il caso del giuramento alla Sede Apostolica.
A questi dubbi diplomatistici si accompagnano quelli di natura storica. Essi interessano la sequenza cronologica degli avvenimenti, il ruolo svolto dai perso-naggi principali della vicenda e gli effetti istituzionali e diplomatici su di essa. Il fatto che Benedetta ricordi di aver dovuto prestare il suo giuramento al comune di Pisa nelle mani di un Consul Pisanorum non vuol dire automaticamente che lo prestò a uno dei consoli che amministrarono la città fino al marzo 1215. La cari-ca di console si estendeva infatti a una serie di magistrature pisane testimoniate prima, durante e dopo la podesteria di Ubaldo Visconti, sul cui rapporto coi ceti dirigenti pisani Laura Ticciati osserva che:
Ai consoli del Mare alcuni privilegi (non sappiamo quali) furono assegnati proprio al tempo di una delle podesterie di Ubaldo Visconti, verosimilmente nel 1215; Ubal-do aveva dunque trovato nell’Ordine del Mare una base di consenso al suo potere, e insieme un valido strumento per una condotta agile ed efficace della guerra che imper-versava42.
42 l. tiCCiati, Mare, Mercanti, Lana: gli “Ordines” a Pisa nel Duecento e l’evoluzione degli or-
[19]
378 CoRRado Zedda
Insomma, il console a cui giurarono Benedetta e Barisone sembra essere stato uno dei consoli del Mare, rappresentante di quel mondo influente al quale si era legato Ubaldo per assestare il suo potere a Pisa in quel fatidico anno 1215.
Un precoce giuramento al comune pisano pone poi dei problemi non trascu-rabili riguardo all’atteggiamento e al posizionamento di diversi personaggi, a co-minciare da Pisa e dal suo arcivescovo Lotario, fedelissimo di papa Innocenzo III. Lotario rimase a capo dell’arcidiocesi pisana fino alla morte, avvenuta nei primi mesi dell’anno 1216 a Roma, dove si era recato per partecipare al IV Concilio Lateranense. Una sentenza da lui emanata il 25 luglio 1215 su delega del papa, per una lite tra la chiesa pistoiese di San Marco e il monastero di San Michele in Forcole ce lo mostra, a quella data, fedele esecutore delle volontà pontificie43. È impossibile che Lotario, quale legato pontificio e primate di Sardegna, abbia accettato di far finta di niente su quanto succedeva lungo il fronte sardo pisano in quel periodo e non abbia avvisato Innocenzo del fatto che il “console dei pisani” avesse ottenuto tra il novembre 1214 e il marzo 1215 di annullare il giuramento fatto al pontefice da parte di Benedetta. Evidentemente, agli inizi del 1215 nulla doveva essere ancora mutato.
A ciò si accompagnano i cruciali aspetti cronologici sull’effettivo arrivo del podestà Ubaldo Visconti a Cagliari, che Sanna colloca nel 1215, una datazione che si rivela anch’essa molto problematica da accogliere. La tesi di un arrivo di Ubaldo a Cagliari in quell’anno, durante un intenso periodo di podesteria svolto a Pisa44, non sembra accoglibile per alcuni fondati motivi. Innanzitutto Ubaldo si
dinamenti comunali, in Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione nor-mativa esemplare, Napoli 2001, pp. 267-286, in particolare p. 279, nota 62.
43 l. CHiaPPelli, Maestri e scuole in Pistoia fino al secolo XIV, in «Archivio Storico Italiano», I, 1920, p. 163; k. PenninGton, Lotharius of Cremona, in Miscellanea D. Maffei dicata, a cura di P. wei-MaR - a. GaRCía y GaRCía, vol. I, Goldbach 1995, pp. 236-238.
44 La prima menzione di Ubaldo podestà di Pisa è del 29 marzo 1215 e la sua elezione risale pro-prio a quei giorni compresi fra il 21 e il 29 marzo, probabilmente in coincidenza con il nuovo anno dell’Incarnazione, il 25 marzo. I consoli Bolso del fu Pietro Albizzone (Casapieri), Gherardo ‘Verchio-ne’ del fu Ebriaco (Ebriaci/da Parlascio), Ugo di Sigerio di Pancaldo Visconti, Ranieri del fu Benedet-to di Vernaccio Sismondi, sono attestati fra il 31 maggio 1214 (cfr. P. Santini, Documenti dell’antica costituzione del Comune di Firenze, Firenze 1895 [Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Toscana e dell’Umbria, X], n. XLII, pp. 177-179) e il 21 marzo 1215 (cfr. Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico R. Acq. Roncioni, 1215 marzo 21). I per-sonaggi compaiono a fianco del nuovo podestà Ubaldo Visconti nelle lettere credenziali per il console Ranieri del fu Benedetto di Vernaccio Sismondi inviato come ambasciatore in Egitto: evidentemente si trattava del momento del passaggio dei poteri dai consoli al podestà e, dato il tipo di documento, si pre-ferì inserire ambedue le magistrature. Cfr. M. aMaRi, I diplomi arabi del Regio Archivio di Firenze, 2 voll., Firenze 1863-1867, 1a s., n. 24, pp. 81-82, 2a s., n. 23, p. 284. L’ascesa di Ubaldo Visconti rappre-senta l’inizio del racconto della cronaca edita da e. CRiStiani, Gli avvenimenti pisani del periodo ugo-liniano in una cronaca inedita, in �Bollettino Storico Pisano», XXVI (1957), pp. 49-104, e la seconda notizia dei Fragmenta historiae pisanae pisana dialecto conscripta, in Rerum Italicarum Scriptores, a cura di l. a. MuRatoRi, Milano 1723, vol. XXIV, col. 643: ambedue le attribuiscono una durata trien-nale. Con Ubaldo Visconti comincia anche la lista dei �rectores Pisani Communis» – che termina con
[20]
379la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
trovava a Pisa nel mese di aprile, quando ricevette il giuramento di fedeltà da parte del vescovo di Massa Marittima e dei suoi vassalli, che, fra le altre cose, poneva nelle mani pisane il controllo delle miniere d’argento massesi45. Inoltre, durante l’estate Ubaldo rimase a Pisa dove, il 5 settembre, concesse a Pietro, priore del monastero di San Saturno di Cagliari, una salvaguardia per i terreni del monastero situati nel Monte di Castro46, che era in quel momento oggetto di un processo di incameramento da parte del comune pisano, in seguito agli esiti favorevoli di una causa giudiziaria nei confronti del giudice Guglielmo, testimoniata da alcune let-tere dell’epistolario di Innocenzo III47.
Il documento del 5 settembre 1215 testimonia che, anteriormente a quella data, si era verificato un avvenimento eccezionale per la storia del regno cagliaritano, vale a dire l’inizio del tracciamento di una nuova città: il Castro Novo del Monte di Castro, una porzione di terreno dove, successivamente alla morte del giudice Guglielmo (1214), si erano stanziati i mercanti della Societas Kalaritana, che ave-vano vinto il ricorso giudiziario contro Guglielmo per il possesso dell’area e che ora avevano bisogno dell’aiuto della madrepatria per mantenere quella fondamen-tale posizione (da loro sommariamente protetta da un’embrionale fortificazione), per loro ma soprattutto per il comune. Tale avvenimento segnò l’inizio del terre-moto che si sarebbe scatenato di lì a pochi mesi nel giudicato cagliaritano48.
Il tracciamento della nuova città dovette essere stato deciso dopo la primavera 1215 e prima del settembre dello stesso anno, in connessione con la politica di U-baldo verso Massa Marittima e tenendo conto di un altro avvenimento che potreb-
Stefano Rusticacci podestà del 1273 –, pubblicata da F. bonaini, Memoriale consulum et potestatum Pisanorum, in �Archivio Storico Italiano», VI/2, Firenze 1845, pp. 635-643, verificabile sull’originale, conservato in Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico, R. Acq. Roncioni, n. 159, 1214: la durata è qui di due anni, forse per un errore di trascrizione. Una breve sintesi in M. l. CeCCaRelli – M. RonZani, Il re-clutamento dei podestà a Pisa dall’inizio del XIII alla metà del XIV, in I podestà dell’Italia comunale, a cura di J.-C. MaiRe ViGueuR, Roma 1999, pp. 645-657.
45 Il documento del giuramento del vescovo di Massa Marittima (Populonia, suffraganea della Chie-sa pisana dal 1138) è stato pubblicato da G. VolPe, Per la storia delle giurisdizioni vescovili e dei rapporti fra stato e chiesa nelle città italiane dei secoli XII e XIII. Vescovi e comune di Massa Marittima, in «Studi storici», 19 (1910), pp. 261-327 (edizione di documenti), il documento è alle pp. 271-275.
46 ADMar., Fondo Saint-Victor, 1 H 102, n° 496, 1215 settembre 5, Pisa, che qui si ripubblica, e-mendato, nell’Appendice Documentaria.
47 Innocenzo III cit., doc. 77, 1206 marzo 14, pp. 91-92; doc. 125, 1210, dicembre 22, pp. 135-138 e doc. 137, 1213, novembre 26, pp. 145-146.
48 Cfr. C. Zedda – R. Pinna, Fra Santa Igia e il Castro Novo Montis de Castro cit. Lo studio del tracciamento del Castro Novo è oggetto di un lavoro che stiamo intraprendendo con Raimondo Pinna e Marco Cadinu, ricercatore di Storia dell’Architettura presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari. Sul tema si rimanda a M. Cadinu, Urbanistica medievale in Sardegna, Ro-ma 2001, pp. 65-74 e tavv. 17-23, pp. 105-111. Una prima elaborazione di questo studio sarà pubblicata in C. Zedda, Cagliari. La mer et le commerce, XIe-XIIIe siècle, in Les villes portuaires en Méditerranée occidentale au Moyen Âge, Paysages urbains, activités économiques, transferts culturels, Workshop international, Corte 13-14 juin 2013, in pubblicazione per il 2014.
[21]
380 CoRRado Zedda
be essere stringente: il battesimo della figlia primogenita della coppia giudicale da parte di Lamberto Visconti, giudice di Gallura “in pectore” e fratello di Ubaldo49. Tale battesimo dovette avvenire in tempi molto vicini alla nascita della bambina; se ipotizziamo che il parto fosse avvenuto circa nove o dieci mesi dopo il matrimonio fra Benedetta e Barisone, arriveremmo all’aprile 1215. È difficile pensare che, a neanche un mese dalla sua elezione a podestà, Ubaldo potesse immediatamente attuare una decisione di tale importanza come l’avvio della costruzione del Castro cagliaritano, prima ancora di assicurarsi la sottomissione di Massa Marittima, che prevedeva, fra i primi punti da giurare, l’impegno da parte dei massesi a partecipare a tutte le guerre intraprese dal podestà fuori e dentro il distretto pisano. Sul fronte cagliaritano, invece, è altrettanto difficile pensare che Benedetta potesse invitare Lamberto a battezzare la figlia appena nata mentre davanti alle finestre del palazzo giudicale vedeva gli operai pisani sul Monte di Castro erigere palizzate e tracciare gli assetti stradali della nuova città. È più probabile che Lamberto, giunto in Sardegna per il battesimo, sicuramente con grande accompagnamento di pisani, abbia per così dire visionato il sito del Monte di Castro e verificato il modo migliore per una sua prossima trasformazione in rocca fortificata, così da mettere in sicurezza i pisani ivi insediati. Al suo ritorno a Pisa, Lamberto avrebbe concordato col fratello il tracciamento della nuova città, attraverso quella che sarebbe stata una vera e propria azione a sorpresa.
E difatti, poco tempo dopo, all’inizio dell’estate 1215, i lavori preliminari di misu-razione del perimetro del Castro Nuovo e di delimitazione dei suoi confini dovevano essere iniziati, cosicché le operazioni portate avanti dai tecnici pisani, supportati dagli homines della Societas Kalaritana insediati sul colle, dovevano essere ormai evidenti a tutti. Questa era la situazione che si presentava al momento della redazione del documento del settembre 1215 e di questo si era fondamentalmente preoccupato il prio re di San Saturno: la salvaguardia concessa da Ubaldo a Pietro precisava infatti che qualora vi fossero state rivendicazioni future, il comune di Pisa avrebbe tenuto conto dei diritti di San Saturno nell’area del Monte di Castro, senza per questo pre-giudicare quelli spettanti ai pisani per via della sentenza di possesso dell’area. Se nel 1215 il priore non sta attuando un ricorso, ma sta anzi ottenendo una salvaguardia dal podestà di Pisa, significa che il comune non ha ancora occupato quella porzione di monte, pertinenza del priorato e facente perno sull’area dell’odierna cattedrale, ma aveva il controllo di un’area più limitata, lasciando pensare a un’occupazione in più fasi del Monte di Castro. E Ubaldo avrebbe utilizzato l’arma giuridica (la sentenza in favore della Societas) per appropriarsi di fatto e poi di diritto di tutto il Monte di Castro, allargandosi però anche in aree al di fuori dei limiti giudicati di pertinenza pisana, dove vantavano la loro giurisdizione la giudicessa cagliaritana, il monastero
49 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., doc. 58, pp. 74-75. Vi è da domandarsi perché Benedetta avesse chiesto proprio a Lamberto di fare da padrino. Per sigillare una speranza di pace fra le loro fa-miglie, legate ma nemiche? O vi fu in qualche modo costretta?
[22]
381la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
di San Saturno e il capitolo di Santa Maria di Cluso, come ribadirà una sentenza del legato pontificio Goffredo dei Prefetti emessa fra il 1226 e il 1227, la quale attesta una parcellizzazione del Monte di Castro fra l’autorità giudicale e i due enti ecclesiastici50.
Credo che i ricorsi intentati dal priore di San Saturno (e implicitamente dell’ab-bazia di San Vittore) effettuati nel 1218 e nel 122651 non vadano dissociati dal grave vulnus inferto da Ubaldo allo scacchiere internazionale, per il fatto che il po-destà aveva platealmente infranto i patti del 1215 e lo stesso trattato con Marsiglia redatto dal comune pisano nel 120952: l’azione militare di Pisa in Sardegna toccava direttamente gli interessi marsigliesi e la cosa non rimase senza conseguenze. In questo contesto non va dimenticata l’importanza dei rapporti fra i priorati “itali-ci” di Genova, Pisa, Cagliari e Guzule nelle successive scelte politiche e militari che interessavano i rapporti fra Genova e Pisa sul Tirreno; non a caso nello stes-so periodo di emanazione della sentenza del legato Rolando (1218), il pontefice richiamava Genova e Milano in aiuto del giudice di Torres per la guerra che si sarebbe dovuta combattere contro i pisani in Sardegna53, guerra che si sarebbe poi risolta in una nuova sconfitta per le forze anti pisane, come testimonia il trattato
50 ADMar., Fondo Saint-Victor, 1 – H 122 – n° 600, 1246 luglio 4, pubblicata in C. Zedda – R. Pinna, Fra Santa Igia e il Castro Novo Montis de Castro cit., doc. 5, pp. 181-183 e che qui si ripubbli-ca nell’Appendice Documentaria. Si tratta di una bolla di Innocenzo IV inviata al priore e al monastero di San Saturno e all’arcipresbitero e al capitolo di Santa Maria di Cluso con cui si ribadisce la validi-tà della sentenza emanata fra il 1226 e il 1227 dal legato pontificio Goffredo dei Prefetti, sulla causa sorta negli anni precedenti fra il priore di San Saturno, il capitolo di Santa Maria di Cluso e la giudi-cessa Benedetta da una parte e il castellano e gli uomini di Castel di Castro dall’altra circa il posses-so del territorio del Monte di Castro. La sentenza conferma che tale territorio era proprietà in comune del demanio giudicale, del capitolo di Santa Maria di Cluso e del priorato di San Saturno; i due enti ecclesiastici avevano fatto ricorso alla Sede Apostolica, anche approfittando delle difficoltà pisane in Sardegna in quel momento, proprio perché i termini della salvaguardia di Ubaldo del 1215 erano stati infranti dallo stesso podestà negli anni successivi. La sentenza potrebbe essere stata emanata nel 1227 se teniamo conto che nel dicembre 1226, dopo la conclusione del sinodo di Santa Giusta, presieduto proprio dal legato Goffredo, il priore di San Saturno aveva nominato Raimondo Fabrica, camerario del priorato, quale procuratore generale per difendere gli interessi di San Saturno e di rappresentarlo in giudizio contro i suoi avversari, si veda per questo ADMar., 1. H. 110, 539, 1226 dicembre 12, Cagliari (cfr. la trascrizione di M. R. Rubiu, La Sardegna e l’Abbazia di Saint-Victor cit., doc. 28, pp. 199-201).
51 L’emissione della sentenza del legato non presupponeva la sua applicazione: di fatto essa veni-va consegnata all’autorità politica ufficiale del territorio, in questo caso il giudice, che avrebbe dovuto farla concretamente eseguire. Si comprende dunque, come in un giudicato cagliaritano militarizzato e con i suoi sovrani sotto stretto controllo da parte pisana, l’attuazione pratica di una sentenza pontificia avesse ben scarse possibilità di diventare effettiva, nel 1218 come negli altri casi del 1226-1227 e del 1246. In quest’ultimo caso mancherà addirittura il soggetto politico riconosciuto a cui indirizzarla, da-to che in quel periodo non esisteva più un giudice a Cagliari e il comune di Pisa non avrebbe mai dato esso stesso attuazione a un provvedimento preso contro i suoi interessi. Su tutti questi interessantissimi aspetti cfr. M. Conetti, L’esecuzione della sentenza dei delegati e dei legati nella scienza canonisti-ca del XIII secolo, in M. P. albeRZoni - C. Zey (a cura di), Legati e delegati papali cit., pp. 339-359.
52 Cfr. e. SalVatoRi, Boni amici et vicini. Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridiona-le dall’XI alla fine del XIII secolo, Pisa 2002, docc. 13, pp. 208-212; 14, pp. 212-215; 15, pp. 215-219.
53 M. G. Sanna, Papato e Sardegna cit., docc. 45-46, pp. 65-66 (1218 novembre 10).
[23]
382 CoRRado Zedda
di Noracalbo, del 1219. Insomma, un quadro generale davvero molto complesso, che andava ben oltre i pur cruciali aspetti regionali che interessavano il giudicato di Cagliari e l’intera isola di Sardegna.
In seguito a tali avvenimenti, i giudici cagliaritani adottarono una strategia di difesa che passava per il giuramento alla Sede Apostolica (appunto nel novembre 1215) e il rinnovato accordo con l’arcivescovo cagliaritano Ricco (gennaio 1216), azioni evidentemente consequenziali l’una all’altra in un ristretto arco temporale.
Il giuramento alla Sede Apostolica, fino a quel momento dilazionato, è la di-mostrazione che i giudici cercarono di giocare fino in fondo l’unica carta rimasta a loro disposizione: porsi totalmente sotto la protezione pontificia. E lo fecero attra-verso una cerimonia solenne, alla quale furono presenti tutte le massime autorità del giudicato e il cui destinatario subliminale era il comune di Pisa. Fra i personag-gi presenti al giuramento si segnalano infatti i rappresentanti del comune pisano: Bandino e Ildebrandino Visconti. Nel documento di giuramento non viene data di questi due personaggi una qualsiasi indicazione sul loro ruolo istituzionale ma i due potrebbero essere i Capitanei portuum Sardinee, garanti degli interessi del comune a Cagliari e nell’isola. È vero che, oltre a risiedere in Sardegna, questi ufficiali se-devano accanto ai consoli del mare nella Curia pisana, ma tale ipotesi sembrerebbe abbastanza plausibile, se possiamo identificare in loro i personaggi qui Pisano no-mine censentur in Sardegna menzionati nella salvaguardia del 1215.
Il giuramento dei giudici alla Sede Apostolica, con tutto il suo carico di peri-colosità per Pisa, provocò la messa in moto dell’apparato politico e militare del comune. La sequenza degli avvenimenti lascia intendere che, entro un brevissimo arco temporale, dopo il novembre 1215, un console dei pisani (il console del mare di cui si è detto poc’anzi), appositamente incaricato da Ubaldo, si sia recato a Cagliari con lo scopo di ottenere da Benedetta e Barisone il giuramento di fedeltà al comune di Pisa proprio per ordine del podestà, il quale aveva necessità di una situazione di totale e non più rivendicabile legittimità giuridica per realizzare com-piutamente e pienamente l’impianto della città, che peraltro aveva ormai anche il suo nome: Castro Novo Montis de Castro.
Il console dovette avere due compiti: far giurare la giudicessa al comune di Pisa e garantire la realizzazione del castro che si doveva ormai iniziare a costruire: i molti seguaci al seguito del console servivano esattamente a questo: a garantire il cantiere da qualsiasi iniziativa giudicale contraria, non per nulla la frase di Bene-detta, relativa alla successione fra il suo giuramento a Pisa, la concessione del col-le e la costruzione del castro è: “in quo postea”, cioè che prima della sua effettiva erezione passò un certo lasso di tempo, utilizzato evidentemente dai tecnici pisani per studiare il modo migliore per il suo impianto54. D’altronde, una nuova città e
54 Va chiarito che Benedetta non mente davanti al pontefice, quando gli dice che il castrum venne
[24]
383la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
delle dimensioni di quella creata a Cagliari, non si costruiva certo di getto e senza avere dietro un ponderato progetto urbanistico.
Va detto che anche Mauro Ronzani ritiene che il console pisano ricordato dalla giudicessa Benedetta nella sua lettera a Onorio III del 1217, sia uno dei due con-soli del mare presenti nel documento di sottomissione del vescovo e della città di Massa Marittima a Pisa, del 22 aprile 121555 e, a proposito dei Consules Maris, rileva che:
è interessante osservare che il Breve Communis del 1286 [ma ormai datato con certezza al 1287] tramanda il ricordo di un certo “privilegium” accordato ad essi appunto “ab Ubaldo olim Pisanorum potestate”. Se, come è probabile, tale concessione avvenne durante la prima delle tre esperienze di governo podestarile del Visconti, essa illumi-nerebbe di nuova luce un passo, sin qui d’interpretazione incerta, della famosa lettera indirizzata nel corso del 1217 da Benedetta di Cagliari al successore di Innocenzo III (Onorio III Savelli)56.
Dopo il giuramento della coppia giudicale a Pisa, gli avvenimenti andarono sempre più a seguire un percorso quasi obbligato, mentre la reazione da Roma non si fece attendere. In quel momento, tra l’altro, l’arcivescovo pisano Lotario si trova-va nell’Urbe, dove di lì a poco sarebbe morto e la sua assenza da Pisa potrebbe aver convinto il partito visconteo ad accelerare le sue azioni in Sardegna. Ma durante il IV Concilio Lateranense dovette giungere la notizia, a Lotario e quindi a Inno-cenzo, della rottura del giuramento da parte dei giudici cagliaritani. A quel punto il pontefice scrisse immediatamente al podestà di Pisa una lettera in cui ribadiva che la Sardegna apparteneva alla Sede Apostolica57. In tale contesto, la notizia giun-ta a Pisa dell’accordo fra la coppia giudicale e l’arcivescovo cagliaritano Ricco,
costruito dopo la sua concessione del colle: tecnicamente la fortificazione e la trasformazione del pre-cedente insediamento vennero dopo la concessione estortale.
55 Cfr. M. RonZani, Pisa nell’età di Federico II, in Politica e cultura nell’età di Federico II, a cura di S. GenSini, Pisa 1986, pp. 135-136: con riferimento al giuramento del vescovo di Massa Marittima, fra i testimoni compaiono �numerosi altri personaggi attestati prima e dopo nelle più alte magistratu-�numerosi altri personaggi attestati prima e dopo nelle più alte magistratu-numerosi altri personaggi attestati prima e dopo nelle più alte magistratu-re cittadine o comunque destinati ad occupare posizioni di rilievo nelle vicende politiche, e infine due consoli del mare. Se si fa eccezione per i Gherardesca, assenti in questi anni dalla scena pubblica pisa-na, gran parte del collaudato gruppo dirigente degli ultimi decenni sembra dunque aver assecondato la prima ed importante mossa del nuovo podestà».
56 M. RonZani, Pisa cit., p. 136. Ringrazio Mauro Ronzani per aver discusso recentemente con me su questa ipotesi, ribadendo la forte plausibilità dell’identificazione del “Consul Pisanorum” con uno dei Consoli del Mare. Tale magistratura, proprio agli inizi del XIII secolo, risulta stipendiata dal pode-stà, dal rettore o dai consoli del comune, dato che risulta estremamente interessante, cfr. R. tReViSan, Per la storia dell’Ordo Maris di Pisa intorno alla metà del Duecento: il Registro «Comune A 46», in Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo, 1, A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, presentazione di G. RoSSetti, Pisa, 1991, pp. 325-366, in particolare p. 330.
57 Innocenzo III cit., doc. 147, p. 152.
[25]
384 CoRRado Zedda
del gennaio 1216, potrebbe aver provocato un’accelerazione degli avvenimenti, in quanto presupponeva il tentativo di Benedetta e Barisone di sganciarsi dal comune: a quel punto Ubaldo dovette capire che non si poteva più perdere tempo ed era or-mai necessario intervenire con il suo stesso arrivo nel giudicato cagliaritano.
Ubaldo e la sua consorteria andavano perseguendo una strategia politica di respiro internazionale, inaugurata col giuramento del vescovo di Massa Marit-tima al comune; di tale strategia, certamente pianificata per tempo, la Sardegna era solo un tassello, anche se importante. Ubaldo, infatti, anche per contrastare il forte espansionismo di Firenze, intendeva collocare Pisa quale attore principale all’interno del corridoio tirrenico in cui la città aveva da tempo i suoi interessi e sul quale rivendicava precise ragioni giuridiche in virtù delle concessioni impe-riali rilasciatele nei decenni precedenti e per Pisa, in quegli anni, l’Auctoritas di riferimento era l’Impero di Federico II e non più la Sede Apostolica58.
Il progetto di Ubaldo per la Sardegna era da attuarsi senza ulteriori remore perché era la situazione mediterranea che lo richiedeva. Si tengano presenti, per lo stesso periodo, il riaccostamento di Venezia a Pisa nel 1214, con un trattato di alleanza59 e un accordo analogo con Gaeta60, che testimoniano la direttrice di ampio respiro mediterraneo che deve essere riconosciuta al Visconti61. Ma da tale complesso progetto Ubaldo e Pisa avrebbero tratto il loro profitto solo dopo la morte di Innocenzo III, come si deduce dal confronto fra l’epistolario di Innocenzo e quello di Onorio. Anzi, tutto lascia pensare che Ubaldo dovette attendere proprio la morte di Innocenzo prima di dare il via alla vera e propria invasione militare del giudicato cagliaritano e alla trasformazione del Castro Novo Montis de Castro in una vera e propria città fortificata. E proprio a partire dal pontificato di Onorio e non prima, che inizia la fitta serie di documenti pontifici relativi alla situazione del giudicato cagliaritano in seguito all’invasione pisana.
58 Per una primo approccio a questo tema cfr. d. abulaFia, Le due Italie. Relazioni economiche fra il regno normanno di Sicilia e i comuni settentrionali, Napoli 1991, pp. 184-185; cfr. inoltre O. banti, Alcune considerazioni a proposito del privilegio federiciano del 6 aprile 1162 a favore di Pisa, in Un “filo rosso”. Studi in onore di Gabriella Rossetti, a cura di G. GaRZella ed e. SalVatoRi, Pisa 2007, pp. 321-336.
59 Gli atti originali della cancelleria veneziana (1090-1227), a cura di M. PoZZa, Venezia 1994-1996, II, n. 12.b.
60 l. a. MuRatoRi, Antiquitates Italicae Medii Aevii sive Dissertationes, Tomus Quartus, Mila-no 1741, coll. 413-416.
61 Che può essere individuata anche in un documento relativo al suo terzo mandato podestarile, nel 1228, quando l’imperatrice reggente di Bisanzio, Maria, ringrazia il podestà Ubaldo del suo aiuto prestatogli attraverso un membro della famiglia Visconti, che esercitava l’ufficio di console dei mer-canti a Costantinopoli, cfr. H. MoRanVille, Une régente inconnue de l’Empire de Constantinople, in �Bibliothèque de l’École des chartes», Année 1887, Volume 48, Numéro 1, pp. 727-728 e la trascrizio-Bibliothèque de l’École des chartes», Année 1887, Volume 48, Numéro 1, pp. 727-728 e la trascrizio-», Année 1887, Volume 48, Numéro 1, pp. 727-728 e la trascrizio-, Année 1887, Volume 48, Numéro 1, pp. 727-728 e la trascrizio-ne del documento, con riproduzione, a opera di C. Riant, Une lettre de l’Impèratrice Marie de Con-stantinople, in «Archives de l’Orient Latin», Tome II, Paris 1884, 2, Lettres, pp. 256-257 (attribuito dall’autore al 1213 ma riportato correttamente da Moranville al 1228).
[26]
385la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
La notizia dell’intenzione dei pisani di costruire, già verso il 1218, una chiesa all’interno del Castro (Santa Maria di Castello?)62 lascia intendere che a quella data il progetto di trasformazione urbanistica del Monte di Castro e della sua for-tificazione iniziale era già a un punto molto avanzato63.
Il fatto che a portare avanti l’azione giuridica contro la decisione pisana sia stato espressamente il priorato di San Saturno fa pensare che esso avesse dei forti interessi anche sulla parte alta del Monte di Castro e non solamente sulle falde, che si affacciavano sull’antico monastero cagliaritano. Queste pertinenze sembrano elencate nella carta marsigliese in sardo e caratteri greci, con la quale il giudice Costantino Salusio disponeva la dotazione dei beni per la basilica di San Saturno, che di lì a poco sarebbe diventata la sede del priorato vittorino nel giudicato di Cagliari64. Nel testo vengono donate, fra gli altri beni, delle “ariolas ki suntu supra donnicalia de Cluso” e dal momento che tutto porta a pensare che l’area di Cluso si trovasse alle falde del Monte di Castro65, dobbiamo ritenere che l’area donata ai Vittorini, indicata come “sopra” la donnicalia di Cluso, non potrà che essere la parte orientale dello stesso monte. Da qui si spiega la liceità, per il priorato di San Saturno di presentare il suo ricorso davanti alla Sede Apostolica, dal momento che i pisani avevano invaso e occupato qualcosa di loro proprietà, cacciandone proba-bilmente i massai e i servi che vi lavoravano66.
62 Cfr. la già menzionata lettera di Onorio III, finora inedita (ADMar., 1. H. 631, f. XXXIIIv), che qui si pubblica nell’Appendice Documentaria. La costruzione di una chiesa all’interno del Monte di Castro avrebbe significato far acquisire un’autonomia ecclesiastica al Castro Novo, sottraendolo alla giurisdizione dell’arcivescovo attraverso la creazione di una propria chiesa battesimale. Una tale azio-ne non avrebbe mai potuto essere accettata dalla Sede Apostolica, perché avrebbe dovuto comportare il riconoscere una situazione di fatto ormai ineludibile: la nascita di una nuova città e la perdita di Ca-gliari per la giurisdizione pontificia.
63 La prima menzione di una Sancte Marie de Castello è del 1254 e si trova in I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/6, a cura di M. bibolini, introduzione di e. PallaViCino, Roma 2000 (Fonti, XXXII), doc. 1.059, pp. 225-227 (1254 settembre 23, Cagliari).
64 ADMar., Fondo Saint-Victor, 1. H. 88, 427. Cfr. la trascrizione data da e. blaSCo FeRReR, Cre-stomazia sarda dei primi secoli. Testi di grammatica storica, glossario, Carte, documenti 2 voll., in �Offi cina Linguistica», Anno IV, Nuoro 2003, IV, pp. 51-52). Personalmente sono del parere che i do-Officina Linguistica», Anno IV, Nuoro 2003, IV, pp. 51-52). Personalmente sono del parere che i do-», Anno IV, Nuoro 2003, IV, pp. 51-52). Personalmente sono del parere che i do-, Anno IV, Nuoro 2003, IV, pp. 51-52). Personalmente sono del parere che i do-cumenti utili per la ricostruzione della storia giudicale cagliaritana dei secoli XI-XIII ci siano tutti o quasi e che il problema vero non stia tanto nel lamentare la mancanza di documentazione dispersa o distrutta da un destino avverso alla storia sarda, quanto nell’interpretare correttamente quanto abbiamo a disposizione. Per dirla con Marc Bloch, “Un documento è come un testimone: non parla che quando lo si interroghi. E la difficoltà consiste nello stabilire il questionario” (M. bloCH, Lavoro e tecnica nel Medioevo, Roma-Bari 1970 [terza edizione, 2001], p. 35).
65 Finora si era supposto che l’area di Cluso fosse ubicata dietro lo stagno di Santa Gilla, andando verso Elmas, applicando un semplice sillogismo: Siccome Santa Maria di Cluso si trovava dentro San-ta Igia e Santa Igia sarebbe stata edificata fra gli stagni e i canneti di Santa Gilla, allora l’area di Cluso si doveva trovare per forza oltre questi confini.
66 Alcuni di questi potrebbero essere i discendenti di quei servi e altri uomini presenti nell’area di Cluso e donati dal giudice Costantino a San Saturno insieme agli altri beni elencati nella carta in ca-ratteri greci.
[27]
386 CoRRado Zedda
Dai dati che stanno emergendo si ha l’impressione che il Monte di Castro sia stato, fino alla riqualificazione pisana, una grande area suburbana dedicata allo sfruttamento agricolo e zootecnico, abitata da addetti ai lavori dei campi e all’in-terno della quale potettero persistere degli insediamenti di carattere rurale67. Tutto ciò appare in linea con la tipologia di sfruttamento del territorio usuale per gli enti monastici ed ecclesiastici del tempo (come il priorato di San Saturno e Santa Maria di Cluso) e con quanto ci rivelano le fonti, in particolare riguardo a tutto il patrimonio di cose e persone, dislocate sul Monte di Castro e alle sue falde, per il quale il priore Pietro aveva chiesto la salvaguardia nel 1215 al podestà Ubaldo (“domos et servos et ancillas et bestias et res et bona et possessiones”).
In conclusione, la storia della Sardegna giudicale fra XII e XIII secolo presenta un dinamismo e una complessità molto più accentuati di quanto finora è stato rico-struito. Il cammino verso una sua soddisfacente interpretazione complessiva appa-re ancora lungo e difficoltoso ma anche i contributi come quello di Mauro Sanna costituiscono un prezioso strumento di lavoro sulle fonti, finalmente pubblicate in modo sistematico, e di riflessione, laddove si riprenderanno in esame quelle zone d’ombra presenti nell’analisi interpretativa dello studioso.
SOMMARIO
Dopo la pregevole edizione delle lettere relative ai rapporti fra papa Innocenzo III e la Sardegna (1198-1216), Sanna propone con questa pubblicazione in versione digitale e a stampa on demand, un altro strumento atteso da decenni da tutti gli stu-diosi interessati ad approfondire la natura dei rapporti fra la Sardegna giudicale e la Sede Apostolica durante il XIII secolo.L’opera si presenta interessante e portatrice di nuove e sostanziali acquisizioni sul tema oggetto di trattazione, pur se si devono evidenziare alcune riserve sull’inter-pretazione generale del contesto storico.In questo articolo si esaminano criticamente alcuni dei punti chiave dell’opera del-lo studioso, in particolare si tengono presenti tre nodi chiave per operare una seria riflessione storiografica di cosa fu la realtà giudicale sarda nei secoli XI-XIV, nel suo nascere, nel suo svilupparsi e nel suo spegnersi alle soglie dell’Età Moderna:1) Individuare la natura del potere dei giudici sardi.2) Riconoscere il reale legame fra giudicati e Sede Apostolica romana.3) Comprendere appieno il contesto storico, politico e geografico in cui si collocano i
giudicati e il loro rapporto con le altre entità territoriali con le quali furono in contatto.
67 A questo punto potrà essere approfondita l’interessante ipotesi di Marco Cadinu sulla perma-nenza nel tessuto urbano del castro pisano, di “una consistente quantità di murature preesistenti e non conformi alle regole di orientamento della nuova fondazione” (cfr. M. Cadinu, Urbanistica medieva-le cit., pp. 66-67).
[28]
387la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
Quello che emerge dal riesame dell’opera di Sanna e dal suo confronto con la sto-riografia più recente è che la storia della Sardegna giudicale fra XII e XIII seco-lo presenta un dinamismo e una complessità molto più accentuati di quanto finora è stato ricostruito. Il cammino verso una sua soddisfacente interpretazione com-plessiva appare ancora lungo e difficoltoso ma anche i contributi come quello di Mauro Sanna costituiscono un prezioso strumento di lavoro sulle fonti, finalmente pubblicate in modo sistematico, e di riflessione, laddove si riprenderanno in esame quelle zone d’ombra presenti nell’analisi interpretativa dello studioso.
Corrado Zedda68
ABSTRACT69
After the valuable printing of letters referring to relations between Pope Innocence 3rd and Sardinia (1198-1216), Sanna suggests, with the present work, worked out in digital format and to be printed on demand, one more different tool - expected and expected by decades - by all of those scholars interested in deepening how re-lations between Judge administration Sardinia and the Apostolic Site in the 13th century really were. The work is interesting and bears new substantial acquisitions regarding the topic we are investigating, even though must be underlined some doubts about the over-all interpretation of the historic context involved.In the present article will be investigated some critical points inside the work of our scholar, in particular, has to be highlighted 3 key points in order to carry out an historical review of what - in fact - Judge ruled Sardinia had been in 11th and 14th centuries, from its birth, passing through its development until its extinguishing at the beginning of the Modern Age that is:1) to find out, in fact, the Judge Power in Sardinia was; 2) recognizing the real connections existing between Judge Administration and the
Roman Apostolic Site;3) understanding in the whole the historical, political, and geographical context
where can be placed Judge administrations and their relations with some differ-ent territorial governments with which they came into contact.
After reviewing Sanna work and having compared to the latest available histori-ography, it can be said that the history of Sardinia ruled by Judge Administration
68 Corrado Zedda: laurea in Lettere con dottorato di ricerca in Storia medioevale, docente di ruo-lo in Lettere nelle Scuole statali, dottorando alla Università Pasquale Paoli di Corsica (Corte). E-mail: [email protected].
69 Traduzione di Antonello Pizzoni, laureato in Tedesco e Inglese presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Cagliari (e-mail: [email protected]); supervisione di Mary Groeneweg, già lettri-ce d’Inglese presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Cagliari (e-mail: [email protected]).
[29]
388 CoRRado Zedda
between 12th and 13th century is very much dinamic and far more complex than what have been restored until now. The path to its satisfying understanding seems to be a rather long and difficult task , but works as those of Mauro Sanna are a valuable tool for working on sources, being finally published and ordered siste-matically, and of reviewing as well, and some shadow areas arosen when scholars investigated he above mentioned sources, will be reviewed once more.
[30]
389la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
APPENDICE DOCUMENTARIA70
1Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille, Fondo
Saint-Victor, 1 H 102, n° 496, 1215 settembre 5, Pisa71.Ubaldo Visconti, podestà di Pisa, concede a Pietro, priore del monastero di
San Saturno di Cagliari, piena assicurazione per i beni del priorato nel giudicato di Cagliari e in particolare per quelli che concernono il Monte di Castro.
In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti Amen. Cum pia loca vereri eorumque redditos, ita ut possessiones et rationes manutenere merito debeamus, ideo nos Hubaldus vicecomes Dei gratia pisanorum potestas, habito consilio senatorum per sonum campane coadunatorum, sequentes formam ipsius consilii pro nobis et pro civitate pisana et pro fidelibus nostris, tibi donno Petro, priori et rectori monasterii Sancti Saturnii de judicatu kallaretano, pro te tuisque successoribus constitutis in monasterio presenti, plenam securitatem et fidantiam damus et concedimus et te et ministros monasterii predicti et conversos et fratres et domos et servos et ancillas et bestias et res et bona et possessiones et iura ipsius monasterii fidamus et asse-curamus, ita quod decetero predicte res salve sint et secura terra et mari et ubique a pisanis omnibus et ab his qui pisano nomine censentur, precipientes et firmiter iniungentes omnibus partibus et qui pisano nomine censentur ut te prefatum prio-rem et rectorem monasterii predicti tuosque successores et ministros et conversos et monachos et servos et ancillas facti monasterii et bestias et res et bona et pos-sessiones et iura ipsius monasterii terra et mari et ubique solvent et solvendum est defendere et in nullo offendere vel dampnificare presumant, non preiudican-do nobis nec comuni pisano per hanc securitatem sive fidantiam nec hominibus in Castro Novo Montis de Castro cum suis pertinentiis aliquid dicto monasterio competit. Et taliter scribere rogavimus Guiscardum judicem et notarium domini Henrici imperatoris.
Actum Pisis in choro monasterii et ecclesie Sancti Michaelis de Burgo presen-
70 Desidero qui ringraziare vivamente il personale delle Archives Départementales des Bouches-du-Rhône di Marsiglia e in particolare la dottoressa Véronique Raguseo per la gentilezza e l’assistenza prestatemi durante il mio lavoro in archivio.
71 Il documento è stato da me già pubblicato in C. Zedda – R. Pinna, Fra Santa Igia e il Castro No-vo Montis de Castro cit., doc. n. 2, pp. 163-166. Tuttavia, il fatto di avere lavorato per la prima edizione solamente su una riproduzione fotografica, ne ha impedito una trascrizione corretta, per via di macchie e scoloriture e di particolari visibili solamente dall’originale e con l’ausilio della lampada di Wood. A ciò si sono accompagnati anche alcuni refusi nella redazione finale del testo, per cui quella che si pro-pone in questa sede, è una trascrizione, effettuata durante una recente missione di studio a Marsiglia, sicuramente più attendibile della precedente.
[31]
tibus donno Guillelmo abbate facti monasterii et ecclesie Sancti Michaelis et Cal-cisano de Mercato et Bulliafave quondam Bernardi Bulliafave et Feliciano notario filii Jacobi testibus ad hec rogatis. Dominice vero incarnationis anno Millesimo Ducentesimo Sestodecimo indictione tertia nonas septembris.
Ego Guiscardus quondam Bernardinus de Silvalonga domini Henrici romano-rum imperatoris judex ordinarius et notarius prefatis interfui et hanc inde cartam scripsi atque firmavi.
Verso: Pisani dant securitatem priori Sancti Saturni Calaritane diocesi in SardiniaCarta de Sardinia
2Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille, Fondo
Saint-Victor, 1 – H 631, f. XXXIIv., 1220 febbraio 2072.Papa Onorio III conferma la sentenza emanata dal legato pontificio Rolando
contro i pisani che pretendevano di edificare una chiesa all’interno del Castello del Monte di Castro, in danno e pregiudizio del priorato di San Saturno.
Honorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis priori et conventui Sancti Saturni Caralitane diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et vota que a ra-tium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et vota que a ra-ium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et vota que a ra-tionis tramite non discordant effectu prosequente complere. Ea propter dilecti in Dominum filii nostris, iustis precibus inclinati, diffinitivam sententiam quam di-lectus filius Rolandus cappellanus noster tunc Apostolice Sedis legatus pro nobis contra Pisanos super eo quod in Castro ab eis erecto tenere in Sardinia ecclesiam edificare volebant exigente iustitia promulgavit sicut et iusta auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infrin-gere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit mensuram.
Datum Viterbii XII kalendas marcii pontificatus nostri anno quarto.
72 Per un confronto si veda la trascrizione proposta da M. R. Rubiu, La Sardegna e l’Abbazia di Saint-Victor cit., doc. 26, p. 196. Il legato pontificio Rolando risulta attestato, come ben rileva Sanna, fra il 17 marzo 1218 e il 10 luglio 1219. La sentenza confermata da Onorio III nel presente documento potrebbe risalire all’agosto 1218, quando Rolando si sta occupando di altre questioni simili, inerenti le alienazioni di beni giudicali.
[32]
391la SaRdeGna GiudiCale e la Sede aPoStoliCa nel MedioeVo
3Archives Départementales des Bouches-du-Rhône de Marseille, Fondo
Saint-Victor, 1 – H 122 – n° 600, 1246 luglio 473.Papa Innocenzo IV conferma al priore e al convento di San Saturno e all’arci-
presbitero e al capitolo di Santa Maria di Cluso la validità della sentenza emanata dal legato pontificio Goffredo de Prefetti sulla causa sorta negli anni precedenti fra il priore di San Saturno, il capitolo di Santa Maria di Cluso e la giudicessa Benedetta da una parte e il castellano e gli uomini di Castel di Castro dall’altra circa il possesso del territorio del Monte di Castro. La sentenza conferma che tale territorio è proprietà in comune del demanio giudicale, del capitolo di Santa Maria di Cluso e del convento di San Saturno.
Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis priori et conven-tui Sancti Saturni et archipresbitero ac capitulo ecclesie Sancte Marie de Cluso Calaritane diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Solet annuere Sedes Apostolica piis votis et honestis petentium precibus favorem benivolum impertiri. Cum igitur sicut nobis exponere curavistis inter vos ex una parte et clare memorie donnicellam Benedictam judicissam Calaritanam ac castellanum et homines Ca-stelli de Castro Calaritane diocesi ex altera super territorio ipsius Castelli ad vos communiter pertinenti et rebus aliis coram dilecto filio Goffredo de Prefectis be-thelemitano electo tunc subdiacono et capellano nostro in illis partibus Apostolice Sedis legato questio verteretur idem electionis cognitis cause meritis iuris ordine observato diffinitivam pro nobis sententiam promulgavit prout in istrumento su-per hoc confecto plenius continetur. Quare nobis humiliter supplicastis ut eandem confirmationem sententiam apostolico munimine dignaremur. Nos igitur, vestris supplicationibus inclinati, sententiam ipsam diffinitivam et iusta ratam habentes eam auctoritate apostolica confirmamus presentis scripti patrocinio communimus.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infrin-gere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.
Data Lugdunis IIII julii.
Verso: Confirmatio sententieSardiniaSancti Saturni
73 Documento già pubblicato in C. Zedda – R. Pinna, Fra Santa Igia e il Castro Novo Montis de Castro cit., doc. 5, pp. 180-183. Si ripubblica qui anche questo secondo documento, per via di alcuni refusi in fase di redazione. Per un confronto si veda la trascrizione proposta da M. R. Rubiu, La Sarde-gna e l’Abbazia di Saint-Victor cit., doc. 32, pp. 208-209.