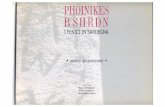L’ornato della collegiata nel quadro della prima arte federiciana
S. Sebis L. Deriu Le pintaderas della Sardegna nuragica della Prima Età del Ferro
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of S. Sebis L. Deriu Le pintaderas della Sardegna nuragica della Prima Età del Ferro
Firenze 2012
LA PREISTORIA E LA PROTOSTORIA DELLA SARDEGNA
Cagliari, Barumini, Sassari 23-28 novembre 2009
Volume III - Comunicazioni
ATTI DELLA XLIVRIUNIONE SCIENTIFICA
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA PREISTORIA E PROTOSTORIA DEL MEDITERRANEO (C.I.P.P.M.)
SEDE DELLA RIUNIONECagliari: Dipartimento di Scienze Archeologiche - Cittadella dei Musei, P.zza Arsenale 1Barumini: Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale “Giovanni Lilliu”Sassari: Facoltà di Lettere e Filosofia - Aula Magna, Via Zanfarino 62
COLLABORAZIONIUniversità di CagliariCentro Interdipartimentale per la Preistoria e Protostoria del MediterraneoDipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio
Università di Sassari
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
COMITATO D’ONOREGiovanni Lilliu, Ercole Contu, Enrico Atzeni, Raffaele Carlo De Marinis
COMITATO SCIENTIFICOPaola Basoli, Anna Depalmas, Maria Ausilia Fadda, Giovanni Floris, Fulvia Lo Schiavo, Carlo Lugliè, Maria Grazia Melis, Alberto Moravetti, Vincenzo Santoni, Giuseppa Tanda, Giovanni Ugas
COORDINATORI DELLE SESSIONIEnrico Atzeni, Paola Basoli, Paolo Bernardini, Riccardo Cicilloni, Ercole Contu, Anna Depalmas, Maria Ausilia Fadda, Giovanni Floris, Fulvia Lo Schiavo, Carlo Lugliè, Fabio Martini, Maria Grazia Melis, Alberto Moravetti, Elsa Pacciani, Vincenzo Santoni, Salvatore Sebis, Giuseppa Tanda, Carlo Tozzi, Giovanni Ugas, Alessandro Usai, Luisanna Usai
SEGRETERIA ORGANIZZATIVACarlo Lugliè, Riccardo Cicilloni, Giuseppina Marras
CON IL SOSTEGNO DIUniversità degli Studi di CagliariRegione Autonoma della SardegnaProvincia di CagliariComune di CagliariComune di BaruminiFondazione Banco di SardegnaFondazione BaruminiBanca di Credito SardoCemis
REDAZIONE ATTICOMUNICAZIONI: Carlo Lugliè POSTER: Carlo Lugliè, Riccardo Cicilloni DIBATTITO: Carlo Lugliè, Giacomo Paglietti, Barbara Melosu, Valentina Basciu, Andrea Marotto, Marco Serra.
STAMPANuove Grafiche Puddu srlZ.I. - Via del progresso, 6 - Ortacesus (CA)Tel. 070 9819015
© Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 2012Via S. Egidio, 21 - 50122 Firenzetel. 055/2340765 - fax 055/5354821www.iipp.it - e-mail: [email protected]
ISBN 978 88 6045 094 4
XLIV Riunione Scientifica - La preistoria e la protostoria della Sardegna
Salvatore Sebis1 - Lucio Deriu2
Le pintaderas della Sardegna nuragica della Prima Età del Ferro
RIASSUNTO - Le pintaderas della Sardegna Nuragica della Prima Età del Ferro - Viene presentato un quadro preliminare di tutte le pintaderas nuragiche finora rinvenute in Sardegna, cioè di un strumento in terracotta utilizzato verosimilmente come timbro per pani cerimoniali. Tale strumento, di forma quasi esclusivamente discoidale con presa cilindrica sul dorso, si presenta distinto sulla faccia piana da elementi decorativi geometrici costituiti da segmenti radiali, angoli inscritti, cerchi concentrici, segmenti rettilinei, punti impressi, cerchielli, ecc., variamente riuniti in uno stesso esemplare. Le 43 pintaderas nuragiche finora note, di cui ben 23 provenienti dall’Oristanese, sono state suddivise in tre classi fondamentali in base alla forma (circolare, ellittica e rettangolare) e in tipi in relazione al decoro dello specchio frontale. Le prime pintaderas furono prodotte probabilmente nelle fasi conclusive del Bronzo Finale (XII-X sec. a.C.), tuttavia allo stato attuale delle ricerche esse sono attestate per la maggior parte in contesti della fase iniziale della Prima Età del Ferro (IX-prima metà VIII sec. a.C.), fra i quali appare particolarmente significativo quello documentato nell’area del nuraghe Nuracraba del Rimedio, presso Oristano, dove furono rinvenuti ben sette esemplari di questo strumento.
RéSUMé - Les pintaderas de la Sardaigne nuragique du Premier Âge du Fer - On présente un cadre préliminaire de toutes les pintaderas nuragiques jusqu’à présent découvertes en Sardaigne, c’est-à-dire d’un instrument de terre cuite qui est susceptible d’être utilisé comme un timbre pour les pains cérémoniels. Cet instrument, de la forme de disque presque exclusivement, avec une prise cylindrique sur le dos, se présente marqué sur la face plate par des éléments déco-ratifs composés de segments radiaux, angles inscrits, des cercles concentriques, des lignes droites, des points imprimés, de cercles simples, etc., diversement regroupés dans une même exemplaire. Les 43 pintaderas nuragiques actuellement connues, dont 23 provenantes du territoire d’Oristano, ont été divisés en trois classes selon la forme (en forme de dis-que, elliptique et rectangulaire) et en types par rapport à la décoration de la vue de face. Les premières pintaderas étaient probablement produites dans les phases terminales du Bronze final (XIIe-Xe siècle av. J.-C.), mais selon l’état actuel des recherches elles sont certifiées pour la plupart dans de contextes de la phase initiale du Premier Âge du Fer (IXe- pre-mière moitié VIIIe siècle av. J.-C.), entre lesquelles est particulièrement significatif le contexte documenté dans le site du nuraghe Nuracraba du Rimedio, près d’Oristano, où ont été trouvés sept exemplaires de cet instrument.
SUMMARy - The pintaderas in nuragic Sardinia of the Early Iron Age - A preliminary picture of all the nuragic pintaderas so far recovered in Sardinia is introduced. It is about earthenciare tools probably used as a stamp for ceremo-nial bread. Such tools, almost exclusively round in shape with a cylindrical handhold on the back, shows itself marked by geometric decorative elements on the plat side; they are constituted by radial segments, inscribed angles, concentric circles, rectilinear segments, engraved points, circlets etc, variously combined in the same sample. The 43 so far known nuragic pintaderas, 23 of which come from the Oristano territory, have been subdivided into three main groups accord-ing to the shape (circular, elliptic and rectangular) and into types with relation to decoration of the frontal face. The first pintaderas were probably produced at the end of the Final Bronze Age (12th-10th century BC), nevertheless, in the present state of the researches, they are attested for the most part in contexts of the early phase of the First Iron Age (9th-first half of 8th century BC), among them, the one documented in the area of the nuraghe Nuracraba (Rimedio-Oristano) appears particularly revealing; in that area seven samples of this tool have been found.
1 Curatore del Museo Civico “Giovanni Marongiu” - Sezione preistorica e protostorica, Via Tharros 121, 09072 Cabras; e-mail: [email protected] Museo Archeologico “Antiquarium Arborense”, Piazza Corrias, 09170 Oristano; e-mail: [email protected]
S. SEBIS - L. DERIU836
1. Le pintaderas nuragiche
Col termine pintadera viene denominato nel lin-guaggio archeologico uno strumento in terracotta presente in Sardegna in numerosi contesti del pe-riodo nuragico, il quale ebbe verosimilmente la fun-zione di timbro per decorare dei pani cerimoniali.Il termine deriva dal lessico castigliano dove appun-to ha il significato di timbro utilizzato con questa funzione. La stessa parola fu usata dai conquistado-res spagnoli, nel primo Cinquecento, per indicare anche quei timbri che il popolo Maya usava per imprimere dei tatuaggi sulla pelle umana.In Sardegna fu Antonio Taramelli lo studioso che per primo adottò questo termine in campo arche-ologico, riferendosi a tre oggetti in terracotta (pin-taderas) della collezione oristanese dell’Avv. Efisio Pischedda (Taramelli 1916), ereditata in parte dall’Antiquarium Arborense di Oristano, e sempre con questo nome lo studioso classificò “i timbri a pressione in terracotta” rinvenuti nel nuraghe Santu Antine di Torralba (Taramelli 1939, coll. 67-68).Allo stato attuale delle conoscenze, sono 43 le pin-taderas nuragiche finora rinvenute in Sardegna ed è l’Oristanese l’area geografica con maggiori attesta-zioni: ben 23 su un totale di 43 (53,48%).La pintadera nuragica, così come molte altre espres-sioni dell’artigianato tradizionale isolano, quanto appare estremamente semplice nella forma, tan-to per contro si presenta elaborata nell’apparato decorativo.La forma fondamentale, e pressoché unica ed esclu-siva, della pintadera è quella del disco con un dia-metro che va da un minimo di 6 cm fino ad un massimo di circa 14,2 cm, mentre lo spessore me-dio non supera il centimetro. Sul dorso, dal profilo convesso, è applicata nel punto centrale una piccola presa cilindrica adatta ad essere maneggiata con i polpastrelli del pollice e dell’indice.Ovviamente è lo specchio frontale o faccia piana a costituire la parte distintiva dell’oggetto con i suoi motivi decorativi di tipo geometrico variamente composti, siano essi incisi o impressi. Ricorrenti i cerchielli semplici o concentrici, i segmenti radia-li, i decori a spina di pesce o chevrons, gli angoli inscritti con il vertice posizionato verso il centro, i punti impressi ecc.Sul piano formale possono essere distinte tre classi fondamentali nella categoria delle pintaderas:- la Classe A: a contorno circolare;- la Classe B: a contorno quadrangolare;- la Classe C: a contorno ellittico.
In effetti quasi tutte le pintaderas figurano nella Classe A (39 esemplari su 43), mentre sono appe-na quattro quelle rappresentate dalle Classi B e C, costituendo quindi quasi degli unica. All’interno di ciascuna Classe a loro volta possono essere indivi-duati vari tipi sulla base dei motivi decorativi rap-presentati sulla faccia piana, ma al momento questa classificazione appare opportuna e fattibile soltanto in relazione alla Classe A per la quale si dispone, come già precisato, di una ricca documentazione.
Tipo A.1Decoro a segmenti radiali intervallati da brevi seg-menti o da punti presso il margine e disco centrale in rilievo.Contesti di provenienza:1. Abbasanta, Nuraghe Losa (fig. 1.1)(Santoni 1993b, p. 88, tav. XIII.8; p. 100, tav. XXV.2; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1136. Pin. 1.6, tav. 455.6);2. Villanovaforru, Villaggio di Genna Maria (fig. 1.2)(Badas 1987, p. 144, tav. V; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1136. Pin. 1.2, tav. 455.2; Cossu 2005, p. 55, fig. 51);3. Villanovaforru, Villaggio di Genna Maria (fig. 1.3)(Cossu 2005, p. 55, fig. 52);4. Isili, Nuraghe Is Paras (fig. 1.4)(Moravetti 1985, p. 29; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1136. Pin. 1.4, tav. 455.4);5. Cabras, Loc. sconosciuta del Sinis (?) (fig. 1.5)(Santoni et alii 1988, p. 21, fig. 11);6. Cabras-Tharros, Villaggio nuragico di Torre di San Giovanni (fig. 1.6)(Santoni 1978, p. 89, n. 20, tav. XXVII.1; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1136. Pin. 1.1, tav. 455.1);7. Villaurbana/Siamanna, Nuraghe San Giovanni (fig. 1.7)(Santoni 1993a, tav. IV.15, tav. VIII.1; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1136. Pin. 1.5, tav. 455.5);8. Villaurbana/Siamanna, Nuraghe San Giovanni (fig. 1.8)(Santoni 1993a, tav. IV.14, tav. VI.5; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1136. Pin. 1.3, tav. 455.3);9. Genoni, Nuraghe S. Antine (fig. 1.9)(Guido 1991, p. 937, fig. 2.b);10. Oristano-Rimedio, Nuraghe Nuracraba (Rim. 7) (fig. 1.10; fig. 2.7)(Deriu e Sebis 2011);11. Oristano-Rimedio, Nuraghe Nuracraba (Rim. 4) (fig. 1.11; fig. 2.4)
Le pintaderas della Sardegna nuragica della Prima Età del Ferro 837
Fig. 1 - Tipologia delle pintaderas nuragiche: A.1 (1-16); A.2 (17-31); A.3 (32-39); B (40-42); C (43) (senza scala) (1: da Santoni 1993b; 2,4,19,21,36-37: da Campus e Leonelli 2000; 3,22: da Cossu 2005; 6: da Santoni 1978; 7-8: da Santoni 1993a; 9: da Guido 1991; 11: da Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Cagliari e Oristano; 13: da Sebis 2007; 16: da Massetti 2008; 17: da Lilliu 1952-54; 18: da Lo Schiavo e Sanges 1996; 20: da Moravetti 1988; 23: da Madau 1996; 24,41,43: da Santoni et alii 1988; 29: da Lo Schiavo, s.d.; 30: da Moravetti 1985; 31: da www.comune.irgoli.nu.it; 35: da Cocco 1980; 38: da Santoni 1990; 39: da Santoni 1998; 40: da Sebis 1994; 42: da Ugas 1993; 5,10,14-15,25-28,32-34: foto S. Sebis, L. Deriu) (el. grafica L. Deriu e S. Sebis).
S. SEBIS - L. DERIU838
(Ibid.);12. Oristano-Rimedio, Nuraghe Nuracraba (Rim. 1) (immagine non disponibile, fig. 2.1)(Ibid.);13. Bauladu, Villaggio nuragico Santa Barbara (fig. 1.13)(Sebis 2007, p. 81, fig. 26.14);14. Zeddiani, Loc. sconosciuta (fig. 1.14) (inedita);15. Zeddiani, Loc. sconosciuta (fig. 1.15)(inedita);16. Orune, Villaggio nuragico di S. Efis (fig. 1.16)(Massetti 2008, pp. 87-88, fig. 13).
Tipo A.2Decoro a settori, da quattro a cinque, realizzati con angoli inscritti convergenti in un cerchio centrale e divisi da dorsali spesso punteggiate o da cerchielli concentrici impressi o incisi. Gli angoli inscritti pos-sono presentarsi con i vertici acuti o arrotondati.Contesti di provenienza:17. Barumini, Villaggio Su Nuraxi, capanna 141 (fig. 1.17)(Lilliu 1952-54, p. 305; tav. XLIII, 5; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1140. Pin. 5.B.3, tav. 456.3);18. Orroli, Nuraghe Arrubiu (fig. 1.18)(Lo Schiavo e Sanges 1996, p. 62, fig. 41; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1140. Pin. 5.A.1, tav. 456.1);19. Teti, Villaggio di S’Urbale (fig. 1.19)(Fadda 1985, p. 127, n. 24; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1140, Pin. 5.A.2, tav. 456.2);20. Torralba, Nuraghe Santu Antine (fig. 1.20)(Moravetti 1988, p. 199, fig. 5; tav. XII; Campus e Leonelli 2000, p. 764, 1140. Pin. 5.C.4, tav. 456.4);21. Villanovaforru, Villaggio di Genna Maria (fig. 1.21)(Campus e Leonelli 2000, p. 764, 1140. Pin. 5.C.5, tav. 456.5);22. Villanovaforru, Villaggio di Genna Maria (fig. 1.22)(Badas 1987, p. 144, tav. V; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1137. Pin. 3.1, tav. 455.8; Cossu 2005, p. 55, fig. 50);23. Tinnura, Villaggio nuragico di Tres Bias (fig. 1.23)(Madau 1996, p. 187, fig. 49.10; Campus e Leonelli 2000, p. 764, 1140. Pin. 5.C.8, tav. 456.8);24. Cabras, Sinis. Loc. sconosciuta (?) (fig. 1.24)
(Olim Collezione Efisio Pischedda-Oristano; Taramelli 1916, p. 27);25. Oristano-Rimedio, Nuraghe Nuracraba (Rim. 2) (fig. 1.25; fig. 2.2)(Deriu e Sebis 2011);26. Oristano-Rimedio, Nuraghe Nuracraba (Rim. 3) (fig. 1.26; fig. 2.3a-b)(Ibid.);27. Villaurbana, Loc. sconosciuta (fig. 1.27)(inedita);28. Nuraxinieddu, Loc. Palamestia (fig. 1.28)(ricerche Sebis 1991, inedita);29. Olbia, Pozzo sacro Sa Testa (fig. 1.29)(Lo Schiavo s.d., fig. [2]);30. Isili, Nuraghe Is Paras (fig. 1.30)(Moravetti 1985, p. 29; Campus e Leonelli 2000, p. 764, 1140. Pin. 5.C.6, tav. 456.6);31. Irgoli, Complesso nuragico di Janna ’e Pruna (fig. 1.31)(Fadda 2002).
Tipo A.3Decoro a cerchi concentrici e a zone anulari concen-triche decorate da punti impressi, da tratti oblunghi o a foglioline, da tratti rettilinei, da cerchielli, da chevrons o da linee continue a sviluppo sinusoide. Gli stessi motivi possono comparire in una stessa pintadera senza essere marginati dai cerchi concen-trici, come è possibile osservare nell’esemplare n. 38 del nuraghe Nuracraba.Contesti di provenienza:32. Zeddiani, Loc. sconosciuta (fig. 1.32)(inedita);33. Nuraxinieddu, Centro abitato (fig. 1.33)(ricerche Sebis 1996, inedita);34. Cabras, Loc. sconosciuta del Sinis (?) (fig. 1.34)(Antiquarium Arborense, Collezione Pau; Santoni et alii 1988, p. 25);35. Dorgali, Villaggio nuragico di Serra Orrios (fig.1.35)(Cocco 1980, tav. XL, 2; Campus e Leonelli 2000, p. 764, 1140. Pin. 5.C.7, tav. 456.7);36. Barumini, villaggio Su Nuraxi (fig. 1.36)(Lilliu e Zucca 1988, p. 60, fig. 33; Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1137. Pin. 2.1, tav. 455.7)37. Villanovaforru, Villaggio di Genna Maria (fig. 1.37)(Campus e Leonelli 2000, p. 763, 1139. Pin. 4.1, tav. 455.9);38. Oristano-Rimedio, Nuraghe Nuracraba (Rim. 5) (fig. 1.38; fig. 2.5)
Le pintaderas della Sardegna nuragica della Prima Età del Ferro 839
(Santoni 1990, p. 30, fig. 9; Deriu e Sebis 2011);39. Oristano-Rimedio, Nuraghe Nuracraba (Rim. 6) (fig. 1.39; fig. 2.6)(Santoni e Sebis 1984, p. 99-100; Santoni 1998, p. 27, fig. 22; Deriu e Sebis 2011).La Classe B è distinta da un contorno rettangolare con i lati rettilinei convergenti ad angolo retto o con i lati corti curvilinei. Il decoro è costituito da segmenti rettilinei, da chevrons, da segmenti a fo-glioline e da cerchi inscritti.Contesti di provenienza:40. Nuraxinieddu, Su Cungiau ’e Funtà (fig. 1.40)(Sebis 1995, p. 108, tav. X.4; 2008, p. 76, fig. 22.16; Campus, Leonelli 2000, p. 764, 1141. Pin. 6, tav. 457.1);41. Cabras, Loc. sconosciuta del Sinis (?) (fig. 1.41)(Olim Collezione Efisio Pischedda-Oristano; Taramelli 1916, p. 27);42. San Sperate, Villaggio nuragico di Via Giardini 25 (fig. 1.42)(Ugas 1993, p. 40, n. 419).
Alla Classe C viene ascritta una sola pintadera, la quale propone una sintassi decorativa analoga a quella del tipo A.2.Contesto di provenienza:43. Cabras, Loc. sconosciuta del Sinis (?) (fig. 1.43)(Olim Collezione Efisio Pischedda-Oristano; Taramelli 1916, p. 27).
L.D.
2. Il contesto del Nuraghe Nuracraba (Rimedio-Oristano)
Come è noto, l’indagine archeologica condotta nell’area del nuraghe Nuracraba negli anni 1983/84 permise di documentare diverse fasi insediative, le prime due del periodo nuragico, le successive di età romana repubblicana ed imperiale e probabilmen-te anche medioevale (Santoni e Sebis 1984; Sebis 2008).In relazione alla prima fase nuragica furono eviden-ziati i resti di due torri nuragiche (A e B) unite da
Fig. 2 - Rimedio-Oristano, Nuraghe Nuracraba: localizzazione delle pintaderas nel vano abitativo addossato alla cortina A-B (ril. e dis. S. Sebis).
S. SEBIS - L. DERIU840
cortina rettilinea (A-B) presumibilmente pertinenti all’antemurale di un nuraghe complesso, mentre nell’area situata subito a S di tali strutture furono messe in luce delle fosse ellittiche (S1, S2) e delle trincee curvilinee (C1, C2) per le quali è tuttora problematico proporre una spiegazione plausibile circa la loro reale funzione (Sebis 2008, pp. 491-493, 499, fig. 2.1). I materiali ceramici che si ac-compagnano a queste strutture (Santoni e Sebis 1984, pp. 103, 105; Sebis 1995, pp. 119-120 tavv. IX-X; Ugas et alii 2004, p. 406, fig. 2.1-3,6-7,10-12,19-21,23,25-27,29-34,36,39-43,46-54,56,58-59,62,64-71,75) sono stati ascritti alla facies della ceramica a pettine evoluta nell’ambito del Bronzo recente (1365-1200 a.C.) (Ibid., pp. 404-405).Le pintaderas di Nuracraba, complessivamente set-te fra integre e frammentarie, non sono tuttavia in connessione con questa prima fase nuragica, bensì con quella successiva, riconducibile, come si preciserà più avanti, alla fase iniziale della Prima Età del Ferro (IX-prima metà VIII sec. a.C.). Ben quattro pintaderas su sette, le n. 3, 4, 5 e 6, furono
rinvenute raggruppate nello spazio immediatamen-te adiacente alla cortina A-B del complesso nura-gico preesistente, all’interno di un ambiente che, sebbene scavato solo in parte, può essere definito di tipo domestico sulla base di diversi elementi (fig. 2): la presenza di un focolare (US 38, fig. 2.F) e i resti di pasto, le forme ceramiche e gli oggetti anche di uso quotidiano (coppe di cottura, ciotole, olle, anforette, brocche askoidi, dolii, fusaiole, pestelli) restituiti dallo strato di frequentazione (US 39) (fig. 3.A.1-19) e dallo stesso focolare (fig. 3.B.1-5). Le pintaderas n. 1 e 7 furono invece trovate nella trin-cea di spoglio della Torre B e la 2 presso la cortina A-B nel terreno rimaneggiato dai mezzi meccanici, ma verosimilmente associate in origine alle altre dell’US 39 (fig. 2).Gli aspetti tipologici dei prodotti ceramici docu-mentati nello strato di frequentazione (US 39), o in relazione al focolare (US 38), sono in genere ascritti alla facies “pregeometrica” del Bronzo Finale (XII-X sec. a.C.) (Campus e Leonelli 2000), ma possono es-sere riferiti anche alla successiva facies “geometrica”
Fig. 3 - Rimedio-Oristano, Nuraghe Nuracraba, ceramica nuragica: A. dall’US 39 (1-19); B. dall’US 38 (1-4), dallo strato di cenere soprastante la base del focolare (5), presumibilmente dall’US 26 (6), presumibilmente dall’US 39 (7-8), dalla trincea di spoglio della Torre A (9) (dis. S. Sebis).
Le pintaderas della Sardegna nuragica della Prima Età del Ferro 841
della fase iniziale della Prima Età del Ferro, qua-lora rinvenuti in associazione, come in alcuni siti dell’Oristanese, con il vaso piriforme, il vaso a sa-liera, il vaso portabrace e la decorazione a cerchielli concentrici, ritenuti appunto forme vascolari ed elementi ornamentali tipici di quest’ultima fase. Mi riferisco in particolare ai contesti ceramici restituiti dal villaggio S. Barbara di Bauladu (Gallin e Sebis 1985, p. 275; Sebis 2007, pp. 81-82, fig. 26.9-12), dallo strato 13 della fonte nuragica Mitza Pidighi (Usai 2007, pp. 42-44, figg. 1-3) e dall’abitato del nuraghe Pidighi di Solarussa (Ibid., pp. 46-48, figg. 4-6), come pure dal nuraghe Orgono di Ghilarza (Ibid., p. 51, figg. 8A.8, 8B.3.8). E sempre a questa fase iniziale della Prima Età del Ferro ritengo pos-sa essere attribuito anche il contesto archeologico da cui provengono le pintaderas di Nuracraba. Può essere considerata quasi certa, infatti, l’appartenen-za alla US 39 di un frammento di vaso piriforme decorato a spina di pesce, rinvenuto in prossimità della cortina A-B sebbene nel terreno rimaneggiato dai mezzi meccanici (fig. 3.B.8) (Sebis 2007, p. 81, fig. 26.15), come pure è probabile che dallo stesso ambiente delle pintaderas possa derivare un fram-mento di vaso a saliera recuperato nella trincea di spoglio della adiacente Torre B (fig. 3.B.6) (Ibid., p. 81, fig. 26.16). Inoltre è opportuno tener presente che dalla trincea di spoglio della Torre B proviene un frammento di brocca askoide con l’ansa canali-colata decorata all’attacco inferiore dell’ansa da sei cerchielli concentrici (fig. 3.B.9) (Ibid., pp. 81-82, figg. 26.17, 27), e che ai materiali già editi della discarica D1 (Santoni, Sebis 1984, p. 101; Sebis 2008, pp. 494, 499, figg. 2.2) e attribuiti nel 1984 al Bronzo Finale (Santoni, Sebis 1984, p. 100), va unito un frammento di parete con decorazione a cerchielli concentrici, individuato di recente in oc-casione del riordino dei materiali di scavo.In conclusione, quindi, si avrebbe una ulteriore con-ferma di quanto, dal punto di vista cronologico, le pintaderas presenti nei contesti ceramici dei villaggi di Genna Maria di Villanovaforru (Badas 1987, pp. 134, 144, tav. V) e di S. Barbara di Bauladu (Sebis 2007, p. 81, fig. 26.14) ci consentivano già di affer-mare. Ovviamente questo dato non esclude che la produzione di tale manufatto nella cultura materiale nuragica possa risalire a fasi più antiche, se si condi-vide l’attribuzione a momenti conclusivi del Bronzo Finale del vano F del villaggio di S’Urbale di Teti, dove appunto fu rinvenuta una pintadera di tipo A.2 (fig. 1.19) (Fadda 1985, pp. 118, 127, fig. 24; 1987, pp. 53-61), come pure possa perdurare fino a
fasi avanzate della stessa I Età del Ferro, nell’ambito dell’VIII sec. a.C., come dimostrerebbe il contesto materiale restituito dal villaggio di Su Cungiau ’e Funtà di Nuraxinieddu (Sebis 2007).
S.S.
Riferimenti bibliografici
atti selargius 2 - AA.VV., 1987, La Sardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primo millennio a.C., Atti del Convegno, Cagliari.
Badas U. 1987, Genna Maria-Villanovaforru (Cagliari). I vani 10-18. Nuovi apporti allo studio delle abitazioni a Corte Centrale, in Atti Selargius 2, pp. 133-146.
Campus F., Leonelli V. 2000, La tipologia della ceramica nu-ragica. Il materiale edito, Viterbo.
Cocco D. 1980, Il villaggio nuragico di Serra Orrios. I materiali fittili, in AA.VV., Dorgali. Documenti archeologici, Sassari, pp. 115-140.
Cossu T. 2005, Il pane in Sardegna dalla preistoria all’età ro-mana, in AA.VV., Pani. Tradizioni e prospettive della pani-ficazione in Sardegna, Nuoro, pp. 52-59.
Deriu L., Sebis S. 2011, Le pintaderas della Prima età del ferro in Sardegna, in Mastino A., Spanu P.G., Usai A., Zucca R., a cura di, Tharros Felix 4, Roma pp. 387-419.
Fadda M.A. 1985, Il villaggio, in AA.VV., La civiltà nuragica, Milano, pp. 102-119.
Fadda M.A. 1987, Villaggio nuragico di S’Urbale (Teti-NU). I materiali del vano F, in Atti Selargius 2, pp. 53-61.
Fadda M.A. 2002, Tutta la preistoria di Irgoli, Archeologia Viva 91, pp. 56-61.
Gallin L., Sebis S. 1985 (1989), Bauladu (Oristano). Villaggio nuragico di S. Barbara, NBAS II, pp. 271-275.
Guido F. 1991, Scavi nella fortificazione punica di S. Antine di Genoni (Nuoro), in AA.VV., Atti del II Congresso interna-zionale di Studi Fenici e Punici, Roma, pp. 931-940.
Lilliu G. 1952-54 (1955), Il nuraghe di Barumini e la strati-grafia nuragica, SS XII-XIII, I, pp. 90-469.
Lilliu G., Zucca R. 1988, Su Nuraxi di Barumini, Sassari.Lo Schiavo F. s.d, Pintaderas, Banco di Sardegna, s.l.Lo Schiavo F., Sanges M. 1996, Il nuraghe Arrubiu di Orroli,
Sassari.Madau M. 1996, Tinnura, loc. Tres Bias, BdArch 19-21, pp.
186-188.Massetti S. 2008, Orune (Nuoro). Località Sant’Efisio. Area
archeologica di Sant’Efis, in Fadda M.A., a cura di, Una Comunità Montana per la valorizzazione del Patrimonio Archeologico del Nuorese, Cagliari, pp. 83-91.
Moravetti A. 1985, Nuraghe Is Paras-Isili, in AA.VV., Dieci anni di attività nel territorio della Provincia di Nuoro, Nuoro, pp. 28-29.
Moravetti A. 1988, Il nuraghe S. Antine di Torralba. Brocche askoidi, pintadere, lisciatoi, in Moravetti A., a cura di, Il nuraghe S. Antine nel Logudoro-Meilogu, Sassari, pp. 189-206.
Santoni V. 1978, Il villaggio nuragico di Tharros. Campagna 1977, RSF VI, pp. 81-96.
Santoni V. 1990, Il territorio in epoca nuragica (circa 1500-200 a.C.), in Casula F.C., a cura di, La Provincia di Oristano. L’orma della storia, Cinisello Balsamo, pp. 27-40.
S. SEBIS - L. DERIU842
Santoni V. 1993a, Il nuraghe S. Giovanni di Villaurbana-Siamanna (Or), in D’Arienzo L., a cura di, Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. I. La Sardegna, Studi storici in memoria di Alberto Boscolo, Roma, pp. 91-104.
Santoni V. 1993b (1994), L’architettura e la produzione mate-riale nuragica, in AA.VV., Il nuraghe Losa di Abbasanta. I, QSACO 10-Supplemento, Cagliari, pp. 5-110.
Santoni V. 1998, Il nuraghe Madonna del Rimedio-Oristano, in AA.VV., Aureum Stagnum. Le origini di Oristano, Oristano-Cagliari, pp. 26-27.
Santoni V., Sebis S. 1984 (1986), Il complesso nuragico «Madonna del Rimedio» (Oristano), NBAS I, pp. 97-114.
Santoni V., Zucca R., Pau G. 1988, Oristano, in Lilliu G., a cura di, L’Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna, Sassari, pp. 13-42.
Sebis S. 1994 (1995), Materiali dal villaggio nuragico di Su Cungiau ’e Funtà nel territorio di Nuraxinieddu, QSACO 11, pp. 89-109.
Sebis S. 1995, La ceramica nuragica del Bronzo Medio (XVI-XIV sec. a.C.) e del Bronzo Recente (XIII-XII sec. a.C.) nell’Oristanese, in AA.VV., La ceramica racconta la storia. La ceramica artistica, d’uso e da costruzione nell’Oristanese
dal neolitico ai giorni nostri, Atti del Convegno, Oristano, pp. 101-120.
Sebis S. 2007 (2008), I materiali ceramici del villaggio nuragi-co di Su Cungiau ’e Funtà (Nuraxinieddu-OR) nel quadro dei rapporti fra popolazioni nuragiche e fenicie, Sardinia, Corsica et Baleares Antiquae V, pp. 63-86.
Sebis S. 2008, La stratigrafia del nuraghe Nuracraba (Madonna del Rimedio, Oristano). Campagna di scavo 1983-84, in AA.VV., La civiltà nuragica. Nuove acquisizioni. II, Atti del Convegno, Cagliari, pp. 489-504.
Taramelli A. 1916, Catalogo della collezione archeologica del Cav. Avv. Efisio Pischedda di Oristano, dattiloscritto, Archivio Storico Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano - Fasc. Antiquarium Arborense.
Taramelli A. 1939, Il nuraghe Santu Antine di Torralba, MAL XXXVIII, coll. 1-70.
Ugas G., Lugliè C., Sebis S. 2004, La ceramica, in Cocchi Genick D., a cura di, L’età del bronzo recente in Italia, Atti del Congresso, Viareggio, pp. 399-410.
Ugas G. 1993, San Sperate dalle origini ai baroni, Cagliari.Usai A. 2007 (2008), Riflessioni sul problema delle relazioni tra
i Nuragici e i Fenici, Sardinia, Corsica et Baleares Antiquae V, pp. 39-62.