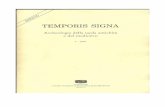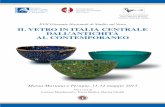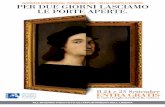I reperti metallici in Sardegna tra VIII e XI secolo: problematiche e prospettive di ricerca
Transcript of I reperti metallici in Sardegna tra VIII e XI secolo: problematiche e prospettive di ricerca
Settecento-MillecentoStoria, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
Dalle fonti scritte, archeologiche ed artistiche alla ricostruzione della vicenda storica
la Sardegna laboratorio di esperienze culturali
Convegno di Studi
Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio
Cittadella dei Musei - Aula Roberto Coroneo
17-19 ottobre 2012
a cura di Rossana Martorelli
con la collaborazione di Silvia Marini
Cagliari - Scuola Sarda Editrice 2013
I REPERTI METALLICI IN SARDEGNA TRA VIII E XI SECOLO: PROBLEMATICHE
E PROSPETTIVE DI RICERCA1
Marco MuresuUniversità degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e TerritorioScuola di Specializzazione in Beni [email protected]
Riassunto. Tra gli indicatori cronologici e socio-economici della cultura materiale inerente i “secoli bui” in Sardegna i manufatti in metallo costituiscono uno degli insiemi più numerosi e articolati e custodiscono un potenziale informativo notevole, in virtù delle specificità contestuali nelle quali di volta in volta vengono rinvenuti e delle peculiarità morfologiche differenti in base all’utilizzo. Tale contributo costituisce un primo approccio alle problematiche riguardanti lo status quaestionis della ricerca archeologica sarda sui reperti metallici e propone una serie di ipotesi per la conduzione di ricerche future, scandite non solo da un approccio archeologico scientifico ma corroborate dall’apporto di tecnologie informatiche di gestione di database.
Parole chiave: manufatti metallici, database, cultura materiale.
Abstract. Metal handworks and artifacts can be defined as one of the most meaningful set of archaeological evidence of Middle Age in Sardinia, thus as keepers of a deep potential of information thanks to specific contextual and morphological characteristics. This essay would be an inchoate approach to the problems concerning Sardinian archaeological research level of accuracy. Moreover it has the purpose of proposing some brand new ways of proceeding in the future research, by an archaeological scientific approach corroborated by archaeometry, archaeometallurgy and database gestional software technologies.
Keywords: metallic artifacts, database, material culture.
Le pubblicazioni in merito alle ricerche archeologiche e alle indagini terri-toriali svoltesi a partire dagli anni Ottanta del XX secolo hanno consenti-to di reperire, in oltre sessanta località della Sardegna rientranti nell’ambito cronologico della ricerca2, una nutrita serie di manufatti realizzati in metallo
1 Chi scrive desidera porgere un caloroso ringraziamento a Rossana Martorelli e Fabio Pinna per aver reso possibile la stesura di tale contributo, fornendo supporto e preziosi consigli durante l’attività di studio e la seguente elaborazione. Ringrazio Domingo Dettori e Paolo Benito Serra per le precisazioni su alcune problematiche emerse in seguito allo svolgimento della ricerca.
2 L’insieme di siti e località rientranti nella ricerca ha previsto, per la provincia
31 741
742 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
di Sassari: S. Pietro di Sorres-Borutta (Maetzke, 1959 pp. 657-658; Caprara, 1988 p. 399; Serra, 2000 p. 499), S. Filitica-Sorso (Caprara, 1992 p. 80; Rovina, 2000 p. 39; Rovina, 2001 p. 22; Rovina, 2002 pp. 515-516; Coroneo, 2011 p. 273), loc. Museddu-Cheremule (Caprara, 1988 pp. 430-431; Serra & Salvi, 1990; Lilliu, 1993 p. 119; Serra, 1998 pp. 348-349), S. Giulia-Padria (Pandolfi, 2002 p. 515), Loc. S. Michele (Pitzalis et al., 2002 p. 194), Collez. Dessì (Serra & Salvi, 1990)-Laerru, Tissi (Maetzke, 1958 pp. 356-357; Rovina, 1986 pp. 54-55; Salvi & Serra, 1990), loc. Balai (Necropoli di Scoglio Lungo) (Serra, 1976 pp. 8-10; Serra, 2005 p. 472), Collez. Privata (Piras, 1989 pp. 93-108), Terme romane (Taramelli, 1922 p. 294; Caprara 1992, p. 80; Guido 2002, p. 169; Castellaccio, 2005 pp. 44, 56, nota 102), S. Gavino (Serra, 2000 pp. 447-448) -Porto Torres (Spano, 1857 p. 156; Guido, 2002 p. 169), loc. La Crucca-Domus de Janas Giorre Verdi (Contu, 1972 pp. 471-472; Serra, 1976 pp. 9-10), Collez. Merella-Viddazza (Serra, 1976 p. 10), S. Maria di Mesumundu-Siligo (Maetzke, 1958 pp. 360-363; Maetzke, 1965 pp. 307-314; Caprara, 1988 pp. 401-404), loc. Tiriu-Uri (Rovina, 2000 p. 44), loc. Ruinas (Guido, 2002 p. 167), Collez. Amadu (Guido, 1989 pp. 86-92; Guido, 2002 p. 167)-Ozieri, Chiesa di S. Giovanni-Ossi (Guido, 2002 p. 167), Sassari (Castellaccio, 2005 pp. 44, 56, nota 103), S. Maria-Tergu (Dettori, 2007 pp. 40-41). Per la provincia di Olbia-Tempio: S. Vittoria-Telti (Caprara, 1986 pp. 52-53; Pisanu, 2004 p. 502; Coroneo, 2011 pp. 278, 298-299; Pala, 2011 p. 140). Per la provincia di Nuoro: Via Ballero-Nuoro (Serra, 1978 pp. 217-221, tav. LXXXIX, figg. 1-3; Caprara, 1986 p. 51; Lilliu, 1993 p. 120), loc. Gedillau-Aritzo (Serra & Salvi, 1990), Ispinigoli-Dorgali (Moravetti, 1980 pp. 165-171; Lilliu, 1990 pp. 422-423, nota 39), Su Toni-Tonara (Caprara, 1978 pp. 211-212), Domus de Janas Fenosu-Oliena (Lo Schiavo, 1989 p. 171), Sas Concas-Oniferi (Santoni, 1996 p. 114; Santoni, 2000 pp. 939-941), Oliena (Guido,1986a p. 57), loc. Parte Sole-Posada (Guido, 1986b pp. 57-58), S. Pietro-Galtellì (D’Oriano, 1986 p. 60). Per la provincia di Ogliastra: S. Maria-S.M. Navarrese (Pala, 2011 p. 67). Per la provincia di Oristano: S. Salvatore (Spanu & Zucca, 2004 pp.103-123, 126,145-146), Tharros-Cabras, loc. Tanca ‘e Suei-Norbello (Usai, 1998 pp. 122-124, 130-131), Nuraghi Losa (Serra, 1993 p. 166) e Aiga-Abbasanta (Taramelli, 1929 p. 318; Guido, 2002 p. 169), S. Lucia-Assolo (Mureddu, 2002 p. 503), Anfiteatro (Bacco et al., 2010 pp. 1391, 1413-1459), Ponte-Fordongianus (Coroneo, 2011 pp. 480-481, 492 fig. 6), S. Giovanni Battista-Nurachi (Stefani, 1985 p. 60), Nuraghe Candala-Sorradile (Santoni et al., 1987 pp. 83 e ss.), loc. Su Cungiau ‘e Funtà-Nuraxinieddu (Serra, 1998 pp. 351 e ss.), Nuraghe Sa Domu ‘eccia-Uras (Serra, 2002a pp. 149, 151-153; Serra, 2002b pp. 212-213; Salvi & Serra, 2002 p. 162), Vigna Sechi-Bosa (Guido, 2002 p. 169), S. Francesco-Oristano (Coroneo, 2011 pp. 278-283, 299-302). Per la provincia del Medio Campidano: un solo esempio proveniente da Villanovafranca. Per la provincia
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
743
inseribili in classi comprendenti gli oggetti dell’equipaggiamento militare3, quelli relativi all’ornamento della persona4, i finimenti per animali5, gli og-
di Carbonia-Iglesias: Chiesa-S. Antioco (Coroneo, 2011 p. 295), Pani Loriga-Santadi (Serra, 1995 pp. 387-396; Serra, 2001 tav. V, 5a-g; Serra, 2002c p. 215). Per la provincia di Cagliari: Piazza del Carmine-Cagliari, loc. Sa Cungiadura Manna (Zucca, 1998 p. 8; Salvi & Serra, 1990), loc. Serrai-Serri (Salvi & Serra, 1990; Serra, 2002d p. 201), loc. Sa Funtanedda ‘e S. Andrea-Quartu S. Elena (Salvi, 1990 pp. 193-194), Nuraghe S. Vito-S. Vito (Lilliu, 1993 pp. 128-129), Nuraghe Armungia-Armungia (Santoni, 1995 pp. 15-24), Su Nuraxi-Siurgus Donigala (Ugas & Serra, 1990 p. 111 e ss.), S. Lussorio (Manunza, 2006 p. 87; Serra, 2008 p. 341), S. Giuliano-Selargius (Serra et al., 1989 pp. 227-232, 236-238; Coroneo, 2000a pp. 481-489), loc. Bruncu ‘e s’Olia-Serdiana (Salvi & Serra, 1990), Is Cirredis-Villaputzu (Salvi & Serra, 1990; Martorelli, 2003 p. 307; Serra, 2008 p. 341; Bacco et al., 2010 p. 1423), loc. Su Pardu-Sestu (Serra, 2005a pp. 469-471; Coroneo, 2011 p. 294), Collez. Lulliri-Domus de Maria (Biamonti, 1996 pp. 244-245), infine i materiali localizzati attualmente presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, tra i quali è compresa anche la sezione bizantina e medievale della raccolta numismatica del can. Giovanni Spano, da lui stesso ceduta all’allora Regio Museo nel 1865 (cfr. Spano, 1865; sui manufatti si vedano anche Pani Ermini & Marinone, 1981; Guido, 2002 p. 169; Coroneo, 2011 p. 289 e ss.) e la Pinacoteca Nazionale del medesimo centro abitato, presso la quale è custodito un esemplare di acquamanile bronzeo, riguardo al quale è possibile reperire una bibliografia esaustiva in Serra et al., 1990 pp. 19, 24 scheda n. 6; Pala, 2011 pp. 65, 133).
3 Chi scrive ha adottato per la realizzazione del database e la stesura di tale contributo la classificazione dei manufatti proposta da Rossana Martorelli (Martorelli, 1999 pp. 14-19, in particolare p. 17 per la classe in esame) e in seguito adottata da Francesca Zagari (Zagari, 2005 pp. 148-152).
4 I manufatti descrivibili come accessori del vestiario (Martorelli, 1999 p. 17) comprendono le fibbie, da cintura o cinturone, per le cui varietà morfologiche è consuetudine adottare la terminologia proposta da Joachim Werner (si veda Werner, 1955) e da Otto von Hessen (cfr. Von Hessen, 1974), le fibule, gli anelli digitali e gli orecchini. Per una puntuale descrizione della classe e delle sue articolazioni, si rimanda a Zagari, 2005 pp. 138-148.
5 La classe dei finimenti per animali comprende manufatti quali fibbie da sella, staffe e ferri di cavallo, asino e mulo, talvolta provvisti di chiodi di fissaggio i quali, tuttavia, risultano spesso di difficile individuazione (Martorelli, 1999 p. 17; Zagari, 2005 pp. 154-155).
744 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
getti primariamente legati al corredo funebre6, le emissioni monetali7; per gli
6 Martorelli, 1999 p. 17. La classe di manufatti in questione è connessa ad una serie di problematiche di non facile risoluzione, legate principalmente alla trasversalità: non è raro che oggetti appartenenti ad altre classi (es. i chiodi, legati all’edilizia), se inquadrati in contesti funerari, possano acquisire una valenza apotropaica (cfr. Zagari, 2005 p. 157). Tra i reperti metallici di chiara valenza devozionale (Martorelli, 1999 p. 17) si segnalano le croci (sulla cui origine, significato e funzioni si rimanda a Giostra, 2010), e gli enkolpia (crocifissi), carichi di un forte significato salvifico e spesso ricavati dalla fusione di oggetti preesistenti, come nel caso delle quattro croci in lamina d’oro rinvenute tra i corredi delle tombe di età bizantina presso la cripta della basilica di S. Lussorio (Fordongianus), due delle quali ricavate dalla fusione di due tremissi d’oro di Liutprando (712-744) (Spanu, 1998 p. 74). Tra gli enkolpia si segnala il celebre esemplare rinvenuto presso la chiesa di S. Vittoria di Telti, con iconografia del Christus triumphans e datato da Paolo Benito Serra e Roberto Coroneo tra l’VIII e il IX secolo (Caprara, 1986 pp. 52-53; Pisanu, 2004 p. 502; Coroneo, 2011 pp. 278, 298-299; Pala, 2011 p. 140). Su croci ed enkolpia si veda infine Peroni, 1984 pp. 229-297. Anche per i campanellini, per lo più in lega di rame e originariamente impiegati come oggetti da gioco, si riscontra un utilizzo come elementi di corredo con finalità apotropaiche, sia in contesti funerari della Sardegna (es. Pani Loriga-Santadi: Serra, 1995 pp. 387-396; Serra, 2001 tav. V, 5a-g; Serra, 2002c p. 215. S. Lussorio-Selargius: Manunza, 2006 p. 87; Serra, 2008 p. 341. Sa Domu ‘eccia-Uras: Serra, 2002a pp. 149, 151-153; Serra, 2002b pp. 212-213; Salvi & Serra, 2002 p. 162. Is Cirredis-Villaputzu: Salvi & Serra, 1990; Martorelli, 2003 p. 307; Serra, 2008 p. 341; Bacco et al., 2010 p. 1423) sia in contesti peninsulari (Salvetti, 1978 pp. 117-118). Un manufatto di particolare interesse è emerso durante le indagini archeologiche svoltesi tra il 1984 e il 1986 presso la chiesa di S. Giuliano di Selargius (Cagliari), su una serie di sepolture medievali comprese nell’area del portico ad una profondità tra i m 0,45 e 0,60: si tratta di una placchetta rettangolare di ridotte dimensioni, in piombo e stagno, decorata con l’iconografia dei santi Pietro e Paolo e interpretata da Roberto Coroneo come una quadrangula, un’insegna di pellegrinaggio romeo (Serra et al., 1989 pp. 227-232; Coroneo, 2000a pp. 481-489; Martorelli, 2012 pp. 218-221). Il manufatto è stato collocato cronologicamente tra l’XI e il XII secolo in base allo studio delle tipologie di deposizione (fosse monosome) e all’analisi stilistica dei corredi. Appartiene ad una categoria di manufatti metallici diffusa in età altomedievale ed utilizzata dai fedeli come “attestazione dell’avvenuto pellegrinaggio” (Zagari, 2005 pp. 158-159; Martorelli, 2012 pp. 201-204).
7 In diversi contesti (es. Su Nuraxi-Siurgus Donigala: Ugas & Serra, 1990 p. 111; Sa Domu ‘eccia-Uras e S. Lussorio-Selargius, cfr. nota 27) la presenza di monete costituisce il principale elemento su cui teorizzare ipotesi di datazione dei reperti.
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
745
strumenti da lavoro è stata riscontrata una presenza molto ridotta8.La possibilità di consultare un ampio patrimonio bibliografico ha messo in luce delle difficoltà per le quali è necessario fornire una premessa: non sempre i dati e i risultati di scavo sono stati riportati in modo univoco e spesso sono stati omessi particolari in merito alla descrizione dei reperti o alla stratigrafia; inoltre, la collocazione cronologica è risultata per lo più attribuita in base a criteri stilistici e di rado corroborata da ulteriori di contesto, rendendo ne-cessaria l’adozione di una certa cautela nel maneggiare le informazioni9. Le complesse modalità espositive e di reperimento dei dati hanno suggerito la creazione di un database, organizzato secondo un modello logico reticolare10 e costituito da records definiti in base ai diversi campi di ricerca: cronologia, localizzazione geografica, classe ed eventuali sottoclassi annesse11. Scopo pri-
È altrettanto frequente riscontrare ritrovamenti di monete non suffragati da dati sufficienti a comprendere il contesto e/o le modalità deposizionali (es. Vigna Sechi-Bosa: Guido, 2002 p. 169. Nuraghe Aiga-Abbasanta: Taramelli, 1929 p. 318; Guido, 2002 p. 169). Per un quadro esaustivo sui rinvenimenti di moneta altomedievale in Italia si rimanda a Arslan, 2005. Per la Sardegna cfr. Piras, 1980; Piras, 1989; Piras, 1996; Guido, 2002.
8 Sulla classe in esame si veda Martorelli, 1999 pp. 16-17; Zagari, 2005 p. 110 e ss. Tra le località oggetto della ricerca l’unica in cui si fa esplicita menzione di strumenti da lavoro è il sepolcreto altomedievale rinvenuto nell’agro di Laerru (Sassari), consistente in una numerosa serie di deposizioni maschili e femminili e studiato da Paolo Benito Serra in Serra & Salvi, 1990. Serra elenca, tra i materiali rinvenuti, anche “cesoie e una serie di strumenti da lavoro” senza fornire informazioni aggiuntive in merito alla foggia, la deposizione e lo stato di conservazione dei reperti.
9 Cfr. infra, nota 13.10 Il modello reticolare (o network) è un metodo di implementazione di un
database organizzato secondo un sistema di records (o registrazioni, oggetti contenenti campi o elementi e a loro volta racchiusi in una banca dati) e puntatori (elementi che consentono l’indirizzamento, idealmente simili alle query). L’interrogazione dei records tramite l’uso dei puntatori permette di elaborare i dati inseriti nel database per condurre delle ricerche specifiche.
11 Nel caso specifico dei metalli, gli elementi in base ai quali vengono generalmente classificati i reperti attengono alla morfologia, al tipo di metallo o lega impiegati e alle tecniche e/o agli strumenti impiegati nella lavorazione. Studiosi come Alessandra Molinari (Molinari, 1997 pp. 167-169) e Rossana Martorelli (Martorelli, 1999 pp. 14-19) hanno elaborato specifiche schede di sintesi delle caratteristiche
746 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
mario dell’archivio digitale è stato la strutturazione e il collegamento delle testimonianze reperite in bibliografia secondo un modello gestionale unico, gestito da un DBMS (DataBase Management System) in grado di effettuare interrogazioni sincroniche e diacroniche. Si è inoltre posta in rilievo l’accu-ratezza del dato archeologico, organizzando le località con rinvenimenti di reperti metallici in base alle informazioni tecniche fornite (US, quote, dati spaziali precisi)12. Tra le difficoltà emerse nel corso del reperimento dei dati, la prima riguar-da l’ampio spettro cronologico al quale i reperti sono associati; in mancanza di elementi quali monete o peculiarità riferibili (non sempre) ad aspetti più agevolmente inquadrabili, alcune sottoclassi sono inserite in un range che talvolta oltrepassa i duecento anni che, per quanto permetta la formulazione di ipotesi a livello generale, non consente di accedere ad uno standard infor-mativo più accurato, obbligando la ricerca archeologica postclassica ad ac-contentarsi di dati spesso insufficienti13. Soltanto recentemente l’apporto di
dei manufatti metallici al fine di garantire una più agevole e meglio utilizzabile classificazione. Sul problema si veda infine Zagari, 2005 pp. 45-51.
12 I siti per i quali è stata riscontrata una chiarezza soddisfacente nell’esposizione del dato archeologico sono: S. Maria-Tergu (Dettori, 2007 pp. 40-41); Su Nuraxi-Siurgus Donigala (cfr. nota 7); Anfiteatro romano-Fordongianus (Bacco et al., 2010 pp. 1391, 1413-1459); S. Lussorio-Selargius (cfr. nota 27); S. Giuliano-Selargius (Serra et al., 1989 pp. 227-232, 236-238; Coroneo, 2000a pp. 481-489).
13 Ciò emerge in particolare durante la consultazione delle pubblicazioni realizzate a partire dalla seconda metà del XX secolo. Si veda l’esempio di S. Maria di Mesumundu a Siligo: Guglielmo Maetzke nel 1965 definisce “di epoca tarda con possibilità di scendere anche al IV-V secolo” i materiali relativi al corredo di una tomba a fossa addossata al muro perimetrale del complesso delle terme romane di Siligo, successivamente trasformato in chiesa e consacrato come S. Maria di Bubalis-Mesumundu (cfr. Maetzke, 1958 pp. 360-363; Maetzke, 1965 pp. 307-314). Diversi anni dopo Roberto Caprara propone di datare il nucleo originale dell’edificio al VI secolo, ma non si pronuncia in merito all’effettiva datazione dei materiali rinvenuti in seguito agli scavi del Maetzke, limitandosi a fornirne una descrizione oggettiva (Caprara, 1988 pp. 401-404). Poco più tardi Donatella Salvi cita gli anelli digitali recuperati a Siligo come principale elemento di confronto per analoghi esemplari provenienti dalla località di Bruncu ‘e S’Olia (Serdiana-CA) e recuperati occasionalmente nel corso dei primi del Novecento (Salvi & Serra, 1990), ma anche in questo caso il confronto è
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
747
studiosi quali Paolo Benito Serra e Roberto Coroneo ha permesso di compiere un passo avanti nella ricerca sarda, attraverso la progressiva “globalizzazione” dei contesti in un’ottica non più ristretta alla Sardegna ma attenta ai fenomeni socio-economici e insediativi sviluppatisi in Italia e nel mondo mediterraneo; in quest’ottica sono stati condotti confronti ad ampio raggio con la cultu-ra materiale proveniente dal deposito medievale della Crypta Balbi (Roma)14, dalle necropoli di Nocera Umbra (Perugia)15, Cividale (Udine) (Ahumada Sil-va, 2010 pp. 14-15; De Marchi, 2011) e Castel Trosino (Ascoli Piceno)16.Paolo Benito Serra ha avanzato l’ipotesi che per alcune tra le fibbie di cin-tura a placca “ad U” di tipo bizantino, generalmente collocate entro l’VIII secolo17, si possa formulare un avanzamento di cronologia arrivando anche ai primi del IX. Nel corso dello studio su alcuni manufatti relativi al corredo funebre del sepolcreto altomedievale di Su Pardu (o su Padru, Sestu), Serra ha concentrato la sua attenzione su un esemplare di pregevole fattura di fibbia a placca “ad U” non traforata, in ottone, raffigurante un volatile, probabilmente
impostato sul piano morfologico e stilistico, senza dati certi o meglio utilizzabili per la formulazione di una cronologia affidabile.
14 Sui risultati emersi in seguito alle indagini archeologiche si veda Guidobaldi, 1999 pp. 69-70, 77 per la bibliografia specifica sulla Crypta; Arena et al., 2001 e in ultimo Zagari, 2005 pp. 190-191 per una scheda di sintesi.
15 Si vedano Paroli, 1997; Rupp, 1997.16 Delogu, 1980 pp. 111-168; Bierbrauer, 1984 pp. 445-508; von Hessen, 1993 pp.
382-383. Tra l’ampia letteratura riguardo alla necropoli di Castel Trosino, si segnalano in particolare Ricci et al., 1995; Giostra, 2007 pp. 319-324 per un inquadramento cronologico e contestuale degli oggetti di corredo funebre rinvenuti nella necropoli longobarda di Castel Trosino, anche in rapporto alle tipologie tombali; Paroli & Ricci, 2007;
17 Le fibbie di cintura “ad U” costituiscono la classe di fibbie di cintura bizantine maggiormente diffusa in Sardegna, con una relativa omogeneità territoriale. Il loro range cronologico di diffusione parte dal VII secolo fino al IX secolo inoltrato; tra gli esemplari più importanti, all’VIII secolo risalgono quelli rinvenuti presso: Sa Domu ‘eccia-Uras; Su Nuraxi-Siurgus Donigala; Pani Loriga-Santadi; loc. Tiriu-Uri (Rovina, 2000 p. 44); nuraghe S. Vito-S. Vito (Lilliu, 1993 p. 119); Tissi (Maetzke, 1958 pp. 356-357; Rovina, 1986 pp. 54-55; Salvi & Serra, 1990). Si veda Coroneo, 2011 per un quadro di sintesi sulle principali caratteristiche della classe e i suoi esemplari più importanti in Sardegna.
748 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
un’anatra secondo Coroneo18, con lunga coda, laccio al collo e fiore nel becco (Coroneo, 2011 p. 294, scheda 5.11) (fig. 1). L’esemplare, attualmente custodito presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, è stato studiato anche da Letizia Pani Ermini nel corso della stesura dell’inventario dei manufatti alto-medievali dello stesso Museo19. La studiosa collocò l’oggetto al VI-VII secolo come prodotto di bottega bizantina (Pani Ermini & Marinone, 1981 p. 106); le analisi condotte da Serra hanno permesso di scorgere presso la placca dell’ar-diglione una serie di incisioni (fig. 2) che lo studioso, come Roberto Caprara prima di lui, ha interpretato come un monogramma in lettere greche piuttosto che una croce rimandante all’ambito copto come invece era stato suggerito da Letizia Pani Ermini20. Tramite confronti paleografici è stata riconosciuta l’invocazione Θεοτόκε βοήθε(ι), formula dedicatoria indirizzata alla Vergine e presente in Sardegna in due anelli facenti parte della Collezione Spano (pri-vi di dati di giacitura) rinvenuti rispettivamente ad Orroli ed in una località indeterminata dell’isola e datati da Serra tra il VII e l’inizio del IX secolo in base a parallelismi concernenti la forma del cassone, analogo anche a quello di tre esemplari rinvenuti fuori stratigrafia nel sepolcreto mediobizantino (VII-VIII secolo) di Bruncu ‘e s’Olia (Serdiana)21. Su Pardu ha restituito anche un
18 Roberto Coroneo nell’analisi delle peculiarità stilistiche dell’esemplare riprodotto sulla fibbia sarda si concentra sul lembo di stoffa intorno al collo dell’animale e sulla vaporosità della sua coda, ravvisando similitudini con il repertorio animalistico sassanide successivo al VI d.C. e diffuso in Occidente tramite il commercio delle stoffe pregiate e della seta proveniente dall’Oriente (Coroneo, 2000b pp. 188-189).
19 Letizia Pani Ermini aveva interpretato l’animale riprodotto sulla placca della fibbia di Su Pardu come un pavone, ritratto prospiciente una palma (Pani Ermini & Marinone, 1981 p. 106).
20 La studiosa già intuiva si potesse trattare di un monogramma e, nell’osservare un segno composto da una circonferenza di ridotte dimensioni connessa ad un simbolo cruciforme, aveva ravvisato, seppur con la dovuta cautela, una croce di ambito copto (Pani Ermini & Marinone, 1981 p. 106). Pochi anni dopo Roberto Caprara ha ripreso l’interpretazione fornita ma riconoscendo nel segno di dubbio significato un nesso omicron-tau, da considerare per lo scioglimento del monogramma, rivelatosi come una formula invocativa o alla Vergine (Θεοτόκε βοήθε(ι) o all’Onnipotente (Κύριε βοήθει) (Caprara, 1986 p. 398).
21 Cfr. nota 13. La ricerca bibliografica ha permesso di individuare ritrovamenti di anelli digitali (nella quasi totalità a cassone con perlina in pasta vitrea) in oltre dieci
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
749
esemplare di spatha a lama lunga, che Serra ha interpretato come appartenen-te “all’orizzonte longobardo-romanzo” e successivamente collocato cronolo-gicamente all’VIII secolo pieno, anche in virtù delle caratteristiche comuni del manufatto rispetto ad altri esemplari di foggia analoga rinvenute in varie località della Sardegna22.
località della Sardegna, relativamente ad un contesto funerario e in un arco cronologico generalmente compreso tra il VII e l’ultimo scorcio dell’VIII secolo: i manufatti rinvenuti risultano per lo più realizzati in bronzo e dotati di cassone contenente una perlina di pasta vitrea (spesso mancante per il degrado subito dal reperto nel tempo); tra i rinvenimenti più importanti si segnala l’anello d’oro rinvenuto presso la cella C del vano I delle Domus de Janas “Giorre Verdi” in loc. La Crucca (Sassari), con castone cilindrico, in origine completo di perlina in pasta vitrea, con verga decorata con un motivo a due volute di filo godronato racchiudente granuli aurei (Serra, 1978 pp. 9-10); dalla tomba n. 33 di Tharros (Cabras) proviene un anello nuziale aureo decorato a niello con iscrizione a caratteri greci (Serra, 1998 p. 348 e ss.). Presso S. Maria di Mesumundu-Siligo e Is Cirredis-Villaputzu sono stati recuperati anelli in argento. Per un quadro esaustivo sulla diffusione degli anelli digitali bizantini in Sardegna, si rimanda a Salvi & Serra, 2002; Bacco et al., 2010 p. 1430.
22 La spatha fa parte dell’equipaggiamento dei fanti e dei militari impiegati durante l’alto medioevo e si ritrova in contesti longobardi e bizantini (Serra & Salvi, 1990; Possenti, 1998 p. 201). Tra i pochi esemplari di spathae rinvenuti in Sardegna si segnalano due esemplari, entrambi a lama lunga a doppio taglio e con codolo trapezoidale. Il primo manufatto, fortemente frammentario e rinvenuto in un sepolcreto a poca distanza dall’abitato di Laerru (Sassari), è stato studiato da Otto von Hessen, il quale ha proposto un parallelismo con esemplari rinvenuti nei corredi funebri delle necropoli altoitaliche, compresi in un arco cronologico dal VI alla fine del VII secolo (von Hessen 1975, pp. 147-148; von Hessen, 1983 p. 33; von Hessen, 1990 p. 178; Possenti 1998, pp. 201-204; Serra, 2005a p. 470); Paolo Benito Serra, sulla base della presenza tra gli elementi del corredo di Laerru di “monete dell’orizzonte bizantino, longobardo e carolingio” (cit. Serra & Salvi, 1990) e in particolare di un tremisse aureo del sovrano longobardo Liutprando (712-744) (cfr. Serra, 2005a p. 480) ha proposto un avanzamento di cronologia per la spatha fino almeno all’VIII secolo. L’ipotesi è stata successivamente ribadita e rafforzata dai risultati delle indagini condotte da Serra presso il nuraghe Sa Domu ‘eccia di Uras (Oristano), dove il corredo relativo ad una sepoltura all’interno della torre D del complesso, comprendente anche una spatha (seppur a lama più corta rispetto all’esemplare sassarese), è stato associato al rinvenimento in strato di due tremissi aurei longobardi relativi a conii di Astolfo
750 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
A partire dagli anni Novanta del XX secolo le indagini archeologiche condot-te presso alcuni monumenti di età nuragica hanno portato al rinvenimento di tracce di occupazione successiva, per lo più funeraria, da attribuire all’età postclassica ed altomedievale23; sono state messe in luce numerose tombe col-lettive attribuibili a comunità composte da soldati e dalle loro famiglie. È il caso del nuraghe polilobato “Sa Domu Beccia” di Uras (OR), sottoposto a una serie di campagne di scavo tra il 1992 e il 1993 (Serra, 2002a pp. 149, 151-153; Serra, 2002b). Tra i reperti ritrovati all’interno della torre D (figg. 3-4) spic-cano sei fibbie di cintura, pertinenti al corredo di un inumato maschile: esse consistono in quattro esemplari del tipo a placca traforata, due “Corinto”24 e due “Balgota”25, più due “ad U” complete di anello ed ardiglione (Serra, 2002a
(749-756) e Desiderio (756-774). Sull’esemplare di moneta carolingia rinvenuto presso il sepolcreto di Laerru si vedano Taramelli 1905, p. 121; Dessì 1908, p. 308; Serra 2005a, p. 480.
Sulla seconda spatha, proveniente da Serrai-Serri (Cagliari), si è soffermato Paolo Benito Serra proponendo un confronto stilistico con un esemplare rinvenuto presso la tomba U della necropoli di Castel Trosino (Salvi & Serra, 1990; Ricci et al., 1995 p. 231) ma mantenendo anche per questa una datazione analoga a quella di Laerru e gli esemplari rinvenuti presso il nuraghe Sa Domu ‘eccia. Sulle spathae in Sardegna, si veda Serra, 2002a; Serra, 2002d; Serra, 2005a.
23 Il tema del riuso dell’architettura nuragica in età tardoromana e postclassica è stato affrontato nel corso di uno specifico convegno, dal titolo “Daedaleia. Le torri nuragiche oltre l’età del bronzo”, tenutosi a Cagliari dal 19 al 21 aprile 2012.
24 Le fibbie di cintura di tipologia “Corinto” (denominazione in base a caratteristiche formali, coniata da Joachim Werner in Werner, 1955 e utilizzata ancora oggi) fanno parte della categoria di fibbie a placca traforata. Per quanto si ritenga che l’origine della tipologia sia da ricercarsi in ambito orientale, diversi studiosi hanno ipotizzato l’esistenza di botteghe locali in Sardegna, Sicilia e Salento (cfr. Attolico, 2010 p. 67 per un quadro di sintesi sulle pubblicazioni in merito) successivamente al ritrovamento di fibbie “Corinto” caratterizzate da varianti formali diffuse in areali ridotti. In Sardegna è attestata una variante della tipologia “Corinto” a placca mobile, presente a partire dal VII secolo (es. Linna Perunta-S. Andrea Frius; Su Nuraxi-Siurgus Donigala; Santa Vittoria-Serri; S. Giovanni Battista-Nurachi. Per la bibliografia esaustiva sulle località elencate si veda Santoni et al., 1987 p. 83 e ss.) fino agli esemplari rinvenuti presso il nuraghe Sa Domu ‘eccia, datati all’VIII secolo inoltrato in virtù dell’associazione stratigrafica con i tremissi aurei longobardi.
25 La denominazione “Balgota” identifica una sottoclasse di fibbie a placca
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
751
pp. 149, 151-153; Serra, 2002b pp. 212-213; Salvi & Serra 2002, p. 162). Ancora più importante è che all’interno della torre D sono stati ritrovati due tremissi aurei longobardi, di Astolfo (749-756) e Desiderio (756-774)26 (figg. 5-6). L’as-sociazione stratigrafica tra le emissioni monetali e le fibbie di cintura ha per-messo di confermare per gli esemplari “ad U” una datazione corrispondente al pieno VIII secolo, e in parallelo di avanzare una cronologia recenziore per le fibbie a placca traforata, possibilità suggerita anche dai risultati dei recenti scavi condotti da Maria Rosaria Manunza presso la necropoli di età medievale posta in luce nella lottizzazione Salux contermine alla chiesa romanica di S. Lussorio di Selargius27. Nella tomba II, c.d. “Tomba della Cintura”, localiz-
dotata di traforatura centrale la cui diffusione parte dal VI secolo (Coroneo, 2011 p. 290) ma subisce una progressiva inflessione negativa rispetto alle altre sottoclassi; la sua attestazione in contesti della Sardegna rientranti nell’ambito cronologico della ricerca appare piuttosto ridotta e nella totalità dei casi esaminati non sono state rispettate le doverose metodologie scientifiche di scavo, pertanto i risultati sono inattendibili. Da scavi clandestini condotti presso il nicchione parietale di sinistra della camera principale del nuraghe Armungia, presso il paese omonimo della provincia di Cagliari, è emerso un esemplare di fibbia “Balgota” (cfr. Santoni, 1995 pp. 15-24). Altri manufatti della medesima sottoclasse sono attualmente custoditi presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e l’Antiquarium Arborense (vedi Pani Ermini & Marinone, 1981; Serra, 1998).
26 I quattro esemplari rinvenuti presso la torre D del nuraghe Domu ‘eccia risalgono all’epoca dei sovrani longobardi Astolfo (749-756) e Desiderio (756-774), e in base alla classificazione proposta in Grierson & Blackmour, 2007 p. 64 risulterebbero tremissi del III o IV tipo: due presentano sul recto la scritta DN AISTULF REX e sul verso la raffigurazione di S. Michele Arcangelo (III tipo), gli altri due sono caratterizzati da una stella sul recto e da una croce potenziata sul verso, unita alla scritta DN DESIDERIUS REX e nome della zecca di produzione (variante del IV tipo). Per un quadro d’insieme sulla monetazione bizantina e sulla diffusione delle varie emissioni, tra cui i tremissi, si vedano Grierson, 1961a; Grierson, 1961b. Per un quadro generale sulla monetazione bizantina, si veda Panvini Rosati, 1992 pp. 534-536. L’associazione stratigrafica delle monete rinvenute al Domu ‘eccia di Uras è stata confermata dallo stesso Serra dopo una apposita richiesta di chiarimento da parte di chi scrive. Si veda, inoltre, Serra, 2005b, pp. 727-745.
27 Sulla chiesa romanica di S. Lussorio a Selargius (Cagliari) si osservi in particolare Serra, R. 1989 pp. 347-348; Coroneo, 1993 scheda n. 73; Coroneo, 2005 p. 95.
752 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
zata presso il lotto 33 e compresa nell’US 2001, è stata ritrovata una fibbia di cintura in bronzo a placca traforata di tipo “Bologna”28 (fig. 7), per la quale è stata proposta una datazione all’inizio dell’VIII secolo grazie alla presenza in strato di un tesoretto di monete bizantine il cui esemplare più recente è di tipologia “mezzo follis”29 attribuibile a Tiberio III di Bisanzio, detto Absìmaro (698-705) (Manunza, 2006 p. 97). In base a quanto enunciato finora, per le fib-bie ad “U” sembrerebbe plausibile l’attribuzione all’VIII pieno, possibilmente oltrepassandone la seconda metà; relativamente alle “Corinto”, alle “Bologna” e alla classe delle fibbie “a placca traforata” in generale, per quanto inizialmen-te attribuite al VI-VII secolo e non oltre30, lo stato dei risultati a seguito delle indagini archeologiche recenti potrebbe far sperare in un avanzamento della cronologia permettendo di collocarle all’interno dell’orizzonte di VIII secolo, ciò grazie all’associazione dei manufatti con le emissioni monetali bizantine e longobarde. È bene tenere a mente tuttavia che, anche se comprovata da asso-ciazioni stratigrafiche, la presenza di monete potrebbe riferirsi ad un utilizzo come beni tesaurizzabili, non necessariamente coevi alla sepoltura31, permet-
28 La sottoclasse “Bologna”, piuttosto rara in Sardegna, comprende un particolare insieme di fibbie di cintura realizzate in maniera tale da ricavare l’anello e la placca dalla medesima porzione di metallo. L’arco cronologico si orienta di norma intorno al VII secolo. Per una carta di diffusione sintetica delle fibbie in questione nell’isola, si osservi Manunza, 2006 pp. 98-99.
29 L’esemplare invenuto presso la tomba II/US 2001 presenta sul recto la figura dell’imperatore Tiberio III Absimaro (698-705) ritratto stante e armato di lancia, e sul verso le due lettere SK, da intendere rispettivamente come la sigla identificativa della zecca sarda (=Sardinia) e il valore della moneta stessa (Manunza, 2006 p. 97). Sulle peculiarità del follis e sul suo utilizzo come moneta di scambio in età bizantina, si veda Arslan, 1998. Sulla zecca sarda (più precisamente a Cagliari), sulla sua reale esistenza e sulle peculiarità delle emissioni bizantine in Sardegna cfr. nota 34.
30 Si vedano Werner, 1955; Pani Ermini & Marinone, 1981; von Hessen, 1983.31 La datazione tramite associazione tra manufatti ed emissioni monetali,
possibilmente comprovata da associazioni stratigrafiche, costituisce una possibilità valida per fornire una cronologia che non sia indicativa, ma il più delle volte ridotta ad un raggio di pochi anni. Tuttavia, la moneta non costituisce un elemento datante infallibile, a causa della “vocazione alla tesaurizzazione” che può falsare eventuali ragionamenti sulla sua diffusione e conseguentemente sullo status economico dei suoi utenti; ad esempio, un conio ad emissione ridotta può subire un’alta percentuale
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
753
tendo di tollerare la formulazione di un postulato secondo cui l’eventuale te-soretto rinvenuto in un contesto di ambito funerario fornirebbe dunque un termine a partire dal quale sarebbe avvenuta la deposizione in tomba, ma non una cronologia assoluta per i manufatti in contesto32. Sarebbe consigliabile mantenere un certo livello di cautela prima di considerare le datazioni ivi for-nite perfettamente affidabili; ciò eviterebbe la creazione di assiomi o postulati di dubbia valenza scientifica. Pur se interessate dalle difficoltà esposte precedentemente, le monete costi-tuiscono la preponderante maggioranza dei reperti in metallo in grado di attestare il passaggio tra VIII e IX secolo, per quanto talvolta i dati archeo-logici risultino carenti poiché le pubblicazioni di natura numismatica spesso tralasciano i particolari che potrebbero interessare all’archeologo33. Gli stu-diosi sardi di numismatica si sono interrogati per diversi anni sull’effettiva esistenza di una zecca bizantina in Sardegna, le cui emissioni sarebbero state contraddistinte dalla lettera S e avrebbero accusato una costante flessione in negativo della produzione a partire dall’VIII secolo a causa delle incursioni
di tesaurizzazione e giungere ai giorni nostri in più esemplari rispetto ad un altro conio (Arslan, 1998 p. 383) o, per via della sua preziosità, essere destinato a diventare un “tesoro” con valenza funeraria rispetto ad altre monete (per esempio in argento, bronzo o rame) più adatte ad un uso come moneta circolante (Arslan, 1998 p. 387).
32 A questo proposito Caterina Giostra ha dimostrato come non siano infrequenti i casi in cui manufatti più antichi vengono sepolti insieme ad oggetti con cronologie assai differenti, ad esempio presso le necropoli di Romans d’Isonzo, Povegliano, Trezzo sull’Adda-S. Martino, Leno-Campo Marchione, Goito, Testona, Collegno, S. Albano Stura, Spilamberto, oltre alle già citate Nocera Umbra e Cividale del Friuli. Si veda Giostra, 2011 pp. 10-24.
33 È il caso di una “piccola ma importantissima collezione” consistente in un discreto numero di monete di età bizantina rinvenute in varie località del Sassarese e appartenuta a “un noto studioso di numismatica sarda” di cui viene omesso il nome (Piras, 1989 pp. 93-108), della collezione Amadu di Ozieri-Sassari (cfr. Guido, 1989 pp. 86-92; Guido, 2002 p. 167) o ancora, parte della collezione Lulliri di Domus de Maria-Cagliari (Biamonti, 1996 pp. 234-254). I dati utili all’archeologo, quali la stratigrafia, il contesto di rinvenimento o i processi deposizionali, spesso risultano fortemente carenti o omessi, pertanto risulta di notevole complessità formulare ragionamenti sul “ruolo sociale” della moneta.
754 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
arabe34. Per quanto il dibattito risulti di complicata risoluzione per la mancan-za di informazioni storiche ed archeologiche in merito, i risultati della ricerca hanno rivelato un discreto numero di testimonianze monetarie in Sardegna, diffuse in maniera complessivamente omogenea nel territorio dell’isola35. Un
34 In merito all’esistenza o meno di una Zecca bizantina in Sardegna i pareri e le opinioni sono state spesso contrastanti. Già Philip Grierson riflettè sull’esistenza di una zecca cagliaritana definendola “non esattamente parlando, una zecca italiana”, poiché dall’osservazione delle monete riscontrò alcune analogie con le emissioni africane; lo studioso ipotizzò che a seguito della capitolazione di Cartagine, nel 695, la zecca dell’Esarcato d’Africa sarebbe stata trasferita a Cagliari, continuando a battere moneta con le matrici africane almeno per altri venticinque anni; unico segno distintivo sarebbe stata “una grande S nel campo del rovescio” (Grierson, 1961a pp. 39-40). Secondo Carlo Meloni e Diego Ricotti Prina l’emissione di monete bizantine d’oro in terra sarda avrebbe avuto inizio prima, nel periodo della crisi delle istituzioni giustinianee, durante il regno di Maurizio Tiberio (582-602) (Meloni, 1969 p. 6; Ricotti Prina, 1972 p. 18); tale ipotesi fu ritenuta non condivisibile da G. Campazzi e G. Graziano a causa della mancanza di testimonianze in grado di provare quanto sostenuto. Seppure fosse entrata in funzione una zecca a Cagliari, per ora parrebbe non documentabile in quanto tali monete non manifesterebbero segni distintivi tanto marcati da permettere un loro riconoscimento rispetto ad altre produzioni (Campazzi & Graziano, 1975 pp. 1-13). Enrico Piras si è dimostrato favorevole all’esistenza della zecca: nel corso dello studio su un tesoretto di monete altomedievali provenienti da varie località del Sassarese (cfr. nota 106) ha riscontrato che la quasi totalità dei manufatti di età bizantina presenta sul verso la lettera S, che lui ha interpretato come l’abbreviazione di Sardinia (Piras, 1989 pp. 100-101). L’ipotesi è stata successivamente ripresa da Franco Panvini Rosati (Panvini Rosati, 1996 pp. 9-10). Anche Maria Rosaria Manunza menziona la zecca sarda in Manunza, 2006 p. 97.
35 Le località nelle quali sono state rinvenute testimonianze di monete bizantine sono: Nuraghe Losa-Abbasanta (Serra, 1993 p. 166), Nuraghe Aiga-Abbasanta, Tharros-Cabras, Su Nuraxi-Siurgus Donigala, Anfiteatro romano-Fordongianus, S. Lussorio-Selargius, loc. Ruinas-Ozieri, Chiesa di S. Giovanni-Ossi, loc. Parte Sole-Posada (Guido, 1986b pp. 57-58), Is Cirredis-Villaputzu, Terme romane/Palazzo di Re Barbaro-Porto Torres, Vigna Sechi-Bosa; a ciò si aggiungano i manufatti monetari custoditi presso il Museo Civico di Ozieri, quelli inclusi nelle collezioni Lulliri-Domus de Maria e Amadu-Ozieri e infine due rinvenimenti effettuati dal canonico Giovanni Spano in agro di Porto Torres (Spano, 1857 p. 156; Guido, 2002 p. 169) e Cagliari (Spano, 1872 p. 5; Guido, 2002 p. 169).
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
755
importante rinvenimento è il già citato tesoretto ritrovato presso la Lottiz-zazione Salux di Selargius, all’interno della tomba II (US 2001)36; altrettanto interessante risulta il gruzzolo rinvenuto presso Ozieri, località Ruinas, in cir-costanze sconosciute (Guido, 2002 p. 167).Oltre alle bizantine si annoverano testimonianze di monete longobarde37, come il tesoretto del nuraghe Domu ‘eccia di Uras (Serra, 2002a pp. 149, 151-153; Serra, 2002b pp. 212-213; Salvi & Serra, 2002 p. 162) o quello costituito da tredici tremissi d’oro di Liutprando (712-744) raccolti insieme ad emissioni bizantine di VIII secolo e scoperto nei primi del XX secolo presso la chiesa di S. Giovanni di Ossi (Guido, 2002 p. 167). È opportuno ricordare anche i tre-missi d’oro di Liutprando localizzati rispettivamente all’interno della Domus I del complesso sepolcrale prenuragico di Fenosu-Oliena (Lo Schiavo, 1989 p. 171) e presso la necropoli con preesistenze romane di Is Cirredis-Villaputzu (Martorelli, 2003 p. 307; Serra, 2008 p. 1423). Al IX secolo vanno ascritte quat-tro monete appartenenti alla collezione Lulliri e riferibili ad emissioni di Co-stantino VI (780-797) e Leone V l’Armeno (813-820) (Biamonti, 1996 pp. 244-245), oltre al tesoretto rinvenuto presso le Terme Romane di Porto Torres, c.d. Palazzo di Re Barbaro38, consistente in trentasette solidi di Teofilo (829-842), Basilio I il Macedone (867-886) e Costantino IX Monomaco (1042-1055) (Ta-ramelli, 1922 p. 294; Guido, 2002 p. 169; Pinna, 2010 p. 26). Nella medesima località Taramelli segnalava la presenza di tre monete arabe del primo anno di regno dell’Emiro aghlabida Abū Ibrāhīm Ahmad (856-863)39, uno degli
36 Manunza, 2006 p. 97. Cfr. nota 27.37 Le località nelle quali sono state rinvenute testimonianze di monete
longobarde sono: S. Lussorio-Fordongianus (Spanu, 1998 p. 74), Nuraghe Losa-Abbasanta, S. Giovanni-Ossi, Nuraghe Sa Domu ‘eccia-Uras, Domus de Janas Fenosu-Oliena, Is Cirredis-Villaputzu; in ultimo si segnala l’esistenza di un tremisse aureo di Liutprando (712-744) proveniente da Oliena (senza ulteriori informazioni) e attualmente custodita presso il Museo Nazionale “G. A. Sanna” di Sassari (Guido, 1986a p. 57).
38 Sul complesso si veda Spanu, 1998 pp. 107-109. Per una panoramica generale su Porto Torres e sulle fasi inerenti la tarda antichità si osservi, tra le numerose pubblicazioni consultabili, Mastino, 1992 pp. 9-72; Caprara, 1992 pp. 73-80; Rovina, 1995 pp. 145-158.
39 Gli Aghlabidi costituirono all’inizio del IX secolo d.C. la prima dinastia musulmana autonoma all’interno del califfato abbaside (la cui dinastia governò il
756 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
importanti rinvenimenti arabi attestati in Sardegna assieme ad altri di natu-ra numismatica rinvenuti a Sassari (loc. Argentiera) (Taramelli 1922, p. 294; Castellaccio, 1996 pp. 44, 56, nota 102), Olbia40 e Assemini41. Per il X secolo, il canonico Spano nel 1871 riportava il rinvenimento presso Cagliari di due mo-nete bronzee di Giovanni Tzimisce (969-976) (Spano, 1872 p. 5; Guido, 2002 p. 169); merita di essere segnalato anche il tesoretto di duecento denari lucchesi d’argento di Ottone III di Sassonia (996-1002), emerso a seguito dei lavori di ristrutturazione di un antico edificio del centro storico di Sassari ed attual-mente conservati nel Museo Nazionale “G. A. Sanna” della stessa città (Castel-laccio, 1996 pp. 44, 56, nota 103). La testimonianza numismatica bizantina più tarda nell’ambito cronologico di questa ricerca sembrerebbe riferirsi alle due
mondo islamico dalla sua sede di Baghdad fra il 750 e il 1258, si veda Abun-Nasr, 1987). Per una bibliografia aggiornata sui rapporti tra gli Arabi e la Sardegna e le testimonianze archeologiche a riguardo si veda Pinna, 2010.
40 Roberto Caprara segnala l’esistenza di numerosi “aurei bizantini non studiati” e provenienti da varie collezioni private olbiensi (Caprara, 1986 p. 53). Su Olbia tardoantica si veda Spanu, 1998 pp. 114-119; per una interpretazione sull’evoluzione urbanistica di Olbia durante l’età medievale e per una cronistoria della città stessa si veda Cadinu, 2001 pp. 91-94. Da Olbia provengono anche due brocche in bronzo, datate al VII secolo su base stilistica, di cui una decorata a bulino e due con ansa terminante con protome umana stilizzata, rinvenute presso un sepolcreto di età bizantina localizzato tra i resti di una preesistente villa romana, tra C.so Umberto e C.so Garibaldi (Pisanu, 2004 pp. 495-503). Altri esemplari di brocche bronzee, tutte ascritte in un range cronologico compreso tra il VII e l’VIII secolo, provengono da S. Pietro di Sorres-Borutta (Maetzke, 1959 pp. 657-658; Caprara, 1988 p. 399; Serra, 2000 p. 499), loc. Su Cungiau ‘e Funtà-Nuraxinieddu (Serra, 1998 pp. 351 e ss.), loc. Bruncu ‘e s’Olia-Serdiana (Salvi & Serra, 1990), oltre agli esemplari appartenenti al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (Pani Ermini & Marinone, 1981 p. 93 e ss.) e il celebre acquamanile bronzeo custodito presso la Pinacoteca Nazionale della medesima città (Serra et al., 1990 pp. 19, 24 scheda n. 6; Pala, 2011 pp. 65, 133); infine, la necropoli di Scoglio Lungo in loc. Balai presso Porto Torres ha restituito un esemplare di brocca in rame, datata anch’essa tra il VII e l’VIII secolo. Per ulteriori informazioni sulle brocche in rame rinvenute in Sardegna si rimanda a Serra, 1976 p. 19, nota 42.
41 Si osservi Pinna, 2010 p. 26 e ss. per un quadro d’insieme sui rinvenimenti monetari islamici altomedievali in Sardegna. Si veda anche il contributo di Fois in questi stessi Atti.
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
757
emissioni di Costantino X Ducas (1059-1067) e alle due di Michele VII Ducas (1078-1090), custodite presso il Civico Museo Archeologico di Ozieri ma prive di dati relativi alle condizioni di rinvenimento in quanto provenienti dalla ormai ex collezione privata Amadu (Guido, 2002 p. 167). Dai risultati della ricerca emergerebbe un quadro di diffusione dei manufat-ti metallici interessato da una progressiva inflessione negativa a partire dal passaggio tra VIII e IX secolo; tuttavia, qualora l’associazione cronologica tra le emissioni monetali e i manufatti metallici rinvenuti nelle stratigrafie di al-cune località quali il nuraghe Domu ‘eccia di Uras si rivelasse esatta, risulte-rebbe agevole ritenere che anche nei “Secoli Bui” sia perdurata nell’isola una qualche forma di controllo da parte di Bisanzio, manifestatosi sotto diversi punti di vista, non solo militare ma probabilmente amministrativo, come di-mostrerebbe il rinvenimento di numerosi sigilli bizantini presso S. Giorgio di Cabras (Oristano), alcuni dei quali relativi a incarichi di natura statale in uso presso la corte e la cancelleria romea anche nel corso del IX secolo42. Tra i manufatti in esame spiccano i sigilli arcontali di Zerchis ed Orkotor, rivelatisi personaggi strettamente connessi alla prima fase dell’età giudicale43. Sebbene a parere di chi scrive uno studio sui manufatti e sulle loro associazio-ni e specificità contestuali possa costituire un promettente punto di partenza su cui strutturare ipotesi per la ricerca futura, appare manifesto che la que-stione della presenza bizantina in Sardegna (nei modi e nei tempi) mantenga comunque un elevato grado di complessità dove la maggior parte degli indica-tori selezionati, certamente interessanti, provengono da contesti che, in effetti, chiariscono proprio la complessità più che fornire risposte definitive. Pertan-to, lo studio dei reperti metallici e le problematiche emerse a seguito della ricerca renderebbero necessaria, per una più corretta mission archeologica, l’adozione di una strategia improntata sulla maggiore attenzione al rappor-
42 Si veda Spanu & Zucca, 2004 p. 102 e ss. per l’elenco dei sigilli rinvenuti in Sardegna e relativi a cariche dell’amministrazione centrale e provinciale dell’impero bizantino.
43 Sui sigilli arcontali di Zerkis e Orkotor si veda Spanu & Zucca, 2004 pp. 145-147. Durante lo svolgimento del Convegno di Studi Pier Giorgio Spanu e Piero Fois hanno menzionato l’esistenza di un terzo sigillo arcontale, recante il nome di Torbeno. Per informazioni dettagliate si rimanda al contributo di Pier Giorgio Spanu e Piero Fois in questi stessi Atti.
758 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
to rinvenimento/contesto ai fini di una comprensione più puntuale del dato emerso; sarebbe auspicabile una maggiore specificità nell’analisi contestuale, delle dinamiche socio-economiche e insediative, differenti a seconda del con-testo in cui l’archeologo è chiamato a operare, oltre all’applicazione di una diversa metodologia d’azione scandita da modalità di project management differenti a seconda delle caratteristiche del luogo o delle condizioni di gia-citura (operando una distinzione tra contesti in base alle diverse meccaniche socio-antropologiche e alle caratteristiche del territorio in cui è localizzato il reperto).Nell’ottica di un approccio multidisciplinare un’interessante prospettiva di ricerca vedrebbe l’apporto dell’archeometria44, previa conoscenza da parte dell’archeologo dei fondamenti della disciplina a livello tale da evitare che analisi di laboratorio effettuate senza la dovuta competenza conducano ad av-valorare premesse in realtà erronee. L’approccio archeometrico si rivelerebbe utile per approfondire il tema delle modalità di produzione e diffusione dei manufatti da un punto di vista non solo quantitativo ma qualitativo, coadiu-vato dall’apporto di discipline quali l’archeologia del territorio, della produ-zione e l’archeometallurgia45, quest’ultima recentemente beneficiaria di una notevole considerazione soprattutto a partire dagli studi condotti da Riccardo Francovich nel sito di Rocca San Silvestro (Campiglia Marittima)46. In Sarde-
44 Le tecniche archeometriche più utili per lo studio dei manufatti metallici sono la SIMS (Secondary Ions Mass Spectrometry, per lo studio delle scorie), o le tecniche spettroscopiche Auger (per conoscere lo sviluppo dei fenomeni di corrosione sulle leghe del rame) e Mössbauer (per lo stato di ossidazione del ferro sulle patine di degradazione dei manufatti metallici). Sull’approccio teorico all’archeometria in Italia si veda in particolare Mannoni & Giannichedda, 1996 pp. 49-54; per approfondimenti sulle modalità di attuazione, Mannoni, 1988; Leute, 1993; Giannichedda, 2005.
45 L’archeometallurgia si interessa dei processi produttivi della metallurgia, dall’estrazione del minerale al prodotto finito, e dei fenomeni di circolazione e consumo dei metalli; la disciplina propone la ricostruzione della storia sociale degli impianti estrattivi e produttivi. Si vedano Francovich ed., 1993; Mannoni & Giannichedda, 1996 p. 61 e ss.; Giardino, 1988; La Salvia, 2000; Zagari, 2005 p. 38 e ss., p. 171 e ss. per l’elenco dei principali impianti metallurgici medievali attualmente rinvenuti in Italia e infine, specificatamente in rapporto a Rocca San Silvestro e all’archeologia del potere in rapporto al controllo dello sfruttamento delle risorse minerarie, Farinelli, 2007.
46 Sul sito in esame, tra le numerose pubblicazioni, si vedano Francovich, 1985;
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
759
gna un valido esempio può essere costituito dal complesso abbaziale di Tergu (Sassari) per la presenza, nell’ambiente 2000/10 (datato tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo sulla base di scavi stratigrafici condotti da Domin-go Dettori), di scorie metalliche in lega di rame connesse ad una cassaforma destinata al contenimento di matrici per la fusione del metallo (Dettori, 2007 pp. 40-42). Come segnala Francesca Zagari, la presenza di officine metallurgi-che nell’ambito dei monasteri altomedievali peninsulari è largamente attesta-ta sia da fonti documentarie (Monastero di S. Columbano a Bobbio)47 che da ritrovamenti archeologici (S. Vincenzo al Volturno)48; nel caso di Tergu ci si troverebbe di fronte ad attività metallurgica di età premonastica e, se si tiene conto della cronaca medievale risalente al XIII secolo nota come Liber (o Libel-lus) Iudicum Turritanorum, che descrive la chiesa come commissionata dalla famiglia giudicale Turritana nell’XI49, uno studio sul rapporto tra commit-tenza giudicale e attività metallurgica in Sardegna potrebbe costituire un’al-tra promettente prospettiva di ricerca. La possibilità di venire a conoscenza della produzione e dei relativi processi formativi costituisce per l’archeologo un indubbio vantaggio, utile per definire meglio l’occupazione del territorio e le meccaniche che regolavano la vita dei suoi abitanti. Nel caso della Sardegna
Cima, 1991 pp. 87, 126-133; Mannoni & Giannichedda, 1996 pp. 311-313. Per una scheda di sintesi, si rimanda a Zagari, 2005 pp. 185-186.
47 Nel caso del celebre monastero di S. Columbano a Bobbio (Piacenza) si apprende, da un breve memoriationis dell’abate Wala (in carica dall’833 all’855), che esisteva uno schema organizzativo finalizzato alla gestione delle risorse del monastero e delle officine per la realizzazione dei manufatti necessari, tra cui “omnia ferramenta” (Zagari, 2005 p. 99). Su Bobbio si veda Segagni Malacart, 1992.
48 Presso il monastero di S. Vincenzo al Volturno (Isernia) nel corso delle indagini archeologiche condotte durante gli anni Novanta del XX secolo sono state individuate le officine relative al cantiere della chiesa di S. Vincenzo Maggiore (759-825), tra cui un impianto destinato alla fusione del rame e del bronzo. La serie di ambienti allungati ad est del sopracitato edificio sacro (Mitchell, 1999 p. 318) è stata interpretata come officina permanente, destinata alla lavorazione di materiali diversi tra cui i manufatti metallici. Su S. Vincenzo al Volturno cfr. Chr. Vult.; Mitchell, 1999; Mitchell, 2003; Zagari, 2005 pp. 192-193.
49 Nel Liber (Besta, 1906 p. 3) si legge che la chiesa di S. Maria sarebbe stata edificata per volontà del cognato del giudice Mariano I di Torres (1073-1082) nell’XI secolo (… et isu frade de sa mugere fedit a Santa Maria de Tergu). Dettori, 2007 p. 19.
760 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
altomedievale l’approccio multisettoriale può costituire un valido modo per poter “leggere” più proficuamente i dati emersi, oltre ad un interessante crite-rio per affrontare quelli che stanno emergendo ed emergeranno.
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
761
BIBLIOGRAFIA
Abun-Nasr, J.M. 1987. A History of the Maghrib in the Islamic period. Cambrid-ge: University Press.
Ahumada Silva, I. 2010. La collina di San Mauro a Cividale del Friuli: dalla necro-poli longobarda alla chiesetta bassome-dievale. Ricerche di archeologia altome-dievale e medievale, 35-36. Archeologia a Cividale, studi e ricerche, 1. Borgo S. Lorenzo: All’Insegna del Giglio.
Arena, M.S., Delogu, P., Paroli, L., Ricci, M., Saguì, L. & Vendittelli, L. 2001. Roma. Dall’antichità al Medioevo: arche-ologia e storia nel Museo Nazionale Ro-mano Crypta Balbi. Milano: Electa.
Arslan, E. 1998. Mutamenti di funzione e struttura degli stock monetari in Europa tra V e VIII secolo. In Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichita e alto Medioevo. Settimane di Studio del Centro italiano studi sull’alto Medioevo, XLV (Spoleto, 3-9 aprile 1997). Spoleto: presso la sede del Centro, pp. 379-460.
Arslan, E. 2005. Repertorio dei ritrovamen-ti di moneta Altomedievale in Italia (489-1002). Testi, studi, strumenti, 18. Spole-to: Fondazione Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo.
Bacco, G., Ganga, T., Oppo, C., Serra, P.B., Vacca, M., Zanella, R.M. & Zuc-ca, R. 2010. Structores amphitheatri. A proposito dell’anfiteatro di Forum Traia-ni (Sardinia). In M. Milanese, P. Ruggeri & C. Vismara eds., I luoghi e le forme dei mestieri e della produzione nelle provin-ce africane. Atti del XVIII convegno su L’Africa Romana (Olbia, 11-14 dicembre 2008). Roma: Carocci, pp. 1371-1459.
Besta, E. 1906. Il Liber Iudicum Turrita-norum. Con altri documenti logudoresi. Palermo: The New York.
Biamonti, G. 1996. Monete vandaliche e bizantine dalla Collezione Lulliri. Qua-derni della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano 13, 233-254.
Bierbrauer, V. 1984. Aspetti archeologici di Goti, Alamanni e Longobardi. In G. Pugliese Garratelli ed., Magistra Barba-ritas. I barbari in Italia. Milano: Credito Italiano, pp. 445-508.
Cadinu, M. 2001. Urbanistica medievale in Sardegna. Civitates, 4. Roma: Bonsigno-ri.
Campazzi, G. & Graziano, G. 1975. Con-tributo all’inquadramento storico della monetazione sardo-bizantina. Quaderni dell’Associazione Numismatica Sarda, 2, pp. 1-20.
Caprara, R. 1978. Reperti metallici alto-medievali. In Sardegna centro-orientale: dal Neolitico alla fine del mondo antico. Nuoro, Museo civico speleo-archeologi-co. Mostra in occasione della XXII Riu-nione scientifica dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprinten-denza ai Beni Archeologici per le pro-vincie di Sassari e Nuoro. Sassari: Dessì, pp. 217-221.
Caprara, R. 1986. Nuoro, tomba a polian-dro. In A. Boninu et al., L’archeologia tardo-romana e medievale nella Sarde-gna centro-settentrionale. In L’archeolo-gia romana e altomedievale nell’Orista-
762 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
nese. Atti del Convegno (Cuglieri, 22-23 giugno 1984). Taranto: Scorpione, pp. 33-61.
Caprara, R. 1988. L’età altomedievale nel territorio del Logudoro-Meilogu. In A. Moravetti ed., Il nuraghe S. Antine nel Logudoro-Meilogu. Sassari: Carlo Delfi-no, pp. 397-441.
Caprara, R. 1992. Turris Libisonis romana. In M. Crillissi, G. Rum & R. Caprara eds., Porto Torres e il suo volto. Sassari: Carlo Delfino, pp. 73-80.
Castellaccio, A. 1996. Sassari medievale. Sassari: Carlo Delfino.
Cima, M. 1991. Archeologia del ferro. Siste-mi materiali e processi dalle origini alla Rivoluzione industriale. Archeologia & Ambiente, I. Torino: Nautilus; Brescia: Grafo.
Contu, E. 1972. Giorre Verdi. Rivista di Scienze Preistoriche 27 (1), 471-472.
Coroneo, R. 1993. Architettura romanica dalla metà del Mille al primo ’300. Storia dell’Arte in Sardegna. Nuoro: Ilisso.
Coroneo, R. 2000a. Segni e oggetti del pel-legrinaggio medievale in Sardegna. L’età Giudicale. In L. D’Arienzo ed., Gli anni santi della storia. Atti del Convegno (Cagliari, 16-19 ottobre 1999). Cagliari: AV, pp. 481-489.
Coroneo, R. 2000b. Scultura mediobizanti-na in Sardegna. Nuoro: Ilisso.
Coroneo, R. 2005. Chiese romaniche della Sardegna: itinerari turistico-culturali. Cagliari: AV.
Coroneo, R. 2011. Arte in Sardegna dal 4 alla metà dell’11 secolo. Cagliari: AV.
P. Corrias & S. Cosentino eds., Ai confini dell’Impero: storia, arte e archeologia del-la Sardegna bizantina. Cagliari: M&T.
D’Oriano, R. 1986. Nuoro, Galtellì, Necro-poli medievale presso la Cattedrale di San Pietro. In A. Boninu et al., L’archeologia tardo-romana e medievale nella Sardegna centro-settentrionale. In L’archeologia romana e altomedievale nell’Oristanese. Atti del Convegno (Cuglieri, 22-23 giu-gno 1984). Taranto: Scorpione, pp. 33-61.
Delogu, P. 1980. Il regno longobardo. In P. Delogu, A. Guillou, G. Ortalli & G. Ga-lasso eds., Storia d’Italia, I: Longobardi e Bizantini. Torino: UTET, pp. 2-216.
De Marchi, M. 2011. Circolazione e varie-tà di influenze culturali nelle necropoli longobarde di VI e VII secolo: l’esempio di Cividale del Friuli. In C. Ebanista & M. Rotili eds., Archeologia e storia delle migrazioni. Europa, Italia Mediterraneo fra tarda età romana e alto medioevo. Atti del Convegno internazionale di stu-di (Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 17-18 giugno 2010). Giornate sulla tarda antichità e il medioevo, 3. Napoli: Tavo-lario Edizioni, pp. 275-298.
Dessì, V. 1908. I tremissi longobardi. A pro-posito di un piccolo ripostiglio di mone-te d’oro di Liutprando rinvenuto presso il villaggio di Ossi-Sassari. Rivista Italia-na di Numismatica 20, 295-311.
Dettori, D. 2007. Abbazia di S. Maria di Tergu: le fasi premonastiche. In L. Pani Ermini ed., Committenza, scelte insedia-tive e organizzazione patrimoniale nel Medioevo. Atti del Convegno (Tergu, 15-17 settembre 2006). De Re Monastica, 1. Spoleto: Fondazione Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo, pp. 9-51.
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
763
Farinelli, R. 2007. I castelli della Toscana delle città “deboli”. Dinamiche del popo-lamento e del potere rurale nella Toscana meridionale (secoli VII-XIV). Firenze: All’insegna del Giglio.
Francovich, R. 1985. Un villaggio di mina-tori e fonditori del metallo nella Toscana del medioevo: San Silvestro (Campiglia Marittima). Archeologia Medievale: cul-tura materiale, insediamenti, territorio 12, 313-401.
Francovich, R. ed. 1993. Archeologia del-le attività estrattive e metallurgiche: V ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia. Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle arti dell’U-niversità di Siena, 32-33.
Giannichedda, E. 2005. Archeometria fra scienza e storia. In B. Fabbri, S. Gualtieri & G. Volpe eds., Tecnologia di lavorazio-ne e impieghi dei manufatti. Atti della VII Giornata di archeometria della cera-mica (Lucera, 10-11 aprile 2003). Insulae Diomedae, 1. Archeometria della cera-mica, 7. Bari: Edipuglia, pp. 11-20.
Giardino, C. 1998. I metalli nel mondo an-tico: introduzione all’archeometallurgia. Manuali Laterza, 105. Roma: Laterza.
Giostra, C. 2007. Luoghi e segni della mor-te in età longobarda: tradizione e tran-sizione nelle pratiche dell’aristocrazia. In G. P. Brogiolo & A. Chavarria eds., Archeologia e Società tra Tardo Antico e Alto Medioevo. Documenti di Archeolo-gia, 44. Mantova: Società Archeologica, pp. 311-344.
Giostra, C. 2010. Le croci in lamina d’oro: origine, significato e funzione. In M. Sannazaro & C. Giostra eds., Petala Au-
rea. Lamine di ambito bizantino e longo-bardo dalla Collezione Rovati. Catalogo della Mostra (Monza, 15 dicembre 2010-16 gennaio 2011). Monza: Johan & Levi Editore, pp. 129-141.
Giostra, C. 2011. Goths and Lombards in Italy: the potential of archaeology with respect to ethnocultural identification. Post Classical Archaeologies, 1, pp. 7-37.
Grierson, P. 1961a. Monete bizantine in Italia dal VII all’XI secolo. In Moneta e scambi nell’alto Medioevo. Settimane di Studio del Centro italiano studi sull’al-to Medioevo, VIII (Spoleto, 21-27 aprile 1960). Spoleto: presso la sede del Centro, pp. 35-55.
Grierson, P. 1961b. Coinage and money in the Byzantine Empire 498-1090. In Mo-neta e scambi nell’alto Medioevo. Setti-mane di Studio del Centro italiano studi sull’alto Medioevo, VIII (Spoleto, 21-27 aprile 1960). Spoleto: presso la sede del Centro, pp. 411-453.
Grierson, P. & Blackmour, M. 2007. Me-dieval European Coinage (MEC), I, The Early Middle Ages (5th–10th Centuries). Cambridge: University Press.
Guido, F. 1986a. Oliena, moneta longobar-da. In A. Boninu et al., L’archeologia tar-do-romana e medievale nella Sardegna centro-settentrionale. In L’archeologia romana e altomedievale nell’Oristane-se. Atti del Convegno (Cuglieri, 22-23 giugno 1984). Taranto: Scorpione, pp. 33-61.
Guido, F. 1986b. Un tremisse bizantino da Parte Sole. In A. Boninu et al., L’ar-cheologia tardo-romana e medievale nella Sardegna centro-settentrionale.
764 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
In L’archeologia romana e altomedie-vale nell’Oristanese. Atti del Convegno (Cuglieri, 22-23 giugno 1984). Taranto: Scorpione, pp. 33-61.
Guido, F. 1989. Le monete. In Lilliu, G. & Atzeni, E., pp. 86-92.
Guido, F. 2002. Note sulla monetazione sardo-bizantina. In P Corrias, P. & Co-sentino, S. eds., pp. 165-170.
Guidobaldi, F. 1999. Roma. Storia, urba-nistica, architettura. In Enciclopedia dell’Arte Medievale, 10. Milano: Centro Grafico Ricordi, pp. 63-77.
von Hessen, O. 1974. Byzantinische Schnal-len aus Sardinien im Museo Archeolo-gico zu Turin. In G. Kossack & G. Ul-bert eds., Studien zur Vor- und Frühge-schichtlichen Archäologie. Festschrift für Joachim Werner zum 65. Geburtstag. II. Munchen: C.H. Beck, pp. 546-556.
von Hessen, O. 1975. Langobardische Fun-de aus Sardinien. Archäologisches Korre-spondenzblatt 5, 147-148.
von Hessen, O. 1983. Il materiale altome-dievale delle collezioni Stibbert di Firen-ze. Ricerche di Archeologia Altomedie-vale e Medievale, 7. Borgo S. Lorenzo: All’insegna del Giglio.
von Hessen, O. 1990. Il Costume Maschile. In G. Menis ed., I Longobardi. Catalogo della Mostra (Passariano-Cividale del Friuli, 2 giugno-30 settembre 1990). Mi-lano: Electa, pp. 178-201.
von Hessen, O. 1993. Castel Trosino. In En-ciclopedia dell’Arte Medievale, 4. Mila-no: Centro Grafico Ricordi, pp. 382-383.
La Salvia, V. 2000. Archeometallurgia. In R. Francovich & D. Manacorda eds., Di-
zionario di Archeologia. Roma-Bari: La-terza, pp. 18-24.
Leute, U. 1993. Archeometria: un’introdu-zione ai metodi fisici in archeologia e in storia dell’arte. Studi NIS archeologia, 24. Roma: NIS.
Lilliu, G. 1990. Sopravvivenze nuragiche in età romana. In A. Mastino ed., Atti del VII convegno di studio su L’Africa romana (Sassari, 15-17 dicembre 1989). Sassari: Edizioni Gallizzi, pp. 415-446.
Lilliu, G. 1993. Milizie in Sardegna duran-te l’età bizantina. In L. D’Arienzo ed., Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed età moderna: studi storici in memoria di Alberto Boscolo. Roma: Bulzoni, pp. 105-135.
Lilliu, G. & Atzeni, E. eds. 1989, L’Anti-quarium Arborense e i civici musei ar-cheologici della Sardegna. Sassari: Banco di Sardegna.
Lo Schiavo, F. 1989. Oliena. L’età Storica. In Lilliu, G. & Atzeni, E., p. 171.
Maetzke, G. 1958. Fibbie barbariche da Tissi e Siligo. Studi Sardi 16, 357-363.
Maetzke, G. 1959. Scavi e scoperte nelle provincie di Sassari e Nuoro 1959-1961. Studi Sardi 17, 651-663.
Maetzke, G. 1965. Siligo (Sassari): resti di edificio romano e tombe di epoca tardo imperiale intorno a S. Maria di Meso-mundu. Notizie degli Scavi di Antichità, 307-314.
Mannoni, T. 1988. Introduzione all’arche-ometria. In T. Mannoni & A. Molinari eds., Scienze in archeologia: II ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in arche-ologia. Quaderni del Dipartimento di
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
765
Archeologia e Storia delle arti dell’Uni-versità di Siena 20-21, 27-39.
Mannoni, T. & Giannichedda, E. 1996. Archeologia della produzione. Torino: Einaudi.
Manunza, M.R. 2006. Recenti scavi nella lottizzazione “Salux” presso S. Lussorio-Selargius, campagne di scavo 2001-2003. Relazione preliminare. Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le pro-vince di Cagliari e Oristano 22, 87-130.
Martorelli, R. 1999. Scheda per il ma-teriale metallico. In L. Ermini Pani & S. Del Lungo eds., Leopoli-Cencelle I. Le preesistenze. Tardo Antico e Medio Evo. Studi e strumenti di archeologia, I. Roma: Palombi, pp. 14-19.
Martorelli, R. 2003. Proposte metodo-logiche per un uso dei corredi funerari come fonte per la conoscenza dell’età tardoantica e medievale in Sardegna. In S. Lusuardi Siena ed., Fonti arche-ologiche e iconografiche per la storia e la cultura degli insediamenti nell’alto-medioevo. Atti delle giornate di studio (Milano-Vercelli, 21-22 marzo 2002). Contributi di Archeologia, 3. Milano: V&P, pp. 301-321.
Martorelli, R. 2012. Martiri e devozione nella Sardegna altomedievale e medieva-le. Archeologia, Storia, Tradizione. Pon-tificia Facoltà Teologica della Sardegna. Studi e Ricerche di Cultura Religiosa. Testi e Monografie, 1. Cagliari: PFTS University Press.
Mastino, A. 1992. Turris Libisonis romana. In M. Crillissi, G. Rum & R. Caprara eds., Porto Torres e il suo volto. Sassari: Carlo Delfino, pp. 9-72.
Meloni, C. 1969. La Sardegna: monetazio-ne di Bisanzio. Bollettino Numismatico, 6, 6.
Mitchell, J. 1999. San Vincenzo al Voltur-no. In Enciclopedia dell’Arte Medievale, X. Milano: Centro Grafico Ricordi, pp. 318-322.
Mitchell, J. 2003. San Vincenzo al Voltur-no: the Archaeology of the Arts and Magic at an Early Medieval Monastery. In I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento. Atti del XVI Congresso in-ternazionale di studi sull’alto Medio-evo (Spoleto-Benevento, 20-27 ottobre 2002). Spoleto: Fondazione Centro ita-liano di studi sull’alto Medioevo, pp. 1099-1124.
Molinari, A. 1997. I metalli. In A. Molina-ri ed., Segesta, II. Il castello e la moschea (scavi 1989-1995). Segesta: ricerche sto-rico-archeologiche, II. Palermo: Flacco-vio, pp. 167-180.
Moravetti, A. 1980. Nuovi materiali dalla voragine di Ispinigoli. In A. Boninu ed., Dorgali: documenti archeologici. Sassari: Chiarella, pp. 165-171.
Mureddu, D. 2002. L’area archeologica di S. Lucia ad Assolo (OR). In Spanu, P.G. ed., pp. 497-504.
Pala, A. 2011. Arredo liturgico medievale: la documentazione scritta e materiale in Sardegna tra IV e XIV secolo. Cagliari: AV.
Pandolfi, A. 2002. Indagini archeologiche nella parrocchiale di S. Giulia a Padria (SS). In Spanu, P.G. ed., pp. 512-518.
Pani Ermini, L. & Marinone, M. 1981. Museo Archeologico Nazionale di Ca-
766 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
gliari. Catalogo dei materiali paleocri-stiani e altomedievali. Roma: Libreria dello Stato.
Panvini Rosati, F. 1992a. Monetazione bi-zantina. In Enciclopedia dell’Arte Medie-vale, 3. Milano: Centro Grafico Ricordi, pp. 534-536.
Panvini Rosati, F. 1996. Introduzione. In E. Piras ed., Le Monete della Sardegna dal IV secolo a.C. al 1482. Sassari: Fon-dazione Banco di Sardegna, pp. 9-10.
Paroli, C. ed. 1997. L’Italia centro setten-trionale in età longobarda. Atti del Con-vegno (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995). Biblioteca di Archeologia Medievale, 13. Borgo S. Lorenzo: All’insegna del Giglio.
Paroli, L. & Ricci, M. 2007. La necropoli al-tomedievale di Castel Trosino. Catalogo. Ricerche di Archeologia Medievale e Al-tomedievale, 32-33. Firenze: All’insegna del Giglio.
Peroni, A. 1984. L’arte nell’età longobarda. Una traccia. In G. Pugliese Garratelli ed., Magistra Barbaritas. I barbari in Italia. Milano: Credito Italiano, pp. 229-297.
Pinna, F. 2010. Le testimonianze archeolo-giche relative ai rapporti tra gli Arabi e la Sardegna nel Medioevo. RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Medi-terranea 4, 11-37.
Piras, E. 1980. Manuale delle monete me-dioevali e moderne coniate in Sardegna. Sassari: Libreria Scientifica Internazio-nale.
Piras, E. 1989. Un ripostiglio di monete d’oro bizantine. Nuove ipotesi sulla mo-netazione aurea sardo-bizantina. Acta Numismatica 19, 93-108.
Piras, E. 1996. Le Monete della Sardegna dal IV secolo a.C. al 1482. Sassari: Banco di Sardegna.
Pisanu, M. 2004. Olbia dal V al X secolo. In A. Mastino & P. Ruggeri eds., Da Olbìa ad Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea. Atti del Convegno (Olbia, 12-14 maggio 1994). Sassari: Edes, pp. 495-503.
Pitzalis, G., Dettori, D. & Liscia, G. 2002. Anglona: rinvenimenti e scoperte. In Corrias, P. & Cosentino, S. eds., pp. 193-194.
Possenti, E. 1998. Le armi. In M. De Marchi & E. Possenti eds., Rocca di Monselice (Pd) - Le sepolture longobarde. In Sepol-ture tra IV e VIII secolo. Atti del 7° semi-nario sul tardo antico e l’alto medioevo in Italia centro settentrionale, (Gardone Riviera, 24-26 ottobre 1996). Documenti di Archeologia, 13. Mantova: Società Ar-cheologica, pp. 201-204.
Ricci, M., Profumo, M.C. & Paroli, L. eds. 1995. La necropoli altomedievale di Ca-stel Trosino: Bizantini e Longobardi nelle Marche. Catalogo della Mostra (Ascoli Piceno, 1-31 ottobre 1995). Ascoli Pice-no: Grafica Picena.
Ricotti Prina, D. 1972. La monetazione aurea delle zecche minori bizantine dal IV al IX secolo. Roma: P. & P. Santama-ria.
Rovina, D. 1986. Tissi. In A. Boninu et al., L’archeologia tardo-romana e medieva-le nella Sardegna centro-settentrionale. In L’archeologia romana e altomedie-vale nell’Oristanese. Atti del Convegno (Cuglieri, 22-23 giugno 1984). Taranto: Scorpione, pp. 33-61.
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
767
Rovina, D. 1995. Turris Libisonis: strutture romane e altomedievali nell’area della sede del Banco di Sardegna. In P.G. Spa-nu ed., Materiali per una topografia ur-bana: status quaestionis e nuove acqui-sizioni. Atti del V convegno sull’arche-ologia tardoromana e altomedievale in Sardegna (Oristano, 24-26 giugno 1988). Oristano: S’Alvure, pp. 145-158.
Rovina, D. 2000. La sezione medievale del Museo “G. A. Sanna” di Sassari. Piedi-monte Matese: Imago media.
Rovina, D. 2001. Insediamenti rurali tra an-tichità e medioevo: il sito di S. Filitica. In J.-M. Poisson ed., Archeologie et histoire de la Sardaigne médiévale:actualité de la recherche. Atti della Tavola Rotonda (Roma, 14-15 novembre 1997). Roma: École Française de Rome, pp. 10-26.
Rovina, D. 2002. Il complesso romano e altomedievale di S. Filitica di Sorso. In Spanu, ed. 2002, pp. 519-524.
Rupp, C. 1997. La necropoli longobarda di Nocera Umbra (loc. Il Portone): l’anali-si archeologica. In C. Paroli ed., L’Italia centro settentrionale in età longobarda. Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995). Biblioteca di Archeologia Medievale, 13. Firenze: All’insegna del Giglio, pp. 23-130.
Salvetti, C. 1978. Il catalogo degli ogget-ti minuti conservati presso la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Ri-vista di Archeologia Cristiana, 54, 103-130.
Salvi, D. 1990. Nuove testimonianze di età altomedievale nel territorio di Quartu S. Elena: Sa Funtanedda e S. Andrea. Qua-derni della Soprintendenza Archeologica
per le province di Cagliari e Oristano 7, 193-200.
Salvi, D. & Serra, P.B. 1990. Corredi tom-bali e oreficerie nella Sardegna altome-dievale. Quaderni didattici della Soprin-tendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano, 3.
Salvi, D. & Serra, P.B. 2002. La Gioielleria. In Corrias, P. & Cosentino, S. eds., pp. 159-163.
Santoni, V. 1995. L’attività della Soprinten-denza nel campo dell’archeologia tar-doromana e medievale nella Sardegna centro-meridionale. In V. Santoni ed., Carbonia e il Sulcis, Archeologia e terri-torio. Oristano: S’Alvure, pp. 15-24.
Santoni, V. 1996. La necropoli ipogeica di Sas Concas (Oniferi, Nuoro). In Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche. Atti del XIII Congres-so (Forlì, 8-14 settembre 1996). Forlì: A.B.A.C.O., pp. 114-121.
Santoni, V. 2000. La necropoli di Sas Con-cas, Oniferi (Nuoro). In L’ipogeismo nel Mediterraneo: origini, sviluppo, quadri culturali. Atti del Congresso Interna-zionale (Sassari-Oristano, 23-28 maggio 1994). Muros: Stampacolor, pp. 939-951.
Santoni, V., Bacco, G. & Serra, P.B. 1987. Lo scavo del nuraghe Candala di Sorra-dile (Oristano) e le indagini territoriali al lago Omodeo. Quaderni della Soprin-tendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano 1, 67-115.
Segagni Malacart, A. 1992. Bobbio. In Enciclopedia dell’Arte Medievale, 3. Mi-lano: Centro Grafico Ricordi, pp. 537-543.
768 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
Serra, P.B. 1976. Reperti tardoantichi e al-tomedievali dalla Nurra nel Museo Na-zionale G.A. Sanna di Sassari. Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le province di Sassari e Nuoro, 3.
Serra, P.B. 1978. Tomba a poliandro altomedievale di via Ballero, Nuoro. In Sardegna centro-orientale: dal Neolitico alla fine del mondo antico: Nuoro, Museo civico speleo-archeologico. Mostra in occasione della XXII Riunione scientifica dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza ai Beni Archeologici per le provincie di Sassari e Nuoro, pp. 217-221.
Serra, P.B. 1989. Exagia e Tesserulae nomi-nibus virorum laudabilium inscriptae di età bizantina della Sardegna. Archivio Storico Sardo 36, 46-76.
Serra, P.B. 1993. I materiali di età storica: dall’Alto Impero all’Alto Medioevo: secc. I-VII d.C. Quaderni della Soprin-tendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano 10 (Supplemento), 123-219.
Serra, P.B. 1995. Contesti tombali di età tardoromana ed altomedievale da San-tadi. In V. Santoni ed., Carbonia e il Sul-cis, Archeologia e territorio. Oristano: S’Alvure, pp. 381-476.
Serra, P.B. 1998. Ceramiche d’uso e prodot-ti dell’industria artistica minore del Si-nis. In La ceramica racconta la Storia. La ceramica nel Sinis dal Neolitico ai giorni nostri. Atti del II Convegno (Oristano-Cabras, 25-26 ottobre 1996). Cagliari: Condaghes, pp. 335-401.
Serra, P.B. 2000. Segni e oggetti del pelle-grinaggio medievale in Sardegna. L’alto medioevo. In L. D’Arienzo ed., Gli anni santi della storia. Atti del Convegno (Cagliari, 16-19 ottobre 1999). Cagliari: AV, pp. 431-465.
Serra, P.B. 2001. Elementi di cultura ma-teriale tardoromana e altomedievale da Sedilo (Oristano). In Associazione Cul-turale Filippo Nissardi ed., Architettura, arte e artigianato nel Mediterraneo dalla Preistoria all’alto Medioevo. Atti della Tavola Rotonda internazionale in me-moria di Giovanni Tore (Cagliari, 17-19 dicembre 1999). Oristano: S’Alvure, pp. 353-376.
Serra, P.B. 2002a. L’armamento. In Corrias, P. & Cosentino, S. eds., pp. 149-157.
Serra, P.B. 2002b. Uras: materiali dell’e-quipaggiamento dei guerrieri e dell’or-namento femminile dal nuraghe Domu Beccia. In Corrias, P. & Cosentino, S. eds., pp. 212-213.
Serra, P.B. 2002c. Santadi: tomba collettiva di Pani Loriga. In Corrias, P. & Cosenti-no, S. eds., p. 215.
Serra, P.B. 2002d. Serri: tomba di guerriero del sepolcreto di località Serrai. In Cor-rias, P. & Cosentino, S. eds., T, p. 201.
Serra, P.B. 2005a. Su una fibbia dell’oriz-zonte altogiudicale del sepolcreto di Su Pardu. In G. Mele ed., Chiesa, potere po-litico e cultura in Sardegna dall’età giudi-cale al Settecento. Atti del II Convegno (Oristano, 7-10 dicembre 2000). Orista-no: ISTAR, pp. 469-492.
Serra, P.B. 2005b. Su un ponte nuragico a Desulo e sugli insediamenti tardo-ro-mani e altomedievali di ambito rurale
I reperti metallici in Sardegna tra viii e xi secolo: problematiche e prospettive di ricerca
769
nell’isola. In La Civiltà Nuragica. Nuove acquisizioni (Senorbì, 14-16 dicembre 2000), I. Quaderni, Atti e Monografie della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano, 2, pp. 727-745.
Serra, P.B. 2008. Su alcune matrici in bron-zo di linguette altomedievali decorate a “punti e virgole” dalla Sardegna. In L. Casula, A. Corda & A. Piras eds., Orien-tis radiata fulgore. La Sardegna nel con-testo storico e culturale bizantino. Atti del Convegno di Studi (Cagliari, dicem-bre 2007). Cagliari: Pontificia Facoltà di Teologia della Sardegna, pp. 313-351.
Serra, P.B., Coroneo, R. & Serra, R. 1989. San Giuliano di Selargius. Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le pro-vince di Cagliari e Oristano 6, 227-259.
Serra, R. 1989. La Sardegna. Italia Romani-ca, 10. Milano: Jaca Book.
Serra, R., Maltese, C. & Coroneo, R. 1990. Pittura e scultura dall’età romani-ca alla fine del 500. Nuoro: Ilisso.
Spano, G. 1857-1858. Ultime scoperte. Bul-lettino Archeologico Sardo 3, 153.
Spano, G. 1865. Catalogo della raccolta ar-cheologica sarda del can. Giovanni Spa-no da lui donata al museo d’antichita di Cagliari. Monete e Medaglie. Cagliari: Tipografia Timon.
Spano, G. 1872. Scoperte archeologiche fat-tesi in Sardegna in tutto l’anno 1871 con appendice sugli oggetti sardi dell’esposi-zione italiana. Cagliari: Tipografia del Commercio.
Spanu, P.G. 1998. La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo. Mediterraneo tardoanti-
co e medievale. Scavi e ricerche, 12. Ori-stano: S’Alvure.
Spanu, P.G. ed. 2002. Insulae Christi: il cri-stianesimo primitivo in Sardegna, Corsi-ca e Baleari. Mediterraneo tardoantico e medievale: scavi e ricerche, 12. Oristano: S’Alvure
Spanu, P.G. & Zucca, R. 2004. I sigilli bizan-tini della Sardenia. Roma: Carocci.
Stefani, G. 1985. Le tombe: tipologia, anali-si, corredi. In Nurachi: storia di un’Eccle-sia. Oristano: S’Alvure, pp. 56-67.
Taramelli, A. 1905. Bizantina. Archivio Storico Sardo 1, 120-121.
Taramelli, A. 1922. Portotorres: scoperta di monete d’oro di età bizantina in re-gione Balai. Notizie degli Scavi di Anti-chità, 288-338.
Taramelli, A. 1929. XI. Abbasanta (Ghilar-za), Terzo di solido d’oro di Tiberio III Absimare, rinvenuto presso il Nuraghe Aiga. Notizie degli Scavi di Antichità, 318.
Ugas, G. & Serra, P.B. 1990. Complesso sepolcrale bizantino nel mastio del nu-raghe Su Nuraxi di Siurgus Donigala-Cagliari. In Le Sepolture in Sardegna dal IV al VII secolo. Atti del IV Convegno sull’archeologia tardoromana e me-dievale (Cuglieri, 27-28 giugno 1987). Mediterraneo tardoantico e medievale, scavi e ricerche, 8. Oristano: S’Alvure, pp. 107-131.
Usai, A. 1998. Scavi nelle tombe di giganti di Tanca ‘e Suei e di Tanca ‘e Perdu Cossu (Norbello, OR). Quaderni della Soprin-tendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano 15, 122-149.
770 Settecento-Millecento Storia, Archeologia e Arte nei “secoli bui” del Mediterraneo
Werner, J. 1955. Byzantinische Gürtel-schnallen des 6. und 7. Jahrhunderts aus der Sammlung Diergardt. Kölner Jahr-buch für Vor und Frühgeschichte I, 36-48.
Zagari, F. 2005. Il Metallo nel Medioevo. Tecniche Strutture Manufatti. TardoAn-
tico e MedioEvo. Studi e strumenti di archeologia, 2. Roma: Palombi.
Zucca, R. 1988. Il santuario nuragico di S. Vittoria di Serri. Sardegna Ar-cheologica: guide e itinerari, 7. Sassari: Carlo Delfino.
Fig. 1. Su Pardu (Sestu), sepolcreto altomedievale. Fibbia di cintura con placca “ad U” di tipo bizantino (da Serra, 2005a).Fig. 2. Su Pardu (Sestu), sepolcreto altomedievale. Fibbia di cintura con placca “ad U” di tipo bizantino, dettaglio della decorazione sulla placca dell’ardiglione (da Serra, 2005a).Fig. 3. Nuraghe Sa Domu ‘eccia (Uras), torre D, sepolcreto altomedievale. Fibbia di cintura con placca “ad U” di tipo bizantino (da Serra, 2005a).
1
3
2
Fig. 4. Nuraghe Sa Domu ‘eccia (Uras), torre D, sepolcreto altomedievale. Fibbia di cintura a placca tra-forata di tipologia “Corinto” (da Serra, 2005a).Figg. 5, 6. Nuraghe Sa Domu ‘eccia (Uras), torre D, sepolcreto altomedievale. Tremissi aurei di Astolfo (749-756, sup.) e Desiderio (756-774, inf.) (da Serra, 2005a).Fig. 7. Selargius (Cagliari), Lottizzazione Salux, chiesa di S. Lussorio, tomba II, US 2001. Fibbia di cintura a placca traforata di tipologia “Bologna” (da Manunza, 2006).
5 6
7
4