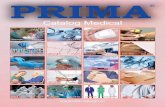Esposito-Pollini-Pottery and cultural borders in Magna Graecia and Sicily
D. Camardo-A. Esposito, I reperti in vetro dallo scavo della fossa settica dell’Insula Orientalis
-
Upload
herculaneum -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of D. Camardo-A. Esposito, I reperti in vetro dallo scavo della fossa settica dell’Insula Orientalis
Association Internationale pour l’Histoire du Verre
Comitato Nazionale Italiano
Ministerodei beni e delleattività culturalie del turismo
XVII Giornate Nazionali di Studio sul Vetro
IL VETRO IN ITALIA CENTRALEDALL’ANTICHITÀ
AL CONTEMPORANEO
Massa Martana e Perugia, 11-12 maggio 2013Atti a cura di
Luciana Mandruzzato, Teresa Medici, Marina Uboldi
Association Internationale pour l’Histoire du Verre
Comitato Nazionale Italiano
XVII Giornate Nazionali di Studio sul Vetro
IL VETRO IN ITALIA CENTRALEDALL’ANTICHITÀ
AL CONTEMPORANEO
Massa Martana e Perugia, 11-12 maggio 2013
Atti a cura di Luciana Mandruzzato, Teresa Medici, Marina Uboldi
Ministerodei beni e delleattività culturalie del turismo
Giornate realizzate da:Comitato Nazionale Italiano A.I.H.V. – Association Internationale pour l’Histoire du Verre
Con il patrocinio di:Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’UmbriaUniversità degli Studi di PerugiaRegione UmbriaComune di Massa Martana (PG)Centro Studi Alto Medioevo - Spoleto
Con il contributo di:Angelantoni Industrie S.p.A.Archimede Solar EnergyBruni Glass Calvi S.p.A.
Con la collaborazione di:Pro Loco di Massa Martana Comitato scientificoErmanno A.Arslan, Maurizio Buora, Maria Grazia Diani, Annamaria Larese, M.Giuseppina Malfatti, Luciana Mandruzzato,Sandro Pezzoli, Marisa Scarpignato, Francesca Seguso, M.Cristina Tonini, Marina Uboldi
Comitato organizzatoreM.Giuseppina Malfatti, Maria Grazia Diani, Luciana Mandruzzato, Sandro Pezzoli, Marisa Scarpignato
Coordinamento amministrativoGuido Zanin
Atti a cura diLuciana Mandruzzato, Teresa Medici, Marina Uboldi
Consiglio Direttivo 2014-2016Ermanno A. Arslan, Presidente onorarioMaria Grazia Diani, PresidenteLuciana Mandruzzato, Vice-PresidenteSandro Pezzoli, TesoriereSimone G. Lerma, SegretarioConsiglieriSilvia Ciappi, Teresa Medici, Marta Moretti, M.Cristina Tonini, Marina UboldiRevisori dei contiEnrico Bersellini, Mauro Favari
[email protected] 9788890729744
È vietata la riproduzione non espressamente autorizzata anche parziale o ad uso interno o didattico con qualsiasi mezzo effettuata.
In copertina: Coppe in vetro a mosaico, Todi (PG), necropoli di via Orvietana (Manconi, p. 21, Fig. 4. Fotografie Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologia dell'Umbria)
Indice
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7M. Giuseppina Malfatti - Maria Grazia Diani, Comitato Nazionale Italiano A.I.H.V.
Saluti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Maria Pia Bruscolotti, Sindaco di Massa Martana Federica Angelantoni, Archimede Solar Energy
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Mario Pagano, già Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Umbria
Il Castelliere di Monte Cerchio a Massa Martana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Carlo Ridolfi
Il vetro in Italia Centrale dall’Antichità al Contemporaneo
I vetri ellenistici della necropoli di Todi (PG), via Orvietana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Dorica Manconi
I reperti vitrei della Pieve di Pava: problematiche ed osservazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Elisa Rubegni
Ipotesi di un’officina vetraria di sectilia a Colle Oliva (Ciampino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Diego Blanco
Ricerche preliminari sui vetri rinvenuti nello scavo dell’insediamento rustico romano di Ca’ de’ Fabbri, Minerbio (BO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Valentino Nizzo - Cristina Draghici - Lisa Volpe
Caratterizzazione di vetri archeologici provenienti dal sito delle Piccole Terme di PalazzoValentini a Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Angelo Montenero - Giovanni Visco - Paola Baldassarri - Sara Capretti - Cinzia Petrini
Materiali vitrei dal Palazzo Estense di Ferrara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Chiara Guarnieri
Reliquiari del convento di San Damiano, Assisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85M.Cristina Tonini
Il vetro a Firenze nel XV e XVI secolo: tra arte e scienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Silvia Ciappi
Vetrai muranesi a Roma nel Seicento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Paolo Zecchin
La produzione storica del vetro a Piegaro e i resti dell’antico edificio industriale . . . . . . . . . . . . . . . 107Chiara Berichillo - Paolo Bracciali
5
Altre ricerche sul vetro
Nuovi reperti vitrei dal Bellunese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Annamaria Larese
Studio tipologico e carta di distribuzione dei balsamari a forma di colomba (Isings 11) nel territorio dell’attuale provincia di Pavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Maria Grazia Diani - Rosanina Invernizzi
I reperti in vetro dallo scavo della fossa settica dell’Insula Orientalis II di Ercolano . . . . . . . . . . . . 127Domenico Camardo - Angelo Esposito
La presenza di vetri alle finestre di edifici pubblici e privati nell’antica Ercolano . . . . . . . . . . . . . . 139Maria Paola Guidobaldi - Domenico Camardo - Angelo Esposito - Mario Notomista
La straordinaria metamorfosi dei vetri dorati in epoca costantiniana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Lucina Vattuone
Due bottigliette/balsamari con tracce di impagliatura dal Museo Archeologico Privato dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Giuseppe Schiavariello - Enrica Zambetta
Materiale vitreo dallo scavo del “Chiostro dei Canonici” presso il Duomo di Padova. Relazione preliminare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Alessandra Marcante
Tecnologia vetraria veneziana: i segreti del colore blu nei ricettari rinascimentali . . . . . . . . . . . . . . 163Marco Verità - Sandro Zecchin
Il Convento Francescano di S.Maria del Tempio (LE): suppellettile vitrea da spezieria e per la pratica medica tra XV e XVI secolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Patricia Caprino - Simona Catacchio
Lo specchio convesso nella pittura fiamminga: simbolismo, magia, scienza e arte fra realtà e trascendenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Maria Giuseppina Malfatti
La vetreria Venini di Varenna (Lago di Como). Storia di una industria ottocentesca dimenticata . . 189Marina Uboldi
Aggiornamenti per il Corpus dei bolli su vetro in Italia
Un vetro con bollo da Calvatone-Bedriacum (CR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Miriam Romagnolo
La bottiglia con scena gladiatoria e la coppa di Aristeas dalla Raccolta Archeologica “Antonio Strada” di Scaldasole (Pavia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Maria Grazia Diani - Rosanina Invernizzi
Note sui balsamari con bollo del gruppo patrimoni di produzione ravennate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Elisabetta Roffia
6
Il problema del ristagno delle acque meteorichenel sito dell’antica Ercolano è da sempre una dellecause principali di degrado delle strutture e degli ap-parati decorativi della città. Ormai da quasi dieci anni l’Herculaneum Conser-
vation Project, un’iniziativa del Packard HumanitiesInstitute in collaborazione con la Soprintendenza Spe-ciale per Pompei, Ercolano e Stabia e la British Scho-ol at Rome, sta lavorando per la messa in sicurezza edil restauro del sito1. Il progetto di un riutilizzo della fogna che corre,
parallelamente al V Cardo, immediatamente all’inter-no della facciata degli edifici dell’Insula Orientalis II,ci ha portato a realizzare il completo scavo della strut-tura (Fig. 1)2. Questa era stata già stata parzialmenteindagata da Amedeo Maiuri nel 1949.Al momento del nostro intervento nella porzione
della fogna scavata nel 1949 si erano accumulati circa1,5 m di sedimenti moderni trasportati dalle piogge. Abbiamo iniziato la rimozione di tale deposito con
l’intento di liberare completamente la fogna. Ben pre-sto ci siamo resi conto della presenza di un tratto dicirca 30 m che non era stato scavato nel 1949 ed eraancora totalmente occluso dal fango compatto del-l’eruzione del 79 d.C. Avendo completato la rimozio-
ne dello strato di fango dell’eruzione, abbiamo ora lacertezza delle dimensioni e dello sviluppo planimetri-co della fogna. La fogna è articolata in un braccio N-S ed uno E-
W. Il primo dato che colpisce sono proprio le sue di-mensioni, di gran lunga maggiori rispetto alle altre fo-gne di Ercolano, quali quella esistente sotto il III Car-do e quella recentemente individuata sotto la partemeridionale del IV Cardo. In entrambi i casi siamo difronte a condotti alti circa 1 m e larghi circa 60 cm. Il braccio N-S della fogna dell’Orientalis II è in-
vece largo 0,80 m, alto tra i 2 ed i 3,5 m e lungo 85,60m (Fig. 2). All’altezza del civico 2 in questo si innestail braccio E-W, che ha dimensioni ancora maggiorimisurando 1,70 m di larghezza, 3,20 m di altezza e20,90 m di lunghezza. Anche questo è coperto da unavolta perfettamente conservata nella quale si indivi-duano le impronte delle assi di legno della centina. La fogna mostra una struttura muraria in incerto di
tufo con ampie zone costruite in un reticulatum irre-golare tipico di Ercolano. In diversi punti si individua-no delle piccole zone con rifacimenti del paramento inopera reticolata.L’Insula Orientalis II fu costruita compensando il
doppio dislivello del terreno che da Nord andava ver-
Atti delle XVII Giornate Nazionali di Studio sul Vetro, Massa Martana e Perugia, 11-12 maggio 2013
Association Internationale pour l’Histoire du Verre - Comitato Nazionale Italiano
Domenico Camardo - Angelo Esposito
I reperti in vetro dallo scavo della fossa settica dell’Insula Orientalis II di Ercolano
Abstract
The excavation of the sewer of the “Insula Orientalis II” in Herculaneum led to the discovery of amazing finds coming fromthe discharges of latrines and kitchens of the insula. The objects were completely sealed by the layer of pyroclastic materials.This structure was built more like a huge septic tank than a sewer, since there was no exit into the sea; therefore it had tobe emptied periodically.The excavation allowed the recovery of a great quantity of organic material, but 170 boxes were filled with different objectsfallen or thrown into the pit, mostly coarse wares, cooking pots, “terra sigillata” and lamps. In many cases these objects arealmost intact because they were thrown into the sewer just after being broken. Among glass finds, almost all the forms ofFlavian period are recorded, but also types hitherto missing. The most common finds are beakers, cups and unguentaria,very widespread in the first century A.D. Furthermore, objects related to daily life (pyxis, game pieces and blue glass beads)were found as well.
Parole chiave - Keywords
Ercolano - fossa settica - vetroHerculaneum - sewer - glass finds
so Sud e dal V Cardo andava verso Est. Infatti il murodi facciata dell’Insula sul V Cardo non è altro che ilmuro W della fogna che parte circa 3 m al di sotto del-la strada. Il complesso dell’Insula Orientalis II fu costruito
in età tiberiano-claudia e fu strutturato come un vastoisolato di botteghe e abitazioni disposte su almeno trepiani, che si aprivano sul V Cardo, mentre verso l’in-terno si sviluppava la complessa struttura della pale-stra, con ampie sale di rappresentanza e di servizio.Per raccogliere gli scarichi delle latrine e delle cu-
cine di tutto l’isolato fu concepito, già in fase costrut-tiva, un complesso sistema che prevedeva la presenzadi latrine posizionate nell’angolo destro dopo l’in-gresso di ogni bottega che si affacciava sul V Cardo,e tubuli di terracotta inseriti nello spessore dei muriche portavano nella fogna gli scarichi delle latrine edelle cucine esistenti nei 3 piani di cui era compostal’Insula.Lo scavo complessivo della fogna ha permesso di
verificare che questa si sviluppava esattamente all’in-terno delle dimensioni dell’Insula Orientalis II, ini-ziando in corrispondenza del civico 14 e finendo incorrispondenza del muro Sud della bottega 1, che se-gna il confine dell’Orientalis II sul Vicolo meridiona-le (Fig. 1). Manca quindi qualsiasi condotto di scaricodei liquami verso il mare. Trovandoci di fronte ad un sistema chiuso questo
sembra assimilabile, piuttosto che una vera e propriafogna, ad una gigantesca fossa settica. Tale situazionepresuppone che la stessa fosse periodicamente svuo-tata utilizzando i numerosi pozzetti che si individuanosia nel braccio N-S che in quello E-W. Il contenuto
128
Fig. 1. Planimetria dell’Insula orientalis II con in evidenzail tracciato della fogna lungo il V Cardo. (PlanimetriaSANP con integrazioni di M. Brizzi per HCP).
Fig. 2. Ercolano-Fogna dell’Insula Orientalis II. Particola-re del braccio Nord-Sud durante le attività di scavo (FotoD. Camardo per HCP).
Fig. 3. Ercolano-Fogna dell’Insula Orientalis II. Lo scavoper quadrati di un metro di lato del sedimento della fogna(Foto D. Camardo per HCP).
della fossa settica, formato prevalentemente da mate-riale organico e scarichi di cucine, era probabilmenteutilizzato per la concimazione dei campi.Al momento dell’eruzione si era formato un depo-
sito di spessore compreso tra i 0,60-0,80 m nel brac-cio N-S ed oltre 1,35 m nel grande braccio E-W, doveconfluiva la pendenza dei piani di scorrimento dellafogna. Questi depositi furono sigillati dalla colata difango vulcanico nel 79 d.C. che danneggiò solo in mi-nima parte la struttura della fossa settica. Una volta ripuliti i tratti di fogna scavati nel 1949
abbiamo poi provveduto a rimuovere, con l’ausilio delmartello pneumatico, il fango vulcanico nei circa 30m dove non era stato scavato dal Maiuri, badando afermarci 5-10 cm al di sopra del deposito organico, inmodo che questo fosse protetto durante le operazionidi scavo. Lo scavo del deposito è stato realizzato sulla base
di quadrati di un metro di lato, in modo da poter ri-muovere stratigraficamente il sedimento e riferire glioggetti rinvenuti ai numerosi condotti e quindi allesingole botteghe o abitazioni dell’Insula Orientalis II(Fig. 3). I diversi strati, normalmente tre, di simile colore e
composizione, sono separati da un sottile strato disabbia. La giacitura dei reperti, orizzontale e con as-senza di tracce di erosione, conferma la natura pocodinamica dell’ambiente della fogna.Questo scavo ha permesso il recupero di oltre 170
cassette di reperti costituiti in maggior parte da cera-mica da fuoco e comune, sigillata, lucerne, vetri. In molti casi sono stati rinvenuti oggetti quasi in-
teri o ricostruibili perché gettati negli scarichi dellecucine immediatamente dopo essersi rotti (Fig. 4). Sono state ricuperati anche molti oggetti in bronzo
fortemente ossidati come brocche, lucerne, un anello,oltre sessanta monete in bronzo. Si segnalano inoltre
spilloni in osso lavorato, vaghi di collana, un castonedi anello in corniola con incisa una figura di Mercu-rio, tre gemme ed un anello d’oro con gemma che recaincisa l’immagine di una coppa.Per quanto riguarda il materiale vitreo, oggetto di
questo intervento, la quantità rinvenuta è notevole esono numerose le forme attestate. È stato possibile ricomporre molti oggetti, anche
se la maggior parte degli individui attestati si conservasolo parzialmente, pur non mancando esemplari inte-gri. Anche se con percentuali minime si segnalano al-cuni frammenti diagnostici di difficile attribuzione acausa delle ridotte dimensioni. Sono stati rinvenuti circa 1500 frammenti diagno-
stici da cui sono stati identificati quasi 500 individuidi diversa tipologia (Fig. 5). Una prima utile osservazione, sul totale delle for-
me rinvenute, mette in luce la prevalenza delle formeaperte su quelle chiuse. Tra le forme aperte sono nu-merose le tipologie individuate, ovviamente tutte le-gate al servizio da mensa, nello specifico bicchieri,piatti, coppe e coppette, dove si registra la presenza dinumerosi tipi. Per quanto riguarda i bicchieri gli individui attesta-
ti sono quarantaquattro, di molti di essi si conserva so-lo l’orlo e parte della parete, mentre in altri casi ab-biamo resti più consistenti. Il maggior numero è composto da ventuno indivi-
dui riconducibili alla forma Isings 343 caratterizzatada un corpo ovoide allungato e piede a disco. Il tipo,non attestato precedentemente ad Ercolano, trova pe-rò confronto nell’area vesuviana dal sito di Pompeidove è presente con un esemplare dalla Casa di Cerere(I, 9, 13)4. Della stessa forma è possibile identificaredue diverse varianti riconducibili a forme attestate adAdria5. Alla prima, tra i bicchieri rinvenuti, appartieneun esemplare quasi totalmente ricostruito e realizzato
129
Fig. 4. Ercolano-Fogna dell’Insula Orientalis II. Il rinveni-mento di una coppetta in vetro (Foto D. Camardo perHCP).
Fig. 5. Grafico con percentuali dei reperti in vetro rinvenutinella fogna (Elaborazione A. Esposito).
in due diverse colorazioni, celeste e ambra (Figg. 6 e,19). Questo tipo di bicchiere, secondo la Isings, co-mincia ad essere prodotto nella seconda metà del Isec. d.C. Simile alla forma Isings 34, ma con decorazione a
stampo, è attestato un individuo di forma Isings 316 dicui si conserva solo parte della parete e non è possibi-le definire nello specifico il tipo di decorazione. Altriesemplari, riconducibili a forme già attestate ad Erco-lano, sono otto individui della forma Isings 307, tipicibicchieri dalla forma cilindrica. Sono attestati ad Er-colano e, in genere, nell’intera area campana. Il tipo èdatabile dall’inizio del I sec. d.C. fino all’epoca tardo-antica. Su molti individui è presente una decorazionea linee incise sul corpo. Infine, una modesta quantità è composta dai bic-
chieri troncoconici a depressioni attestati nelle duevarianti con e senza piede8. Anch’essi già presenti adErcolano e Pompei. Tra le forme aperte le coppe sono attestate in mol-
teplici tipi e dimensioni, tutte monocrome e a paretilisce. Solo pochi individui presentano la classica de-corazione a costolatura. Si tratta delle comuni coppeemisferiche monocrome decorate con costolature che
si irradiano dal fondo, fuse entro stampo. Questo tipodi coppa è attestato dall’epoca augustea fino alla finedel I d.C. All’interno della fogna sono stati rinvenutinove frammenti, tra cui è possibile identificare tre in-dividui della forma Isings 3A9, caratterizzata dalla va-sca poco profonda, ed un solo individuo della varianteIsings 3B10, con vasca profonda. Tutti gli individui at-testati si presentano di colore celeste opaco. Oltre alle coppe costolate è presente un individuo
di coppa emisferica monocroma, riconducibile allaforma Isings 1. Questo tipo, colato in stampo, in ge-nere si trova ad Ercolano realizzato in vetro millefio-ri11. Nel caso preso in esame invece è stato realizzatoin vetro verde, di una tonalità smeraldo. La coppa ècaratterizzata dall’orlo tagliato e levigato a mola, sot-tolineato all’esterno da un accenno di gola, manca ilfondo. Questo tipo di coppa è diffuso in tutto il Medi-terraneo ed ha un arco cronologico di produzionemolto ampio12. Un primo dato interessante, per le coppe, è la pre-
senza di numerosi individui riconducibili alla formaIsings 1213 nelle due varianti a A e B. Questa coppaimita le forme realizzate in ceramica o metallo. Il tipospesso presenta una decorazione a linee incise sotto
130
Fig. 6. Alcuni oggetti in vetro dalla fogna parzialmente ricostruiti: a) Coppetta tipo Scatozza 8; b) Coppa tipo Toniolo 281;c) Piatto in vetro blu; d) Coppa cilindrica in vetro blu; e) Bicchiere forma Isings 34 (Foto M. Notomista per HCP).
l’orlo e sul corpo. La forma è riconducibile alla metàdel I sec. d.C. (Fig. 20). La forma Isings 12 non risulta attestata preceden-
temente ad Ercolano14. All’interno della fogna è pre-sente con ventotto individui in diverse colorazioni,prima tra tutte il celeste, il verde acido chiaro e pochigli esemplari in azzurro, giallo miele e tre individui invetro incolore. Inoltre, sono presenti altri ventiquattroindividui che per le caratteristiche generali potrebberoessere riconducibili alla forma Isings 12, ma si diffe-renziano da essa per una diversa conformazione dellepareti. Il tipo è caratterizzato da una lieve strozzaturasotto l’orlo, tagliato irregolarmente a spigolo vivo,corpo troncoconico, in alcuni casi decorato da sottililinee incise e fondo con bassa carenatura. Questi sonoattestati sia a Padova15 sia ad Adria16. Questo tipo, nonattestato precedentemente ad Ercolano, finora si ritro-
va in ambiti cronologici tra la metà del I secolo d.C. egli inizi del II secolo d.C.Presenti, infine, anche i modioli17, attestati da due
individui di colore verde e con pochi frammenti ri-componibili. I due esemplari presi in esame sono ri-conducibili alla forma Isings 3718.Oltre alle coppe sono numerose le coppette di pic-
cole dimensioni presenti con diversi tipi. La percen-tuale più alta è formata dalle coppette Isings 4419 at-testate da cinquantaquattro individui per la variante Ae da diciotto per la variante B. Si tratta delle comunicoppette emisferiche con orlo tubolare (Fig. 6 a). Il ti-po viene suddiviso in due varianti, la versione di pic-cole dimensioni, utilizzata per salse (diam. 8 cm ca.)e la versione più grande (diam. 13 cm circa) adoperataper le bevande. Questo tipo di coppa è abbondante-mente attestato ad Ercolano e trova ampio riscontro aPompei20. Risulta diffusa in tutto l’impero dal periodoneroniano-flavio agli inizi del II sec. d.C.Attestata, con nove individui, è la forma Isings 2021,
un tipo di coppetta emisferica a vasca poco profonda epiede a listello; con cinque individui, invece, la formaIsings 4222. Questo tipo di coppa è testimoniata da nu-merosi individui ad Ercolano e molto frequente a Pom-pei, ed è attestata dal terzo quarto del I sec. d.C. Solodue individui appartengono alla forma Isings 41B, ca-ratterizzata dalla vasca con andamento troncoconico edorlo espanso. Databile dalla seconda metà del I secolod.C. Tale tipo, presente a Pompei e a Stabiae nella villain località Carmiano, sembra godere di una popolaritàmodesta ad Ercolano, dove ricorre con pochi esempla-ri23. Nel nostro contesto specifico sono stati rinvenutidue individui di cui un esemplare di colore celeste qua-si integro di grandi dimensioni, lacunoso di una piccolaparte dell’orlo e del ventre (Fig. 7). Altri sette individui sono riferibili alla forma
Isings 41 B24 simile al tipo Scatozza 10, dal quale sidifferenzia per la conformazione della parete. Questacoppa è ampiamente attestata in Campania, oltrechénel resto della penisola, dove si afferma a partire dallaseconda metà del I secolo d.C. Infine, sempre tra le coppette, sono attestati tre
esemplari carenati, riconducibili alla forma Isings 2,uno di colore bianco opaco e due di colore verde scu-ro, con breve orlo estroflesso e piede ad anello. Il pe-riodo di diffusione è il I secolo d.C., con una maggiorefrequenza fra l’età augustea e quella neroniana. Infi-ne, tra le coppe di piccole dimensioni, vi è un esem-plare in verde smeraldo, riconducibile, ad una varian-te della forma Isings 20, ed attestato nella collezionedel Museo Archeologico Nazionale di Este25. Essa ècaratterizzata dal corpo emisferico con alto piede adanello ed orlo tagliato e arrotondato (Fig. 6 b). Sempre tra le forme aperte e legati al servizio da
mensa sono i piatti, presenti con una buona quantità,anche se notevolmente inferiore rispetto alle coppe e
131
Fig. 7. Coppetta Forma Scatozza 10 - Isings 41 (Foto A.Esposito per HCP).
Fig. 8. Balsamari tubolari (Foto A. Esposito per HCP).
bicchieri. Sono attestati ventiquattro individui, di di-verse colorazioni, di piatti Isings 4726. Il tipo è carat-terizzato da un piede ad anello e bassa vasca dal pro-filo rientrante in prossimità dell’orlo arrotondato.Contenitori simili sono piuttosto frequenti a Pompeied Ercolano. Il periodo di massima fortuna del tipo,noto sin dall’età neroniana, sembra protrarsi per tuttala seconda metà del I secolo d.C. Altri dodici individuisono da attribuire alle forme Isings 22/48, anche se sitratta di frammenti esigui. Il colore predominante è ilceleste, ma sono presenti ugualmente colorazioni co-me l’azzurro, il verde, tre individui sono in vetro in-colore, e un esemplare, in gran parte ricostruito, è invetro blu scuro (Fig. 6 c).Tra le forme chiuse, invece, la percentuale più alta
è costituita da balsamari tubolari e bottigliette-balsa-mario (Fig. 8), mentre in quantità esigua sono le bot-tiglie e le brocche. Le forme documentate, integre oricostruite, appartengono a diverse tipologie e a va-rianti specifiche. Per quanto concerne i balsamari tu-bolari e le bottiglie-balsamario è difficile isolare nellospecifico serie tipologiche distinte, tenendo conto so-lo delle variazioni minime presenti tra le varie tipolo-gie (maggiore o minore accentuazione della strozza-tura, maggiore convessità del fondo o della parete,etc.). Infatti, per quanto riguarda i balsamari tubolarisono riconducibili alla forma Isings 827 quasi cento in-dividui.Per alcuni esemplari, integri o con lacune tali da
non impedire un preciso inquadramento tipologico, èstato possibile riferirli ad altre specifiche tipologie.Studi successivi alla Isings, come quello della Scatoz-za per il contesto ercolanese, e di De Tommaso per gliunguentari dell’Italia romana, hanno differenziato i ti-pi in base alla diversa combinazione di alcuni elemen-
ti (collo, ventre, fondo), raggruppando in tipologie piùspecifiche i balsamari tubolari, così da avere delle va-rianti più dettagliate. Infatti, ad Ercolano la formaIsings 8 è attestata da quattro versioni dalla Scatozza47 (a,b,c,d) e alcuni balsamari sono riferibili ai tipi 60,70, 71 e 73 della classificazione De Tommaso. Altri sette individui attestati sono riconducibili
sempre a balsamari tubolari ma assimilabili alla forma28A della classificazione Isings28 e riconducibile algruppo De Tommaso 6729, datato tra l’età tiberiana ela prima età flavia (Fig. 9). Presente con un unico esemplare, è un balsamario
con corpo troncoconico in vetro verde di notevole
132
Fig. 9. Balsamario tipo De Tommaso 67 (Foto A. Espositoper HCP).
Fig. 10. Balsamario tipo De Tommaso 42 (Foto A. Espositoper HCP).
Fig. 11. Balsamario tipo Zampieri 203 (Foto A. Espositoper HCP).
spessore. Il passaggio dalla forma tubolare ad un cor-po troncoconico, è in genere attestato dalla fine del Isecolo d.C. Questo tipo non trova riscontro nelle tipo-logie Isings e Scatozza ma è riconducibile al gruppoDe Tommaso 4230 (Fig. 10). Attestato anche ad Aqui-leia, la Calvi li ritiene egizi31. L’ultimo balsamario attestato è di piccole dimen-
sioni, con labbro svasato e orlo tagliato, piccolo colloindistinto, corpo piriforme arrotondato verso il fondo,e trova un diretto confronto nella collezione del Mu-seo Civico Archeologico di Padova32 (Fig. 11). Oltreai balsamari tubolari è stata rinvenuta una notevolequantità di bottigliette-balsamario di diverse dimen-sioni. La percentuale più alta è riconducibile alla for-ma Isings 633, attestata con cinquantaquattro indivi-dui, e caratterizzata dall’orlo estroflesso irregolare,semplicemente tagliato, collo cilindrico, con strozza-tura alla base. La diversa conformazione del corpo ciconsente di associarla alla forma Scatozza 4534, conventre bulboso, o alla forma 4635, con ventre tondeg-giante allungato. La percentuale maggiore è compostada esemplari realizzati in vetro celeste, anche se èconsistente la quantità di esemplari in vetro incolore.Questi tipi di balsamari, realizzati in vetro sottilissi-mo, si ritrovano dal periodo augusteo e rimangono inuso per tutto il I sec. d.C., e ad Ercolano sono attestatiin particolar modo nell’età flavia36. Sempre tra le bottigliette-balsamario sono presen-
ti, in quantità minore, quelle con corpo piriforme ri-conducibile alla forma Scatozza 4937. Questo tipo dicontenitori è largamente diffuso dall’inizio del I sec.d.C. in tutto il mondo romano. Alcuni esemplari similisono stati rinvenuti nella bottega sul Decumano Mas-simo ad Ercolano legati alla fabbrica di Ampliatus, at-tiva nel 79 d.C. Uno dei centri di produzione doveva
esistere nell’area vesuviana, dove, peraltro, sono mol-to frequenti38. Sempre tra i balsamari a corpo piriforme, simili al-
la forma Scatozza 49, sono presenti sette individui ri-conducibili al gruppo De Tommaso 3239. Il gruppo èampiamente diffuso in tutta la penisola tra l’età flaviae l’età antonina. Infine, sono attestati altri cinque individui di bal-
samari olliformi riconducibili alla forma Isings 6840,tipo piuttosto comune della seconda metà del I sec.d.C. Di alcuni esemplari si conservano solo partidell’orlo e del ventre.Da un unico esemplare, in vetro marrone, è attesta-
to il balsamario De Tommaso 2541 (Fig. 12). Di essosi conserva solo il ventre e i tre tipici piedi cilindrici.Di piccole dimensioni, il tipo è considerato un prodot-to campano, poiché nel territorio sono stati rinvenutiesemplari simili decorati a granulazione. Tra le forme chiuse, non numerosa è la presenza di
frammenti diagnostici riconducibili a bottiglie e broc-che di diverse tipologie. In particolare sono attestateda almeno sette individui le bottiglie monoansate condiverse tipologie di fondi. Sono comuni bottiglie mo-noansate a forma di parallelepipedo a fondo quadratoo circolare (forme Isings 50 e Isings 51)42 attestate adErcolano in due varianti, di piccole e medie dimensio-ni. Sul fondo spesso compaiono marchi di fabbrica osemplici cerchi concentrici. Queste bottiglie sono par-ticolarmente attestate nell’abitazioni dell’area vesu-viana. Utilizzate per contenere liquidi, si presentanospesso di diverse capacità. La loro diffusione è pre-sente per un arco cronologico molto esteso che va dalI fino al III secolo d.C. Nel contesto specifico della fo-gna sono attestate sia di medie che di piccole dimen-sioni.
133
Fig. 12. Balsamario su piedini cilindrici tipo De Tommaso25 (Foto A. Esposito per HCP).
Fig. 13. Bottiglietta con orlo trilobato (Foto A. Esposito perHCP).
Particolare, invece, la presenza di una bottiglia asezione esagonale, attestata dalla sola presenza delfondo, di colore verde acido chiaro traslucido corri-spondente alla forma Isings 50a43, variante esagonale.Come accennato precedentemente, anche se in pochiindividui, sono attestati esemplari da ricondurre alservizio da mensa come bottiglie e brocche. Un primoesemplare, è una lagoena di colore celeste. Questo ti-po di bottiglia monoansata è caratterizzata dal collocilindrico stretto e dal ventre espanso. Corrisponde al-la forma Isings 1344 che deriva da un tipo di lagoena
fittile molto diffusa in età augustea. Questo tipo di for-ma si riscontra frequentemente entro la prima metàdel I secolo d.C. Molto interessante tra le bottiglie èla presenza di un raro collo di bottiglietta con orlo tri-lobato, di colore celeste (Fig. 13). Si conserva solo illungo collo e l’orlo, mancano il ventre ed il fondo.Oltre ai contenitori legati al servizio da mensa e ai
vari balsamari, sono stati rinvenuti anche altri oggetticonnessi alla vita quotidiana. Primi tra tutti tre infundi-bula riconducibili alla forma Isings 7445 di cui si con-serva solo il fondo, mancano invece la vasca e l’orlo.Tra gli oggetti particolari, attestata da un unico esem-plare, è una coppa, o attingitoio, con vasca profonda edorlo estroflesso. Essa, di grandi dimensioni (diam. 13cm ca.), è caratterizzata da un filamento di pasta vitreabianca, molto spesso, avvolto a spirale. Il colore di fon-do della coppa è verde acido chiaro (Fig. 14). Tra le forme aperte, inoltre, sono presenti gli unici
due esemplari di vetro policromo rinvenuti nella fo-gna. Nello specifico un piccolo piatto in vetro marmo-rizzato di colore blu con venature bianche. Un esem-plare simile è stato rinvenuto a Pompei46. Tra i piccoli oggetti in vetro si segnalano dodici
pedine da gioco piano convesse in pasta vitrea di di-verse colorazioni. È stato rinvenuto anche un ago(Fig. 15) in vetro pieno, a sezione circolare, appiattitoverso la cruna47. Questo oggetto, molto raro in vetro,veniva molto probabilmente utilizzato come bastonci-no per miscelare profumi. Infine, si presentano due importanti attestazioni, si
tratta di due coppe cilindriche, una in vetro blu e l’altrain bianco opaco, rinvenute in frammenti e in parte ri-costruite (Figg. 6 d; 16). Esse presentano la medesimadecorazione soffiata a stampo e composta da una pal-ma e un gruppo di cerchi concentrici. Per entrambe siconserva parte del fondo decorato con linee circolari.
134
Fig. 14. Coppa con filamento in pasta vitrea bianca (FotoA. Esposito per HCP).
Fig. 15. Ago-mixer in vetro (Foto A. Esposito per HCP).
Fig. 16. Coppa cilindrica: particolare della decorazione(Foto A. Esposito per HCP).
Il tipo di decorazione e la colorazione del vetro richia-mano subito le coppe “ennoniane” del Museo Archeo-logico Nazionale di Adria48, in particolare la n. 352 chepresenta gli stessi elementi decorativi (Fig. 17).La decorazione superstite degli esemplari ercola-
nesi presenta due cerchi concentrici e due colonne atriplice scanalatura, forse una palma stilizzata. En-trambi gli elementi decorativi compaiono sulla coppaveneta, ai lati del cartiglio. I reperti campani differi-scono dalla coppa di Adria per la presenza di una fa-scia orizzontale a losanghe che corre lungo il corpo.Questo tipo di decorazione è presente su un’altra cop-petta presente nella collezione del Museo NazionaleConcordiese di Portogruaro49 (Fig. 18). È questione ancora aperta l’eventuale trasferimen-
to di Ennion e della sua officina dall’Oriente in Italia,anche se tale ipotesi non sembra più convincente allaluce delle nuove acquisizioni50. Come già aveva ipo-tizzato la Larese51, infatti, l’ampia distribuzione deireperti non è da interpretare come uno spostamentodell’atelier, ma più verosimilmente legata a scambi
commerciali di oggetti e matrici. Sicuramente intornoalla metà del I secolo d.C. sono numerose le coppe at-testate con firma dell’artigiano Ennion, insieme adoggetti anonimi eseguiti secondo uno stile “sido-nio”52. Le decorazioni a stampo di tipo orientale sem-brano avere un enorme successo e sono molto apprez-zate. I due esemplari ercolanesi, purtroppo, non con-servano nessuna firma ma sicuramente possono essereinseriti in quei repertori anonimi con decorazioni distile sidonio. Le due coppe sono un’attestazione mol-to importante nel sud Italia, diventando un confrontopuntuale per questi tipi di oggetti maggiormente do-cumentati in Italia Settentrionale53. Lo scavo della fogna, come illustrato, ha restituito
una notevole quantità di frammenti di oggetti in vetro.L’intero materiale vitreo risultava disperso su tuttal’area di scavo con una maggiore quantità nella partecentrale. Lo studio delle forme rinvenute mette in lucela prevalenza delle forme aperte, attestate al 56%, suquelle chiuse, pari al 44%. Tra le forme aperte la per-centuale più alta è costituita da coppe e coppette. In-vece, per le forme chiuse il numero più consistente diindividui è costituito dai balsamari tubolari, confer-mando l’uso frequente di questi piccoli contenitori nelI secolo d.C. ed in particolare dall’età flavia. I balsa-mari tubolari trovarono ampia diffusione in tutto l’im-pero, e furono prodotti in grandi quantità dal I sec.d.C., con una picco massimo a metà secolo, fino al IIsec. d.C. Questo tipo di contenitore era realizzato invetro soffiato in modo rapido ed economico. Dalloscavo della fogna sono attestati per questo primogruppo 92 individui, in molti casi esemplari integri oricomponibili. Il resto dei reperti è costituito da ele-menti sporadici o da percentuali minime, e non man-cano anche esemplari unici. La percentuale più alta di tutto il materiale vitreo
rinvenuto è composta dalle coppe, presenti in svariati
135
Fig. 17. Particolare della coppa n° 352 del Museo Archeologico Nazionale di Adria (da LARESE 2004).
Fig. 18. Particolare della decorazione del bicchiere n° 127del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro (da LA-RESE - ZERBINATI 1998).
tipi. Molti di essi già attestati ad Ercolano, ma il nu-mero maggiore è costituito da esemplari non docu-mentati finora nell’antica città, nello specifico dallecoppe Isings 12 nelle sue due varianti, diffuse dallametà del I sec. d.C. In percentuale quasi uguale alle coppe sono i bal-
samari tubolari, presenti con una quantità notevole,forse da considerare legata alla presenza della vicinapalestra. Si tratta dei comunissimi balsamari tubolaricon fondo a goccia. Con una presenza dell’11% sonoattestate poi le bottigliette-balsamarioIl resto degli individui identificati è presente con
percentuali simili, come bicchieri o piatti. In percen-tuale esigua invece le bottiglie e le brocche. Alcuniframmenti di fondi presentano i classici “bolli” a cer-chi concentrici, mancano invece totalmente marchi difabbrica ed iscrizioni, precedentemente attestate adErcolano dal bollo “gessis ampliati”. Notevole invecela presenza di coppette utilizzate per contenere salse,presenti con il 15% e in diverse tipologie, già ben at-testate ad Ercolano.Dalle forme si ricostruisce la presenza di una ri-
stretta tipologia di oggetti. Infatti, oltre ai balsamaritubolari e alle bottigliette-balsamario, il resto deglioggetti è legato alla mensa. Nello specifico coppe ebicchieri che, sommati, rappresenterebbero la quanti-tà maggiore, confermando la preferenza di questo ma-teriale per le forme potorie. Seguono le piccole coppelegate sempre alla mensa, pochi in percentuale i piatti.Le forme particolari sono presenti solo con qualche
elemento sporadico, come pissidi, pedine da gioco,imbuti etc.Solo due gli individui di vetro policromo, una cop-
pa costolata ed un piattino. Questi, in vetro marmoriz-zato, sono realizzati su fondo blu e chiazze bianche egialle. Due soli oggetti mostrano appliques in pastavitrea bianca.Per quanto riguarda la gamma cromatica delle pa-
ste è presente una netta prevalenza dei monocromi agradazioni tenui. Tra esse predomina il colore celeste,nelle varianti traslucido ed opaco, seguono il verde el’azzurro. Non mancano colori più decisi come il bluo il marrone o colorazioni, attestate con pochi esem-plari, come il giallo miele, il verde acido chiaro ed in-fine, numerosi sono i pezzi in vetro incolore, la cuipresenza è attestata maggiormente nell’epoca flavia.Infine, per quanto concerne le tecniche di lavora-
zione è prevalente quella del vetro soffiato a canna li-bera, con una maggiore attestazione di individui sof-fiati parzialmente a stampo. Più rari gli esemplari rea-lizzati a stampo presenti con poche forme ed individui. Il contesto di rinvenimento ci consente di restrin-
gere notevolmente l’arco cronologico d’uso di questioggetti, infatti, i materiali rientrano in un arco crono-logico che va dalla realizzazione dell’isolato, d’età ti-beriano-claudia alla fatidica data del 79 d.C. Il luogodi rinvenimento, consente di restringere maggiormen-te la datazione d’uso. La fossa settica, non essendouna vera e propria fogna con scarico a mare, necessi-tava di essere svuotata periodicamente. Lo svuota-mento, in base anche alle dimensioni della fogna, èstato stimato con un intervallo di 5/7 anni. Quindi glioggetti devono essere considerati come quelli in usoproprio negli ultimissimi anni di vita della città, almassimo nell’ultimo decennio. Altro elemento da sot-tolineare è l’enorme quantità di materiale vitreo rinve-nuto. Come accennato nella parte introduttiva, la fossa
136
Fig. 19. Bicchiere forma Isings 34 (Foto M. Notomista perHCP).
Fig. 20. Coppa forma Isings 12 (Rilievo A. Esposito perHCP).
settica fu scavata parzialmente dal Maiuri, mentre larecente campagna ha indagato la parte non ancorascavata, per una lunghezza di 30 m ca. Nonostante laristretta porzione sono stati rinvenuti oltre i 5000frammenti di vetro. Tali dati risultano essere fonda-mentali per lo studio sulle quantità di vetri utilizzatinel I secolo d.C. quando, inoltre, come ci testimonia-no le fonti, era in uso anche il riciclaggio dei fram-menti di vetro. Ancora una volta le città vesuviane,consentono di apportare nuovi dati qualitativi/quanti-tativi, utilissimi per una corretta stima delle classi dimateriali usati nella vita quotidiana delle città romanedel I sec. d.C. in particolari contesti, come quello ana-lizzato, che appaiono riferibili a botteghe ed abitazio-ni del ceto popolare dell’antica Herculaneum.
Domenico Camardo - Angelo Esposito, Herculaneum Conservation Project
Lo scavo e lo studio dei reperti della fogna dell’Insula Orien-talis II sono stati realizzati nell’ambito delle attività dell’Her-culaneum Conservation Project (www.herculaneum.org) cheda oltre dieci anni si occupa della salvaguardia e della valoriz-zazione dell’antica Ercolano. Si tratta di un’iniziativa che uni-sce partner pubblici e privati in una proficua collaborazione.Desideriamo ringraziare David e Pamela Packard che l’hannoresa possibile ed hanno saputo creare e valorizzare un team in-terdisciplinare di giovani specialisti, quasi tutti italiani, senzail quale questo studio non avrebbe visto la luce. Un ringrazia-mento infine a Maria Paola Guidobaldi, Direttore degli Scavidi Ercolano, che ci ha sostenuto ed aiutato in tutte le fasi deilavori.
Note
1 L’Herculaneum Conservation Project è un’iniziativa del-l’Istituto Packard per i Beni Culturali (una filiazione della fon-dazione Packard Humanities Institute) e della SoprintendenzaSpeciale per Pompei, Ercolano e Stabia che ha visto anche ilcoinvolgimento di un terzo partner, la British School at Rome,per il decennio 2004-2014.Sulla nascita e le attività dell’Herculaneum Conservation Pro-ject cfr. Conservation and Management 2007, pp. 187-252;Guidobaldi 2006, pp. 135- 142; Wallace-Hadrill - Gui-dobaldi - Camardo 2008, pp. 409-424.2 Le attività di scavo si sono svolte nell’ambito di una cam-pagna pluriennale di interventi nelle aree del sito a rischio perridurre il degrado e per ripristinare ove possibile il sistema fo-gnario antico. La campagna è stata guidata dall’arch. Paola Pe-saresi e realizzata da un ampio team interdisciplinare con inprima linea lo Studio Massari di ingegneria idraulica, che si èoccupato della difesa del sito dalle acque piovane e dall’umi-dità. Sullo scavo della fogna dell’Insula Orientalis II di Erco-lano cfr. Camardo 2007 pp. 167-187; Camardo 2008, pp.415-423; Camardo - Court 2010, pp. 38-42.3 Bicchiere di forma ovoide allungata, con breve orlo conca-vo svasato, a taglio netto. Fondo introflesso con piede ad anel-lo. Sulle pareti decorazione con linee concentriche incise. Per
il tipo Isings 1957, pp. 48-49, f.34. Questa forma è utilizzataanche nella ceramica a pareti sottili: Ricci 1985, tav.LXXVIII, 12. 4 Scatozza Höricht 2012, p. 108, n. 8389, tav. X.5 I due esemplari si differenziano per una diversa conforma-zione dell’orlo e del corpo, maggiormente allungato nel-l’esemplare 283 e più ovoide nel 284. Bonomi 1996, p. 125,nn. 283-284.6 Scatozza Höricht1986, pp. 39-40, f. 19.7 Bicchiere cilindrico con orlo svasato a taglio netto. Fondoapodo e leggermente introflesso. Già attestato ad Ercolano tro-va confronti diretti anche a Pompei. Per Ercolano: ScatozzaHöricht 1986, pp. 42-43, f. 23; per Pompei: Scatozza Hö-richt 2012, p. 116, n. 12901, tav. XIII.8 Bicchieri troncoconici decorati a depressioni con orlo con-cavo a taglio netto. Variante Isings 32 apoda (sei individui) eIsings 35 su piede ad anello (otto individui). Scatozza Hö-richt 1986, p. 40, f. 20 e 21.9 Scatozza Höricht1986, pp. 25-27, f. 2a.10 Scatozza Höricht1986, pp. 30-31, f. 3a.11 Scatozza Höricht 1986, p. 25, f. 1.12 Isings 1957, pp. 45-46.13 Coppa emisferica, con pareti inclinate leggermente versol’interno e fondo introflesso. Isings 1957, pp. 29-30.14 Questa forma è già attestata a Pompei. Scatozza Höricht2012, pp. 303, 336, nn. 11108 e 13948, tavv. XXIX, LXII.15 Per il tipo: Zampieri 1998, p. 171, n. 284.16 Bonomi 1996, pp. 161-163, nn. 361-362.17 Bicchiere troncoconico con pareti convesse all’esterno, or-lo con bordo rialzato. Questi tipi di bicchieri presentano unapiccola ansa “insellata” al centro e fondo introflesso con piedead anello.18 Scatozza Höricht 1986, p. 42, f. 22b.19 Coppetta a vasca emisferica schiacciata con orlo tubolare,piede ad anello pieno. Il tipo è riconducibile alla forma 44 del-la tipologia Isings. Scatozza Höricht 1986, pp. 32-34, f. 8.20 Scatozza Höricht 1986, p. 32.21 Scatozza Höricht 1986, p. 32, f. 7.22 Scatozza Höricht 1986, p. 35, f. 9.23 Scatozza Höricht 1986, pp. 35-36, f. 10.24 Isings 1957, pp. 56-57.25 Toniolo 2000, p. 121, n. 281.26 Isings 1957, p. 68. Scatozza Höricht 1986, p. 31, f. 4. 27 Isings 1957, pp. 24-25.28 Isings 1957, pp. 61-62.29 Balsamario con orlo inclinato verso l’esterno, breve collocilindrico con strozzatura alla base, parete inclinata versol’esterno e fondo convesso. Per il tipo si veda: De Tommaso1990, pp. 81-82.30 Balsamario con orlo perpendicolare alla parete, collo drittocon strozzatura alla base, spalla inclinata verso l’esterno, fon-do appiattito. Per il tipo, De Tommaso 1990, p. 66. L’esempla-re di Ercolano presenta un’altezza di 10,5 cm e Ø 3,0 cm.31 Calvi 1968, n. 273, p. 45.32 Zampieri 1998, p. 116, n. 203.33 Isings 1957, pp. 22-23.34 Scatozza Höricht1986, p.57.35 Scatozza Höricht1986, pp. 57-58.36 Scatozza Höricht1986, p.58.37 Scatozza Höricht1986, pp. 64-65.38 Scatozza Höricht 1986, pp. 80-81.39 De Tommaso 1990, pp. 58-59.40 Scatozza Höricht 1986, pp. 70-72, f. 58b.
137
41 De Tommaso 1990, p. 54.42 Scatozza Höricht 1986, pp. 43-48, f. 24 e 25.43 Isings 1957, pp. 43-46. Per Pompei Cfr. Scatozza Hö-richt 2012, p. 338, n. 14084, tav. LXIV.44 Isings 1957, pp. 30-31.45 Isings 1957, p. 92. Per Pompei cfr. Scatozza Höricht2012, p. 336, n. 13527, tav. LXII.46 Vitrum 2004, p. 214, n 1.45.47 Ago a sezione circolare con cruna appiattita: Ø 0,5 cm elungh. 7,5 cm. 48 Le coppe nn. 352-353 sono state rinvenute in località Cuoranel comune di Cavarzere. Bonomi 1996, p. 158.49 Larese - Zerbinati 1998, pp. 60-62, n. 127, tav. IX.50 Maccabruni 1983, p.29.51 Larese 2004, p. 18.52 Larese 2004, p. 19.53 Larese - Zerbinati 1998, pp. 60-62.
Bibliografia
Bonomi S.1996, Vetri antichi del Museo Archeologico na-zionale di Adria, (Corpus delle Collezioni Archeologi-che del Vetro nel Veneto, 2), Venezia.
Calvi M. 1968, I vetri romani del Museo di Aquileia, Aqui-leia.
Camardo D. 2007, Ercolano: la gestione delle acque inuna città romana, in “Oebalus”, II-2007, Roma, pp.167-187.
CamardoD. 2008, Lo scavo della fogna dell’Insula Orien-talis II; Lo scavo nel Vicolo Meridionale; Lo scavodell’ala meridionale della Casa del Rilievo di Telefo, inNuove ricerche archeologiche a Pompei ed Ercolano II,a cura di P. G. Guzzo - M.P. Guidobaldi, Roma, pp.415-423.
Camardo D. - Court S. 2010, What lies beneath. Drain-ing Herculaneum, in “Current World Archaeology”, 42,pp. 38-42.
Conservation and Management 2007 = Conservation andManagement of Archaeological Sites. Special editionon Herculaneum, 8.4, pp. 187-252.
De Tommaso G. 1990, Ampullae vitreae,contenitori in ve-tro di unguenti e sostanze aromatiche dell’Italia roma-na, Roma.
Guidobaldi M.P. 2006, L’Herculaneum ConservationProject. Un programma di conservazione per salvare lacittà antica, in “Ocnus”, 14, pp. 135- 142.
Isings C. 1957, Roman Glass from dated finds, Gröningen-Djakarta.
Larese A. 2004, Vetri antichi del Veneto, (Corpus delleCollezioni Archeologiche del Vetro nel Veneto, 8), Ve-nezia.
Larese A. - Zerbinati E. 1998, Vetri antichi di raccolteconcordiesi e polesane, (Corpus delle Collezioni Ar-cheologiche del Vetro nel Veneto, 4), Venezia.
Maccabruni C. 1983, I vetri romani dei Musei civici diPavia: lettura di una collezione, Pavia.
Ricci A. 1985, Settefinestre una villa schiavistica nel-l’Etruria romana. La villa e i suoi reperti, III, Modena.
Scatozza Höricht L.A. 1986, I vetri romani di Ercolano,Roma.
Scatozza Höricht L.A 2012, L’ instrumentum vitreum diPompei, Roma.
TonioloA. 2000, Vetri antichi del Museo Archeologico diEste, (Corpus delle Collezioni Archeologiche del Vetronel Veneto, 6), Venezia.
Vitrum 2004 = Vitrum. Il vetro fra arte e scienza nel mondoromano, a cura di M. Beretta - G. Di Pasquale (Ca-talogo della mostra, 27 marzo - 31 ottobre 2004), Firen-ze.
Wallace-Hadrill A. - Guidobaldi M. P. - Camardo D.2008, Le ricerche archeologiche nell’’ambito dell’Her-culaneum Conservation Project, in Nuove ricerche ar-cheologiche nell’area vesuviana (scavi 2003- 2006).,Atti del Convegno Internazionale, (Roma, 1-3 febbraio2007, a cura di P.G. Guzzo - M.P. Guidobaldi, Roma,pp. 409-424.
Zampieri G. 1998, Vetri antichi del Museo Civico Archeo-logico di Padova, (Corpus delle Collezioni Archeologi-che del Vetro nel Veneto, 3), Venezia.
138