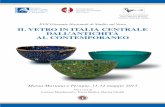Atti della Società e della famiglia Siebzehner 1. Atti sociali ...
Martini F., Lo Vetro D., Casciarri S., Colonese A.C., Di Giuseppe Z. 2012, Primi risultati della...
Transcript of Martini F., Lo Vetro D., Casciarri S., Colonese A.C., Di Giuseppe Z. 2012, Primi risultati della...
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
PAGINE EDITORIALI_Campione_17x24_Daniela 04/10/12 15.10 Pagina 1
ISTITUTOITALIANO DI PREISTORIA
E PROTOSTORIA
ATTI DELLA XLIRIUNIONE SCIENTIFICA
DAI CICLOPI AGLI ECISTISOCIETÀ E TERRITORIO
NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA
San Cipirello (PA), 16-19 novembre 2006
FIRENZE 2012
PAGINE EDITORIALI_Campione_17x24_Daniela 04/10/12 15.10 Pagina 3
ENTI PROMOTORIIstituto Italiano di Preistoria e ProtostoriaAssessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e P.I.Comune di San CipirelloUnione de Comuni Monreale JetasCentro Siciliano di Preistoria e Protostoria Archeoclub di Corleone
COMITATO D’ONOREA. Buttitta, N. Bonacasa, E. De Miro, S. Lagona, V. La Rosa, G. Rizza, E. Tortorici,M. Tosi, V. Tusa, G. Voza
CON IL SOSTEGNO DISoprintendenza BB CC AA AgrigentoSoprintendenza BB CC AA CaltanissettaSoprintendenza BB CC AA CataniaSoprintendenza BB CC AA EnnaSoprintendenza BB CC AA MessinaSoprintendenza BB CC AA PalermoSoprintendenza BB CC AA RagusaSoprintendenza BB CC AA SiracusaSoprintendenza BB CC AA TrapaniSoprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”Museo Archeologico Regionale, AgrigentoMuseo Archeologico Regionale “A. Salinas”, PalermoMuseo Archeologico Regionale “P. Orsi”, SiracusaMuseo “Agostino Pepoli”, TrapaniMuseo Archeologico Regionale della Villa del Casale di Piazza ArmerinaMuseo Archeologico Regionale di CamarinaMuseo Archeologico Regionale di GelaMuseo Archeologico Regionale Eoliano “L. Bernabò Brea”Museo della Ceramica di CaltagironeMuseo di storia naturale e del carretto di Palazzo d’Aumale, TerrasiniParco Archeologico Regionale di Agrigento
COMITATO SCIENTIFICOPaleolitico e Mesolitico: M.R. Iovino, F. MartiniNeolitico: V. Tinè, S. Tusa Eneolitico: A. Cazzella, D. Cocchi Genik, L. Maniscalco Età del Bronzo: N. Bruno, M. Cavalier, M.C. Martinelli, F. Nicoletti, E. Procelli, S. Tusa Età del Ferro: R.M. Albanese ProcelliInterazioni Sicilia - Mediterraneo: A.M. Bietti Sestieri, M. Marazzi Coordinamento: S. Tusa
SEGRETERIA ORGANIZZATIVAC. Buccellato, A. Scuderi, A. Vintaloro, E. Viola
REDAZIONE DEGLI ATTIEnrico Procelli
In copertina: Vaso della cultura di Serrafarlicchio
© Istituo Italiano di Preistoria e Protostoria, 2012Via S. Egidio, 21 - 50122 Firenzetel. 055/2340765 - fax 055/5354821www.iipp.it - e-mail: [email protected]
PAGINE EDITORIALI_Campione_17x24_Daniela 04/10/12 15.10 Pagina 4
COMUNICAZIONI
Paleolitico-Mesolitico
occhielli per daniela_Campione_17x24_Daniela 03/10/12 08.53 Pagina 1
FABIO MARTINI* - DOMENICO LO VETRO* - SILVIA CASCIARRI* - ANDRÉ CARLO COLONESE* - ZELIA DI GIUSEPPE* -
ROSSELLA GIGLIO** - SEBASTIANO TUSA**
Primi risultati della campagna di scavo 2005 a Grotta della Ucceria (Favignana, TP)
IL SITO E LE RICERCHE (D. Lo Vetro, F. Martini)
La grotta si apre sulla parete rocciosa di una rupe calcarea detta “ilGrosso” nei pressi di Punta Faraglione, all’estremità Nord dell’isola(quota m 33 slm). Si tratta di un complesso residuale di un’ampia cavità,in origine articolata in più camere, una delle quali presenta una galleria difondo che termina in uno stretto e basso cunicolo (fig. 1). Dopo la primasegnalazione di G. Dalla Rosa (1870), le ricerche di J. Bovio Marconi(1952), di A. Malatesta (1957) e di G. Mannino (Bisi 1969) si limitarono abrevi escursioni e a raccolte di superficie. Il nostro intervento nel 2005 siinserisce nell’ambito del progetto POR Sicilia 2000-2006 Asse II, Misura2.0.1.1 Le nuove ricerche hanno interessato soprattutto il grande ambien-te principale (ambiente B) e il cunicolo di fondo (ambiente D), un saggioè stato aperto anche in una camera interna (ambiente C). Nell’ambienteA il piano di calpestio è quasi interamente costituito dalla roccia di base.Come già rilevato dal Dalla Rosa la grotta doveva possedere in origine undeposito archeologico di circa un metro di spessore, del quale restano
* Dipartimento di Scienze dell’Antichità “G. Pasquali”, Paletnologia, Università degliStudi di Firenze; Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “P. Graziosi”, Via S. Egidio 21, Fi-renze; tel. 055215788; e-mail: [email protected].
** Soprintendenza del Mare, Assessorato per i Beni Culturali Ambientali e Pubblica Istru-zione Regione Siciliana, Palazzetto Mirto, Via Lungarini, 9, 90133 Palermo; e-mail:[email protected].
*1 L’indagine archeologica è stata realizzata dalla cattedra di Paletnologia del Dipartimentodi Scienze dell’Antichità “G. Pasquali” dell’Università degli Studi di Firenze di concerto con ilMuseo e Istituto Fiorentino di Preistoria, su incarico dell’Assessorato regionale per il BB. CC.AA. e P.I., Area Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani. Ci è gradito ringra-ziare il prof. Sebastiano Tusa per averci coinvolto nel progetto e la dott.ssa Rossella Giglio, re-sponsabile del procedimento al momento delle ricerche.
290 F. MARTINI et alii
*2 Scrive Dalla Rosa: «… scopersi che tutto il deposito costituente il primitivo strato dellagrotta era stato levato, e solo ne esisteva una parte all’altezza di circa un metro dal suolo nelpunto estremo di essa. Ve ne erano circa due metri superficiali sostenuti a modo di una tavolada un sol piede. Con ripetuti colpi potei gran parte infrangerne, ed ottenere così e conchiglie eossa, e alcuni denti di animali e selci…».
*3 Questa ricostruzione non esclude l’ipotesi di un successivo intervento ad opera di conta-dini locali che in epoca recente avrebbero asportato insieme al letame parte del deposito resi-duo per utilizzarlo come concime.
tracce a luoghi sulle pareti con molluschi terrestri e marini inglobati inplacche di sedimento concrezionato2, riferibile al Paleolitico superiore, alMesolitico e al Neolitico. Gli eventi che sono all’origine della demolizio-ne del deposito originario potrebbero essere dovuti ad uno o verosimil-mente a più ruscellamenti (sifoni) che dal cunicolo di fondo sono fuoriu-sciti erodendo un deposito a sabbie rossastre che sopportava la sequenzasopra detta3. Nell’ambiente B e soprattutto nell’ambiente D sono stati ri-sparmiati lembi di strati concrezionati e lembi ospitati in piccole nicchienelle pareti che sono stati oggetto del nostro intervento.
Fig. 1 - Grotta delle Uccerie: pianta della grotta e localizzazione delle trincee discavo.
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 291
La frequentazione della grotta durante la Preistoria e ricostruibile neldettaglio mediante la sequenza crono-culturale messa in luce nell’Am-biente D. La serie stratigrafica giaceva sotto uno strato legato all’impiegodella grotta come ricovero del bestiame sino ad oggi; al di sotto una cro-sta calcitica (a) sigillava una massiciata di pietrame di medie dimensioni aspigoli vivi archeologicamente sterile. Sotto di essa il deposito archeologi-co era così articolato:
- strato 1: deposito concrezionato sabbioso argilloso di colore bruno,con raro scheletro calcareo a spigoli smussati. Neolitico;
- stalagmite b: colata calcitica di esiguo spessore;- strato 2: deposito concrezionato sabbioso argilloso di colore bruno
scuro; è stato suddiviso in due livelli archeologici, 2A e 2B. Mesolitico;- strato 3: deposito concrezionato sabbioso argilloso di colore nocciola.
Mesolitico;- strato 4: deposito concrezionato argilloso sabbioso di colore nocciola
con scheletro calcareo a spigoli smussati; è stato suddiviso in quattro di-stinti livelli di frequentazione, 4A, B, C, D. Paleolitico superiore (Epigra-vettiano finale);
Sottostante allo strato 4 giaceva uno strato argilloso-limoso di colorerosso-arancio sterile di evidenze antropiche che rappresenta il tetto di undeposito a “terre rosse” che si rinviene anche nell’ambiente B dove è sta-to indagato in un area di 4 mq all’interno della trincea aperta nell’atrio.Tale deposito ha restituito pochi resti di microfauna e mammalofauna (incorso di studio).
Alla sequenza descritta è stato possibile correlare i sondaggi effettuatiin una piccola nicchia prossima la fondo grotta all’interno dello stessoambiente D, ma priva di correlazione diretta con la precedente, e in unaseconda nicchia a ridosso della parete Sud dell’ambiente B dove era inposto solo la porzione basale dello strato epigravettiano. In parete resta-no lembi deposito placcato che fu oggetto delle indagini del Dalla Rosa.
ECONOMIA E AMBIENTE (A.C. Colonese, Z. Di Giuseppe)
L’ambiente e lo sfruttamento delle risorse naturali a Grotta delle Ucce-rie durante i differenti episodi di occupazione epigravettiana e mesoliticasono in questa sede desunti dai reperti faunistici. Tuttavia, a causa di fat-tori tafonomici, in particolare dovuta all’intensa percolazione di stillici-dio, non è stato possibile ricostruire in dettaglio le dinamiche ambientalied culturali sulla base dei reperti stessi. Dal punto di vista economico, sianegli orizzonti epigravettiani che mesolitici, l’attività di caccia, la raccolta
292 F. MARTINI et alii
*4 Lo studio dell’ittiofauna è attualmente in corso.
di molluschi marini e a pesca4 sono ben rappresentate e costituiscono, co-me in atri giacimenti coevi (Martini et alii in questo volume), la base del-l’economia di sussistenza durante tutta la frequentazione della grotta.
Lo studio preliminare della composizione faunistica a macromammife-ri, attualmente limitato ai livelli epigravettiani, ha evidenziato associazionisimili a quelle rinvenute in siti coevi (Martini et alii in questo volume).Equus hydruntinus, accompagnato da Bos primigenius, con cui condividegli stessi habitat aperti a prateria, costituisce più della metà del campioneosseo indagato. Tali presenze, per il momento, sembrano andare a disca-pito dell’associazione faunistica di tipo boschivo costituita da Cervuselaphus e Sus scrofa.
La raccolta di molluschi marini a scopo alimentare è documentata apartire dai livelli epigravettiani ma è solo con l’occupazione mesoliticadello strato 3 che essa è significativamente documentata, per poi ridursiprogressivamente nel corso della deposizione dello strato 2. Tale fenome-no potrebbe essere legato alla risalita del livello del mare e all’avvicina-mento della linea di costa tra l’Epigravettiano finale e il Mesolitico. La ri-duzione della raccolta nello strato 2 potrebbe essere dovuta a differentiepisodi di occupazione della grotta, oltre che a disturbi post-deposiziona-li come quelli accennati in precedenza. Le specie raccolte a scopo alimen-tare appartengono alla biocenosi delle rocce mesolitorali superiori e infe-riori, rappresentate da Trochidae e Patellidae. Osilinus turbinatus è laspecie dominante in tutta la stratigrafia e il suo sfruttamento è attestato intutte le stagioni dell’anno, sia nei livelli epigravettiano che mesolitici, sug-gerendo in tal modo un occupazione antropica del sito in tutte le stagioni(Colonese et alii in questo volume).
Come in altri giacimenti paleolitici e mesolitici della Sicilia nord-occi-dentale (Colonese in questo volume a, b), nei livelli epigravettiani e meso-litici di Grotta delle Uccerie sono presenti specie marine di piccola taglia,non eduli e tipiche delle praterie a Posidonia oceanica (Colonese et alii inquesto volume). La presenza di queste piccole specie potrebbe essere ilrisultato dell’introduzione nella grotta, da parte dell’uomo, di piante ma-rine utilizzate come giacigli, combustibile o per la produzione di manu-fatti (es. cordame, reti e ceste). (Vellanoweth 2003)
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 293
*5 Quando non espressamente indicato tutte le date menzionate nel testo sono state cali-brate con deviazione a 2s utilizzando il software OxCal ver. 3.10 basato sui dati atmosferici diReimer et alii 2004.
*6 La presenza di selce sulla Montagna Grossa è ben documentata in letteratura (Agnesi etalii 1993; Malatesta 1957; Carta geologica d’Italia, foglio 256).
LE INDUSTRIE LITICHE DELL’EPIGRAVETTIANO E DEL MESOLITICO
(D. Lo Vetro, F. Martini)
I livelli epigravettiani (strato 4)Per questo studio viene presa come riferimento la sequenza del fondo
grotta, accorpando i materiali degli altri due settori che sono con buonaapprossimazione riferibili stratigraficamente agli stessi orizzonti. Nel fon-do grotta lo strato 4 comprende una serie di esigui livelli (da 4A a 4D;non è stato possibile definire se si tratta o meno di paleosuperfici conl’esclusione di 4B che conteneva una struttura di combustione) per i qualisono state ottenute tre misure radiometriche:
4C: 12.958±90 BP (cal 13.750-13.000 a.C.)5
4D: 13.191±120 BP (cal 14.200-13.200 a.C.)4E: 12.933±75 BP (cal. 13.700-13.000 a.C.)I quattro livelli sono stati accorpati in due orizzonti uno superiore (4A,
B, C) e uno inferiore (4D, E) coerentemente con le indicazioni prove-nienti dallo studio delle industrie litiche.
Lo scavo ha restituito alcune centinaia di reperti litici tra strumenti ri-toccati (fig. 2), manufatti non ritoccati, nuclei e scarti di lavorazione. Sot-to l’aspetto tecnologico i due orizzonti si presentano omogenei; i dati pre-liminari attestano per entrambi i casi una scheggiatura, abbastanza stan-dardizzata e poco elaborata, volta alla produzione di supporti laminari(lame più o meno regolari, sovente larghe, e lamelle) con sfruttamentoprevalente di nuclei prismatici ad un piano di percussione (raramente ipiani sono due) talvolta preparato; è attestata la presenza di nuclei subpi-ramidali. La selce è verosimilmente di provenienza locale rappresentatada diverse varietà, tutte di ottima qualità6. È documentato sia lo sfrutta-mento di ciottoli sia di noduli e anche probabilmente di blocchi di distac-co da liste. Si nota una differenziazione tra i supporti utilizzati per glistrumenti comuni, che sono larghi e molto larghi, anche poco regolari,usati soprattutto per grattatoi e raschiatoi lunghi (in qualche caso sonoutilizzati anche schegge e lame di primo débitage), e quelli destinati aconfezionare i dorsi e alcune troncature per i quali si registra l’utilizzo dilamelle anche strette a morfologia più regolare e simmetrica, verosimil-mente ottenute durante la fase terminale di sfruttamento dei nuclei. La
294 F. MARTINI et alii
Fig. 2 - Grotta delle Uccerie, industria litica dello strato 4: 1-6) grattatoi fron-tali; 7-11) raschiatoi lunghi; 12) troncatura; 13) becco; 14) punta a dor-so; 15, 16) frammenti di dorso; 17, 18) geometrici (dis. L. Baglioni).
tecnica del microbulino è documentata da alcuni residui che concernonosia supporti laminari probabilmente microlitici e stretti sia lame larghe ditaglia maggiore.
Per quanto riguarda gli strumenti l’assetto tipometrico, consideratonell’insieme dei due orizzonti, è caratterizzato da pezzi di piccole dimen-sioni (54,1%) seguiti da quelli di medie dimensioni (28,3%), microliti
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 295
*7 Queste osservazioni in senso evolutivo del assetto tipometrico sono da considerarsi indi-cative a causa del basso numero di strumenti soprattutto nell’orizzonte superiore.
(15,3%) e molto rari ipermicroliti (2,4%). Nel dettaglio, nel passaggiodall’orizzonte inferiore al superiore si coglie un aumento del microlitismoin generale (microliti sommati agli ipermicroliti: da 12,1% a 23,2%) ascapito delle medie dimensioni. L’indice di laminarità complessivo deglistrumenti è alto soprattutto nello strato inferiore (circa 70%), con unaflessione al passaggio all’orizzonte superiore7.
L’industria litica dell’orizzonte inferiore comprende 136 tipi primari.Dal punto di vista strutturale i caratteri principali sono: il primo rangodel Substrato (42,6%) e al suo interno l’incidenza dei raschiatoi lunghiche sono dominanti (le modalità di scavo con martello elettrico hannoportato alla frammentazione di molti manufatti) e di raschiatoi corti edenticolati molto meno importanti; lo sviluppo degli Erti differenziati, so-prattutto ad opera di troncature e secondariamente di dorsi, mentre igeometrici sono appena rappresentati; lo sviluppo di grattatoi, soprattut-to lunghi con buona presenza di forme carenate.
I raschiatoi lunghi, che costituiscono il gruppo strutturalmente più for-te, sono otttenuti su supporti per lo più poco regolari e tendenzialmenteslanciati, alcuni sono larghi e al limite con le schegge laminari. La lavora-zione è sia periferica sia profonda generalmente parziale; tra i ritocchiprofondi si registra una buona percentuale di pezzi a lavorazione accura-ta, totale, talora bilaterale. Da segnalare la presenza di punte a lavorazio-ne accurata e invadente, ben simmetriche anche in associazione con grat-tatoi. Le troncature sono soprattutto profonde, sia normali (5,2%) siaoblique (4,4%), ben sviluppate anche quelle marginali (7,4%). Sono piùspesso accurate, profonde e totali. All’interno di questa lavorazioneprofonda va ricordato anche l’analogo stile dei becchi. Le armature com-prendono essenzialmente strumenti a dorso (14,0%), quasi esclusivamen-te punte a dorso (5,9%) (molti sono i frammenti indeterminabili) soprat-tutto PD4. Si tratta di elementi di dimensioni piccole e più raramente mi-crolitiche, sia larghi sia stretti, sempre slanciati con alto indice di allunga-mento. Il ritocco e tendenzialmente subrettilineo o a convessità poco ac-centuata. L’unico geometrico è un romboide di grossa taglia, ricavato daframmento di grande lama a lati paralleli, (doppio piquant-triedre) condue troncature oblique ben marcate. Il gruppo dei grattatoi costituisceuno degli elementi distintivi di questa industria; sono caratterizzati daun’ampia variabilità a livello di tipo secondario, sia in relazione al sup-porto (simmetria, laminarità etc.), sia alla morfologia del fronte, sia anco-
ra all’importanza del ritocco latrale. Si tratta di forme lunghe ampiamenteprevalenti sulle corte (Gfl/Gfc 8,5), anche su supporto laminare slanciatotendenzialmente regolari, con fronte sempre accurato, molto convesso opoco convesso, in asse, i margini sono rettilinei o sinuosi, talora conver-genti alla base, alcuni pezzi carenati, riprendono i caratteri generali diquelli piatti, non mancano i pezzi composti e quelli multipli. I bulini, discarso peso strutturale, vanno ricordati in quanto si allineano con lo stilegenerale dell’industria legato alle dimensioni considerevoli, all’utilizzo disupporti su lama; la lavorazione è più spesso poco elaborata a stacchi uni-ci. La tecnica del microbulino è documentata da alcuni residui che con-cernono sia supporti laminari probabilmente microlitici e stretti sia lamedi taglia maggiore larghe.
L’industria litica ritoccata dell’orizzonte superiore comprende 67 tipiprimari, con un assetto che sembrerebbe non molto diverso da quellodell’orizzonte inferiore. Questa possibile omogeneità quantitativa pareconvalidata anche dai caratteri stilistici dei singoli gruppi anche se si rav-visano alcuni elementi che insieme al dato tipometrico sopra descritto po-trebbero testimoniare una certa dinamica evolutiva. Registriamo un au-mento dei grattatoi corti che tuttavia restano minoritari rispetto ai lunghi,una degressione dei raschiatoi lunghi e dei denticolati e degli strumenti adorso. Tra i reperti più significativi si segnala, un geometrico (Gm5 ten-dente a Gm8), microlitico, a lavorazione molto marcata, su porzione dilama larga e spessa che trova confronti all’Acqua Fitusa.
I due orizzonti di Uccerie, sostanzialmente omogenei, rappresentanoun’importante nuova acquisizione nell’ambito dell’Epigravettiano finalesiciliano in quanto portano a definire la presenza sull’isola attorno a13.000 anni orsono (non calibrata) di uno stadio industriale ben definito,organico, con aspetti peculiari che lo differenziano da altri stadi più re-centi documentati sia nella Sicilia occidentale sia nella parte orientale(Martini et alii 2007; Lo Vetro e Martini in questo volume).
Sono alcuni caratteri sia quantitativi sia stilistici a creare una fisionomiaspecifica: a livello strutturale il Substrato domina sugli Erti differenziati; dirilievo sono lo scarso sviluppo dei dorsi e la presenza irrilevante di geome-trici rappresentati da forme trapezoidali e romboidali; le punte a dorso so-no microlitiche e piccole, su supporto tendenzialmente lamellare e slancia-to; la convessità del dorso è poco accentuata; lo sviluppo dei grattatoi, conforme lunghe prevalenti, variabili a livello di tipi secondari, e la presenzasignificativa di grattatoi spessi; l’alto valore delle lame; la lavorazione accu-rata e invadente, che concerne quasi tutti i gruppi tipologici, soprattuttograttatoi, lame, troncature, punte; l’alta laminarità complessiva che coin-volge tutti i gruppi tipologici, anche con elementi molto slanciati.
296 F. MARTINI et alii
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 297
I livelli mesolitici (strati 2 e 3)Gli strati 2 e 3 testimoniano una presenza umana in grotta durante il
Mesolitico; questa fase è documentata in base alle due misure radiometri-che, in quanto il materiale è estremamente scarso.
Come per la fase epigravettiana anche nei livelli mesolitici è attestatol’utilizzo di diverse varietà di selce locale di buona qualità in forma diciottoli, noduli e liste. Dal punto di vista tecnologico registriamo la pre-senza di nuclei poliedrici molto sfruttati di dimensioni ridotte e una pre-valenza della componente microlitica su scheggia e su lamella.
Lo strato 3, datato a 8.320±85 BP (7.550-7.130 a.C.), ha restituito po-chi manufatti tra i quali alcuni ritoccati; al loro interno emergono alcunigrattatoi (fig. 3), in due casi di medie dimensioni associati ad elementicorti di piccole dimensioni di cui uno frontale a morfologia tettiforme(fig. 3, n. 4) che rimanda a modelli mesolitici peninsulari (cfr. Sauveterria-no). I raschiatoi sono di taglia media e a lavorazione non invadente, unB6 è microlitico. Si rileva la presenza di un microbulino su microlamella.
Lo strato 2, datato a 7.998±80 BP (7.090-6.650 a.C.), è stato altrettan-to avaro di manufatti. Tra i ritoccati (fig. 4) compaiono alcuni raschiatoidi piccole dimensioni e un grattatoio corto ma soprattutto va segnalata lapresenza di due frammenti di dorso, uno microlitico spesso e poco accu-rato l’altro microlitico stretto.
Il materiale degli strati 2 e 3 non permette una diagnosi esaustiva; pos-siamo solo indicare la presenza di alcuni elementi che per i caratteri tecno-tipologici potrebbero rimandare agli insiemi che sono stati attribuiti al fi-lone di tradizione epigravettiana (Lo Vetro e Martini in questo volume).
Fig. 3 - Grotta delle Uccerie, industria litica dello strato 3: grattatoio frontali lun-ghi e corti (foto D. Lo Vetro).
298 F. MARTINI et alii
Fig. 4 - Grotta delle Uccerie, industria litica dello strato 2: 1, 2) nuclei; 3, 4) grat-tatoi; 5, 6) frammenti di dorso. (foto D. Lo Vetro).
LA FREQUENTAZIONE NEOLITICA (S. Casciarri, D. Lo Vetro)
Le evidenze neolitiche sono contenute nello strato 1, per il quale è sta-ta ottenuta su carbone vegetale la misura radiometrica pari a 5.921±50BP (4.940-4.690 a.C.). Nell’industria litica, in verità poverissima, si regi-stra come nelle fasi precedenti l’utilizzo di selce locale raccolta in affiora-mento e in deposizione secondaria; tra i supporti sono presenti lame e la-melle molto regolari a sezione triangolare e trapezoidale. Tra i manufattiritoccati (fig. 5), oltre a qualche troncatura, ad alcuni raschiatoi (sia su la-ma che su scheggia) e a un denticolato a ritocco poco accurato, si segna-lano due grattatoi su supporto massiccio e irregolare e un trapezio iper-microlitico di buona fattura.
La ceramica (fig. 6) comprende pochi ma significativi frammenti tra iquali compaiono alcuni elementi decorati. Gli impasti utilizzati sono di ti-po grossolano e depurato, i primi presentano superfici sommariamente li-sciate, con tracce di lisciatura sulle pareti interne, di colore arancio in su-perficie e nero sulle fratture, quelli depurati si distinguono per un aspettopiù compatto, con superfici lisciate di colore grigio-arancio. Tra gli impa-sti grossolani, di cui non è stato possibile riconoscere una serie formale diappartenenza, sono presenti due frammenti a pareti spesse, decoratiesternamente da profonde incisioni. Sul frammento più significativo le in-cisioni sono disposte in maniera poco ordinata e seguono un andamento
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 299
Fig. 5 - Grotta delle Uccerie, industria litica dello strato 1: 1, 2) grattatoi; 3) tron-catura; 4) geometrico; 5) lamella non ritoccata. (foto D. Lo Vetro).
Fig. 6 - Grotta delle Uccerie, reperti ceramici decorati dello strato 1: ceramica adimpasto grossolano con decorazione a solchi profondi; 2-5) ceramica adimpasto depurato decorata con motivi incisi (dis. S. Casciarri).
subparallello, sembrano essere state eseguite con uno strumento a puntarettangolare o circolare che ha lasciato segni di striature nella solcatura(fig. 6, n. 1). Tra gli impasti depurati è stato possibile ricostruire una for-ma a carena arrotondata (di morfologia globulare schiacciata) di grandidimensioni (Ø 340 mm ca), ad orlo non distinto diritto su cui si è conser-vato parte dell’attacco dell’ansa a nastro, impostata dall’orlo al punto dimassima curvatura della parete. La decorazione è caratterizzata da linee
300 F. MARTINI et alii
*8 Nei paragrafi a più nomi il contributo degli Autori è equivalente.
incise con motivi a “chevrons” che partono da una linea orizzontale inci-sa poco sotto l’orlo e da motivi angolari paralleli, eseguiti sulla parte diansa conservata (parte del nastro e punto di imposta inferiore) (fig. 6, n.5). Altri tre frammenti di parete ad impasto depurato con spessori sottilisi presentano decorati da motivi incisi (fig. 6, nn. 2-4). In due frammenti imotivi, forse triangolari, sono campiti da linee incise parallele ed angolari(fig. 6, nn. 3, 4). Per un inquadramento cronologico e culturale dell’indu-stria ceramica di Grotta delle Uccerie si propone un confronto con il ma-teriale proveniente dalla Grotta del Kronio di Sciacca (Agrigento), (Tinè1971; Maggi 1976-77) in particolare con il livelli neolitici (liv. 8-14) dellafase IVb, attribuibilie alla facies “impresse evolute” di stile Kronio classi-co (Tinè et alii 1994). Tra le forme tipiche del Kronio classico è ben inse-ribile la tazza carenata con ansa a nastro decorata da incisioni di Grottadelle Uccerie. Risultano inoltre confrontabili i tipi di impasto (grossolanoe depurato) e le decorazioni incise, con bande e motivi triangolari.L’assenza di ceramica dipinta di stile Capri e Serra d’Alto a Grotta delleUccerie, presente invece nello strato IVa di Grotta del Kronio e caratte-rizzante lo stile successivo evoluto, può essere una ulteriore conferma perl’attribuzione del materiale allo stile del Kronio classico8.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
BISI A. M. 1969, Favignana e Marettimo (Isole Egadi). Ricognizione archeologica,Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Notizie degli Scavi di Antichità,serie VIII, vol. XXIII, pp. 316-340.
BOVIO MARCONI J. 1952, Isole Egadi. Esplorazioni archeologiche a Levanzo e Favi-gnana, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Notizie degli Scavi di Anti-chità, serie VIII, vol. VI, pp. 185-199.
COLONESE A.C. in questo volume-a, Molluschi marini in depositi antropici: il casodi Grotta d’Oriente (Favignana).
COLONESE A.C. in questo volume-b, Lo sfruttamento dei molluschi mesolitorali:evidenze mesolitiche a Grotta di Cala Mancina (S. Vito lo Capo - Trapani).
COLONESE A.C., ZIVERI P., TROELSTRA S. in questo volume, Primi dati sulla sta-gionalità di raccolta di Osilinus turbinatus (von Born, 1778; Gastropoda, Proso-branchia) a Grotta d’Oriente (Favignana), Grotta delle Uccerie (Favignana) eGrotta di Cala Mancina (S. Vito Lo Capo).
DALLA ROSA G. 1870, Ricerche Paleotnologiche nel litorale di Trapani, Parma.
PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA DELLA UCCERIA 301
LO VETRO D., MARTINI F., in questo volume, Il Paleolitico e il Mesolitico inSicilia.
MAGGI R. 1976-77, Gli scavi nelle Stufe di San Calogero sul Monte Kronio, Koka-los 22-23, pp. 510-518.
MALATESTA A. 1957, Terreni faune e industrie quaternarie nell’Arcipelago delleEgadi, Quaternaria, IV, pp. 165-257.
MARTINI F., LO VETRO D., COLONESE A. C., DE CURTIS O., DI GIUSEPPE Z., LO-CATELLI E., SALA B., 2007, L’Epigravettiano finale in Sicilia, Atti della Tavolarotonda: L’Italia tra 15.000 e 10.000 anni fa. Cosmopolitismo e regionalità nelTardoglaciale, Firenze 18 Novembre 2005, pp. 209-254.
MARTINI F., LO VETRO D., COLONESE A. C., CILLI C., DE CURTIS O., DI GIUSEP-PE Z., GIGLIO R., LOCATELLI E., SALA B., TUSA S. in questo volume, Primi ri-sultati sulle nuove ricerche stratigrafiche a Grotta d’Oriente (Favignana, Trapa-ni). Scavi 2005.
REIMER P.J., BAILLIE M.G.L., BARD E., BAYLISS A., BECK J.W., BERTRAND C.J.H.,BLACKWELL P.G., BUCK C.E., BURR G.S., CUTLER K.B., DAMON P.E.,EDWARDS R.L., FAIRBANKS R.G., FRIEDRICH M., GUILDERSON T.P., HOGG
A.G., HUGHEN K.A., KROMER B., MCCORMAC G., MANNING S., BRONK RAM-SEY C., REIMER R.W., REMMELE S., SOUTHON J.R., STUIVER M., TALAMO S.,TAYLOR F.W., VAN DER PLICHT J., WEYHENMEYER C.E. 2004, IntCal04 terre-strial radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP, Radiocarbon, 46 (3), pp.1029-1058.
TINÈ S. 1971, Lo stile Kronio in Sicilia, lo stile di Ghar Dhalam a Malta e la suc-cessione del Neolitico nelle due isole, AttiIIPP XIII, Firenze, pp. 75-88.
TINÈ S., TINÈ V., TRAVERSO A. 1994, La campagna di scavo del 1986 nell’AntroFazello del complesso “Stufe di San Calogero” del Monte Kronio di Sciacca(AG), in TUSA S., a cura di, La Preistoria del basso Belice e della Sicilia meri-dionale nel quadro della preistoria siciliana e mediterranea, pp. 245-262.
VELLANOWETH R.L., LAMBRIGHT M.R., ERLANDSON J.M., RICK T.C. 2003, EarlyNew World maritime technologies: sea grass cordage, shell beads, and a bonetool from Cave of the Chimneys, San Miguel Island, California, USA, Journal ofArchaeological Science 30, pp. 1161–1173.
RIASSUNTO. - PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI SCAVO 2005 A GROTTA
DELLE UCCERIE (FAVIGNANA, TP). - Le ricerche nella Grotta delle Uccerie hannomesso in luce una sequenza stratigrafica con livelli dell’Epigravettiano finale, delMesolitico e del Neolitico antico. Dal punto di vista economico, sia negli oriz-zonti epigravettiani che mesolitici, l’attività di caccia, la raccolta di molluschi ma-rini e la pesca costituiscono, come in atri giacimenti coevi, la base dell’economiadi sussistenza. La raccolta di molluschi marini a scopo alimentare diviene signifi-cativa a partire dall’occupazione mesolitica dello strato 3. Il complesso epigravet-tiano, datato a circa 13.000 BP, indica una fase originale che potrebbe rappresen-
302 F. MARTINI et alii
tare l’aspetto più antico sinora documentato sull’isola. L’industria mesolitica,non abbondante, potrebbe riferirsi alla facies di tradizione epigravettiana. La fre-quentazione neolitica si riferisce, sulla base dell’indicatore ceramico, alla facies“impresse evolute” di stile Kronio classico.
RÉSUMÉ. - PREMIERS RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE FOUILLES 2005 DI GROT-TA DELLE UCCERIE (FAVIGNANA, TP). - Les recherches dans la Grotta delle Ucce-rie ont mis en évidence une séquence stratigraphique avec niveaux del’Epigravettien final, du Mésolithique et du Néolithique ancien. Au point de vuede l’économie, dans les horizons soit épigravettiens que mésolithiques, la chasse,la récolte de mollusques marines au but alimentaire et la pêche constituent la ba-se de l’économie de subsistance, de même que dans d’autres gisements contem-porains. La récolte de mollusques marines au but alimentaire devient significati-ve seulement avec l’occupation mésolithique di niveau 3. Le complexe épigravet-tien, daté d’environ 13.000 ans BP, montre une phase originale qui pourrait re-présenter l’aspect le plus ancien jusqu’à présent documenté sur l’île. L’industriemésolithique, pas abondante, pourrait se référer au facies de tradition épigravet-tienne. La fréquentation néolithique se réfère aux facies «imprimés évolués» dustyle Kronio chassique, selon les données fournies par la céramique.