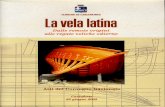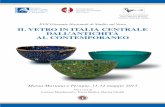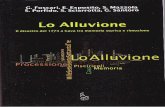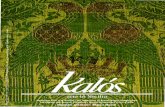Esposito-Pollini-Pottery and cultural borders in Magna Graecia and Sicily
Note sulla genesi e l'evoluzione dell'autopragia demaniale nei secoli IV-VI, in Ricerca come...
-
Upload
uni-tuebingen1 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Note sulla genesi e l'evoluzione dell'autopragia demaniale nei secoli IV-VI, in Ricerca come...
Comitato scientifico
Orsola Amore, Giuliana Ancidei, Antonello Biagini, Anna Maria Gloria Capomacchia, Antonino Colajanni, Anna Esposito,
Francesco Gui, Anna Maria Isastia, Anna Maria Iuso, Mariano Pavanello, Guido Pescosolido, Emanuela Prinzivalli, Alessandro Saggioro,
Alberto Sobrero, Maria Antonietta Visceglia (coordinatore)
Segreteria di redazione
Michela Guerrato
I testi della collana sono valutati da specialisti esterni con procedura anonima
Ricerca come incontroArcheologi, paleografi e storici
per Paolo Delogu
a cura di Giulia Barone, Anna Esposito e Carla Frova
viella
Copyright © 2013 – Viella s.r.l.Tutti i diritti riservatiPrima edizione: settembre 2013ISBN: 978-88-6728-137-4
viellalibreria editricevia delle Alpi, 32I-00198 ROMAtel. 06 84 17 758fax 06 85 35 39 60www.viella.it
Tabula gratulatoria
Alberzoni Maria Pia, MilanoAmore Orsola, RomaAndenna Giancarlo, MilanoArchetti Gabriele, MilanoArnaldi Girolamo, RomaBalestracci Duccio, SienaBaronio Angelo, BresciaBeatrice Pier Franco, PadovaBeolchini Valeria, RomaBernacchia Roberto, MondolfoBiblioteca di Scienze della Storia e Documentazione Storica,
Università degli Studi di MilanoBonfiglio-Dosio Giorgetta, PadovaBritish School at Rome, RomaCaciorgna Maria Teresa, RomaCarbonetti Cristina, RomaCarocci Sandro, RomaCavallo Guglielmo, RomaCentro Italiano di Studi Longobardi, BresciaCherubini Giovanni, FirenzeChittolini Giorgio, MilanoCollavini Simone Maria, PisaCorsi Pasquale, BariCortonesi Alfio, ViterboCosentino Salvatore, BolognaDierkens Alain, BruxellesEsch Arnold, RomaFalcioni Anna, Fanovon Falkenhausen Vera, Roma
VI Ricerca come incontro
Gangemi Maria Luisa, RomaGelichi Sauro, VeneziaGianmaria Gioacchino, AnagniGinatempo Maria, SienaGiostra Caterina, MilanoGoetz Hans-Werner, HamburgIstituto Storico Germanico / Biblioteca Storica, RomaIstituto Storico Italiano per il Medioevo, RomaKujawiński Jakub, PoznańLeggio Tersilio, FarfaLeverotti Franca, MassaLorè Vito, RomaLuzzati Michele, PisaMaire Vigueur Jean-Claude, RomaManacorda Daniele, RomaMatheus Michael, MainzMeyer Andreas, MarburgMiglio Massimo, RomaMiller Maureen C., BerkeleyMolinari Alessandra, RomaNishimura Yoshiya, NagoyaOfficina di Studi Medievali, PalermoPiccinni Gabriella, SienaPinto Giuliano, FirenzeRacine Pierre, StrasburgoRossetti Gabriella, PisaSaguì Lucia, RomaSaitta Biagio, CataniaSangermano Gerardo, NapoliSenatore Francesco, NapoliSlavazzi Fabrizio, MilanoStroppa Francesca, BresciaVannini Guido, FirenzeVaranini Gian Maria, VeronaVarela-Rodríguez Ma Elisa, GironaVendittelli Marco, RomaVisceglia Maria Antonietta, RomaWard-Perkins Bryan, OxfordWolf Kordula, Roma
Da quando, nel 1964, venne pubblicato sul «Bullettino dell’Istituto Sto-rico italiano per il Medio Evo» il suo primo saggio Consors regni. Un problema carolingio, Paolo Delogu è stato una presenza costante e via via di sempre maggior rilievo nella medievistica italiana.
Professore prima a Salerno, in seguito a Firenze e, dal 1985, a Roma, gli interessi di Delogu si sono rivolti in un primo tempo alla dissoluzione del potere carolingio in Italia, poi alla storia di Salerno tra VIII e XI secolo, in seguito ai longobardi – e soprattutto al loro sempre discusso rapporto con i romani –, più tardi ai normanni nel Mezzogiorno d’Italia e alla storia eco-nomica di Roma nell’alto medioevo. Fondamentale è certamente stato il suo contributo all’affermazione dell’archeologia medievale, una disciplina che in Italia – fino agli Settanta del XX secolo – era stata “schiacciata” dall’incombente presenza di quella classica e che Paolo Delogu ha inizial-mente praticato di persona, restando poi, fino ad oggi, attento e stimolante interlocutore per tutti quelli che la praticano sul campo.
Nel corso di questo lungo itinerario, geografico e culturale, Delogu ha avuto modo di incontrare molti colleghi, di formare ottimi allievi e di in-crociare i più diversi campi di ricerca. Questo volume raccoglie i saggi di chi è entrato in rapporto con lui, come collega, allievo o compagno nell’av-ventura dell’indagine del passato.
La raccolta di saggi, pensata in occasione del suo settantesimo com-pleanno, coglie la fortunata opportunità di festeggiare la sua nomina a pro-fessore emerito della “Sapienza”.
Giulia Barone, Anna Esposito, Carla Frova
Indice
Paolo TedescoNote sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale nei secoli IV-VI 3
Gian PieTro BroGioloVerona tra tardo antico e alto medioevo: alcune considerazioni 19
Marco di BrancoPregi e difetti della compilazione: gli attacchi arabi contro Rodi nelle fonti islamiche 33
sauro GelichiLupicinus presbiter. Una breve nota sulle istituzioni ecclesiastiche comacchiesi delle origini 41
alessia rovelliDns Victoria. Legende monetali, iconografia e storia nelle coniazioni della Langobardia meridionale del IX secolo 61
Giuliano MilaniIl secondo Simone. Le fonti letterarie e visuali di un’illustrazione del salterio Chludov (Bisanzio, secolo IX) 83
viTo lorèLa chiesa del principe. S. Massimo di Salerno nel quadro del Mezzogiorno longobardo 103
X Ricerca come incontro
Giulia BaroneTheophanius imperator augustus? Postille sul documento dell’imperatrice Theophanu per Farfa (1° aprile 990) 125
daniele BianconiTracce di scrittura beneventana in un nuovo codice italogreco 143
Paolo PeduToDal legno alla pietra nelle fortificazioni normanne in Italia meridionale 165
Federico MarazziUltimi longobardi. La contea di Venafro e il suo territorio fra Montecassino, S. Vincenzo al Volturno e i normanni (950-1100 circa) 183
chris WickhaMAlbano in the central Middle Ages 209
anTonio sennisLinguaggi della persuasione. Le visioni soprannaturalinel mondo monastico medievale 227
eMMa condello«In monasterio sancti Christi martirys Anastasii qui vocaturAqua Salvia». Un nuovo codice superstite del monastero delle Tre Fontane 245
lidia caPoSulle cronache medievali 265
alFonso MariniI viaggi di Francesco. Storia e “memorie”, leggende e metafore 279
carla FrovaLa storia delle istituzioni scolastiche nel medioevo come tema di storia sociale 293
XIIndice
Bruno FiGliuoloI priorati celestiniani molisani di Trivento e Agnone dalle origini alla soppressione (secoli XIII-XIX) 309
ivana aiTDomini Urbis e moneta (fine XIII-inizi XV secolo) 329
Marco cursiCacciatori di autografi: ancora sul codice Riccardiano 2317 e sulla sua attribuzione alla mano del Boccaccio 351
alFredo cocciTemi antiebraici e islamici nel De adventu Messiae (1339) di Alfonso Buenhombre OP 379
Giovanni viToloGoverno del territorio e rappresentazione dello spazio nel Mezzogiorno aragonese 399
riTa cosMaIl codice Vaticano latino 3993 425
eleonora PleBaniVerso l’Africa e l’Oriente. Alcune riflessioni sulla recente medievistica italiana 451
anna esPosiToFamiglie aristocratiche e spazi sacri a Roma tra medioevo e prima età moderna 471
uMBerTo lonGoL’inventio di Archelao: ovvero la riscoperta delle origini cristiane nel Seicento sardo 483
leonida PandiMiGlioDue libri di famiglia del terzo millennio 495
Paolo Tedesco
Note sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale nei secoli IV-VI
Il presente studio si propone di descrivere sinteticamente la genesi e lo sviluppo dell’istituto conosciuto con il nome di autopragia demaniale. L’obiettivo principale della ricerca è distinguere il privilegio/obbligo della delega fiscale, vale a dire l’onere di raccogliere e in alcuni casi anticipare l’imposta in nome e per conto della manodopera ascritta, da forme illegali di patronato o autopractorium, al contrario finalizzate a sottrarre i contri-buenti minori all’assoggettamento tributario.
L’indagine vuole altresì presentare la funzione dei fondi autopragi-ci come parte integrante della riorganizzazione amministrativa perseguita dalla riforma di Diocleziano; in altre parole non come entità antistatali e anticittadine, ma come conformazioni che si inserirono fino in epoca molto avanzata nel funzionamento della fiscalità imperiale e degli istituti civici.
La genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale nei secoli che van-no dal IV al VI d.C. presentano numerosi aspetti controversi, in riferimento sia alla natura del “fenomeno”, sia al grado della sua diffusione nel conte-sto del sistema di gestione fiscale della proprietà fondiaria.
Il primo aspetto riguarda l’ambivalente natura del privilegio autopra-gico: da un lato la dimensione istituzionale regolata dal legislatore per fa-cilitare la riscossione delle imposte, nel cui ambito la delega fiscale rappre-sentava prima di tutto un obbligo; dall’altro la pratica affermatasi presso i fondi, contro la quale la legislazione dovette intervenire in seguito, per definire limiti e modalità di un potere divenuto in alcuni casi arbitrario, e correggere così gli abusi.
Il secondo aspetto, conseguente al primo, attiene al grado di diffusione del fenomeno presso le proprietà piccole e medie, al valore da attribuire
4 Paolo Tedesco
all’espressione “quantulacumque possessio”, quale requisito per accedere al diritto di versare personalmente le imposte.1
Il ricorso diffuso al termine possessio introduce un ulteriore tema ri-guardante l’assegnazione del privilegio/obbligo autopragico ai concessio-nari titolari di diritti diversi dalla proprietà.2
La prima questione si pone per il semplice fatto che nella legislazione del IV secolo è assente un’esplicita definizione dell’istituto, benché in più di una costituzione si faccia riferimento a un meccanismo che presuppone-va l’esercizio della funzione di collettori delle imposte da parte dei proprie-tari, riconducibile senza difficoltà all’autopragia.3 Nell’intero corpus nor-mativo l’unica costituzione che utilizzi un termine esplicitamente riferito a tale pratica è C.Th. 11.22.4 del 409.4 La legge tuttavia non parla dell’au-topragia vera e propria, ma dell’autopractorium, che anche sul piano les-sicale non è evidentemente la stessa cosa.5 Nel testo l’autopractorium è definito come l’usurpazione, il travalicamento delle funzioni dell’istituto originario, fattispecie che si verificava quando il proprietario andava oltre l’obbligo di corrispondere l’imposta dei propri coloni, ed estendeva abusi-
1. Codex Theodosianus (d’ora in avanti C.Th.) 11,1,14 (371) = Codex Iustinianeus (d’ora in avanti C.I.) 11,48,4.
2. E. Levy, West Roman Vulgar Law: The Law of Property, Philadelphia 1951, pp. 87-90, sottolinea che il termine possessor nel diritto tardo imperiale indicava il proprietario. R. Delmaire, Cités et fiscalité au Bas-Empire. À propos du rôle des curiales dans la levée des impôts, in La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale, a cura di C. Lepelley, Bari 1996, pp. 59-70: p. 70, ritiene che possessor si riferisse ai concessionari (conduttori, enfiteuti, ecc.) e non alla titolarità del diritto pieno ed esclusivo, che era invece identificata dall’uso del termine dominus. M.J. Castillo Pascual, Algunas notas sobre los términos dominus y posses-sor en la literatura gromática, in «Iberia», 1 (1998), pp. 109-113, ribadisce la distinzione giu-ridica tra i due termini precisando che possessor era comunemente utilizzato nei casi di occu-pazione o sfruttamento di terre confinanti a quelle di proprietà. Sull’argomento si veda anche Id., El vocabulario jurídico de los agrimensores romanos, in «Brocar», 19 (1995), pp. 7-26.
3. C.I. 11,50,1 (325); C.Th. 5,17,1 (332); C.Th. 11,1,7 (361).4. C.Th. 11.22.4 (409): «Nonnullos possessores exactionis consuetae more dissimu-
lato eo temeritatis procedere cognovimus, ut quidam auctoritate rescriptionis elicita instan-tiam compulsorum eludant sub eo obtentu, quod sponte pronius inferant expetenda. Qua usurpatione patefacta promulgamus, ut huiusmodi impetrationis novitate supplosa, quae vulgo autopractorium vocatur, universa pensitationis profligandae quae fuit reviviscat sol-lemnitas et curiales vel apparitio provincialis huius muneris vota procurent, exceptis his, quos eminentissimae tuae sedis specialiter consideratio digessit».
5. J.-M. Carrié, Colonato del Basso Impero:la resistenza del mito, in Terre, proprie-tari e contadini dell’Impero romano. Dall’affitto agrario al colonato tardoantico, a cura di E. Lo Cascio, Roma 1997, pp. 75-150: p. 107.
5Note sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale
vamente la prerogativa alle terre non di sua proprietà. Sembra evidente che affinché potesse verificarsi un abuso del diritto era necessario che l’istituto fosse già definito nella sua forma lecita; appare dunque improprio pensare a un’identità tra le due fattispecie.6
Andando a ritroso nella legislazione del IV secolo vi sono diverse costituzioni e altri documenti legali che disciplinano il funzionamento dell’autopragia, benché non si faccia mai esplicito riferimento all’istituto con questo nome. L’assenza del termine nelle fonti legislative non esclude tuttavia a priori che l’esercizio del diritto si sia affermato prima nella pras-si, il che non vuol dire né al di fuori né contro la legge, piuttosto secundum legem. L’evoluzione ebbe luogo conformemente all’esigenza del sistema fiscale di raggruppare i contribuenti in nuclei collettivamente responsabili e solidali, all’interno dei quali trasferire i conflitti che prima opponevano i contribuenti agli esattori. Era una necessità, quest’ultima, divenuta par-ticolarmente rilevante nel nuovo scenario amministrativo realizzato dalla riforma fiscale per la riscossione dell’imposta personale di capitazione, sulla scorta dell’esempio fornito dal modello egiziano, già organizzato in comunità collettivamente responsabili degli oneri pubblici.7
Il nuovo sistema, infatti, presupponeva per poter funzionare efficace-mente, da un lato il vincolo alla residenza fiscale della popolazione agricola non titolare di terra propria, dall’altro l’obbligo del proprietario del fondo di raccogliere l’imposta dovuta dai coloni ascritti. L’osservanza di questi due requisiti, consapevoli o meno gli estensori della riforma, produsse rilevanti conseguenze. Innanzi tutto l’adscriptio dei coloni e degli schiavi al fondo; l’incidenza della popolazione censita sul calcolo dell’imposta dovuta; infine l’obbligo per i proprietari di raccogliere l’imposta di capitazione.8
Una costituzione del 293 rivela già il legame tra l’imposta (capitatio) e il fondo sul quale il lavoratore era registrato, e il principio secondo il quale in conseguenza del trasferimento della proprietà (praedii venditi) l’onere fi-scale passava dal venditore al compratore.9 Per onere fiscale si intende l’ob-
6. M. Mirkovic, Autopragia and the Village Aphrodito, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Rom. Ab.», 113 (1996), pp. 346-357: p. 349, identifica i due termini attribuendovi lo stesso significato.
7. D. Rathbone, Economic Rationalism and Rural Society in Third-Century A.D. Egypt: The Heronimos Archive and the Appianus Estate, Cambridge 1991, pp. 120-125.
8. Carrié, Colonato del Basso Impero, p. 105.9. C.I. 4.49.9 (293): «Si minor a venditore sive sciente sive ignorante dicebatur capi-
tatio praedii venditi et maior inventa sit, in tantum convenitur, quanto, si scisset emptor ab
bligo in capo al proprietario di raccogliere l’imposta personale dovuta dai coloni fiscalmente residenti sul suo fondo. L’obbligo tuttavia non implicava il trasferimento della responsabilità tributaria dal colono al proprietario. Il colono continuava a essere responsabile delle proprie imposte, mentre il proprietario costituiva solo il primo anello del sistema di riscossione, anti-cipando all’erario, quando necessario, le imposte dovute dal colono. Signi-ficativo in questo senso è il contributo offerto da un papiro del VI secolo (P. Oxy, XXVII 2479), nel quale si parla di un colono egiziano, fuggito da tre anni dal fondo cui era ascritto, che contratta il suo rientro a condizione che sia il proprietario a pagare le sue imposte personali arretrate.10
La questione della restituzione della capitatio arretrata è al centro dell’intervento legislativo contenuto in C.Th. 5,17,1 (332) e anche in que-sto caso sono i proprietari del fondo sul quale il colono si era fraudolente-mente trasferito a essere investiti dell’onere di recuperare e poi restituire al dominus del fondo su cui il colono era ascritto l’imposta personale.11
Il confronto tra questo testo e il precedente (C.I. 4,49,9) mette in evi-denza come l’onere della capitatio, mediante la registrazione dei coloni (adscriptio), entrasse a far parte del valore del fondo, sia in termini po-sitivi, l’apporto di manodopera agricola, sia negativi, il gravame fiscale. Spettava pertanto in ambito rurale al proprietario, se titolare di autopragia, o al praepositus pagi per il villaggio,12 in ambito urbano ai responsabili della civitas o delle associazioni professionali,13 preservare, vigilando sul
initio, minus daret pretii. Sin vero huiusmodi onus et gravamen functionis cognovisset, nul-lam adversus venditorem habet actionem». J.-M. Carrié, Dioclétien et la fiscalité, in «An-tiquité Tardive», 2 (1994), pp. 33-64: pp. 49-50. Principio ribadito in C.Th. 11,3,5 (391).
10. J.G. Keenan, On P.Oxy. XXVII 2479, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigra-phik», 38 (1980), pp. 246-248; J.-M. Carrié, Un roman des origines: les généalogies du “colonat di Bas-Empire”, in «Opus», 2 (1983), pp. 205-251: pp. 233-234.
11. W. Goffart, Caput and Colonate: Towards a History of Late Roman Taxation, To-ronto 1974, pp. 70-74: p. 71; M. Mirkovic, Colonus iuris alieni and Taxation, in «Opus», 5 (1986), pp. 53-73; Carrié, Colonato del Basso Impero, pp. 108-109. Diversamente B. Sirks, The Colonate in Justinian’s Reign, in «Journal of Roman Studies», 98 (2008), pp. 120-143: p. 132, ritiene che il dovere di pagare la capitatio cessava in capo al proprietario del fondo sul quale il colono era registrato nel momento in cui veniva individuato il proprietario che lo aveva accolto; pertanto l’imposta era pagata solo da quest’ultimo.
12. Papyri Cairo Isidorus (d’ora in avanti P. Cair. Isid.) 126 (308-309 A.D.), in cui il pagus è considerato un distretto fiscale a cui devono essere ricondotti i residenti fuggiti.
13. Papyri Oxyrinchus (d’ora in avanti P. Oxy.) LI.3622; P. Oxy. L.3571, rispettiva-mente sull’introduzione e funzione del systates da parte di Diocleziano per sovrintendere alla riscossione della capitatio urbana. J.-M. Carrié, Developments in Provincial and Local Ad-
Paolo Tedesco6
7Note sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale
vincolo al praedium, la corretta corrispondenza tra l’ammontare dell’im-posta da distribuire tra i contribuenti censiti e la popolazione effettivamen-te residente.14
Una legge più tarda, questa volta riferita agli schiavi, ribadisce lo stes-so principio. Il proprietario del fondo era obbligato (obnoxius) a versare l’imposta sulla base dell’intera valutazione della terra dichiarata (terrae professionem), sulla quale gli schiavi risultavano ascritti.15 Gli schiavi na-turalmente, a differenza dei coloni, non potevano essere considerati con-tribuenti responsabili dell’imposta personale, tuttavia la loro registrazione sul fondo incideva contabilmente sulla tariffazione dell’imposta che gra-vava sulla terra.
Una prova di come funzionasse questo sistema di tariffazione è offerta da una costituzione di Valentiniano del 364. La legge richiamata garantiva ai concessionari delle terre imperiali, in caso di miglioramenti dei fondi mediante l’apporto di schiavi e animali, l’immutabilità del canone e della capitatio (cioè la fissità della base imponibile per quest’imposta, nono-stante l’aumento della forza lavoro).16 Il testo disciplina un’eccezione alla legge ordinaria, secondo la quale con l’aumento del numero degli schiavi, aumentava anche il valore della capitatio. La tassa in questione riproduce-va la struttura di base dell’imposta personale in vigore in Egitto prima della riforma. In quella provincia, tutti gli uomini, sia liberi sia schiavi, di età compresa tra i 14 e i 65 anni, pagavano il testatico nella forma dell’imposta di ripartizione.17 Questo non significa che gli schiavi fossero contribuenti
ministration, in Cambridge Ancient History, 12, The Crisis of Empire, A.D. 193-337, a cura di A.K. Bowman, P. Garnsey, A. Cameron, Cambridge 2005, pp. 269-312: p. 306 e n. 162.
14. P. Oxy. XVI 1905, SB V 7756 (359 A.D.), sul valore da attribuire a caput = κεφάλαιον. Sul tema: R. Bagnall, P. Oxy XVI 1905, SB V 7756 and Fourth Century Taxa-tion, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 37 (1980), pp. 185-196: p. 193. D. Vera, Schiavitù rurale e colonato nell’Italia imperiale, in «Scienze dell’Antichità. Storia archeologia antropologia», 6-7 (1992-1993), pp. 291-339: p. 317, definisce tale vincolo un «legame al padrone in funzione dell’imposta».
15. C.I. 11.48.3 (365): «Quisquis ex desertis agris veluti vagos servos liberalitate no-stra fuerit consecutus, pro fiscalibus pensitationibus ad integram terrae professionem, ex qua videlicet servi manere videntur, habeatur obnoxius. 1. Id etiam circa eos observari volumus, qui ex huiusmodi fundis servos ad possessiones suas transire permiserint».
16. C.Th. 5,13,4 (364): «quidquid mancipiorum vel pecoris adcreverit, capitationis aut canonis augmenta non patiatur».
17. P. Oxy. XLVI.3307; Papyri Sakaon 44; Berliner griechische Urkunde 1, 24. J.-M. Carrié, Le riforme economiche da Aureliano a Costantino, in Storia di Roma, a cura di A.
8 Paolo Tedesco
dotati di autonomia giuridica; essi restavano schiavi sottoposti alla pote-stas del padrone, tanto che ancora nel III secolo erano assoggettati a tas-sazione sulla base della dichiarazione censuale del dominus (il padrone).
Sembra dunque rilevante questo specifico aspetto della legge. Il conte-nuto della disposizione permette di comprendere la differenza tra la dichia-razione patrimoniale pre-dioclezianea e il census catastale introdotto dalla riforma: nel nuovo scenario il dominus doveva pagare le imposte sulla base della registrazione al praedium della manodopera servile, in base a una procedura eseguita d’ufficio dalle autorità. In tale contesto il legame alla residenza fiscale (origo/ ἴδια), imposto per esigenze amministrative, non solo era estraneo, ma persino in contraddizione con il diritto civile, che regolava normalmente le relazioni tra il proprietario e i suoi schiavi. Non è del resto l’unica contraddizione che la riforma fiscale introdusse; basta ri-chiamare la legislazione sull’inamovibilità degli schiavi ascritti per trovare un ulteriore evidente contrasto con la normativa che sanzionava il diritto del proprietario di disporre pienamente dei propri schiavi.18 L’assimilazio-ne tra lavoratori liberi e schiavi avveniva solo sul piano amministrativo, non investiva anche la condizione giuridica. La distinzione tra il colono libero e lo schiavo rispetto alla responsabilità per l’imposta personale sem-brerebbe indebolita in quelle province dove era in vigore il regime di iuga-tio sive capitatio. Nei territori organizzati sulla base di quel sistema i due cespiti andavano a confluire in un’unica base imponibile; in questo modo colonus e servus erano ricompresi nella valutazione con un meccanismo analogo a quello in uso per censire piante e animali.
In realtà la procedura di registrazione uniformava i due cespiti soltanto sotto il profilo della contabilizzazione e della conseguente valorizzazione fiscale del fondo; la responsabilità tributaria invece restava a carico dei domini per gli schiavi, dei coloni ascritti, benché attraverso la mediazione del proprietario della terra, per i lavoratori liberi. La differenza tra le due categorie di contribuenti era più marcata in quelle province dove vigeva
Carandini, L. Cracco Ruggini, A. Giardina, 3, L’età tardoantica, 1, Crisi e trasformazioni, Torino 1993, pp. 283-322: p. 294, n. 39; E. Lo Cascio, Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana, Bari 2000, p. 190, sulla composizione e il finanziamento del tributum capitis. M. Corbie, Coinage and Taxation: The State’s Point of View, A.D. 193-337, in Cambridge Ancient History, 12, pp. 327-392: p. 368.
18. C.Th. 3,30,3 (326) = C.I. 5,37,2: «rusticum praedium atque mancipium»; C.Th. 11,3,2 (327): «mancipia adscripta censibus»; C.Th. 7,1,3 (349) = C.I. 12,35,10: «servos adscriptos censibus»; C.I. 11,48,7 (371): «rustici censitisque servi».
9Note sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale
il regime di iugatio e capitatio disgiunte. In queste ultime (ad esempio Egitto, Africa), l’imposta personale, sia che fosse esigibile in natura sia che avesse la forma di contribuzione in denaro (ἐπικεφάλαιον),19 conservava una parte delle caratteristiche del tributum capitis.20 Essa manteneva quin-di un’identità distinta rispetto alla base imponibile dell’imposta fondiaria,21 sebbene il più delle volte le due imposte, tariffate separatamente (quindi con indicazione della ripartizione dei capita), fossero riscosse contestual-mente dallo stesso collettore.22
Le differenze tra una provincia e l’altra nel modo di considerare la capitatio in rapporto all’imposta fondiaria sottolineano l’elemento di no-vità della riforma: un quadro concettuale unitario fondato su due metodi di accertamento validi per tutto l’impero (iugatio e capitatio), e la possibilità di combinare o meno i due criteri a seconda della struttura demografica, economica e del sistema fiscale preesistente nelle singole province.23
Ritornando al tema principale, nel periodo che intercorre tra le due costituzioni citate vi sono altre testimonianze che supportano l’esistenza del privilegio/obbligo dell’autopragia in capo ai proprietari.24
19. A. Bowman, Egypt, in Cambridge Ancient History, 12, pp. 313-326: p. 320; R. Bagnall, D.J. Thomas, Dekaprotoi and Epigraphai, in «Bulletin of American Society of Papirology», 15 (1978), pp. 185-189; Carrié, Le riforme economiche da Aureliano a Co-stantino, p. 300, precisa che nelle province dove le due forme di tassazione coesistevano senza combinarsi, la capitatio sembrava rivestire un ruolo non ugualmente importante nella riscossione del denaro contante.
20. P. Sakaon 9 (314-315 A.D); 13 (307); P. Cair. Isid. (= The Archive of Aurelius Isidorus in the Egyptian Museum, Cairo, and the University of Michigan, a cura di A.E.R. Boak, H.C. Youtie, Ann Arbor 1960) 1 (297); 7 fr.; 72 (314); P. Mich. Inv. 1378 (326/2 A.D.). C.Th. 7,4,32, richiama la distinzione tra imposta fondiaria e personale attraverso il collegamento dei termini “caput” e “tributarius”. H.C. Youtie, P. Mich. Inv. 1378: vestis militaris, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 38 (1980), pp. 289-291: p. 289. Sulle differenze in termini di responsabilità patrimoniale tra fiscalità pre-dioclezianea e dio-clezianea si veda F. Grelle, Stipendium vel tributum. L’imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo, Napoli 1963, pp. 60-65.
21. Papyri London III, p. 239, 1259 (330 A.D.); P. Oxy. XII 1448 (dopo 324 A.D.); Papyri Oslo III 119 (319 A.D.); P. Med. inv. = Papyri Milanesi 197 (342 A.D.), documenta-no il continuo ricorso alle frazioni per le singole voci d’imposta.
22. R. Bagnall, P. Oxy XVI 1905, SB V 7756 and Fourth Century Taxation, in «Zeit-schrift für Papyrologie und Epigraphik», 37 (1980), pp. 185-196: pp. 192-193.
23. J.-M. Carrié, L’incidence de la fiscalité sur les divisions territoriales de l’Empire Tardif, in «Atti dell’Accademia romanistica costantiniana», 13 (1997), pp. 309-331: pp. 312, 330.
24. C.I. 4,49,9 (293) e C.Th. 11,1,14 (371) = C.I. 11,48,4.
10 Paolo Tedesco
Il primo testo di epoca costantiniana (P. Cair. Isid. 71, 314 A.D.) ri-guarda la denuncia contro gli abusi perpetrati da un comarca nella raccolta delle imposte grazie alla collusione con il praepositus pagi.25 Nel secondo documento di poco posteriore, C.I. 11.50.1 (325), si consente ai coloni dei fondi sottoposti ad autopragia di citare in tribunale i proprietari in caso di superexactiones.26 L’azione in giudizio era era concessa al colono in presenza di una richiesta da parte del dominus superiore all’ordinario.27 Sembrerebbe che con il termine superexactiones si facesse specifico rife-rimento agli oneri pubblici, in particolare all’accrescimento dell’imposta personale di capitazione. Non mancano tuttavia episodi in cui le contesta-zioni dei coloni erano dirette contro l’aumento dei canoni.28 Il fenomeno più diffuso riguardava comunque le imposte. In particolare oggetto delle petizioni erano le connivenze tra i potentiores e i tabularii, e le fughe dei contadini dai villaggi per trovare lavoro e protezione nei fondi dei potenti. Entrambi i fenomeni si traducevano in una ripartizione iniqua e ineguale dell’imposta di capitazione a carico dei contadini rimasti nelle loro sedi.29
25. P. Cair. Isid. 71, 72, 73 (314 A.D.); Carrié, Dioclétien et la fiscalité, p. 64. Sul pa-garca si veda: W. Liebeschuetz, The Pagarch: City and Imperial Administration in Byzan-tine Egypt, in «The Journal of Juristic Papyrology», 18 (1974), pp. 163-168, e il saggio di R. Mazza, Ricerche sul pagarca nell’Egitto tardoantico e bizantino, in «Aegyptus», 75 (1995), pp. 169-242.
26. C.I. 11.50.1 (325): «Quisquis colonus plus a domino exigitur, quam ante consue-verat et quam in anterioribus temporibus exactus est, adeat iudicem, cuius primum poterit habere praesentiam, et facinus comprobet, ut ille, qui convincitur amplius postulare, quam accipere consueverat, hoc facere in posterum prohibeatur, prius reddito quod superexactio-ne perpetrata noscitur extorsisse».
27. Carrié, Un roman des origines, pp. 224-225, n. 81.28. D. Vera, Padroni, contadini, contratti: realia del colonato tardoantico, in Lo Ca-
scio, Terre, proprietari e contadini, pp. 185-224: p. 202; Id., Forme e funzioni della rendita fondiaria, in Società romana e impero tardoantico, a cura di A. Giardina, 1, pp. 367-447, 723-760: pp. 390, 740 e n. 127, soprattutto sulla base di alcune costituzioni successive (C.I. 11,50,2,4 del 396), interpreta il fenomeno come un indebito accrescimento dei canoni. Allo stesso modo L. Cracco-Ruggini, “Coloni” e “Inquilini”: “Miseri et egeni homines”?, in «Atti dell’Accademia romanistica costantiniana», 8 (1990), pp. 199-216: pp. 206-208, propone di identificare le superexactiones con riscossioni di locazioni agrarie conteggiate in moneta aurea secondo un numero di solidi superiore per ogni libbra a quello legalmente ammesso.
29. P. Sakaon 5 (P. Strab. 45) del 312; P. Oxy. XLVI 3307; P. Théad. 17 (332). Sulla ripartizione della capitatio si veda: J.-M. Carrié, L’Ėgypte au IVe siècle: fiscalité, économie, société, in Proceedings of the XVII International Congress of Papyrology, Chico 1981, pp. 431-446: p. 440.
11Note sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale
Il governo, principalmente interessato alla riscossione di questa imposta, interveniva sugli abusi con la legge,30 sui munera che i coloni adempivano nei confronti della municipalità attraverso le esenzioni,31 ma solo in manie-ra estemporanea agiva sull’ammontare dei canoni. Questo avveniva solo quando era necessario impedire che canoni troppo elevati esaurissero la capacità fiscale dei coloni.32
L’obbligo facente capo ai proprietari dei fondi di escutere le imposte personali risulta dunque attestato ben prima della sua formalizzazione nel-la costituzione C.Th. 11.1.14 del 371. Questo testo non fa altro che definire sul piano amministrativo una procedura di fatto introdotta dalla riforma fiscale del 287:33 dividere i coloni, nel senso di affittuari, in due catego-rie distinte, da una parte quelli che, detenendo a titolo di proprietà una «quantulacumque possessio», erano da considerarsi contribuenti in nome proprio,34 e dall’altra i coloni originales che erano stati censiti in quegli stessi luoghi, in cui lavoravano in qualità di affittuari.35 La legge regola-mentava dunque due modi di adscriptio, a seconda che il contadino fosse proprietario (e contestualmente affittuario), oppure unicamente affittuario di proprietà altrui. A ciascuno di questi modi di adscriptio corrispondeva un modo diverso di versare l’imposta: personalmente per i primi, presso i soliti esattori, in ragione dell’iscrizione in proprio nome sui registri fiscali, quali unici responsabili del versamento;36 tramite l’intermediario del loro
30. C.Th. 13,10,1 (313).31. C.Th. 11,16, 1 (319): Africa; C.Th. 11,16,9 (359): Italia; C.Th. 11,16,17 (385);
C.Th. 11,16,5 (343) = C.I. 11,75,1; C.Th. 11,16,20 (389) = C.I. 10,48,15; C.Th. 11,1,36 (431) = C.I. 11,75,5. M. Corbie, Coinage, Society and Economy, in Cambridge Ancient History, 12, pp. 393-439: p. 435.
32. Goffart, Caput and Colonate, pp. 68-69.33. Carrié, Le riforme economiche, p. 293; Id., Colonato del basso Impero, p. 108,
osserva che lo stesso principio era alla base di C.I. 11,50,1 (325) e C.Th. 5,17,1 (332). C.Th. 11,1,7 (361) ribadisce, conferendo uno speciale privilegio di esenzione, la comune prassi della responsabilità fiscale dei senatori per le imposte dei coloni fuggiti dalle loro terre. Per l’applicazione dell’istituto nella legislazione successiva si veda C.I. 11,50,2, 3 (396); C.I. 11,48,20,3 (529).
34. C.Th. 11,1 14 (371) = C.I. 11, 48, 4, 1: «qui in suis conscripti locis proprio nomine libris censualibus detinentur».
35. C.Th. 11,1 14 (371) = C.I. 11, 48, 4pr.: «coloni originales in locis isdem censiti». 36. Gli appartenenti a questa categoria rispondevano del debito fiscale con il proprio
patrimonio, facilmente identificabile coincidendo la residenza fiscale con la civitas in cui erano proprietari di un piccolo fondo. Nei casi in cui si fossero trovati in condizione di insolvenza, la proprietà costituiva bene sequestrabile che fungeva da garanzia per il debito
12 Paolo Tedesco
dominus o di uno dei suoi agenti per i secondi.37 Questa legge stabiliva che i proprietari di terre si riferissero per il versamento delle imposte ai soliti esattori; per i coloni privi di una proprietà e pertanto impossibilitati a esse-re annotati nei registri fiscali con il proprio nome, prescriveva che fossero inscritti nei registri del praedium nel quale prestavano il loro lavoro, assu-mendo quindi su quel fondo la residenza fiscale. In ragione della registra-zione i coloni dovevano versare l’imposta personale al proprietario, che aveva l’obbligo di consegnarla, unitamente alle altre imposte, agli esattori. Il privilegio-obbligo dei proprietari era dunque limitato alla raccolta delle imposte dei coloni ascritti sui fondi di loro proprietà. Essi svolgevano la funzione di collatores, non si sostituivano ai compiti degli exactores.38
Una legge di poco posteriore conferma infatti le competenze in mate-ria di riscossione. Dell’exactio dei grandi proprietari (potentes) erano inca-ricati gli officiales del governatore provinciale; i decurioni provvedevano a riscuotere dai curiali, mentre il defensor civitatis si occupava dei proprie-tari minori.39 A loro volta i collettori curiali erano sottoposti al controllo di altri curiali, che potessero fornire le dovute garanzie in caso di insol-venza o accumulo di reliqua.40 Il livello di autonomia tributaria introdotto implicitamente dalla riforma fiscale conferiva ai proprietari unicamente il privilegio-obbligo di escutere le imposte sulle terre di loro proprietà, sen-za sottrarsi al controllo degli esattori. Ai proprietari maggiori poteva poi essere concesso, con apposita autorizzazione, un grado più elevato di au-tonomia. Essi potevano non solo raccogliere le imposte sulle proprie terre, ma anche versare gli introiti fiscali riscossi direttamente presso l’ufficio del
fiscale: l’imposta di capitazione non versata. I casi descritti da Ulpiano di debitori che chiedevano in precario un proprio bene dato ai loro creditori come pignus erano piuttosto frequenti ancora nel V secolo (Dig. 43, 26, 6, 4).
37. Carrié, Colonato del basso Impero, p. 100.38. Sull’identificazione dei vari tipi di funzionari coinvolti nelle procedure di riscos-
sione e sulla maggiore o minore rilevanza di una categoria rispetto a un’altra si veda S. Mazzarino, Aspetti sociali del quarto secolo, Roma 1951, pp. 184-196, che confronta in particolare la politica di Giuliano, a favore dei curiali, voluti anche come exactores, con quella di Valentiniano, che prediligeva invece i funzionari di rango presidiale. L’autore co-munque ritiene (pp. 406-407, n. 52) che a livello generale i susceptores fossero i collettori normalmente curiali, mentre gli exactores erano funzionari dei rectores (ossia dei minores iudices).
39. C.Th. 11,7,12 (383).40. Delmaire, Cités et fiscalité au Bas-Empire, p. 64. I reliqua, vale a dire gli arretrati,
erano riscossi dai compulsores, funzionari di rango prefettizio o presidiale.
13Note sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale
governatore provinciale. Si evitavano in questo modo i ritardi e i possibili abusi causati dall’intermediazione degli exactores.41
I fondi muniti di questo privilegio, almeno nella prassi, erano elevati al rango di distretto fiscale allo stesso livello delle civitates o dei vici; di conseguenza se alcuni fundi rientravano nella circoscrizione della civitas o del vicus, venivano sottratti alla competenza fiscale di questi ultimi. L’au-topragia conferiva, infatti, una sorta di extraterritorialità ai fondi che ne erano investiti.42
La diffusione dei fondi autopragici, lì dove fu rilevante, segnò un inde-bolimento, o meglio una diminuzione delle competenze delle curie munici-pali e quindi più in generale del ceto curiale. In base alla mutata gerarchia amministrativa, terre e relative quote di prodotto fiscale vennero sottratte alle municipalità, per essere inviate direttamente alle casse del governatore provinciale.43 Questo tuttavia non determinò un allentamento della pressio-ne fiscale sui contribuenti, ma solo una riduzione dei livelli di riscossione attraverso l’estromissione della categoria degli esattori intermedi (fossero essi altri curiali o presidiali). In tale scenario le istituzioni municipali rima-sero comunque centri di riferimento per gli aggiornamenti catastali e fiscali, sebbene in un quadro di maggiore autonomia delle proprietà fondiarie.44
Possibili conflitti di competenza invece si presentavano quando i pro-prietari titolari di autopragia erano contestualmente anche affittuari di terre imperiali, situazione in realtà tutt’altro che rara.45 In casi del genere la leg-
41. C.Th. 11,22,4 (409): «…exceptis his, quos eminentissimae tuae sedis specialiter consideratio digessit». Papyri Cairo Maspero I 67019 (VI secolo), l’imperatore Leone (457-474) concede l’autopragia ad Afrodito. Sulla sottrazione agli exactores: Mazzarino, Aspetti sociali del quarto secolo, pp. 186-187.
42. Gregorio Magno, Reg. Ep., I, 42; Ennodio, Ep., 7,1; Agostino, Ep., 247. 43. J. Gascou, Les grands domaines, la cité et l’Ėtat en Ėgypte byzantine, in «Travaux
et Mémoires», 9 (1985), pp. 4-90, prospetta questo scenario per l’Egitto del VI secolo. 44. CIL, X, 407 = Inscr. It. III/1, n. 17 (inizi IV secolo): il catasto di Volcei dimostra
che i fundi erano raggruppati per pagi ma all’interno della Civitas Vulceiana che restava competente per l’esazione delle imposte per mezzo del praepositus. Allo stesso modo dalla Tavola di Trinitapoli (368-375; 389) si evince che l’esazione aveva luogo nel pagus mentre i registri di riferimento erano quelli dei tabularii civitatis (Canosa). Al riguardo si veda A. Giardina, F. Grelle, La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I, in «Mélanges de l’École Française de Rome: Antiquité», 95 (1983), pp. 249-303: p. 261.
45. Senatori: C.Th. 5,15,15 (364); 11,1,25 (398); 11,1,27 (405); Principales e curiali: C.Th. 12,1,33 (342); 10,3,2 (372), 10,3,4 (383); Iul., Misop. 370; Lib., Or. 31, 16-17; C.Th. 10,3,1 (362); 12,1,114 (386)= C.I. 10,32,39; C.I. 10,3,4 (383); interpretatio di Nov. Theod. 9 (439); Clero: C. Litt. Petiliani II, 83, 184 (CSEL, 52, 114); Ep. 66 (34², 235-236).
14 Paolo Tedesco
ge prevedeva che le imposte venissero calcolate sulla somma dei redditi estratti dalle terre private e da quelle imperiali.46 Unitamente al canone do-vevano essere pagate anche le imposte fondiaria e personale.47 Al posses-sor in questo caso era eccezionalmente conferito il diritto di “raccogliere” le imposte su terre sulle quali vantava solo un diritto di godimento, e non di proprietà, come invece era abitualmente richiesto; restava ferma tuttavia la competenza degli officiales di “esigere” le imposte raccolte dal posses-sor/collector sulle terre imperiali assegnate in concessione.48 La questione riguardava infatti non solo la salvaguardia della competenza degli esattori prefettizi, ma anche il rispetto della diversa destinazione dei due cespiti: le imposte dovevano raggiungere l’Arca del prefetto, il canone l’Aerarium dell’imperatore. Gli ufficiali governativi potevano probabilmente assolve-re con più efficacia questo compito rispetto agli esponenti del ceto curiale, normalmente legati più agli interessi locali che a quelli del governo centra-le. La divisione delle competenze non si fondava tuttavia solo sulla catego-ria di appartenenza delle terre, ma anche sul tipo di imposta da prelevare.La gleba, ad esempio, imposta sulle sole terre dei senatori, sul finire del IV secolo passò tra le competenze degli officiales.49
In materia di leva delle reclute e della eventuale fiscalizzazione della prestazione nella forma dell’aurum tironicum,50 le responsabilità dell’ob-bligazione vennero trasferite dal singolo individuo nell’ambito dei patri-moni fondiari.51 Nel nuovo scenario i proprietari di terre raggruppati in
46. C.Th. 12,1,33 (342).47. C.Th. 5,14,30 (386) = C.I. 11,59,7.48. Papyri Abinneus 3 (346); C.Th. 1,13,1 (394); Teodoreto di Ciro, Epist., 42; R.
Delmaire, Largesses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle, Rome 1989, pp. 638-639.
49. C.Th. 6,2,17 e 220 (397). Sulla gleba o follis si veda S. Barnish, A Note on the Collatio Glebalis, in «Historia», 38 (1989), 2, pp. 254-256.
50. Papyri Lips 55 (375-379); P. Oxy. XLVIII 3401 (355); BGU XII, 2145 (440); Papyri Laurenziani II, 42, sul quale H. Harrauer, P. Laur. II, 42. Textus Prior Ined., in «Zeit-schrift für Papyrologie und Epigraphik», 67 (1987), pp. 105-108.
51. C.I. 10,42,8 (289): «Nec protostasiae vel sacerdotii vel decaprotiae munera cor-poralia sunt, sed tantum patrimonii esse non ambigitur». Sulla cronologia della riforma: J.-M. Carrié, L’Ėtat à la recherche de nouveaux modes de financement des armées (Rome et Byzance, IVe-VIIIe siècles), in The Byzantine and Early Islamic East, a cura di A. Cameron, 3, State Resources and Armies, Princeton 2003, pp. 27-60: pp. 34 e 39-44, il quale collega il nuovo sistema di reclutamento alla riforma fiscale di Diocleziano (287). La costituzione C.Th. 7,13,7 (375) sarebbe dunque una misura integrativa volta a migliorare alcuni aspetti della riforma, in particolare rispetto alla turnazione dell’incarico di temonarius e al calmie-
15Note sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale
capitula fiscali erano obbligati a fornire un numero di reclute proporzio-nale ai capitula dichiarati.52 Anche in questo caso la responsabilità della riscossione passò dalla competenza dei curiali a quelle degli officiales.53
Con l’introduzione dell’autopragia si arrivò a una semplificazione del primo livello della riscossione, quello della raccolta delle imposte sulle terre di proprietà. Questo non significa che i fondi autopragici fossero sot-tratti al controllo dei “soliti esattori”. L’esazione, come precisa una legge del 386, era innanzitutto un militare officium.54 Ogni qualvolta la raccol-ta subiva ritardi o incontrava difficoltà interveniva il ceto militare, così come era di esclusiva competenza dei militari il ruolo di compulsores, gli addetti al recupero degli insoluti e dei reliqua.55 Neppure la raccolta delle imposte sui fondi privati era lasciata all’arbitrio dei grandi proprietari. Le costituzioni, contenute nel titolo 24 del libro XI del Codice Teodosiano, intitolato non a caso De patrociniis vicorum, segnalano l’impegno del le-gislatore nel periodo che intercorre tra il 360 e il 415, nel porre una serie di limiti all’esercizio da parte dei potenti di varie forme di patronato. La diffusione di questa pratica sottraeva i contadini agli obblighi sia delle comunità che del fisco imperiale.56 Le autorità tolleravano il patronato, quando si rivelava utile alla riscossione delle imposte.57 Ai potenti era permesso di svolgere le funzioni di collectores (συντελεστής), vale a dire
re imposto sul valore della recluta. Diversa la datazione proposta da C. Zuckerman, Two Reforms of the 370s: Recruiting Soldiers and Senators in Divided Empire, in «Revue des études byzantines», 56 (1998), pp. 79-139.
52. Delmaire, Largesses sacrées et res privata, pp. 321-329: p. 324.53. Sul capitularius/temonarius: F. Grelle, “Obsequium temonarium” e “munus te-
monis”, in «Labeo», 10 (1964), pp. 7-23: p. 18. 54. C.Th. 1,14,1 (386). Sul ruolo dei militari nella raccolta delle imposte: B. Palme,
Verwaltung und Militär im spätantiken Ägypten. Ausgewählte Urkunden aus der Wiener Pa-pyrussammlung, Wien 1997, e Id., The Imperial Presence: Government and Army, in Egypt in The Byzantine World, 300-700, a cura di R. Bagnall, Cambridge 2007, pp. 244-270.
55. Delmaire, Cités et fiscalité au Bas-Empire, p. 65; L. Di Paola, La Tavola di Trini-tapoli e il problema dei reliqua in età valentinianea, in «Atti dell’Accademia romanistica costantiniana», 13 (1997), pp. 293-308.
56. G. Giliberti, Le comunità agricole nell’Egitto romano, Napoli 1993, pp. 73-103.57. Libanio, De patrociniis, 47,4,19, sebbene ne fosse rimasto vittima, giudica il pa-
trocinio come un fenomeno naturale, solo che ritiene che il patrono del contadino dovesse sempre coincidere con il proprietario del fondo. Sul tema di un patronato tollerato dalle autorità si veda B. Sirks, The Colonate in Justinian’s Reign, in «Journal of Roman Studies», 98 (2008), pp. 120-143.
16 Paolo Tedesco
di sostituti d’imposta dei piccoli proprietari.58 La delega rilasciata sulla base di un accordo privato consentiva loro di riscuotere le imposte anche sulle terre non di proprietà.59
Diversi papiri, soprattutto del VI secolo, documentano la diffusione di questo fenomeno;60 resta tuttavia aperta la questione della validità pubblica di questi accordi, cioè della loro opponibilità alle autorità, in considera-zione del fatto che si basavano su una pratica benché tollerata pur sempre illegale. Comportamenti di questo tipo con difficoltà potevano trovare ri-conoscimento in un documento giuridico.61
Al contrario il governo si opponeva a questi stessi comportamenti, riconoscibili nell’autopractorium di C.Th. 11,22,4 (409), di cui si è fatto cenno all’inizio, quando il fine esclusivo era la stipula di un accordo ille-cito tra il potente e il contadino, se non addirittura tra il primo e un’intera comunità di villaggio. L’obiettivo dell’accordo in questi casi era infatti ottenere l’immunità fiscale in cambio della subordinazione di fatto alla po-testas del dominus.62 Il passo successivo compiuto dai potentes era spesso quello di farsi riconoscere veri proprietari delle terre dei loro protetti.63
I fenomeni descritti, poiché sorsero e si svilupparono in opposizione alla fiscalità, furono perseguiti dal governo, anche se in molti casi senza successo.
I fondi autopragici, nell’accezione intesa dalla riforma non erano al contrario entità antistatali o anticittadine, ma forme di organizzazione del-
58. A. Laniado, Συντελεστης: notes sur un terme fiscal surinterprété, in «Journal of Juristic Papyrology», 26 (1996), pp. 23-51: pp. 26-31; W. Liebeschuetz, The Decline and Fall of Roman City, Oxford 2001, pp. 182-183; P. Sarris, Economy and Society in the Age of Justinian, Cambridge 2006, p. 157.
59. M. Mirkovic, Les ktétores, les syntelestai et l’impôt, in Les archives de Dioscore d’Aphrodité cent ans après leur découverte, a cura di J. Fournet, Paris 2008, pp. 191-202: p. 199.
60. SB XX 14669 l. 289; P. Lond. V 1686; P. Cair. Masp. I 67118 ; P. Cair. Masp. II 67251.
61. J.-M. Carrié, Figures du “Colonat” dans les papyres d’Egypte: lexique, contextes, in Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia (Napoli 1983), Napoli 1984, 3, pp. 939-948: p. 944.
62. Libanio, De patrociniis, 11, riferisce che i militari offrivano il patrocinio non solo ai piccoli proprietari o ai vici privati (appartenenti a un solo proprietario), ma anche «a villaggi grandi, ciascuno di diversi padroni» (4). Fenomeno documentato anche in C.I. 11,48,23,2 (531-534). Sarris, Economy and Society in the Age of Justinian, p. 185.
63. C.Th. 11,24,6 (415).
17Note sulla genesi e l’evoluzione dell’autopragia demaniale
la proprietà fondiaria che si inserirono fino in epoca molto avanzata nel funzionamento della fiscalità imperiale e degli istituti civici.64 Essi si so-stituirono progressivamente alle funzioni amministrative di questi ultimi, e sebbene con diversi esiti in Oriente rispetto all’Occidente, divennero la base del potere economico del nuovo ceto post-curiale.65
64. D. Vera, Massa fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio Magno, in «Mélanges de l’École Française de Rome: An-tiquité», 111 (1999), 2, pp. 991-1025: p. 1010; E. Caliri, Città e campagna nella Sicilia tardoantica: massa fundorum ed istituto civico, in «Mediterraneo Antico», 9 (2006), 1, pp. 51-69: pp. 61-62.
65. Liebeschuetz, The Decline and Fall of Roman City, pp. 104-136: pp. 110-111. Sull’Occidente e l’Italia in particolare: G.A. Cecconi, Crisi e trasformazioni del governo municipale in Occidente fra IV e VI secolo, in Die Stadt in der Spätantike. Niedergang oder Wandel, a cura di J. Krause, C. Witschel, Stuttgart 2006, pp. 285-318. Da una diversa pro-spettiva, centrata sull’ininterrotta dominanza delle aristocrazie agrarie, v. Sarris, Economy and Society in the Age of Justinian, pp. 155-159, 175-176; J. Banaji, Agrarian Change in Late Antiquity. Gold, Labour, and Aristocratic Dominance, Oxford 20072, pp. 134-170.