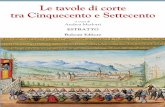Le ville e lo sfruttamento del territorio tra Ticino e Olona in età romana
L'EVOLUZIONE DEL PART-TIME IN ITALIA NEGLI ANNI DELLA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO: LE DIFFERENZE TRA...
-
Upload
uniparthenope -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of L'EVOLUZIONE DEL PART-TIME IN ITALIA NEGLI ANNI DELLA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO: LE DIFFERENZE TRA...
199
Quintano C. (a cura di) (2007), Scritti di Statistica Economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
L’EVOLUZIONE DEL PART-TIME IN ITALIA NEGLI ANNI DELLA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO: LE DIFFERENZE TRA
OCCUPAZIONE MASCHILE E FEMMINILE E TRA LE DIVERSE REGIONI DEL PAESE(*)
Claudio Quintano Rosalia Castellano Antonella Rocca(**)
1. INTRODUZIONE Il lavoro a tempo parziale, in questi ultimi decenni, ha assunto sempre
maggiore importanza, non tanto per l’aumento dell’incidenza dei lavoratori che scelgono o ripiegano verso questa tipologia di lavoro, quanto per una serie di fattori più ampi e complessi, nell’ambito dei quali esso va ad inserirsi e ad assumere funzioni e utilità del tutto nuove.
Ci si riferisce, in particolare, alle misure, poche ancora quelle presenti nel nostro Paese, volte a favorire l’aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro e, quindi, al percorso più generale verso la flessibilità che ancora stenta a decollare in Italia e che, invece, in molti Paesi si è dimostrata, accanto alla maggiore presenza di strutture di child-care, la principale determinante non solo per l’accrescimento dei tassi di partecipazione femminile all’attività lavorativa, quanto anche, e soprattutto, per l’aumento dei tassi di
(*) Il presente lavoro è stato svolto nell’ambito dell’attività di ricerca del Dipartimento di Statistica e
Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. La stampa degli estratti del presente lavoro sarà finanziata con i fondi di dotazione dello stesso
Dipartimento. (**) Claudio Quintano è Professore Ordinario di Statistica economica; Rosalia Castellano è
Professore Ordinario di Rilevazione e controllo dei dati economici; Antonella Rocca è Dottorando in Statistica applicata al territorio, presso il Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
200
natalità. È ben noto a tutti, infatti, come l’Italia si sia distinta in questi ultimi decenni per presentare ancora tassi di partecipazione delle donne al mondo del lavoro tra i più bassi in Europa, ma, allo stesso tempo, anche tassi di fertilità tra i più bassi al mondo. Molti Autori hanno discusso su questo singolare primato e tutti sono concordi sul fatto che tale situazione non discende dall’assenza di desiderio di maternità da parte delle donne, quanto dalla carenza di un insieme di condizioni e di strutture di sostegno che ne risultano, purtroppo, necessari presupposti.
Negli scorsi decenni, infatti, a livello internazionale ed in maniera generalizzata per tutti i Paesi industrializzati, si è assistito ad un incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro ed ad un corrispondente declino dei tassi di natalità, ma mentre in Paesi come Stati Uniti, Svezia, Danimarca e Norvegia, a partire dagli anni Novanta, il tasso di fertilità ha iniziato a risalire, in Italia, così come in Spagna ed in Grecia, non si è registrata alcuna inversione di tendenza. Tra i motivi principali che sembrerebbero aver determinato nei Paesi Scandinavi tale cambiamento di rotta, un ruolo di rilievo è stato svolto proprio dal part-time, scelto come strategia per la conciliazione degli impegni familiari e professionali.
Infatti, la possibilità di lavorare a tempo parziale costituisce per coloro che non vogliono rinunciare all’indipendenza economica, ma che, allo stesso tempo, desiderano avere dei figli in molti casi l’unica possibilità per combinare queste due esigenze troppo spesso, purtroppo, inconciliabili.
I dati più recenti mostrano, però, ancora un’eccessiva riluttanza, da parte delle imprese, a concedere il lavoro part-time che, quindi, presenta scarsa applicazione rispetto all’offerta e, allo stesso tempo, il persistere di una consolidata penalizzazione nelle opportunità di carriera e nelle possibilità di fruizione di corsi di formazione o di premi aziendali per coloro che scelgono questa forma di lavoro. Ciò nonostante la normativa attualmente in vigore in Italia, in ottemperanza a quanto sancito a livello comunitario, abbia esplicitamente espresso il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo parziale, rispetto all’equivalente a tempo pieno, ovvero l’esistenza dei
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
201
medesimi diritti per quel che riguarda la retribuzione oraria, il diritto alle ferie ed al periodo di prova, la durata del periodo di astensione per maternità e conservazione del posto di lavoro per malattia, la tutela per infortunio e malattie professionali, la tutela della salute e della sicurezza, le iniziative datoriali di formazione professionale, i diritti sindacali e l’accesso ai servizi sociali aziendali ed al collocamento.
In questo articolo, dopo alcuni brevi richiami normativi sulla regolamentazione italiana attuale e passata, ed un’analisi dei principali elementi di convenienza del part-time da parte delle imprese, si procederà a fare il punto sulle condizioni e caratteristiche dei lavoratori a tempo parziale in Italia dopo l’entrata in vigore della legge Biagi, sulla base dei dati ISTAT e Banca d’Italia, tentando di comprendere quali siano gli elementi caratterizzanti questa tipologia di lavoratori e quali le esigenze rimaste ancora disattese.
2. ALCUNI RICHIAMI SULL’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE IN ITALIA Il lavoro a tempo parziale è stato introdotto in Italia solo negli anni
Settanta, esclusivamente nella forma orizzontale1 ed a discrezionalità dell’azienda a fronte di situazioni gravi e documentate. Esso rappresentava, dunque, in quegli anni, un istituto nuovissimo, inteso come una sorta di premio, di concessione che il datore di lavoro poteva rilasciare al lavoratore in un momento di particolare difficoltà. Fin dalla sua introduzione, molti lavoratori, nonostante le possibilità di applicazione rimanessero estremamente limitate, manifestarono interesse verso questa forma di lavoro, in particolare le donne con figli piccoli o con genitori anziani non autosufficienti, professionisti con un
1 Si ricorda che il part-time di tipo orizzontale si configura come una giornata lavorativa più corta
mentre in quello di tipo verticale il part-timer lavora a orario ridotto secondo un calendario concordato, per esempio tempo pieno il lunedì e martedì, tempo parziale i restanti giorni della settimana. Vi è, poi, anche il part-time misto, che prevede una combinazione delle modalità orizzontale e verticale.
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
202
doppio lavoro più o meno dichiarato e studenti che volevano mantenersi agli studi (Merlini, 2004).
Il primo intervento legislativo sul lavoro a tempo parziale in Italia risale al 1984, anno in cui, con la legge n. 863 del 19 dicembre, si è tentato per la prima volta di disciplinarne le condizioni, ma senza introdurre quei necessari elementi di flessibilità che avrebbero consentito di sfruttarne le potenzialità ed i vantaggi. Ci si riferisce, in particolare, al divieto esplicito delle clausole di elasticità ed al lavoro supplementare2.
Solo nel 2000, con il decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio, finalizzato ad attuare la direttiva dell’UE 97/81 del 15 dicembre 1997, sono stati introdotti alcuni cambiamenti alla materia e si è proceduto ad inquadrare con più precisione il lavoro a tempo parziale, ponendolo in stretto riferimento con quello a tempo pieno ed intendendo con il primo un’attività ad orario inferiore rispetto a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. L’espressione tempo pieno si collega quindi all’effettuazione dell’orario normale di lavoro, come stabilito dalla legge n. 196/1997 in 40 ore settimanali o dal minor orario stabilito dall’apposito contratto collettivo di lavoro. Per tempo parziale si intende, invece, l’orario fissato dal contratto individuale di lavoro, inferiore a quello normale, senza un limite minimo fissato. Sempre con il presente decreto, inoltre, viene sancita la distinzione tra lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, che prevede la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro, part-time verticale, che introduce la possibilità di lavorare a tempo pieno ma per un numero minore di giorni, anche con la possibilità di seguire l’andamento ciclico dell’intensità di alcune prestazioni lavorative, e forme di lavoro a tempo parziale miste.
Il successivo decreto del 26 febbraio 2001 introduce importanti innovazioni inerenti il lavoro supplementare e le tanto auspicate clausole elastiche, al fine di
2 Le clausole di elasticità attengono all’accordo tra le parti di modificare il rapporto di lavoro part-
time in corso di svolgimento. In particolare, la clausola elastica prevede la possibilità di variare in aumento la prestazione di lavoro part-time. Il lavoro supplementare, infine, è quello che si svolge oltre il tempo parziale e nei limiti del tempo pieno.
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
203
tentare di venire incontro, allo stesso tempo, alle esigenze di competitività delle imprese e agli interessi dei lavoratori.
Infine, nel febbraio 2003, con la definitiva approvazione della legge Biagi, vi è stata una totale revisione delle varie tipologie di contratti di lavoro, con l’obiettivo prioritario di introdurre la tanto auspicata flessibilità, sebbene essa sia stata concepita soprattutto sul versante delle esigenze delle imprese. Sono ormai trascorsi tre anni dall’entrata in vigore di questa legge e sono state numerose le critiche agli effetti che essa ha sortito, tra le quali, soprattutto, quella di aver peggiorato ulteriormente le condizioni dei precari, ma pochi di coloro che sollevano queste critiche ricordano come nella legge stessa si facesse riferimento ad un approccio al monitoraggio delle politiche, che, sebbene tanto auspicato, risulta ad oggi ancora disatteso. La norma, infatti, rimanda al futuro il completamento delle flessibilità “al margine” via via introdotte, auspicando un rafforzamento degli ammortizzatori sociali ed una sistematizzazione di regole e tutele nello Statuto dei lavoratori. In tema di lavoro a tempo parziale, in particolare, la legge Biagi si poneva come obiettivo l’abrogazione e l’integrazione di ogni disposizione in contrasto con l’obiettivo dell’incentivazione del lavoro a tempo parziale. Le principali novità introdotte andavano nel verso di ampliare la flessibilità a beneficio delle imprese, al fine di accrescerne la domanda, con lo scopo di favorire soprattutto l’offerta di lavoro proveniente dalla componente femminile. Non si sono registrati, purtroppo, in questi anni, segnali forti neanche da parte della contrattazione collettiva, forse per una certa resistenza verso il part-time proveniente anche dalle organizzazioni sindacali, nonostante la legge lasci addirittura al singolo datore di lavoro la possibilità di concordare direttamente con ciascun lavoratore margini per intese flessibili (Sestito, 2006).
Infine, l’ultima modifica alla disciplina vigente risale all’ottobre del 2003, decreto legislativo n. 276/03, che ha ulteriormente aumentato flessibilità ed elasticità dell’istituto, prevedendo la possibilità di applicazione del lavoro a tempo parziale anche ai contratti a tempo determinato ed ha esteso l’opportunità di ricorrere al part-time a tutti i settori di attività. Il decreto, inoltre,
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
204
ha eliminato l’obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, alla direzione provinciale del lavoro mentre ha lasciato quello di informazione verso le rappresentanze sindacali. Inoltre, la marcata flessibilità si riscontra anche nella possibilità di modificare, nel corso del tempo, l’orario pattuito originariamente, di effettuare lavoro supplementare, ovvero oltre il tempo parziale, ma nel limite del lavoro a tempo pieno e, addirittura, di poter svolgere lavoro straordinario.
3. IL PART-TIME COME OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE La crisi economica che sta interessando in questi anni in particolar modo
l’Italia ha imposto alle imprese la necessità di sottoporsi a profondi mutamenti che condizionano l’ambiente circostante, di cui devono tener conto. Come è noto, essendo sempre più forte il peso delle competenze professionali qualificate richieste nelle economie sviluppate come quella italiana, i relativi costi registrati sono molto incidenti, anche rispetto al costo del capitale. Tali figure professionali, per loro natura, risultano di conseguenza sempre più svincolate dalla prestazione oraria. Il processo di ristrutturazione organizzativa, orientato alla flessibilità (Pace, 2006) ed incentrato soprattutto sulla minimizzazione dei costi fissi, viene però ostacolato da vari elementi di rigidità, primo fra tutti quello che attiene al mercato del lavoro. Una forma di organizzazione del lavoro che in situazioni come queste risulti vincente deve basarsi infatti proprio sulla riduzione dei costi associati alle posizioni non completamente saturabili (ISTAT, 2004).
In un tale contesto il part-time, unitamente ad altre forme di lavoro flessibile, risulta allora una grande opportunità per le imprese nel verso della flessibilizzazione di tutte quelle posizioni la cui domanda di lavoro non ha andamento stabile nel tempo e va ad interessare tutte le figure professionali, da quelle meno qualificate, quali gli operai coinvolti in produzioni che presentano stagionalità o comunque un ciclo, gli impiegati, la cui mole di lavoro si modifica
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
205
notevolmente, ad esempio, in base all’andamento delle vendite, ma anche i dirigenti ed i consulenti, la cui produttività, già da tempo, è svincolata da qualsiasi riferimento temporale e si connette esclusivamente ai risultati raggiunti.
Affinché, ovviamente, le aziende riescano ad applicare in maniera davvero conveniente il part-time, è necessario che esse realizzino un’attenta analisi organizzativa, in base alla quale l’effettiva utilità sia valutata non sulla base delle persone, ma delle condizioni organizzative esistenti e che conduca ad una struttura organizzativa che sia in tutti gli aspetti più flessibile e polivalente, che consenta di ridurre al minimo il lavoro nei periodi di bassa produzione e di attingere a tutte le risorse a disposizione nei momenti di maggiore domanda.
In questa direzione sono andate proprio le clausole di elasticità e di flessibilità introdotte nell’ottobre 2003, in base alle quali è possibile modificare nel tempo, e con un limite di preavviso di soli due giorni (che il contratto di lavoro può prevedere di eliminare del tutto), l’orario del lavoro, in modo da mettere a disposizione delle imprese strumenti ottimali per fronteggiare improvvisi picchi di lavoro (Cavallotti, 2004).
Nonostante l’indiscutibilità dei su esposti vantaggi, numerose risultano, ancora, le resistenze culturali che frenano in azienda la diffusione del part-time e delle altre forme di lavoro flessibile, in quanto spesso ancora concepite come possibili responsabili della perdita di efficienza (Sestito, 2006).
4. LE CONSEGUENZE PRATICHE ED IL DIBATTITO APERTO A QUALCHE ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE BIAGI
Uno dei principali obiettivi della legge Biagi consisteva nel portare alla luce
le finte collaborazioni, affinché fossero convertite in assunzioni, e nel legalizzare intere nicchie di mercato di lavoro a nero. In realtà, l’obiettivo in parte è stato pure raggiunto, ma poco sembra essere cambiato nelle condizioni dei lavoratori, rimaste nella sfera del precariato. Ad avviso di molti, la riforma ha
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
206
semplicemente prodotto l’effetto di legalizzare una condizione assolutamente lesiva per il lavoratore, in quanto le aziende, più che alla flessibilità, sembrano interessate ad abbattere il costo del lavoro. Le forme di lavoro atipiche sono pertanto scelte prevalentemente allo scopo di ridurre tale costo.
L’IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali)3 ha infatti stimato che l’incremento dei costi per l’impresa nel passaggio dalle collaborazioni occasionali a quelle a progetto è del 21,73% e passa al 41,81% se si considera il lavoro dipendente. Il problema consiste nel fatto che le persone impiegate con un contratto di lavoro atipico non si vedono garantiti i diritti più elementari, sia in termini salariali, in quanto la loro retribuzione si mantiene solitamente a livelli più bassi, sia in termini di contributi previdenziali, in un sistema pensionistico basato sul metodo contributivo. Il tanto auspicato Statuto dei lavoratori, che avrebbe dovuto seguire alla legge Biagi, doveva prevedere un riordino delle aliquote contributive e l’introduzione di una sorta di indennità di precarietà, già sperimentata in Francia, da erogare alla scadenza del contratto al lavoratore in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro non evolvesse in un contratto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o anche a tempo determinato. Una tale iniziativa, infatti, avrebbe pure l’effetto di incentivare l’impresa all’assunzione definitiva del lavoratore.
Accanto agli svantaggi dovuti alla quasi certezza, per questi lavoratori, di non vedersi rinnovato il contratto alla scadenza, si aggiungono pure le discriminazioni dovute al fatto che nessun imprenditore ha interesse ad investire su di loro in termini di formazione e gratificazioni (Boeri e Garibaldi, 2006; Sestito, 2006).
3 L’IRES è un’associazione no profit, fondata dalla CGIL nel 1979, su iniziativa, tra gli altri, di Bruno
Trentin, Giuliano Amato e Vittorio Foa, finalizzata alla promozione, progettazione e realizzazione di studi e ricerche sul lavoro e sui suoi cambiamenti (IRES, http://aziende.economia.virgilio.it/racconti/r138_cococorapporto2.html).
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
207
5. LA DIFFUSIONE DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE IN BASE AI DATI ISTAT
L’indagine statistica italiana periodica più importante dedicata al
monitoraggio del mercato del lavoro è la Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro, eseguita dall’ISTAT in modo continuativo nel corso dell’anno ed i cui risultati vengono sintetizzati con riferimento ad ogni trimestre.
Dagli ultimi dati disponibili, diffusi nel marzo del 2006 e riferiti ad una media dell’anno 2004, gli occupati sono oltre 22 milioni di unità. Su 100 di essi, solo 39 sono donne. Quando si considerano esclusivamente i lavoratori a tempo parziale, che costituiscono soltanto il 13% del totale, il peso della componente femminile è pari al 77% e sale addirittura all’83% nel sub-universo dei lavoratori dipendenti. Piuttosto bilanciata, invece, la suddivisione di genere con riferimento al tipo di contratto a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori. Pertanto, si può sicuramente affermare che le donne, considerate da sempre dalla letteratura forze di lavoro non primarie, pur lavorando in media meno degli uomini, prevalgono in tutti i contratti di lavoro atipico, intendendo con questa espressione quelli diversi dal tradizionale contratto a tempo pieno ed indeterminato.
La distribuzione per età dei lavoratori nel complesso non evidenzia una significativa differenza di genere: il 55% delle donne e degli uomini che lavorano ha un’età compresa tra i 35 ed i 54 anni.
Le donne che lavorano a tempo parziale sono particolarmente presenti nel Nord del Paese mentre l’incidenza degli uomini è superiore nel Mezzogiorno, quando confrontata con quella complessiva degli occupati per ripartizione geografica. Una tale evidenza merita senz’altro qualche approfondimento. Una tesi che, infatti, nel seguito si tenterà di verificare è quella per cui nel primo caso, quello riferito alle donne, il part-time rappresenti una scelta di conciliazione mentre nel secondo, probabilmente, esprima un ripiego in assenza di forme di lavoro alternative più stabili. Inoltre, mentre per gli uomini la
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
208
condizione di part-time si associa essenzialmente alla fascia d’età più giovane, nelle donne risulta più equamente distribuita in tutte le fasce d’età.
Sia i contratti a tempo parziale che quelli a tempo determinato sono diffusi soprattutto nel settore dei servizi4.
Nella Tab. 5.1. i valori assoluti relativi al numero dei lavoratori sono stati relativizzati facendo emergere la contrapposizione tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, sul totale dei lavoratori, per ciascuno dei caratteri socio-demografici considerati. È possibile in tal modo rilevare che una lavoratrice su 4 lavora a tempo parziale mentre l’equivalente percentuale tra gli uomini non raggiunge neanche il 5% sul totale dei lavoratori, ma scende ulteriormente nel sub-collettivo dei soli lavoratori dipendenti (3,75%). Anche tra i lavoratori a tempo determinato nel confronto per genere l’incidenza delle donne (14,5%) è superiore a quella degli uomini (9,89%) mentre in quello territoriale l’incidenza del Centro-Sud è superiore a quella dei colleghi del Nord. In particolare, nel Mezzogiorno, i lavoratori a tempo determinato costituiscono il 16,4% di tutti i lavoratori dipendenti mentre nel Nord tale percentuale non raggiunge il 10,4%.
6. LA DIFFUSIONE DEL PART-TIME TRA I LAVORATORI DIPENDENTI IN BASE AI DATI DELL’INDAGINE BANCA D’ITALIA RIFERITA AL 2004 Nonostante la Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’ISTAT
costituisca, senza dubbio, l’indagine italiana più approfondita sul mercato del lavoro, nel seguito si farà riferimento ai dati desunti da un’altra indagine periodica di tipo multitematico, anch’essa di grande importanza a livello nazionale, in quanto in quest’ultima, accanto alle informazioni sulla condizione lavorativa degli intervistati, ne sono rese disponibili molte altre di estrema rilevanza. 4 Si fa notare che con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 276/03 in vigore dal
24/10/03, orientate ad aumentare la flessibilità e l’elasticità del contratto di lavoro part-time, è stata consentita l’estensione del lavoro a tempo parziale anche ai contratti di lavoro a tempo determinato (Cavallotti, 2004).
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
209
Tab. 5.1. – Distribuzione dei lavoratori italiani nel complesso e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti a tempo pieno, parziale, a tempo determinato e a tempo indeterminato per genere, classi di età, area geografica, e settore di attività economica. Valori in migliaia di unità ottenuti come media per l’anno 2004.
LAVORATORI IN COMPLESSO tempo parziale tempo pieno Totale M F T M F T M F T Classe d'età 15-24 9,74 27,63 17,19 90,26 72,37 82,81 100 100 100 25-34 4,68 25,16 13,21 95,32 74,84 86,79 100 100 100 35-54 3,07 25,08 11,70 96,93 74,92 88,30 100 100 100 55 e oltre 9,43 21,44 13,23 90,57 78,56 86,77 100 100 100 Totale 4,76 24,98 12,68 95,24 75,02 87,32 100 100 100 Area geografica Nord-Ovest 3,78 25,17 12,68 96,22 74,83 87,32 100 100 100 Nord-Est 3,96 25,97 13,09 96,04 74,03 86,91 100 100 100 Centro 5,57 26,02 14,04 94,43 73,98 85,96 100 100 100 Mezzogiorno 5,66 22,90 11,43 94,34 77,10 88,57 100 100 100 Totale 4,76 24,98 12,68 95,24 75,02 87,32 100 100 100 Settore di attività Agricoltura 6,73 21,10 11,11 93,27 78,90 88,89 100 100 100 Industria 2,49 18,59 6,17 97,51 81,41 93,83 100 100 100 Servizi 6,14 26,61 15,86 93,86 73,39 84,14 100 100 100 Totale 4,76 24,98 12,68 95,24 75,02 87,32 100 100 100 DI CUI LAVORATORI DIPENDENTI tempo parziale tempo pieno Totale M F T M F T M F T Classe d'età 15-24 7,97 25,17 15,23 92,03 74,83 84,77 100 100 100 25-34 4,01 24,52 13,08 95,99 75,48 86,92 100 100 100 35-54 2,77 24,96 12,11 97,23 75,04 87,89 100 100 100 55 e oltre 4,99 16,91 9,52 95,01 83,09 90,48 100 100 100 Totale 3,75 24,30 12,46 96,25 75,70 87,54 100 100 100 Area geografica Nord-Ovest 2,66 24,86 12,69 97,34 75,14 87,31 100 100 100 Nord-Est 2,84 25,57 13,24 97,16 74,43 86,76 100 100 100 Centro 4,31 25,21 13,62 95,69 74,79 86,38 100 100 100 Mezzogiorno 4,94 21,55 10,84 95,06 78,45 89,16 100 100 100 Totale 3,75 24,30 12,46 96,25 75,70 87,54 100 100 100 Settore di attività Agricoltura 6,03 14,93 8,89 93,97 85,07 91,11 100 100 100 Industria 1,75 16,78 5,53 98,25 83,22 94,47 100 100 100 Servizi 5,22 26,41 16,17 94,78 73,59 83,83 100 100 100 Totale 3,75 24,30 12,46 96,25 75,70 87,54 100 100 100
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
210
Segue Tab. 5.1.
DI CUI LAVORATORI DIPENDENTI tempo determinato tempo indeterminato Totale M F T M F T M F T Classe d'età 15-24 33,09 36,74 34,63 66,91 63,26 65,37 100 100 100 25-34 11,56 17,59 14,23 88,44 82,41 85,77 100 100 100 35-54 5,86 10,29 7,73 94,14 89,71 92,27 100 100 100 55 e oltre 6,91 7,10 6,98 93,09 92,90 93,02 100 100 100 Totale 9,89 14,50 11,84 90,11 85,50 88,16 100 100 100 Area geografica Nord-Ovest 7,18 10,38 8,63 92,82 89,62 91,37 100 100 100 Nord-Est 8,14 13,01 10,37 91,86 86,99 89,63 100 100 100 Centro 9,17 14,62 11,60 90,83 85,38 88,40 100 100 100 Mezzogiorno 13,75 21,25 16,41 86,25 78,75 83,59 100 100 100 Totale 9,89 14,50 11,84 90,11 85,50 88,16 100 100 100 Settore di attività Agricoltura 41,49 66,42 49,52 58,51 33,58 50,48 100 100 100 Industria 8,62 9,73 8,90 91,38 90,27 91,10 100 100 100 Servizi 9,12 14,39 11,85 90,88 85,61 88,15 100 100 100 Totale 9,89 14,50 11,84 90,11 85,50 88,16 100 100 100
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati ISTAT (2006a) riferiti ad una media dei valori per l’anno 2004. (*) Da notare che l’insieme dei lavoratori dipendenti a tempo parziale non è disgiunto da quello dei lavoratori a tempo determinato in quanto dall’ottobre 2003 è stato possibile introdurre il part-time anche nei contratti di lavoro a tempo determinato.
Ci si riferisce all’Indagine sui Bilanci delle Famiglie Italiane eseguita dalla
Banca d’Italia ogni due anni. L’ultima wave per la quale al momento si dispone dei microdati è quella riferita all’anno 2004, che presenta, come sempre, un’intera sezione (allegato B1) dedicata ai lavoratori dipendenti e prevede la rilevazione, anche sufficientemente dettagliata, di un’ampia batteria di informazioni inerenti il lavoro, tra le quali il tipo di contratto, se a tempo determinato o indeterminato, se a tempo pieno o parziale, il numero di ore lavorate ed il numero di ore che ciascuno avrebbe desiderato lavorare. Quest’ultima informazione è un indicatore importante della volontarietà o meno del part-time e del lavoro a tempo pieno, ovvero consente di individuare quante persone che lavorano a tempo pieno desidererebbero lavorare un minor numero di ore e quante, invece, lavorano a tempo parziale solo perché non hanno trovato un’occupazione a tempo pieno oppure, pur desiderando di
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
211
lavorare part-time, vorrebbero farlo per un numero di ore maggiore, andando quindi ad alimentare l’esercito dei sotto-occupati.
Inoltre, essendo l’Indagine in oggetto una rilevazione multitematica, risulta molto interessante incrociare le notizie sulla tipologia del lavoro con altre di varia natura, quali quelle socio-demografiche ed in particolare sulle caratteristiche familiari dei lavoratori, nonché quelle sulle condizioni economiche, in modo da poter formulare un identikit del part-timer più preciso.
Poiché si ha motivo di pensare che il fenomeno possa presentare comportamenti differenziati a livello territoriale, si è ritenuto opportuno procedere ad un’analisi separata delle caratteristiche del part-time in gruppi di regioni opportunamente individuati in base a criteri di omogeneità rispetto ai principali indicatori socio-economici considerati.
Infine, attraverso l’applicazione di un modello di regressione logistica, si cercherà di capire l’effettiva incidenza dei fattori ritenuti determinanti nel profilo del part-timer sulla sua condizione di lavoratore a tempo parziale, per verificare se e quali caratteristiche si associano a tale scelta.
6.1. UN IDENTIKIT DEL LAVORATORE A TEMPO PARZIALE
L’attività di lavoro dipendente costituisce l’unica occupazione dichiarata da
quasi il 99% degli intervistati, con differenze minime di genere (Tab. 6.1.1.). Per converso, l’attività lavorativa è secondaria nel 5,6% dei casi quando ci si riferisce esclusivamente al collettivo dei lavoratori a tempo parziale, percentuale che sale addirittura al 12,67% per i soli uomini. Anche tra i lavoratori a tempo determinato ed interinali l’incidenza di coloro che dichiarano un’attività secondaria sale, rispettivamente, fino al 6,47% e 7,10%.
Passando alle caratteristiche sociodemografiche, il lavoratore part-time tipo presenta caratteristiche piuttosto differenziate nei due generi (Tab. 6.1.2.).
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
212
Tab. 6.1.1. – Lavoratori dipendenti per genere, tipologia di attività, principale o secondaria, e tipologia di contratto, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato, determinato o interinale (valori percentuali riferiti al 2004).
LAVORATORI DIPENDENTI Tipologia di contratto Attività principale Attività secondaria Totale di lavoro M F T M F T M F T
A tempo parziale 87,33 96,06 94,40 12,67 3,94 5,60 100 100 100A tempo pieno 99,23 99,54 99,35 0,77 0,46 0,65 100 100 100Totale 98,86 98,88 98,87 1,14 1,12 1,13 100 100 100 A tempo indeterm. 99,39 99,78 99,55 0,61 0,22 0,45 100 100 100A tempo determ. 93,91 93,12 93,53 6,09 6,88 6,47 100 100 100Interinale 95,39 0,69 92,90 4,61 11,09 7,10 100 100 100Totale 98,86 98,88 98,87 1,14 1,12 1,13 100 100 100
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Tab. 6.1.2. – Lavoratori dipendenti per genere, tipologia di contratto a tempo pieno o parziale e le principali variabili socio-demografiche (valori percentuali riferiti al 2004).
LAVORATORI DIPENDENTI Variabili sociodemografiche A tempo parziale A tempo pieno Totale M F T M F T M F T Classe d'età Fino a 30 anni 38,27 18,33 22,12 20,72 20,85 20,77 21,26 20,37 20,90Da 31 a 40 anni 30,39 36,67 35,48 30,84 32,33 31,39 30,83 33,16 31,78Da 41 a 50 anni 13,16 34,85 30,73 29,11 30,67 29,69 28,62 31,47 29,79Da 51 a 65 anni 16,25 9,62 10,88 19,15 15,91 17,96 19,06 14,71 17,28Oltre i 65 anni 1,93 0,52 0,79 0,18 0,23 2,00 0,23 0,29 0,25Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Titolo di studio Nessun titolo 0,82 0,63 0,66 0,67 0,19 0,50 0,68 0,27 0,51Licenza elementare 13,10 9,32 10,04 7,91 5,18 6,91 8,07 5,97 7,21Licenza media inferiore 36,26 35,36 35,53 38,49 25,03 33,55 38,42 27,00 33,74Diploma profess. (3 anni) 2,72 7,67 6,73 8,90 8,19 8,64 8,71 8,09 8,45Diploma di media superiore 36,51 36,55 36,54 34,18 45,08 38,19 34,26 43,45 38,03Diploma univ.o/laurea breve 0,91 2,40 2,12 1,20 1,32 1,25 1,19 1,53 1,33Laurea 9,32 8,08 8,32 8,42 14,76 10,75 8,45 13,49 10,52Specializzazione post-laurea 0,35 0,00 0,07 0,22 0,23 0,23 0,23 0,19 0,21Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
213
Segue Tab. 6.1.2.
Stato civile Coniugato/a 36,79 72,19 65,46 63,56 54,89 60,38 62,73 58,20 60,87Celibe/nubile 59,83 16,95 25,09 31,82 30,84 31,46 32,70 28,18 30,85Separato/divorziato 2,55 8,90 7,69 4,16 11,26 6,77 4,11 10,81 6,86Vedovo/a 0,82 1,96 1,75 0,45 3,01 1,39 0,46 2,81 1,42Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N. di figli
0 70,78 35,55 42,24 48,41 49,68 48,88 49,11 46,98 48,231 9,59 25,09 22,15 20,92 23,99 22,05 20,57 24,20 22,062 12,08 34,22 30,01 23,71 22,27 23,18 23,35 24,55 23,843 5,58 4,64 4,82 5,81 3,59 5,00 5,81 3,79 4,984 1,97 0,50 0,78 0,98 0,46 0,79 1,01 0,47 0,795 - - - 0,06 0,02 0,04 0,06 0,01 0,046 - - - 0,05 0,00 0,03 0,04 0,00 0,037 - - - 0,06 0,00 0,04 0,06 0,00 0,03
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 di cui con meno di 3 anni
0 97,90 89,57 91,15 92,10 93,81 92,73 92,28 93,00 92,581 2,10 9,84 8,37 7,46 6,02 6,93 7,29 6,75 7,072 0,00 0,60 0,49 0,44 0,17 0,34 0,43 0,25 0,36
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 di cui tra i 3 ed i 18 anni
0 79,58 53,72 58,63 65,52 69,91 67,13 65,95 66,82 66,311 9,88 28,41 24,89 20,47 19,34 20,05 20,14 21,07 20,522 10,22 16,25 15,10 11,81 9,65 11,02 11,76 10,91 11,413 0,32 1,52 1,29 1,94 1,08 1,62 1,89 1,16 1,594 0,00 0,10 0,08 0,26 0,00 0,17 0,25 0,02 0,165 - - - 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 di cui maggiorenni
0 84,19 76,73 78,15 79,07 75,60 77,80 79,23 75,82 77,831 8,14 14,50 13,29 11,75 16,41 13,46 11,64 16,04 13,452 6,16 8,42 7,99 8,06 7,53 7,86 8,00 7,70 7,883 1,52 0,17 0,43 1,02 0,42 0,80 1,04 0,37 0,764 0,00 0,17 0,14 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07 0,055 - - - 0,05 0,00 0,03 0,05 0,00 0,03
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Area geografica Nord-Ovest 9,79 27,06 23,78 25,89 31,07 27,79 25,39 30,30 27,40Nord-Est 18,07 33,32 30,42 23,29 26,17 24,35 23,13 27,54 24,94Centro 18,71 19,35 19,23 21,32 21,90 21,53 21,24 21,41 21,31Mezzogiorno 24,62 9,67 12,51 19,54 13,50 17,32 19,69 12,77 16,85Isole 28,81 10,60 14,06 9,96 7,37 9,01 10,54 7,99 9,50Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
214
Gli uomini che lavorano a tempo parziale, un’esigua minoranza, in quasi il 70% dei casi hanno un’età inferiore ai 40 anni, per lo più vivono nel Mezzogiorno e sono celibi. La relazione intercorrente tra il numero dei figli e la condizione di lavoratore a tempo parziale è senza ombra di dubbio negativa, se si pensa che oltre un lavoratore part-time su 7 non ha figli, mentre tra quelli che lavorano a tempo pieno tale condizione rappresenta, con il 48,41%, una minoranza. Inoltre, l’incidenza degli uomini con due figli che lavorano part-time è pari alla metà di coloro che, con due figli, presentano una condizione lavorativa a tempo pieno.
Dunque, il lavoro part-time, nel caso degli uomini, si delinea, molto chiaramente, in prevalenza non come uno strumento di flessibilità e di conciliazione, quanto come un ripiego in attesa di una sistemazione a tempo pieno.
Completamente diverso il quadro che si prospetta analizzando le medesime caratteristiche demografiche nelle donne. La lavoratrice part-time ha un’età nel 70% dei casi compresa tra i 31 ed i 50 anni, un titolo di studio perfettamente allineato con quello dei colleghi uomini e concentrato sulla licenza di scuola media inferiore e sul diploma di scuola media superiore ed in oltre il 72% dei casi è coniugata, percentuale che tra le lavoratrici a tempo pieno si attesta invece sotto il 55%.
Con riferimento al numero di figli, mentre la metà delle lavoratrici dipendenti a tempo pieno non ha figli, tra le part-timers tale percentuale scende sotto il 36%. Quasi la metà di queste donne ha almeno un figlio nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 18 anni. La distribuzione territoriale delle lavoratrici part-time fa registrare una maggiore incidenza nel Nord-Est del Paese, a scapito soprattutto del Mezzogiorno, se tale distribuzione è confrontata con le donne che lavorano a tempo pieno, ad indicare, se ve ne fosse pure bisogno, una maggiore vivacità del mercato del lavoro nella zona Nord-Orientale dell’Italia.
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
215
6.2. LE PROFESSIONI PRIVILEGIATE NELL’ACCESSO AL LAVORO PART-TIME La figura professionale in cui il lavoro part-time è maggiormente diffuso è
senza dubbio quella operaia, con un differenziale che, in percentuale, senza distinzione di genere, supera i 5 punti percentuali nel confronto con il lavoro a tempo pieno (Tab. 6.2.1.).
Tab. 6.2.1. – Lavoratori dipendenti per genere, tipologia di contratto a tempo pieno o parziale e le principali variabili legate alla situazione lavorativa (valori percentuali riferiti al 2004).
Variabili LAVORATORI DIPENDENTI Socio- demografiche A tempo parziale A tempo pieno Totale
M F T M F T M F T Qualifica professionale Operaio 58,45 48,80 50,63 52,58 32,00 45,02 52,76 35,21 45,56 Impiegato 18,97 37,96 34,35 35,05 46,58 39,28 34,55 44,93 38,81 Insegnante 3,88 7,36 6,70 2,07 13,73 6,35 2,12 12,51 6,38 Impiegato direttivo/quadro 1,68 1,03 1,15 5,51 4,55 5,16 5,39 3,88 4,77 Dirigente, alto funzionario, ecc. 0,64 0,51 0,54 2,61 1,05 2,03 2,55 0,94 1,89 Libero professionista 2,91 0,19 0,70 0,22 0,14 0,19 0,31 0,15 0,24 Imprenditore individuale 0,00 0,37 0,30 0,15 0,04 0,11 0,15 0,11 0,13 Lavoratore autonomo 1,20 0,36 0,52 0,24 0,14 0,20 0,27 0,18 0,23 Titolare/coadiuv. impresa fam. 1,18 0,10 0,30 0,13 0,10 0,12 0,16 0,10 0,14 Socio/gestore di società 0,36 0,00 0,07 0,27 0,15 0,23 0,28 0,12 0,21 In cerca di prima occupazione 0,00 0,69 0,56 0,00 0,15 0,05 0,00 0,25 0,10 Disoccupato 3,55 0,82 1,34 0,54 0,35 0,47 0,64 0,44 0,56 Casalinga 0,00 0,53 0,43 0,03 0,13 0,07 0,03 0,21 0,10 Pensionato da lavoro 1,31 0,32 0,51 0,20 0,08 0,16 0,24 0,12 0,19 Pensionato non da lavoro 0,82 0,00 0,16 0,00 0,13 0,05 0,03 0,10 0,06 Studente 3,14 0,62 1,10 0,21 0,30 0,25 0,31 0,37 0,33 Volontario/militare di leva - - - 0,08 0,00 0,05 0,08 0,00 0,05 Lavoratore atipico 1,93 0,35 0,65 0,10 0,39 0,21 0,16 0,38 0,25Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Settore di attività economica Agricoltura 13,39 5,80 7,22 4,85 3,98 4,53 5,10 4,33 4,79 Estrazione di minerali 12,83 17,69 16,79 36,16 19,92 30,21 35,46 19,50 28,93 Costruzioni, edilizia 18,27 1,42 4,56 10,67 2,50 7,68 10,90 2,29 7,38 Commercio 9,62 21,25 19,08 10,74 16,66 12,91 10,71 17,53 13,50 Trasporti 4,74 2,33 2,78 5,70 1,67 4,22 5,67 1,79 4,09 Intermediaz. Monetaria 0,37 4,30 3,56 3,30 4,85 3,87 3,21 4,75 3,84 Attività immobiliari, inform. 3,83 4,67 4,51 3,12 4,41 3,59 3,14 4,46 3,68 Servizi domestici 6,46 14,94 13,36 1,79 5,67 3,21 1,93 7,42 4,18 Pubblica Amministrazione 30,28 26,44 27,16 23,54 39,86 29,52 23,74 37,32 29,30 Organizz. e organismi internaz. 0,23 1,16 0,99 0,13 0,48 0,26 0,13 0,61 0,33Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
216
Segue Tab. 6.2.1.
Tipologia di contratto A tempo indeterminato 32,55 69,33 62,34 91,96 91,04 91,63 90,11 86,89 88,79 A tempo determinato 58,83 28,82 34,52 7,43 8,45 7,80 9,03 12,34 10,39 Di lavoro interinale 8,62 1,84 3,13 0,61 0,51 0,57 0,85 0,77 0,82Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Dimensioni aziendali Fino a 4 addetti 26,86 21,20 22,27 10,14 12,26 10,92 10,67 13,97 12,02 Da 5 a 9 addetti 26,87 26,04 26,20 23,95 21,86 23,18 24,04 22,66 23,47 Da 20 a 49 addetti 12,64 17,85 16,86 16,43 11,84 14,75 16,32 12,98 14,95 Da 50 a 99 addetti 4,17 7,78 7,09 11,50 8,54 10,42 11,28 8,40 10,09 Da 100 a 499 addetti 8,80 5,62 6,23 9,10 6,53 8,16 9,09 6,36 7,97 500 addetti e oltre 1,89 6,10 5,30 9,83 7,75 9,06 9,58 7,43 8,70 Pubblica Amministrazione 18,78 15,41 16,05 19,04 31,22 23,52 19,03 28,20 22,79Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N. mesi di lavoro
1 0,00 1,35 1,10 0,26 0,19 0,24 0,26 0,41 0,322 2,99 1,76 1,99 0,38 0,82 0,54 0,47 1,00 0,683 4,53 2,31 2,74 0,99 0,70 0,88 1,10 1,01 1,064 1,82 3,14 2,89 0,65 1,09 0,81 0,69 1,48 1,015 8,15 0,47 1,93 0,53 0,42 0,49 0,77 0,43 0,636 6,28 5,44 5,60 1,85 1,34 1,66 1,99 2,13 2,047 0,75 0,00 0,14 0,40 0,71 0,52 0,41 0,58 0,488 8,50 3,08 4,11 0,88 1,03 0,94 1,12 1,43 1,249 5,53 1,46 2,24 0,90 0,94 0,92 1,05 1,04 1,04
10 3,35 2,76 2,87 0,68 0,80 0,73 0,76 1,18 0,9311 0,25 0,15 0,17 0,24 0,13 0,20 0,24 0,13 0,2012 57,84 78,07 74,23 92,22 91,82 92,07 91,15 89,19 90,35
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Anche rispetto a queste caratteristiche, emerge una situazione piuttosto
differenziata nei generi, che conferma alcune delle ipotesi avanzate nel paragrafo precedente.
Il lavoratore part-time è in oltre il 58% dei casi un operaio mentre il peso di coloro che con un tale tipo di impiego svolgono un’attività impiegatizia è inferiore alla metà rispetto a quelli che lavorano a tempo pieno. Contenute, ma costantemente molto più elevate delle corrispondenti dei lavoratori a tempo pieno, le aliquote riferite alle qualifiche dei lavoratori autonomi (libero professionista, lavoratore autonomo, titolare o coadiuvante di un’impresa familiare, pensionato) e quelle che riguardano le condizioni di precarietà, quali
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
217
disoccupato e lavoratore atipico. Nel primo caso, quindi, si individuano quelli per i quali il lavoro part-time rappresenta una precisa scelta di conciliazione con un’altra attività lavorativa; nel secondo, esclusivamente una condizione di precarietà.
Nel caso delle donne, il part-time si associa prevalentemente a condizioni di lavoro più stabili, ma interessa, in quasi la metà dei casi, solamente la qualifica operaia mentre le impiegate part-time hanno un peso di quasi 10 punti percentuali inferiore rispetto alle colleghe che lavorano a tempo pieno. La maggiore stabilità del lavoro part-time nel caso femminile viene confermata pure dalla distribuzione della variabile che indica il numero di mesi di lavoro svolti nel corso dell’anno di riferimento: quasi 8 donne su 10 hanno lavorato per l’intero anno solare, mentre la medesima percentuale tra gli uomini non raggiunge il 58%. Inoltre, dai dati relativi alla tipologia di contratto part-time, si nota che per quasi il 60% dei part-timers uomini si tratta di un contratto a tempo determinato mentre per le donne quasi il 70% dei contratti part-time sono a tempo indeterminato.
Con riferimento al settore di attività economica, il lavoro part-time è diffuso soprattutto nel terziario ed in particolar modo nel commercio e nei servizi domestici. Un dato forse meno scontato è la consistente presenza, principalmente tra gli uomini, del part-time nel settore primario, consentito solo da pochi anni dalla normativa.
6.3. PART-TIMERS SOTTO-OCCUPATI E DESIDERIO DI PART-TIME
Un’analisi particolarmente interessante che l’enorme patrimonio
informativo proveniente dall’Indagine Banca d’Italia ha reso possibile riguarda l’incrocio tra il numero di ore lavorate mediamente a settimana da ciascun lavoratore e l’orario che, invece, ognuno di essi avrebbe desiderato lavorare. Prima di incrociare le due informazioni, appare utile analizzarne la distribuzione univariata e le relative contrapposizioni rispetto al genere del lavoratore (Tab.6.3.1.).
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
218
Tab. 6.3.1. – Lavoratori dipendenti per genere, tipologia di contratto a tempo pieno o parziale, numero di ore mediamente lavorate a settimana e numero di ore che avrebbero desiderato lavorare (valori percentuali riferiti al 2004).
LAVORATORI DIPENDENTI Numero di ore A tempo parziale A tempo pieno Totale
M F T M F T M F T lavorate in media a settimana Meno di 10 ore 4,58 2,79 3,13 0,39 0,31 0,36 0,52 0,79 0,63da 10 a 19 ore 11,05 14,05 13,48 0,97 2,24 1,44 1,28 4,50 2,60da 20 a 29 ore 36,94 59,38 55,12 1,21 6,73 3,24 2,32 16,79 8,25da 30 a 39 ore 17,35 16,64 16,77 23,44 37,29 28,53 23,25 33,34 27,39da 40 a 49 ore 28,98 6,34 10,64 66,90 50,44 60,86 65,72 42,02 56,0050 ore e più 1,10 0,81 0,86 7,09 2,98 5,58 6,90 2,56 5,13Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 che avrebbero desiderato lavorare a settimana Meno di 10 ore 1,66 0,13 0,35 1,01 0,23 0,74 1,03 0,21 0,71da 10 a 19 ore 17,31 12,21 12,94 0,78 2,04 1,22 1,11 3,93 2,22da 20 a 29 ore 28,35 54,53 50,77 1,84 11,40 5,17 2,37 19,42 9,05da 30 a 39 ore 22,55 26,24 25,71 44,99 51,62 47,30 44,54 46,90 45,47da 40 a 49 ore 29,55 6,68 9,96 47,68 33,20 42,63 47,32 28,27 39,8550 ore e più 0,59 0,22 0,27 3,70 1,51 2,94 3,64 1,27 2,71Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Un dato estremamente significativo che emerge è la minore dispersione
del numero di ore lavorate mediamente dalle donne part-time, concentrate tra le 20 e le 29 ore in quasi il 60% dei casi e la presenza di quasi il 30% degli uomini che, pur lavorando part-time, ha finito per svolgere mediamente tra le 40 e le 49 ore a settimana. Dai dati riferiti ai lavoratori a tempo pieno si evidenzia invece come le donne, mediamente, dedichino al lavoro un minor numero di ore a settimana.
Altrettanto interessante risulta la seconda parte della tavola, riferita al numero di ore che ciascuno avrebbe desiderato lavorare a settimana, volta ad evidenziare alcune delle discrasie presenti nel mercato del lavoro italiano. Al fine di agevolarne la lettura, è stato utilizzato lo sfondo più scuro per indicare la zona relativa al part-time involontario e quello più chiaro, invece, per la domanda di part-time che il mercato ha lasciato disattesa5. Coerentemente a 5 Si fa notare che per individuare coloro che, pur lavorando part-time, avrebbero desiderato lavorare
a tempo pieno è necessario incrociare le due informazioni, ovvero quella sul numero di ore
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
219
quanto emerso in precedenza, si nota che è dagli uomini che lavorano a tempo parziale che proviene il maggior desiderio di convertire il part-time in un lavoro a tempo pieno, visto che sono oltre la metà quelli che vorrebbero lavorare almeno 30 ore a settima. La prevalenza delle donne, invece (54,53%), ritiene ottimale un’attività lavorativa con un numero di ore settimanali comprese tra le 20 e le 29.
Tra coloro che lavorano a tempo pieno, la maggiore insoddisfazione riguarda la componente femminile: oltre la metà delle donne vorrebbe lavorare tra le 30 e le 39 ore (51,62%) e più del 13% ancora meno mentre gli uomini che lavorano a tempo pieno considerano ottimale un’attività che li impegni almeno 30 ore in oltre il 96% dei casi.
Questi risultati sono posti maggiormente in evidenza quando queste informazioni vengono incrociate tra di loro.
Per i lavoratori a tempo parziale (Tab. 6.3.2.), la maggiore concentrazione dei valori lungo la diagonale principale nel collettivo maschile indica proprio la più marcata rispondenza per questo sub-campione tra la propria condizione e le esigenze manifestate.
Con riferimento ai lavoratori a tempo pieno (Tab. 6.3.3.), è possibile notare un’accentuata soddisfazione da parte degli uomini in merito al numero di ore lavorate, concentrate essenzialmente nelle tipiche fasce tra le 30 e le 39 ore e tra le 40 e le 49 ore, sebbene non sia da sottovalutare una consistente quota di essi, oltre il 30%, che ha lavorato in media tra le 40 e le 49 ore a settimana, ma avrebbe preferito lavorare meno, tra le 30 e le 39 ore. Nel collettivo femminile si evidenzia una rispondenza alle aspettative per il numero di ore lavorate quando queste non superano le 39, con aliquote lungo la diagonale principale della tavola pari almeno al 75%. Tra coloro che invece hanno lavorato un numero di ore superiore è più elevata l’incidenza di quelli che avrebbero voluto lavorare meno, che costituisce il 42% tra coloro che hanno lavorato tra le 40 e le 49 ore
lavorate e sul tempo che invece si sarebbe desiderato lavorare, come posto in evidenza nella successiva Tab. 6.3.2. Il confronto tra le parti con sfondo colorato della tavola e le equivalenti righe della parte superiore della stessa pone in evidenza solamente, in caso di differenze non contenute, un mancato incontro tra la quantità di domanda e di offerta di lavoro.
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
220
e supera l’80% tra quelle che hanno lavorato per un numero di ore settimanali ancora superiore6.
Tab. 6.3.2. – Lavoratori dipendenti part-time per genere, numero di ore mediamente lavorate a settimana e numero di ore che avrebbero desiderato lavorare (valori percentuali riferiti al 2004).
Ore lavorate Maschi Femmine
Ore desiderate
<10 10-19 20-29 30-39 40-49 50 e+ <10 10-19 20-29 30-39 40-49 50e+< 10 ore 54,73 0 0 0 0 0 0 1,11 0 0 0 010-19 ore 0 100 9,16 6,74 0 0 100 58,15 7,78 0 0 020-29 ore 0 0 56,70 15,03 0 0 0 35,32 73,56 18,05 24,51 030-39 ore 45,27 0 26,37 32,88 12,41 0 0 1,88 13,80 77,88 42,94 040-49 ore 0 0 7,81 45,36 87,59 49,12 0 3,52 4,86 2,87 32,52 050 ore e + 0 0 0 0 0 50,88 0 0 0 1,21 0 0Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0Tot.ass. 1,48 5,73 21,50 10,98 8,54 0,57 1,84 34,12 178,51 51,98 24,85 0(*) La numerosità totale di questo collettivo è pari a 48,81 unità pesate per i maschi e 291,3 unità pesate per le femmine. Dal computo sono state infatti escluse tutte le osservazioni con valori mancanti nella variabile “ore di lavoro desiderate”, previsti in tutti i casi in cui l’attività lavorativa in oggetto non fosse la principale oppure se gli individui non sono stati intervistati personalmente. Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Per concludere l’esame della relazione intercorrente tra il numero di ore
lavorate mediamente a settimana ed il numero di ore che gli stessi lavoratori avrebbero desiderato lavorare, si è calcolato il coefficiente di correlazione lineare di Pearson sulle variabili originarie, ovvero non raggruppate in classi di valori. Il risultato evidenzia in tutti i casi la presenza di una discreta correlazione positiva (Tab. 6.3.4.), ad indicare, mediamente, un sostanziale incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Il legame più forte si riscontra in corrispondenza dei maschi che lavorano part-time mentre tra i lavoratori a tempo pieno la correlazione più elevata si riscontra tra le donne.
6 Le celle che nella Tab. 6.3.3. presentano lo sfondo scuro contengono il subcollettivo delle donne
che lavorano a tempo pieno ma desidererebbero lavorare a tempo parziale, ma tra le stesse è compreso anche un insieme di esse che vorrebbero lavorare a tempo pieno ma per un numero di ore inferiore. Si ricorda infatti che la normativa considera lavoro a tempo parziale un’attività ad orario inferiore rispetto a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, che non sempre coincide con le 40 ore settimanali.
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
221
Tab. 6.3.3. – Lavoratori dipendenti a tempo pieno per genere, numero di ore mediamente lavorate a settimana e numero di ore che avrebbero desiderato lavorare (valori percentuali riferiti al 2004).
Ore lavorate Maschi Femmine
Ore desiderate
<10 10-19 20-29 30-39 40-49 50 e+ <10 10-19 20-29 30-39 40-49 50e+ < 10 ore 64,63 5,90 0 0,71 0,79 0,43 0 0 0 0 0,45 010-19 ore 12,32 62,63 0 0,26 0,24 0 0 74,55 3,55 1,08 0 020-29 ore 0 2,29 63,75 2,51 0,43 1,51 31,71 17,12 82,03 8,80 3,46 0,9130-39 ore 0 14,59 14,84 91,71 30,41 20,26 46,34 6,26 13,85 83,07 38,40 21,1040-49 ore 23,05 14,59 21,41 4,08 66,74 45,54 21,95 2,03 0,55 5,66 57,20 59,3350 ore e+ 0 0 0 0,72 1,38 32,26 0 0 0 1,39 0,49 18,67Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Tot.ass. 8,8 19,7 28,8 615,6 1515,2 194,4 1,6 23,6 94,3 466,4 638,5 51,9(*) La numerosità totale di questo collettivo è pari a 2.382,51 unità pesate per i maschi e 1.276,35 unità pesate per le femmine. Dal computo sono state infatti escluse tutte le osservazioni con valori mancanti nella variabile “ore di lavoro desiderate”, previsti in tutti i casi in cui l’attività lavorativa in oggetto non fosse la principale oppure se gli individui non sono stati intervistati personalmente. Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Tab. 6.3.4. – Coefficiente di correlazione lineare di Bravais-Pearson calcolato tra le variabili numero di ore lavorate complessivamente in media a settimana e numero di ore che gli stessi lavoratori avrebbero desiderato lavorare. Lavoratori dipendenti considerati nel complesso, part-time e a tempo pieno per genere, numero di ore mediamente lavorate a settimana e numero di ore che avrebbero desiderato lavorare (valori percentuali riferiti al 2004).
Coefficiente di correlazione di Pearson tra n. ore lavorate Tutti Part-time Tempo pieno
a settimana e n. di ore che si desidera lavorare M F T M F T M F T
r 0,49 0,69 0,63 0,70 0,57 0,61 0,45 0,59 0,52
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Al fine di individuare quali caratteri risultano maggiormente associati con la
condizione lavorativa a tempo pieno o parziale, si è proceduto a calcolare una misura dell’associazione tra la variabile che denota, appunto, la condizione lavorativa a tempo pieno o parziale e gli altri caratteri finora presi in considerazione (Tab. 6.3.5.). Quando questa verifica è compiuta sull’intero collettivo, ovvero considerando i maschi e le femmine insieme, le uniche variabili per le quali si segnala l’assenza di un’associazione specifica sono il titolo di studio, lo stato civile ed il numero di figli. Quando la stessa analisi è
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
222
ripetuta separatamente sui due subcampioni, si nota che nel collettivo maschile sono ancora titolo di studio e numero di figli a non presentare alcuna associazione con la condizione lavorativa mentre nel caso delle donne tutte le variabili risultano significative, sebbene per la classe d’età ed il numero dei figli essa si attesti solamente sull’1%.
Tab. 6.3.5. – Indice di contingenza del χ2 e indice di contingenza quadratica media (φ) calcolati tra la variabile che esprime la condizione di lavoro a tempo pieno o parziale e le variabili indicate, di volta in volta, in intestazione di riga. Lavoratori dipendenti considerati nel complesso ed in base alla suddivisione di genere (valori percentuali riferiti al 2004).
Variabili χ2 Significatività del χ2 φ Maschi + femmine Classe d’età 27,6868 <.0001 0,0657 Genere 453,9219 <.0001 0,2661 Titolo di studio 18,4092 0.0103 0,0536 Stato civile 10,9404 0.0121 0,0413 N. di figli 15,5340 0.0297 0,0492 Qualifica professionale 95,2632 <.0001 0,1219 Settore di attività economica 214,3768 <.0001 0,1834 Area di residenza 35,7030 <.0001 0,0764 Tipologia di contratto 483,9319 <.0001 0,2747 Dimensione aziendale 95,4333 <.0001 0,1220 N. mesi di lavoro 236,4689 <.0001 0,1921 Solo maschi Classe d’età 42,3407 <.0001 0,1058 Titolo di studio 9,4548 0.2216 0,0500 Stato civile 41,4912 0.0001 0,1047 N. di figli 6,8398 0.4457 0,0425 Qualifica professionale 163,1627 <.0001 0,2077 Settore di attività economica 56,3181 <.0001 0,1223 Area di residenza 53,3313 <.0001 0,1187 Tipologia di contratto 464,4862 <.0001 0,3504 Dimensione aziendale 44,2843 <.0001 0,1082 N. mesi di lavoro 238,2564 <.0001 0,2510 Solo femmine Classe d’età 17,9802 <.0012 0,0827 Titolo di studio 55,0809 0.0001 0,1447 Stato civile 52,3855 0.0001 0,1412 N. di figli 22,4361 0.0010 0,0924 Qualifica professionale 86,1929 <.0001 0,1811 Settore di attività economica 80,7648 <.0001 0,1761 Area di residenza 20,8916 <.0003 0,0891 Tipologia di contratto 168,1256 <.0001 0,2529 Dimensione aziendale 75,9768 <.0001 0,1700 N. mesi di lavoro 109,3820 <.0001 0,2040
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
223
7. UNO STUDIO DEL PART-TIME IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TERRITORIALI I risultati emersi finora hanno posto in evidenza come il fenomeno del part-
time presenti aspetti piuttosto differenziati, oltre che rispetto al genere degli individui, anche sul territorio nazionale. Per lo studio di un fenomeno complesso come il ricorso al lavoro a tempo parziale, in un Paese come l’Italia, infatti, caratterizzato dalla presenza di rilevanti divari territoriali di tipo sia economico che socio-culturale, si rende necessaria un’analisi differenziata in relazione a contesti territoriali specifici. A tal fine, non ritenendo discriminante la tipica ripartizione territoriale per macro-aree utilizzata solitamente, che si collega prettamente a vincoli di contiguità del territorio, si è ritenuto opportuno procedere preventivamente ad un’analisi dello stesso volta ad individuare delle similarità che prescindano dai confini geografici. Pertanto, considerando un dettaglio regionale, sono considerati alcuni rilevanti indicatori demo-economici ricavati da altra fonte7, in modo da ottenere nuove caratterizzazioni territoriali (Quintano e Romano, 2004).
7.1. GLI INDICATORI SOCIO-ECONOMICI ED I CORRISPONDENTI
RAGGRUPPAMENTI TERRITORIALI Gli indicatori selezionati al fine di individuare contesti territoriali omogenei
sono tutti di fonte ISTAT e ricavati direttamente dalla Contabilità Nazionale, da fonte anagrafica e dalla Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (ISTAT, 2006b). Si tratta, in quasi tutti i casi, di dati di natura censuaria. Nei rimanenti, essi sono comunque riferiti all’intera popolazione attraverso il processo di riporto degli stessi all’universo.
7 Gli indicatori utilizzati ai fini di questa analisi sono variabili di natura demografica ed economica
che si ritiene possano influenzare il fenomeno del ricorso al lavoro parziale. La loro considerazione simultanea consente di accomunare le regioni che, complessivamente, rispetto a questi aspetti, presentano una certa omogeneità. I dati a cui si fa riferimento sono tutti di fonte ISTAT (2006b) e ricavati direttamente dalla Contabilità Nazionale, da fonte anagrafica, dal Censimento dell’Industria e Servizi e dalla Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro. Sono tutti riferiti all’universo della popolazione italiana con dettaglio regionale.
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
224
Qui di seguito la lista degli indicatori utilizzati. Unità di lavoro: ovvero quantità di lavoro standard a tempo pieno, valori
in migliaia di unità relativi al 2003 e relativizzati rispetto al totale Italia; PIL: in milioni di euro al 2005, relativo al 2003 e reso pro-capite
rapportandolo al totale della popolazione di ciascuna regione alla data 1/1/2004; Spesa delle famiglie: in milioni di euro al 2005, relativa al 2003 e resa
pro-capite come sopra; Condizione professionale: separatamente per uomini e donne, sono
considerati gli occupati, le persone in cerca di occupazione e le non forze lavoro, valori in migliaia di unità, riferiti alla media 2004 e relativizzati rispetto al totale per ogni regione (occupati+in cerca di occupazione+non forze lavoro). Ai fini dell’esecuzione dell’analisi, poiché tali tre indicatiori risultano esaustivi della condizione professionale, per evitare di inserire fattori che siano combinazione lineare di altri8, si è escluso quello che indica le persone in cerca di lavoro; tale omissione non ha causato alcuna perdita di informazione in quanto, da un precedente esperimento, si è verificato che la sua correlazione con la variabile che indica l’incidenza degli occupati nella regione è molto elevata e, ovviamente, di segno negativo.
Classi d’età: ai fini della migliore rispondenza con l’analisi in oggetto, esse sono state composte nel seguente modo: meno di 3 anni, tra i 3 ed i 14 anni, tra i 15 ed i 64 anni, 65 anni e più, valori in unità, riferiti al 1/1/05 relativizzati rispetto al totale della popolazione. In questo caso la variabile esclusa, per evitare l’introduzione di informazione completamente ridondante, è stata quella che indica l’incidenza della popolazione in età compresa tra i 15 ed i 64 anni; tale sottoinsieme della popolazione, del resto, costituendo la popolazione in età da lavoro, è già stata ampiamente presa in considerazione nella precedente categoria di indicatori, riferiti alla condizione professionale. Anche in questo caso la fonte è ISTAT.
8 Sebbene nell’analisi in componenti principali la presenza di multicollinearità non intacchi la validità
dei risultati, trattandosi di un metodo di sintesi dell’informazione di partenza, si è preferito escludere dall’analisi variabili completamente ridondanti, essendo il numero di osservazioni disponibili comunque limitato, pari al numero delle regioni italiane.
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
225
Settore di attività economica. Il dettaglio settoriale prescelto è il seguente:
- settore primario (agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca) - settore secondario (estrazione di minerali, attività manifatturiere, produzione
e distribuzione di energia e gas, costruzioni) - commercio - alberghi e ristoranti - trasporto - intermediazione monetaria e finanziaria - attività immobiliari - istruzione, sanità e altri servizi sociali, altri servizi pubblici per ciascuno di essi è stata considerata l’incidenza del numero di addetti rispetto al totale nella regione. I valori sono ricavati dal Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2001 e le aliquote che esprimono l’incidenza del settore istruzione+sanità e altri servizi sociali e altri servizi pubblici sono state escluse. Il motivo per cui si è deciso di scartare proprio l’incidenza degli addetti in questo settore discende dalla considerazione che è quello che si presenta con maggiore uniformità sull’intero territorio nazionale, non essendo, del resto, in questo caso, interessati a cogliere le differenze nell’erogazione dei servizi pubblici.
La sintesi di detti indicatori misurati per le venti regioni italiane è stata realizzata attraverso l’analisi in componenti principali. Tale tecnica, come è noto, consente di riassumere il contenuto informativo insito in una serie di indicatori che, come quelli considerati in questa sede, si presentano particolarmente correlati, attraverso un nuovo e più ristretto numero di variabili.
Come si evince dalla proiezione degli indicatori sul piano fattoriale individuato dalle prime due componenti (Fig.7.1.1.), il primo fattore, che spiega quasi il 45% del totale della variabilità del fenomeno in esame, è direttamente connesso con il livello di ricchezza della regione. Le variabili relative al PIL pro-
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
226
capite, alla spesa familiare pro-capite e alla percentuale di occupati, sia maschi che femmine, si contrappongono nettamente a quelle che denotano l’incidenza delle non forze lavoro di genere femminile, innanzitutto, ma anche maschile. È possibile notare che le regioni più ricche si caratterizzano per un’economia basata prevalentemente sull’industria, sul commercio e sull’intermediazione commerciale e monetaria mentre le più povere trovano sostentamento soprattutto nel commercio.
1,00,50,0-0,5-1,0
Component 1
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
Com
pone
nt 2
add_informad_interm
ad_trasp
ad_albris
ad_comm
ad_second
ad_agr
anni65epiu
anni3_14
meno3anni
non_forze_f
occup_fnon_forze_m
occup_m
Spesa_fam
PIL
unita_lavoro
Component Plot in Rotated Space
Fig. 7.1.1. - Analisi in componenti principali applicata su una batteria di indicatori socio-demografici rilevati sulle regioni italiane. Proiezione dei punti-modalità delle variabili adoperate nello studio sulle prime due dimensioni. Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati ISTAT (2006b).
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
227
Il secondo fattore è chiaramente legato alla differente specializzazione economica delle regioni, vedendo contrapposte, da una parte, le attività legate all’industria e, dall’altra, quelle del terziario, ed in particolare l’attività di trasporto, magazzinaggio e comunicazioni, di intermediazione monetaria e finanziaria e immobiliari, noleggio, informatica e ricerca professionale ed imprenditoriale. Da notare il ruolo neutrale del settore primario, coerente con la caratteristica dell’output prodotto, composto da beni atti a soddisfare i bisogni primari e spesso ad elevata deperibilità che, come tali, sono presenti in modo piuttosto uniforme sull’intero territorio nazionale.
Quanto al terzo fattore, la cui rappresentazione è stata omessa per motivi di rappresentabilità del grafico, come può evincersi chiaramente dalla Tab. 7.1.1. delle coordinate fattoriali delle variabili, esso sembra maggiormente legato alla struttura demografica della popolazione, dato che risultano strettamente in antitesi l’incidenza dei bambini con meno di 3 anni al peso degli anziani con oltre 64 anni.
Tab. 7.1.1. –Indicatori inseriti nell’Analisi in componenti principali, significato e coordinate registrate sulle prime 3 componenti. Metodo di rotazione Varimax con normalizzazione di Kaiser. La convergenza della rotazione è stata ottenuta con 8 iterazioni.
Coordinate sulle componenti principali Indicatori Etichetta
1 2 3 Unità di lavoro unita_lavoro ,236 ,140 ,346 PIL PIL ,945 ,117 -,233 Spesa familiare spesa_fam ,921 ,189 -,209 Occupati maschi occup_m ,967 -,105 ,069 Non forze lavoro maschi non_forze_m -,855 ,055 -,418 Occupati femmine occup_f ,956 -,070 -,238 Non forze lavoro femmine non_forze_f -,958 ,069 ,199 Popolazione con meno di 3 anni meno3anni ,100 ,074 ,927 Popolazione tra i 3 e i 14 anni anni3_14 -,441 -,018 ,851 Popolazione con 65 anni e più anni65epiu ,203 -,045 -,935 Addetti nel settore primario ad_agr -,375 -,195 ,261 Addetti nel settore secondario ad_second ,219 -,908 -,235 Addetti nel commercio ad_comm -,714 ,385 ,314 Addetti alberghi e ristoranti ad_albris ,550 ,317 ,181 Addetti ai trasporti ad_trasp -,274 ,919 ,029 Addetti nell’intermediaz. mon. e fin. ad_interm ,289 ,826 -,146 Addetti al terziario avanzato add_inform ,233 ,778 ,003
(*) Per una definizione più precisa delle modalità delle variabili, si rimanda al par. 7.1. Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati ISTAT (2006b).
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
228
Tuttavia, gli aspetti demografici risultano correlati anche a quelli economici, confermando ciò che è già ampiamente noto, ovvero la maggiore presenza di bambini e ragazzi nelle regioni economicamente deboli, che infatti nei decenni passati hanno fatto ancora registrare tassi di natalità piuttosto sostenuti, ed una maggiore incidenza di anziani nelle regioni più ricche.
La Fig. 7.1.2., contenente la proiezione dei punti-regione sul piano fattoriale individuato, evidenzia, lungo il primo asse, la contrapposizione tra le regioni del Mezzogiorno e quelle dell’estremo Nord, ovvero Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, seguite via via dalle altre regioni settentrionali. Lungo la seconda dimensione si rileva invece la netta contrapposizione tra le regioni Lazio e Liguria, da una parte, e quasi tutte le altre dall’altra.
Sulla base di questi risultati, confermativi in parte delle ipotesi avanzate, si è proceduto con l’applicazione di una tecnica di raggruppamento delle regioni, la cluster analysis di tipo gerarchico, al fine di individuare un numero ristretto di gruppi omogenei di regioni rispetto alle coordinate che le stesse presentano sui primi tre fattori individuati con l’analisi in componenti principali9.
9 Il motivo per cui non si è proceduto direttamente al raggruppamento delle regioni sulla base dei
valori che in esse assumono gli indicatori considerati consiste nella necessità di procedere preventivamente alla sintesi di una carica informativa particolarmente ricca e, per certi versi, ridondante.
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
229
2,000001,000000,00000-1,00000-2,00000
REGR factor score 1 for analysis 3
3,00000
2,00000
1,00000
0,00000
-1,00000
-2,00000
REG
R fa
ctor
sco
re
2 fo
r ana
lysi
s 3
SardegnaSicilia
Calabria
Basilica
Puglia
Campania
Molise Abruzzo
Lazio
Marche
Umbria
Toscana
Emilia R
Liguria
Friuli-V
Veneto
TrentinoLombardi
Valle d'
Piemonte
Fig. 7.1.2. - Analisi in componenti principali applicata su una batteria di indicatori socio-demografici rilevati sulle regioni italiane. Proiezione dei punti-regioni sulle prime due dimensioni. Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati ISTAT (2006b).
I risultati sono stati molto interessanti. Inizialmente, si era pensato di
considerare solamente 3 gruppi di regioni, ma l’analisi del dendrogramma e delle fasi del processo di agglomerazione (Fig. 7.1.3. e Tab. 7.1.2.) hanno fatto scartare questa ipotesi al fine di limitare l’aggregazione ad un livello di inerzia nei gruppi contenuto. In particolare, infatti, le regioni Lazio e Liguria non si associano a nessun’altra fino ad un livello di inerzia molto elevato; pertanto, si è ritenuto più conveniente considerare ciascuna di esse come un gruppo a sé. Le altre regioni si uniscono invece ad un livello di inerzia più basso, costituendo 4 gruppi abbastanza distinti: il primo gruppo è formato da Piemonte, Toscana,
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
230
Friuli-Venezia Giulia e Umbria, a cui subito dopo si unisce anche l’Emilia Romagna. Vi è poi un secondo gruppo formato da Abruzzo e Molise, cui si associano prima la Basilicata e poi le Marche. Il terzo gruppo è composto dalle regioni meridionali, ovvero da Calabria e Sicilia, cui si uniscono subito dopo il gruppo formato da Campania e Puglia e la Sardegna. Infine, un quarto gruppo, composto da Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Lazio e Liguria rappresentano, rispettivamente, i gruppi 5 e 6. Pertanto, si può concludere che l’usuale ripartizione geografica del Paese in Nord, Centro e Sud risulta, ai fini della considerazione dei succitati indicatori socio-economici, validata solo in parte10.
Fig. 7.1.3. – Dendrogramma derivante dall’applicazione della Cluster Analysis di tipo gerarchico alle 20 regioni italiane sulla base degli indicatori socio-economici misurati nelle stesse. Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati ISTAT (2006b).
10 Occorre tenere presente che i criteri che hanno determinato la formazione dei gruppi non sono
completamente intuibili a partire dal grafico relativo alla rappresentazione in coordinate cartesiane dei primi 2 fattori riportato nella Fig. 7.1.2., avendo concorso alla formazione dei gruppi anche il III fattore.
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
231
Tab. 7.1.2. - Aggregazione delle regioni nel processo di formazione dei gruppi nell’applicazione della cluster analysis di tipo gerarchico e coefficienti esprimenti il livello di inerzia al quale è avvenuta l’unione.
Cluster uniti Coefficiente di Passo Cluster 1 Cluster 2
Gruppo formato inerzia
1 Piemonte Toscana 1 0,013 2 (1) Friuli-Venezia G. 1 0,046 3 Abruzzo Molise 2 0,347 4 (1) Umbria 1 0,452 5 Calabria Sicilia 3 0,473 6 (2) Basilicata 2 0,502 7 (1) Emilia-Romagna 1 0,732 8 Valle d’Aosta Lombardia 4 0,812 9 Campania Puglia 9 1,242
10 (3) Sardegna 3 1,318 11 Marche (2) 2 1,503 12 (9) (3) 3 1,642 13 (1) (2) 1-2 2,136 14 (4) Veneto (4) 2,211 15 (4) Trentino (4) 2,947 16 (1) (3) 1-3 5,686 17 Liguria Lazio 5-6 6,393 18 (1) (4) 1-4 6,677 19 (1) Liguria 1-5-6 11,739
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Passando alla caratterizzazione dei gruppi rispetto alle variabili che hanno
concorso a definirli, è possibile notare come il gruppo 3 (Tab. 7.1.3.), composto da tutte le regioni meridionali ad eccezione della Basilicata, si caratterizzi per la maggiore condizione di povertà e presenza di giovani e con specializzazione prevalentemente nelle attività commerciali e dei trasporti. Il primo gruppo presenta invece una situazione piuttosto in linea con la media nazionale, rappresentata dal baricentro. Condizioni economiche molto favorevoli caratterizzano invece il gruppo 4, nonostante la notevole eterogeneità delle regioni che vi appartengono rispetto alle specializzazioni economiche. Piuttosto omogeneo il gruppo composto da Basilicata, Molise, Abruzzo e Marche, regioni che non solo risultano geograficamente confinanti, ma che sono accomunate anche per la morfologia del territorio e per una densità abitativa non elevata, fattori, questi, che, come si sa, si riflettono direttamente sull’economia di un territorio.
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
232
Tab. 7.1.3. - Raggruppamenti delle regioni italiane risultanti dalla Cluster Analysis di tipo gerarchico applicata alle 20 regioni italiane sulla base degli indicatori socio-economici misurati nelle stesse.
Gruppo Regioni 1 Piemonte, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Emilia-Romagna 2 Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata 3 Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna 4 Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige 5 Lazio 6 Liguria
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati ISTAT (2006b).
Infine, Lazio e Liguria, pur nella loro diversità, fanno registrare valori molto
elevati rispetto alla seconda componente, ad indicare la presenza in queste regioni di un’economia basata prevalentemente sul settore terziario.
7.2. LE CARATTERISTICHE DEI LAVORATORI PART-TIME NELLE AREE
TERRITORIALI INDIVIDUATE Una volta individuati i raggruppamenti di regioni omogenee rispetto agli
indicatori socio-economici prescelti, si è ritenuto interessante analizzare le caratteristiche del lavoro a tempo parziale separatamente in ciascuno di tali macro-raggruppamenti. Al fine di verificare se esso è concepito ed utilizzato ovunque come strumento di conciliazione e flessibilità o se, in taluni contesti, esso costituisce esclusivamente una forma di sotto-occupazione, ovvero un ripiego in assenza di un lavoro a tempo pieno, si è tentato di caratterizzare tali raggruppamenti rispetto alla volontarietà o meno del ricorso allo stesso. Quest’ultima è infatti considerata un indicatore di particolare importanza per la comprensione dei segnali provenienti dal mercato del lavoro. Tale volontarietà è stata misurata con una variabile dicotomica costruita sulla base delle risposte fornite dai lavoratori part-time ai quesiti inerenti il numero di ore mediamente lavorate a settimana nel corso dell’anno ed il numero di ore che essi avrebbero invece desiderato lavorare. Pertanto, è stato considerato part-timer involontario, ovvero “obbligato”, colui che ha dichiarato di aver lavorato un numero di ore inferiore rispetto a quello desiderato. Ne viene da sé che ciò che è stato definito
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
233
genericamente come un indicatore di volontarietà può anche essere inteso semplicemente come un segnale di sotto-occupazione, che si configura anche quando il numero di ore che si desidera lavorare, pur essendo superiore a quello delle ore lavorate, rientra comunque nella sfera del lavoro part-time.
I gruppi di regioni individuati fanno registrare un evidente sbilanciamento in termini di numerosità campionaria, che però deriva direttamente dalla eterogeneità della dimensione delle partizioni territoriali costituenti i gruppi. Infatti, le differenze con riferimento all’incidenza dei lavoratori part-time sul totale dei lavoratori dipendenti sono piuttosto contenute, oscillando tra un minimo di 7,48% del terzo raggruppamento, quello composto da tutte regioni meridionali, ed il 10,70% del quarto, formato invece da regioni che si collocano tutte all’estremo Nord del Paese (Tab. 7.2.1.).
Tab. 7.2.1.- Caratteristiche campionarie dei cluster di regioni italiane individuate.
Cluster Numerosità di cui part-time % part-time Volontarietà % di volontarietà
1 1.862 172 9,24No 70 Sì 102
No 40,8 Sì 59,2
2 420 34 8,09No 17 Sì 18
No 48,4 Sì 51,6
3 1.442 148 10,26No 65 Sì 83
No 44,1 Sì 55,9
4 1.823 195 10,70No 90 Sì 105
No 46,2 Sì 53,8
5 655 49 7,48No 25 Sì 24
No 50,8 Sì 49,2
6 209 21 10,05No 13 Sì 8
No 61,5 Sì 38,5
Italia intera 6.411 619 9,65No 280 Sì 340
No 45,2 Sì 54,8
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Le differenze nelle percentuali di lavoratori part-time involontari non risultano in nessun caso significative quando misurate per tutte le coppie di possibili combinazioni tra i raggruppamenti individuati (Tab. 7.2.2.). L’omogeneità nelle condizioni socio-economiche dei clusters individuati non
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
234
sembrano quindi in nessun caso spiegare questo aspetto sottostante al lavoro part-time, quando si considera un livello di significatività del 5% ripartito tra le due code. Tab. 7.2.2. - Confronti a coppie tra i gruppi individuati dai cluster in relazione alla percentuale
di part-timers involontari (pi e pj), ovvero che avrebbero desiderato lavorare un numero maggiore di ore nel corso dell’anno precedente.
Coppie di cluster a confronto pi pj z Sign.
1,2 40,8 48,4 –0,8203 0,2061 1,3 40,8 44,1 –0,5957 0,2743 1,4 40,8 46,2 –1,0408 0,1492 1,5 40,8 50,8 –1,2473 0,1056 1,6 40,8 61,5 –1,8085 0,0351 2,3 48,4 44,1 0,4546 0,3264 2,4 48,4 46,2 0,2373 0,4052 2,5 48,4 50,8 –0,2150 0,4168 2,6 48,4 61,5 –0,9462 0,1711 3,4 44,1 46,2 –0,3870 0,3483 3,5 44,1 50,8 –0,8159 0,2061 3,6 44,1 61,5 –1,4965 0,0668 4,5 46,2 50,8 –0,5767 0,2810 4,6 46,2 61,5 –1,3338 0,0918 5,6 50,8 61,5 –0,8231 0,2061
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Per completare l’analisi del fenomeno del lavoro part-time nei gruppi di
regioni formati, è utile andare ad individuare quali fattori risultano determinanti nella scelta di lavorare part-time, ovvero cercare di capire se esiste un nesso di causalità tra alcune caratteristiche personali del lavoratore e la sua condizione a tempo pieno o parziale.
A tal fine, si è introdotto un modello di regressione logistica in cui la probabilità di lavorare part-time è modellata rispetto al genere, all’età, al numero di figli ed al reddito del lavoratore11. I risultati dell’analisi (Tab. 7.2.3.), che sono
11 Va sottolineato che l’inclusione della variabile reddito percepito dal lavoratore dipendente ha
risposto esclusivamente ad un’esigenza di tipo strumentale, non essendo in questo contesto interessati a verificarne la relazione di dipendenza con il part-time, quanto, piuttosto, ad ottenere un modello di regressione che contenesse un carattere quantitativo sicuramente correlato con la condizione di lavoratore part-time o a tempo pieno. Inoltre, inizialmente, tra i regressori era stato
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
235
stati in un secondo momento ripetuti anche sul solo collettivo femminile (Tab. 7.2.4.), evidenziano una diversità dei gruppi di regioni in relazione alla significatività della variabile numero di figli. Quest’ultima, infatti, presenta un’influenza significativa sulla condizione di lavoratore part-time solo nei clusters 1 e 4, composti da tutte regioni del Centro-Nord, avvalorando l’ipotesi che in questi contesti esso risponda essenzialmente ad una scelta di conciliazione tra impegni lavorativi e familiari. Poco rilevante il peso della variabile età in tutti i gruppi, dall’influenza statisticamente significativa solo per i gruppi 3, 4 e 5, composti da tutte le regioni del Sud, Marche, Abruzzo e Molise e da quelle dell’estremo Nord. Evidentemente, in queste regioni il part-time si associa maggiormente ad una condizione di precarietà che, come tale, interessa maggiormente i giovani.
Tab. 7.2.3. - Risultati della regressione logistica ottenuta considerando come variabile dipendente il part-time e come variabili indipendenti il reddito percepito dal lavoratore (YLM), l’età in anni (eta), il genere (sex) ed il numero di figli (figlio) sui sottoinsiemi di unità considerati nei 6 clusters di regioni italiane individuate e sul totale Italia.
Cluster Variabili significative Variabili escluse Cox&Snell R2
Negelkerke R2 –2LL
1 YLM, sex, figlio eta 0,214 0,465 697,85 2 YLM, sex figlio, eta 0,125 0,290 181,57 3 YLM, sex, eta figlio 0,170 0,351 686,88 4 YLM, sex, figlio, eta 0,246 0,498 727,11 5 YLM, sex, eta figlio 0,188 0,454 213,793 6 YLM eta, figlio, sex 0,233 0,488 80,21
Italia intera YLM, sex, figlio, eta 0,197 0,418 2.671,8
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
La variabile età perde qualsiasi significato statistico nel collettivo composto
da sole donne, evidenziando, in questo caso, la maggiore uniformità della distribuzione del fenomeno part-time sull’intero arco di vita della donna,
inserito anche il titolo di studio del lavoratore dipendente in anni, ma quest’ultimo è stato presto scartato in quanto in nessun caso è risultato significativo con la condizione di lavoro a tempo pieno o meno.
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
236
avvalorando ancora di più l’ipotesi precedente, in base alla quale il part-time è sinonimo di precarietà specialmente nel collettivo maschile.
Tab. 7.2.4. - Risultati della regressione logistica ottenuta considerando come variabile dipendente il part-time e come variabili indipendenti il reddito percepito dal lavoratore (YLM), l’età in anni (eta), il genere (sex) ed il numero di figli (figlio) sui sottoinsiemi di unità considerati nei 6 clusters di regioni italiane individuate e sul totale Italia. Collettivo delle sole lavoratrici dipendenti.
Cluster Variabili significative Variabili escluse Cox&Snell
R2 Negelkerke
R2 –2LL
eta YLM, figlio età 0,260 0,428 548,54 figlio, eta YLM figlio, età 0,150 0,280 104,68 figlio, eta YLM figlio, età 0,240 0,370 339,54 eta YLM, figlio età 0,300 0,460 555,89 figlio, eta YLM figlio, età 0,310 0,520 126,55 figlio, eta YLM figlio, età 0,300 0,500 56,69 eta YLM, figlio età 0,250 0,400 1.814,97
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Poiché il percorso di analisi eseguito non ha evidenziato l’esistenza di una
particolare differenza del fenomeno del lavoro part-time nei gruppi di regioni individuati in base a criteri di omogeneità demo-economici, è possibile avanzare l’ipotesi per cui tali criteri di raggruppamento non costituiscono fattori realmente discriminanti in merito alle caratteristiche del lavoro part-time. Pertanto, si è ritenuto opportuno procedere ripetendo gli stessi passi sfruttando le note ripartizioni geografiche caratterizzate dalla condizione di contiguità identificate come Nord, Centro e Sud (Tabb. I.1.1.-I.1.2.-I.1.3.-I.1.4., in Appendice), da una parte, e da Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole (Tabb. I.2.1.-I.2.2.-I.2.3.-I.2.4., in Appendice), dall’altra.
I risultati ottenuti sono abbastanza interessanti quando si considera la seconda suddivisione in cinque macroripartizioni, in quanto consentono di evidenziare alcune differenze significative nella manifestazione del fenomeno (Tabb.I.2.1. e I.2.4.). In particolare, statisticamente significative risultano le differenze esistenti nella percentuale di part-timers sotto-occupati tra il Nord-Ovest ed il Nord-Est del Paese, tra il Nord-Ovest ed il Sud. Il Nord-Est, oltre che
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
237
dal Nord-Ovest, è statisticamente diverso dalle Isole; il Centro è diverso dal Sud e quest’ultimo anche dalle Isole. È interessante osservare che la minore incidenza di coloro che desiderano lavorare di più si registra al Sud, seguito dal Nord-Est del Paese mentre le percentuali di sotto-occupazione maggiori si riscontrano nelle Isole e nel Nord-Ovest del Paese, con aliquote che in entrambi i casi superano il 50% del totale delle persone che lavorano part-time. Tale eterogeneità, pertanto, non può essere assolutamente colta quando si fa riferimento alla suddivisione del Paese in Nord, Centro e Sud, per l’effetto di compensazione del fenomeno nel Nord, da una parte, e nel Sud del Paese, dall’altra.
L’analisi basata sulla costruzione di modelli di regressione logistica all’interno di ciascuna ripartizione territoriale (Tabb. I.1.2., I.1.3., I.2.2. e I.2.3.) individuata evidenzia l’esistenza di un nesso di causalità tra il numero dei figli e la condizione di lavoratore a tempo pieno o parziale esclusivamente nel Nord del Paese, sia quando si consideri la ripartizione in tre macro-regioni che quella a cinque. Anche la variabile età presenta un’influenza significativa solamente al Nord, nel primo caso, ed esclusivamente nel Nord-Ovest, nel secondo. Viene pertanto confermata l’ipotesi in base alla quale solo nell’Italia settentrionale il lavoro part-time risponde principalmente ad esigenze di conciliazione tra impegni familiari e professionali.
8. CONCLUSIONI Le profonde trasformazioni nella legislazione in materia di organizzazione
del lavoro attuate negli ultimi anni in risposta ai mutamenti intervenuti nella società e nel sistema economico in generale sono risultate del tutto inadeguate a fronteggiare i problemi legati alla disoccupazione, i cui livelli continuano ad essere drammatici in talune aree del nostro Paese. Il mercato del lavoro italiano, infatti, non si è dimostrato capace di adeguarsi alle mutate condizioni economiche generali, recependo e trasformando riforme che avrebbero dovuto
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
238
favorire la riduzione della disoccupazione, in strumenti da utilizzare a discapito dei lavoratori stessi. Le condizioni dei lavoratori sono infatti andate progressivamente peggiorando, facendo emergere un vero e proprio dualismo tra quelli di serie A, dal lavoro ancora sicuro, a tempo indeterminato, e quelli di serie B, caratterizzati da vari tipi di incertezza e discriminazione sul proprio futuro (Contini e Trivellato, 2005).
Accanto a queste considerazioni, la consapevolezza di un forte zoccolo duro di disoccupazione dal carattere ormai strutturale e la continua perdita di terreno dell’Italia rispetto al resto del mondo non solo in materia di occupazione, ma anche nella partecipazione delle donne al mondo del lavoro e nella flessibilità aprono la strada ad ulteriori riflessioni.
Le riforme del lavoro attuate sono ancora insufficienti ed inadeguate. Al legislatore si pone l’arduo compito di definire una radicale riforma del mercato del lavoro che, però, non potrà sortire effetti significativi se prima non verranno risolti problemi ben noti e radicati nel nostro Paese che si collegano ai profondi divari socio-economici che dividono il territorio nazionale.
Qualunque riforma, in altre parole, dovrà tener conto che nessuno dei possibili provvedimenti può adattarsi adeguatamente al territorio nazionale nel suo insieme, ma dovrà necessariamente considerare gli aspetti estremamente diversi che caratterizzano il mercato del lavoro sul territorio. Strumenti come flessibilità, lavoro atipico e part-time assumono connotazioni completamente diverse quando calati in contesti così differenti.
Pertanto, come dimostrano pure le evidenze empiriche compiute in questo articolo, anche quando gli strumenti ci sono, essi risultano spesso incapaci di sortire gli effetti per i quali sono stati predisposti; così capita che il part-time possa divenire solamente un ripiego per chi non riesca a trovare di meglio mentre numerosi lavoratori a tempo pieno desidererebbero impegnarsi in un’attività per un minor numero di ore.
Disoccupazione, sotto-occupazione e assenza di strumenti di conciliazione tra lavoro ed impegni familiari sono problemi che minano nel profondo una
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
239
società ed in presenza dei quali, specie per le dimensioni che essi raggiungono in talune aree del nostro Paese, non può esservi alcun futuro sostenibile.
240
Quintano C. (a cura di) (2007), Scritti di Statistica Economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
APPENDICE
Tab. I.1.1. - Caratteristiche campionarie dei raggruppamenti delle unità campionarie rispetto alle macroaree di regioni italiane Nord, Centro e Sud.
Macroarea Numerosità di cui part-time % part-time Volontarietà % di volontarietà
Nord 3.356 336 10,00 No 150 Sì 182
No 44,8 Sì 55,2
Centro 1.366 119 8,70 No 57 Sì 62
No 48,0 Sì 52,0
Sud 1.689 165 10,26 No 65 Sì 83
No 44,1 Sì 55,9
Italia intera 6.411 619 9,80 No 280 Sì 340
No 45,2 Sì 54,8
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Tab. I.1.2. - Risultati della regressione logistica ottenuta considerando come variabile dipendente il part-time e come variabili indipendenti il reddito percepito dal lavoratore (YLM), l’età in anni (eta), il genere (sex) ed il numero di figli (figlio) sui sottoinsiemi di unità considerati nelle 3 macroaree di regioni italiane considerate e sul totale Italia.
Macroarea Variabili significative Variabili escluse
Cox&Snell R2
Negelkerke R2 –2LL
Nord YLM, sex, figlio, eta
0,238 0,498 1.271,06
Centro YLM, sex figlio, eta 0,179 0,400 539,96 Sud YLM, sex figlio, eta 0,160 0,340 784,47 Italia intera YLM, sex, figlio,
eta 0,197 0,418 2.671,79
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Tab. I.1.3. - Risultati della regressione logistica ottenuta considerando come variabile dipendente il part-time e come variabili indipendenti il reddito percepito dal lavoratore (YLM), l’età in anni (eta), il genere (sex) ed il numero di figli (figlio) sui sottoinsiemi di unità considerati nelle 3 macroaree di regioni italiane considerate e sul totale Italia. Collettivo delle sole lavoratrici dipendenti.
Macroarea Variabili significative Variabili escluse
Cox&Snell R2
Negelkerke R2 –2LL
Nord YLM, figlio, eta 0,286 0,453 1.006,13 Centro YLM figlio, eta 0,261 0,433 347,92 Sud YLM figlio, eta 0,222 0,359 388,36 Italia intera YLM, figlio eta 0,250 0,400 1.814,97
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
241
Tab. I.1.4. - Confronti a coppie tra i gruppi individuati dalle 3 macroripartizioni di regioni
italiane (1=Nord, 2=Centro, 3=Sud) in relazione alla percentuale di part-timers involontari (pi e pj), ovvero che avrebbero desiderato lavorare un numero maggiore ore nel corso dell’anno precedente.
Coppie di macroripartizioni a confronto pi pj z Sign.
1,2 44,8 48,0 –0,6022 0,2743 1,3 44,8 44,1 0,1481 0,4404 2,3 48,0 44,1 0,6509 0,2578
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Tab. I.2.1. - Caratteristiche campionarie dei raggruppamenti delle unità campionarie rispetto alle macroaree di regioni italiane Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud e Isole.
Macroarea Numerosità di cui part-time % part-time Volontarietà % di volontarietà
Nord-Ovest 1.757 147 8,37No 77 Sì 71
No 52,1 Sì 47,9
Nord-Est 1.599 189 11,82No 74 Sì 115
No 39,1 Sì 60,9
Centro 1.366 115 8,71No 57 Sì 62
No 48,0 Sì 52,0
Sud 1.081 78 7,21No 27 Sì 50
No 34,9 Sì 65,1
Isole 609 87 14,29No 46 Sì 42
No 52,3 Sì 47,7
Italia intera 6.411 619 9,80No 280 Sì 340
No 45,2 Sì 54,8
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Tab. I.2.2. - Risultati della regressione logistica ottenuta considerando come variabile dipendente il part-time e come variabili indipendenti il reddito percepito dal lavoratore (YLM), l’età in anni (eta), il genere (sex) ed il numero di figli (figlio) sui sottoinsiemi di unità considerati nelle 5 macroaree di regioni italiane considerate e sul totale Italia.
Macroarea Variabili significative Variabili escluse
Cox&Snell R2
Negelkerke R2 –2LL
Nord-Ovest YLM, sex, figlio, eta 0,227 0,517 561,32 Nord-Est YLM, sex, figlio eta 0,249 0,482 703,01 Centro YLM, sex figlio, eta 0,179 0,400 539,96 Sud YLM, sex figlio, eta 0,129 0,319 409,19 Isole YLM, sex figlio, eta 0,213 0,380 354,14 Italia intera YLM, sex, figlio, eta 0,197 0,418 2.671,79
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
242
Tab. I.2.3. - Risultati della regressione logistica ottenuta considerando come variabile
dipendente il part-time e come variabili indipendenti il reddito percepito dal lavoratore (YLM), l’età in anni (eta), il genere (sex) ed il numero di figli (figlio) sui sottoinsiemi di unità considerati nelle 5 macroaree di regioni italiane considerate e sul totale Italia. Collettivo delle sole lavoratrici dipendenti.
Macroarea Variabili significative Variabili escluse
Cox&Snell R2
Negelkerke R2 –2LL
Nord-Ovest YLM, figlio, eta 0,282 0,471 463,55 Nord-Est YLM, figlio eta 0,289 0,437 535,89 Centro YLM figlio, eta 0,261 0,433 347,92 Sud YLM figlio, eta 0,190 0,338 206,73 Isole YLM figlio, eta 0,259 0,383 174,71 Italia intera YLM, figlio eta 0,250 0,400 1.814,97
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
Tab. I.2.4. - Confronti a coppie tra i gruppi individuati dalle 5 macroripartizioni di regioni italiane (1=Nord-Ovest, 2=Nord-Est, 3=Centro, 4=Sud, 5=Isole) in relazione alla percentuale di part-timers involontari (pi e pj), ovvero che avrebbero desiderato lavorare un numero maggiore ore nel corso dell’anno precedente.
Coppie di macroripartizioni a confronto pi pj z Sign.
1,2 52,1 39,1 2,3772 0,0087 1,3 52,1 48,0 0,6650 0,2546 1,4 52,1 34,9 2,4630 0,0069 1,5 52,1 52,3 –0,0296 0,4880 2,3 39,1 48,0 –1,5383 0,0618 2,4 39,1 34,9 0,6434 0,2611 2,5 39,1 52,3 –2,0565 0,0197 3,4 48,0 34,9 1,8173 0,0344 3,5 48,0 52,3 –0,6097 0,2709 4,5 34,9 52,3 –2,2476 0,0122
Fonte: Elaborazioni ad hoc su dati rilevati per l’Indagine 2004 dalla Banca d’Italia (2006).
L’evoluzione del part-time in Italia negli anni…
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli
243
BIBLIOGRAFIA BANCA D’ITALIA (2006), I Bilanci delle Famiglie Italiane nell’anno 2004,
Supplemento al Bollettino Statistico, Note metodologiche e informazioni statistiche, Anno XVI, n. 7, 17 gennaio.
BOERI T. e GARIBALDI P. (2006), Standard minimi e nuove tipologie contrattuali, articolo pubblicato su www.lavoceinfo.it, 9 gennaio.
BRATTI M., DEL BONO E., PICCHIO M., STAFFOLLANI S. e VURI D. (2004), Il lavoro part-time e l’occupazione femminile, Rapporto redatto nell’ambito della convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Dipartimento di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, 25 giugno.
CAVALLOTTI F. (2004), Part time esteso a tutti i settori, http://aziende.economia.virgilio.it/racconti/r060_part.html, 16 ottobre.
CONTINI B. e TRIVELLATO U. (2005), Eppur si muove, Dinamiche e persistenze nel mercato del lavoro italiano, Il Mulino, Bologna.
EMANUELE M., MAROCCO M. e RUSTICHELLI E. (2001), La Riforma del Part-Time, Il compromesso tra tutela e flessibilità in Italia e in Europa, Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n. 3, ISFOL-RP(MDL).
ISTAT (2004), L’organizzazione dei tempi di lavoro: la diffusione degli orari “atipici”, Argomenti, n. 28.
ISTAT (2006a), Forze di Lavoro, Media 2004, Annuario, n. 10, Serie Lavoro.
ISTAT (2006b), www.istat.it, dati scaricabili nella sottosezione /dati/db_siti/.
MERLINI R. (2004), Part time, perché le imprese sono restie?, http://aziende.economia.virgilio.it/racconti/r061_part1.html, 16 ottobre.
PACE F. (2006), Con l’orario flessibile, più felici sul lavoro, la RepubblicaLavoro.it, 22 maggio.
C. Quintano, R. Castellano e A. Rocca
Quintano C., Castellano R. e Rocca A. (2007), L’evoluzione del part-time in Italia negli anni della flessibilità del lavoro: le differenze tra occupazione maschile e femminile e tra le diverse regioni del Paese, in Quintano C. (a cura di), Scritti di Statistica economica 14, Quaderni di discussione, Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, n. 30, Napoli.
244
QUINTANO C. e ROMANO A.A. (2004), Measuring the Relationship between the Territory and Economic Activity. Classifying the Boroughs in Campania into Homogeneous Groups, in QUINTANO C. (a cura di), Scritti di Statistica Economica 10, Istituto di Statistica e Matematica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
SESTITO P. (2006), L’occupazione dopo la legge Biagi, articolo pubblicato su www.lavoceinfo.it, 9 gennaio.




























































![Filippo Alison: un viaggio tra le forme [english texts only]_PRE-print](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63134e7c5cba183dbf070a2e/filippo-alison-un-viaggio-tra-le-forme-english-texts-onlypre-print.jpg)