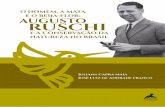oltre la politica. La crisi politico-istituzionale negli Stati Uniti tra Otto e Novecento
I comitati interministeriali tra affermazione e crisi del "Governo maggioritario"
Transcript of I comitati interministeriali tra affermazione e crisi del "Governo maggioritario"
DANIELE CODUTI
I COMITATI INTERMINISTERIALI TRA AFFERMAZIONE E CRISI
DEL “GOVERNO MAGGIORITARIO”
JOVENE EDITORE 2012
DIRITTI D’AUTORE RISERVATI
© Copyright 2012
ISBN 978-88-243-2154-9
JOVENE EDITORE Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87
web site: www.jovene.it e-mail: [email protected]
I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall’art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.
Printed in Italy Stampato in Italia
Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurispruidenza dell’Università degli Studi di Foggia.
Il presente lavoro conclude un percorso di ricerca iniziato ne-gli anni del dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economianell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Sento dunque ildovere di esprimere la mia riconoscenza ai docenti del dottoratocon i quali ho avuto il privilegio di lavorare e confrontarmi: il Pro-fessor Vincenzo Atripaldi, coordinatore del dottorato, e i ProfessoriRaffaele Bifulco, Roberto Miccù, Giovanni Rizza e Claudio Ros-sano. Un particolare ringraziamento va al Professor Marco Oli-vetti, per il costante confronto ed il continuo sprone. Ringrazio al-tresì il Dottor Paolo Laonigro e il Dottor Giuliano Sereno per averletto e commentato il testo. Resta inteso che la responsabilità per ilcontenuto del volume è esclusivamente mia.
Lucera, settembre 2012
INDICE
INTRODUZIONE GENERALE: Delimitazione dell’oggetto dell’analisi ......... p. 1
PARTE PRIMA
IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CAPITOLO PRIMO
IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. Premessa ........................................................................................... » 72.1. L’ordinamento del Governo prerepubblicano: il periodo li-
berale ........................................................................................ » 82.2. Il regime fascista ...................................................................... » 11
3. Il dibattito in Assemblea costituente .............................................. » 143.1. Sulla forma di governo in generale ......................................... » 163.2. Sull’art. 92 Cost. ...................................................................... » 193.3. Sull’art. 95 Cost. ...................................................................... » 223.4. Sugli organi del Governo “non necessari” ............................. » 24
4. La struttura del Governo in Costituzione: un primo commento . » 254.1. Il Governo come Consiglio dei ministri ................................. » 304.2. Il Governo a “multipolarità diseguale” .................................. » 334.3. Il Governo del primo ministro ............................................... » 354.4. Il Governo come organo complesso ....................................... » 364.5. Il Governo come sistema ordinato unitariamente ................. » 38
5. Le fonti deputate alla disciplina dell’organizzazione del Governo » 395.1. La disciplina del periodo prerepubblicano ............................ » 395.2. La l. 400/1988 .......................................................................... » 445.3. I successivi interventi normativi .............................................. » 49
6. I principî di organizzazione del Governo tra fonti atto e fonti fatto .................................................................................................. » 52
PARTE SECONDA
I COMITATI INTERMINISTERIALI
CAPITOLO PRIMO
I COMITATI INTERMINISTERIALI: PROFILI ISTITUZIONALI E CENNI DI COMPARAZIONE
1. Premessa ........................................................................................... p. 612. L’inquadramento costituzionale dei comitati interministeriali: le
diverse ipotesi formulate dalla dottrina .......................................... » 622.1. I comitati interministeriali come organi che rappresentano i
ministri: organi collegiali amministrativi ................................ » 632.2. Il principio del decentramento funzionale: i comitati inter-
ministeriali e l’art. 5 Cost. ....................................................... » 652.3. I comitati interministeriali e le commissioni parlamentari .... » 662.4. I comitati interministeriali come organi ausiliari del Presi-
dente del Consiglio .................................................................. » 682.5. I comitati interministeriali come comitati di ministri ............ » 682.6. I comitati interministeriali come organi costituzionali .......... » 692.7. I comitati interministeriali come sedi della istituzionaliz-
zazione del c.d. concerto ......................................................... » 702.8. I comitati interministeriali e le conferenze di servizi ............. » 732.9. I comitati interministeriali come forma di adeguamento della
struttura del Governo .............................................................. » 743. Il ruolo dei comitati interministeriali nell’interpretazione della
dottrina ............................................................................................. » 784. Classificazione dei comitati interministeriali .................................. » 815. L’organizzazione interna dei comitati interministeriali: composi-
zione e funzionamento .................................................................... » 866. L’attività e gli atti dei comitati interministeriali ............................. » 897. La responsabilità politica per gli atti dei comitati interministeriali » 928. L’incidenza dei comitati interministeriali sui rapporti endogo-
vernativi ............................................................................................ » 999. Cenni di comparazione: l’utilizzo di comitati ristretti come mo-
dello diffuso di articolazione della struttura del Governo ............ » 1029.1. Il modello paradigmatico: il Cabinet system britannico ........ » 103
CAPITOLO SECONDO
I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
1. Premessa ........................................................................................... » 109
VIII INDICE
2.1. Il Consiglio supremo di difesa come comitato interministe-riale: critica ............................................................................... p. 109
2.2. Il Consiglio di Gabinetto come comitato interministeriale: critica ........................................................................................ » 113
3. L’evoluzione del sistema dei comitati ............................................. » 1154.1. I comitati interministeriali attualmente operanti: il CICR ...... » 1224.2. Il CIPE ....................................................................................... » 1264.3. Il CIACE ..................................................................................... » 1334.4. Il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strate-
gica delle politiche di semplificazione e di qualità della re-golazione ................................................................................... » 140
4.5. Il CISR ....................................................................................... » 1454.6. Il Comitato interministeriale per la revisione della spesa
pubblica .................................................................................... » 150
PARTE TERZA
LE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
E I LORO EFFETTI
CAPITOLO PRIMO
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA E LE RIFORME ELETTORALI
IN SENSO MAGGIORITARIO
1. Il principio maggioritario: una premessa di carattere terminologico » 1572. I sistemi elettorali e i loro effetti .................................................... » 161
3.1. I sistemi elettorali in Italia: dall’Unità d’Italia alla Repubblica » 1703.2. La crisi del proporzionalismo ................................................. » 1753.3. La riforma maggioritaria del 1993 .......................................... » 1843.4. Il voto degli italiani all’estero .................................................. » 1873.5. La riforma elettorale del 2005 ................................................ » 188
CAPITOLO SECONDO
L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
SUL GOVERNO E SUI COMITATI INTERMINISTERIALI
1. Premessa ........................................................................................... » 1932.1. Gli effetti delle riforme elettorali in senso maggioritario sul
sistema dei partiti ..................................................................... » 194
IXINDICE
2.1.1. La XII legislatura ......................................................... p. 1942.1.2. La XIII legislatura ........................................................ » 1962.1.3. La XIV legislatura ........................................................ » 1982.1.4. La XV legislatura .......................................................... » 1992.1.5. La XVI legislatura ........................................................ » 2012.1.6. Il sistema partitico nelle legislature maggioritarie: una
valutazione di sintesi .................................................... » 2042.2. Le modifiche dei regolamenti parlamentari ........................... » 2092.3. Il rapporto tra Esecutivo e maggioranza parlamentare nel-
l’attuazione del programma di governo .................................. » 2162.4. Il procedimento di formazione del Governo ......................... » 220
2.5.1. La modificazione del ruolo del Presidente del Consi-glio dei ministri: in seguito ai mutamenti elettorali e politici ........................................................................... » 228
2.5.2. La modificazione del ruolo del Presidente del Consi-glio dei ministri: in seguito alle riforme normative .... » 235
2.5.3. Il rafforzamento della ruolo del Presidente del Con-siglio fra tendenze contrastanti .................................... » 240
2.6. Gli organi “non necessari” del Governo ................................ » 2422.7. Il caso specifico dei comitati interministeriali ........................ » 246
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE ....................................................................... » 257
Elenco dei comitati interministeriali composti di ministri e operanti nell’Italia repubblicana ..................................................................... » 267
Bibliografia citata nel testo .................................................................... » 271
X INDICE
INTRODUZIONE GENERALE
DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ANALISI
L’esperienza istituzionale italiana ha conosciuto la nascita dinumerosi organi definiti comitati di ministri o interministeriali,che, composti – esclusivamente o prevalentemente – di ministri,sono deputati a svolgere differenti tipologie di funzioni in nume-rosi ambiti dell’attività di governo. La Costituzione italiana non faalcun riferimento a tali organi; nonostante ciò, essi si sono ugual-mente sviluppati nell’ordinamento italiano – anche precostituzio-nale1 – al pari di quanto accaduto in numerosi ordinamenti stra-nieri2. L’art. 92, co. 1, Cost., infatti, si limita ad affermare che il«Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consi-glio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei mi-nistri». Sebbene la disposizione costituzionale non faccia riferi-mento ai comitati interministeriali, appare corretta l’opinione se-condo la quale la Costituzione «non li ammette, né li vieta»3.Infatti, poiché gli artt. 92 e 95 Cost. non dettano una disciplinacompiuta e tassativa dell’organizzazione del Governo4, quest’ul-
1 Si pensi, in particolare, all’istituzione – nel 1936 – del Comitato interministe-riale per il credito ed il risparmio (CICR) (sul quale si rinvia infra, parte II, cap. II, par.4.1.) o a quella del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) nel 1944 (su questo co-mitato interministeriale si v. infra, parte II, cap. II, par. 3.).
2 Si v. infra, parte II, cap. I, parr. 9. e 9.1.3 Così G. TREVES, Comitato interministeriale, in Novissimo digesto italiano, vol.
III, Torino, Utet, 1957, p. 595, e ID., I comitati interministeriali, in AA.VV., Scritti giu-ridici in onore della Cedam, vol. II, Padova, Cedam, 1953, p. 222.
4 In questo senso L. PALADIN, Diritto costituzionale, 3ª ed., Padova, Cedam,1998, p. 416.
tima è stata integrata innanzitutto dalla prassi, che ha visto la na-scita di numerose figure che gravitano nell’orbita del Governo mache non trovano un immediato riferimento in Costituzione5.
Occorre precisare che la denominazione “comitati intermi-nisteriali” è attribuita anche a comitati che non sono compostida ministri, bensì da sottosegretari oppure da funzionari di di-versi ministeri, sebbene – a volte, almeno – siano ugualmentepresieduti da un ministro6. In tali casi si tratta, evidentemente, diorgani collegiali amministrativi che – pur presentando notevoliprofili di interesse – esulano dalla presente trattazione7.
Nelle pagine che seguono, infatti, si intende soffermare l’at-tenzione su quei comitati interministeriali che, in virtù della lorocomposizione e delle loro funzioni, entrano a far parte dellastruttura organizzativa del Governo quale organo costituzionale,inteso, cioè, come «quel settore del potere esecutivo chiamato aconcorrere alla formazione dell’indirizzo politico dello stato ed apresiedere alla sua attuazione»8, seguendone le modificazioni el’evoluzione, soprattutto quelle derivanti dalle riforme elettoraliin senso maggioritario9. L’analisi così strutturata dei cambia-menti occorsi a tali organi dovrebbe consentire, al contempo,di studiare anche le trasformazioni dell’intero sistema di Go-
5 Si riprende un’espressione di P. CIRIELLO, Ordinamento di governo e comitatiinterministeriali, Napoli, Jovene, 1981, pp. 16-17.
6 Si v., ad es., il Comitato interministeriale per i finanziamenti alle industrie, c.d.CIF (d.lgs.lgt. 367/1944, art. 3, d.lgs.lgt. 449/1946, art. 2, e d.l. 10/1948, art. 1), oppureil più recente Comitato per il credito agevolato all’editoria (istituito con il d.p.c.m. 3settembre 2002).
7 Si rinvia, in proposito, a L. GALATERIA, Gli organi collegiali amministrativi. Lastruttura, vol. I, Milano, Giuffrè, 1975, ID., Gli organi collegiali amministrativi. L’atti-vità, vol. II, Milano, Giuffrè, 1975, G. MIELE, Collegio amministrativo, in Novissimo di-gesto italiano, vol. III, Torino, Utet, 1959, pp. 471-472, e R. VILLATA, Collegi ammini-strativi, in Enciclopedia giuridica, vol. VI, Roma, Treccani, 1988, pp. 1 ss. Cfr., inoltre,infra, parte II, cap. I, par. 4.
8 Così C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, 10ª ed., Padova, Ce-dam, 1991, p. 558.
9 Sulle quali si v. infra, parte III.
2 INTRODUZIONE GENERALE
verno10, verificando l’evoluzione della sua struttura e del com-plesso dei rapporti endogovernativi. Si tratta di un’analisi chepare opportuna in questo momento perché, nel corso degli anni,il ruolo dei comitati interministeriali è sensibilmente cambiato ri-spetto a quello loro comunemente attribuito. Inoltre, in un mo-mento in cui le riforme elettorali in senso maggioritario hannoormai prodotto i loro effetti e manifestato i propri limiti, l’attualeassetto del sistema costituito dai comitati interministeriali puòrappresentare una sintesi di come le leggi elettorali abbiano in-fluito sull’Esecutivo e sulla forma di governo italiana.
10 In questo senso le osservazioni di V. BACHELET, Comitati interministeriali, inEnciclopedia del diritto, vol. VII, Milano, Giuffrè, 1960, p. 764.
3DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ANALISI
CAPITOLO PRIMO
IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2.1. L’ordinamento del Governo prerepubblicano: il pe-riodo liberale. – 2.2. Il regime fascista. – 3. Il dibattito in Assemblea costi-tuente. – 3.1. Sulla forma di governo in generale. – 3.2. Sull’art. 92 Cost. –3.3. Sull’art. 95 Cost. – 3.4. Sugli organi del Governo “non necessari”. – 4.La struttura del Governo in Costituzione: un primo commento. – 4.1. Il Go-verno come Consiglio dei ministri. – 4.2. Il Governo a “multipolarità dise-guale”. – 4.3. Il Governo del primo ministro. – 4.4. Il Governo come organocomplesso. – 4.5. Il Governo come sistema ordinato unitariamente. – 5. Lefonti deputate alla disciplina dell’organizzazione del Governo. – 5.1. La di-sciplina del periodo prerepubblicano. – 5.2. La l. 400/1988. – 5.3. I succes-sivi interventi normativi. – 6. I principî di organizzazione del Governo trafonti atto e fonti fatto.
1. Premessa
L’analisi dei comitati interministeriali quali organi del Go-verno deve necessariamente prendere le mosse da quella dellostesso Governo e dei suoi organi. A tal proposito, appare oppor-tuna un’osservazione preliminare. La Costituzione dedica al Go-verno l’intero Titolo III, composto dagli artt. 92-100 Cost.; no-nostante ciò, deve escludersi che facciano parte del Governo an-che gli “organi ausiliari”1 previsti negli artt. 99 e 100 Cost.: ilConsiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio di
1 Questa è la rubrica della Sezione III, Titolo III, Parte II, Cost.
Stato e la Corte dei conti. Tale esclusione si fonda su tre ordinidi motivi: in primo luogo, l’art. 92 Cost. elenca tra gli organi checompongono il Governo della Repubblica solo il Presidente delConsiglio dei ministri, i ministri e il Consiglio dei ministri; in se-condo luogo, gli organi ausiliari non partecipano alla funzione diindirizzo politico; infine, la Costituzione prevede espressamenteche la legge debba garantire l’indipendenza degli organi di cuiall’art. 100 Cost. dallo stesso Governo2.
L’analisi che segue, dunque, si concentrerà sulla Sezione Idel Titolo III della Parte II della Costituzione3, ricostruendo ildibattito sulla struttura del Governo svoltosi in Assemblea costi-tuente ma anche l’evoluzione dell’organizzazione dell’Esecutivonel periodo anteriore all’entrata in vigore della Costituzione re-pubblicana.
2.1. L’ordinamento del Governo prerepubblicano: il periodo libe-rale
L’analisi della struttura dell’Esecutivo deve dunque iniziaredalla disciplina dettata dallo Statuto albertino, il quale non fa-ceva riferimento al Governo ma semplicemente ai membri diquesto: i ministri4. Tale omissione deve essere letta alla luce dellaforma di governo che si intendeva istituire con lo Statuto. In unamonarchia costituzionale pura quale quella che sembrava traspa-rire dalla Carta albertina, infatti, la funzione esecutiva spettava alsovrano e, di conseguenza, i ministri – scelti e guidati dal re –
2 Si v. in proposito F. CUOCOLO, Il Governo nel vigente ordinamento italiano, vol.I, Milano, Giuffrè, 1959, p. 114, nonché L. PRETI, Il Governo nella Costituzione ita-liana, Milano, Giuffrè, 1954, p. 9.
3 … che reca la rubrica “Il Consiglio dei ministri” ed è composto dagli artt. 92-96 Cost.
4 Si v. gli artt. 65, 66 e 67 dello Statuto albertino. In proposito, A. MARONGIU,Storia del diritto pubblico, Milano, Cisalpino-Giuridica, 1973, p. 526, osserva che«[s]i vedevano i membri del Governo e non si vedeva il Governo, le parti e non iltutto».
8 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
componevano con quest’ultimo «un’unità organica»5 che eserci-tava il potere esecutivo6.
L’evoluzione della forma di governo in senso parlamentare,tuttavia, comportò delle modifiche non solo in ordine ai rapportitra gli organi di vertice dell’ordinamento statutario ma anche allaloro struttura interna7. Nacquero e si svilupparono, infatti, altriorgani del Governo non previsti dallo Statuto ma che trovavanoil proprio fondamento in provvedimenti legislativi oppure nellaconsuetudine.
Innanzitutto, assunse gradualmente rilievo la figura del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, seppure considerato alla stre-gua di un primus inter pares8. Questi, inizialmente, svolse la fun-zione di manifestare all’esterno la volontà e le decisioni del Go-verno ma, con il rafforzamento del ruolo dell’organo collegialeformato da tutti i ministri – il Consiglio dei ministri9 –, il Presi-dente del Consiglio assunse un ruolo preponderante, tanto da ri-
5 Secondo l’espressione di A. MARONGIU, Storia, cit., p. 529. M. OLIVETTI, Laquestione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, Milano, Giuffrè, 1996, p. 48, os-serva che i ministri non costituivano un vero e proprio organo collegiale.
6 Il Governo, dunque, doveva essere considerato come governo del re, perché iministri erano semplicemente dei suoi fiduciari: così C. MORTATI, Istituzioni, tomo I,cit., p. 560. Secondo S. MERLINI, Il Governo, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Ma-nuale di diritto pubblico, vol. II, 5ª ed., Bologna, il Mulino, 1997, p. 177, invece, poi-ché i ministri erano responsabili ai sensi dell’art. 67 dello Statuto albertino, essi nonerano solo dei collaboratori del re ma erano investiti di un proprio potere.
7 Sull’evoluzione della forma di governo statutaria si rinvia a F. RACIOPPI, I. BRU-NELLI, Commento allo Statuto del Regno, vol. III, Torino, Utet, 1909, pp. 283 ss., C.MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano [1931], Mi-lano, Giuffrè, 2000, pp. 61 ss., A. BARGONE, Governo, in Nuovo digesto italiano, vol.VI, Torino, Utet, 1938, pp. 457-458, C. JEMOLO, M.S. GIANNINI (a cura di), Lo Statutoalbertino, Firenze, Sansoni, 1946, pp. 70 ss., A. MARONGIU, Storia, cit., p. 529, L. PA-LADIN, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1989, pp. 75 ss. Si v. anche laricostruzione di G. FERRARA, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica,Milano, Feltrinelli, 2006, pp. 170 ss.
8 Infatti, una crisi di governo poteva chiudersi anche con la sostituzione del soloPresidente del Consiglio: si v. l’esempio riportato da F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, Com-mento, cit., pp. 314-315.
9 Sul quale si v. il r.d. 1122/1850 (c.d. decreto D’Azeglio).
9IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
coprire il ruolo di Capo del Governo – per distinguerlo dal reche assumeva il ruolo di Capo dello Stato – e da far distinguerei vari Esecutivi in base al nome del loro Presidente10. Al fine dicoordinare l’attività del Consiglio dei ministri, inoltre, furonoistituiti anche l’archivio e la segreteria della Presidenza del Con-siglio11.
Per quanto riguarda i ministri – definiti anche segretari diStato12 –, essi potevano anche non essere posti a capo di un mini-stero e, in questo caso, erano definiti ministri senza portafoglio13.
Sulla scorta dell’esperienza britannica, poi, furono istituiti isottosegretari di Stato, che erano ausiliari dei ministri ed eserci-tavano le funzioni loro delegate da questi ultimi. Essi, inoltre,avevano il compito di rappresentare il ministro in caso di assenzao impedimento. I sottosegretari erano legati al Gabinetto che liaveva nominati e, di conseguenza, cessavano dalle loro funzioni
10 Sull’evoluzione del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri e dellostesso Consiglio si v. il r.d. 3629/1867 (c.d. decreto Ricasoli), il r.d. 3664/1867, il r.d.3289/1876 (c.d. decreto Depretis) e il r.d. 466/1901 (c.d. decreto Zanardelli), nonchéF. RACIOPPI, I. BRUNELLI, Commento, cit., pp. 287 ss., T. BRUNO, Gabinetto, in Digestoitaliano, vol. XII, Torino, Utet, 1900-1904, pp. 33-35, A. BARGONE, Governo, cit., pp.457-458. Anche su tale periodo storico le opinioni espresse in dottrina sui principî diorganizzazione del Governo sono contrastanti: dai decreti citati, infatti, C. MORTATI,L’ordinamento, cit., pp. 67 ss., ricavava che il principio prevalente e che «informa[va]di sé l’effettivo funzionamento del ministero» era quello collegiale; secondo S. MER-LINI, Il Governo, cit., pp. 180 ss., invece, nello Stato liberale il Presidente del Consigliorimase una figura debole, mentre un ruolo di rilievo fu assunto dai singoli ministri per-ché, dopo la riforma elettorale del 1919 e la conseguente nascita di Governi di coali-zione, i ministri rappresentavano i singoli partiti della coalizione, mentre il Presidentedel Consiglio era chiamato a svolgere un ruolo di mediatore fra i partiti di Governo;E. ROTELLI, La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Milano, Giuffrè, 1972, part. p.209, infine, ritiene che, con il consolidamento dell’organo collegiale, si ebbe anche ilrafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio.
11 Cfr. il r.d. 150/1881 e il r.d. 4936/1887.12 I ministri che entravano a far parte del Consiglio dei ministri – definiti, ap-
punto, segretari di Stato (art. 33, co. 1, n. 5, dello Statuto albertino) – non vanno con-fusi con i ministri di Stato, che erano dei consiglieri particolari del sovrano (art. 33, co.1, n. 4, dello Statuto albertino): cfr. C. ROMANELLI GRIMALDI, Ministro, in Enciclopediagiuridica, vol. XX, Roma, Treccani, 1990, pp. 1-2.
13 Su questi ultimi si v. F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, Commento, cit., p. 342.
10 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
in caso di crisi del Governo di cui facevano parte oppure quandoveniva meno il rapporto fiduciario con il Governo stesso o con ilministro di riferimento14.
I commissari del Governo, invece, erano deputati a rappre-sentare il Governo in Parlamento: secondo l’art. 59 dello Statutoalbertino, infatti, solo i ministri o – appunto – i commissari delGoverno potevano essere ascoltati in Parlamento15. In seguito al-l’affermarsi del ruolo dei sottosegretari di Stato, tuttavia, la fi-gura del commissario del Governo perse rilievo, perché i sotto-segretari assunsero il compito di sostituire i ministri nel dibattitoparlamentare. I commissari del Governo, dunque, finirono con ilconfondersi con gli Alti commissari – o, semplicemente, com-missari – che erano posti a capo dei dipartimenti ma non face-vano parte del Consiglio dei ministri16.
2.2. Il regime fascista
Durante il regime fascista si ebbe una completa riforma delsistema di Governo ad opera della l. 2263/1925. Si affermò, in-fatti, la netta prevalenza del c.d. “Primo ministro Segretario diStato”, “Capo del Governo”17 sul Consiglio dei ministri e muta-
14 Cfr. l’art. 2 della l. 5195/1888, e gli artt. 2-4 del r.d. 5247/1888. Si rinvia, inol-tre, a F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, Commento, cit., pp. 349-352, I. SANTANGELO SPOTO, Mi-nistero e ministri, in Digesto italiano, vol. XV, parte II, Torino, Utet, 1904-1911, pp.509 ss., E. GATTA, Ministeri e ministri, in Nuovo digesto italiano, vol. VIII, Torino,Utet, 1939, p. 566, e L. ROSSI, Sottosegretari di Stato, in Nuovo digesto italiano, vol.XII, parte I, Torino, Utet, 1940, pp. 659-660.
15 Si riporta il testo della disposizione citata: «Le Camere non possono riceverealcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Com-missarii del Governo».
16 In proposito cfr. I. SANTANGELO SPOTO, Ministero, cit., pp. 512-513, C. JE-MOLO, M.S. GIANNINI (a cura di), Lo Statuto, cit., pp. 60-63, e G. RIZZA, Commissario ealto commissario. Commissario straordinario, in ID., Saggi di diritto pubblico, Bari, Ca-cucci, 1995, pp. 189-192.
17 … secondo le denominazioni utilizzate dalla l. 2263/1925. Nei testi normativiera frequentemente utilizzata anche la denominazione “Duce”, che, tuttavia, era privadi significato giuridico: così S.N., Duce, in Nuovo Digesto italiano, vol. V, Torino, Utet,1938, p. 244.
11IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
rono i termini del rapporto fiduciario: dalla responsabilità delGoverno – definito “Governo del Re” – verso il Palamento, in-fatti, si passò alla responsabilità del Capo del Governo verso il so-vrano18. I ministri, di conseguenza, assunsero un ruolo di minorrilievo, mentre il Consiglio dei ministri non era neanche richia-mato dall’art. 1 della l. 2263/1925. Al Capo del Governo, inoltre,erano attribuiti poteri che gli consentivano di determinare sia lacomposizione sia il funzionamento delle Camere19. Contestual-mente al rafforzamento del Capo del Governo, assunse un ruolodi grande rilievo anche la Presidenza del Consiglio, a causa dellenumerose attribuzioni ad essa riconosciute20. Il ruolo di assolutaprimazia assunto dal Capo del Governo durante il regime fascistaconsente di comprendere meglio i motivi che spinsero i costi-tuenti a discutere a lungo della struttura del Governo repubbli-cano e – soprattutto – del ruolo da attribuire al Presidente delConsiglio dei ministri nella Costituzione italiana21.
18 Si v. l’art. 2, co. 1, della l. 2263/1925, nonché C. MORTATI, L’ordinamento, cit.,pp. 80 ss., P. CHIMIENTI, Capo del Governo, in Nuovo digesto italiano, vol. II, Torino,Utet, 1937, pp. 839 ss., ID., Consiglio dei ministri, in Nuovo digesto italiano, vol. III,Torino, Utet, 1938, pp. 880-881, A. BARGONE, Governo, cit., pp. 458-460, L. PALADIN,Fascismo (dir. cost.), in Enciclopedia del diritto, vol. XVI, Milano, Giuffrè, 1967, pp.894-896, G. RIZZA, Il Presidente del Consiglio dei ministri, Napoli, Jovene, 1970, p. 85,E. ROTELLI, La Presidenza, cit., pp. 301 ss., e P.A. CAPOTOSTI, Governo, in Enciclopediagiuridica, vol. XV, Roma, Treccani, 1989, p. 2.
19 Si v. l’art. 6 della l. 2263/1925. A tal riguardo A. BARGONE, Governo, cit., pp.459-460, osservava che la «figura nuova del Capo del Governo, (…) giuridicamente epoliticamente, giganteggia sugli altri organi costituzionali»; si v. anche i rilievi di S.MERLINI, Il Governo, cit., pp. 182-183. Secondo L. PALADIN, Diritto, cit., p. 89 (ma an-che ID., Fascismo, cit., pp. 892 ss.), una volta estromesso il Parlamento dalla scena po-litica, la forma di governo italiana poteva definirsi una diarchia, costituita dal Capo delGoverno e da quello dello Stato; tale sistema, però, fu complicato dall’inserimento diun terzo organo costituzionale: il Gran Consiglio del fascismo. Su quest’ultimo si v. lal. 2693/1928, nonché M. MARAVIGLIA, Gran Consiglio del Fascismo, in Nuovo digestoitaliano, vol. VI, Torino, Utet, 1938, pp. 472 ss.
20 Cfr. M.P. VIVIANI SCHLEIN, La Presidenza del Consiglio dei ministri: storia di unfallimento, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, pp. 2736-2738, che la definisce «unsuperministero».
21 Si v. infra, parte I, cap. I, parr. 3. ss.
12 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
Per quanto riguarda i sottosegretari, il loro ruolo politico di-minuì durante il fascismo, perché venne loro attribuito solo ilcompito di svolgere le funzioni delegate dai ministri, senza preve-dere un generale potere di rappresentanza del ministro stesso22.
È importante osservare, inoltre, che proprio durante il fasci-smo fu istituito il primo comitato interministeriale: il CICR23. L’i-stituzione di tale comitato non solleva problemi di legittimità nelsistema delineato dalla l. 2263/1925 se si considera l’ampiezzadei poteri del Capo del Governo, che era senz’altro abilitato adistituire dei comitati ristretti di ministri, determinandone compo-sizione e funzioni. Tale istituzione, inoltre, sembra confermare latendenza ad accentrare la funzione di indirizzo nelle mani delCapo del Governo, considerato che questi presiedeva il CICR eche i provvedimenti del comitato erano assunti con decreto dellostesso Primo ministro24. Bisogna ricordare, però, che l’istituzionedi tale comitato durante il regime fascista è stata anche conside-rata come il tentativo di un (parziale) recupero della collegialitàdell’azione di governo, volto a garantire un indirizzo politicounitario quantomeno nella politica dell’attività creditizia25. Una
22 Si v. l’art. 2 del r.d.l. 1100/1924, nonché L. ROSSI, Sottosegretari, cit., pp. 659-660, e E. GATTA, Ministeri, cit., p. 566.
23 Istituito con il r.d.l. 375/1936, art. 12. Si v. anche infra, parte II, cap. II,par. 4.1.
24 Questa osservazione sembra confermata dalla considerazione che – in periodorepubblicano – il CICR ha rafforzato notevolmente la posizione del suo presidente: ilministro del tesoro. Si v. in proposito P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 138 ss.
25 In questo senso, S. MERLINI, Struttura del governo e intervento pubblico nell’e-conomia, Firenze, La nuova Italia editrice, 1979, pp. 92 ss., secondo il quale l’attribu-zione al Capo del Governo della funzione di indirizzo politico sarebbe stata solo for-male e non venne effettivamente esercitata; il mancato esercizio di tale funzione e lascomparsa del principio di collegialità del Consiglio dei ministri finirono – secondol’A. – con il rafforzare i poteri separati dei singoli ministri, almeno sino al 1934. Se-condo M. GIUSTI, Fondamenti di diritto dell’economia, Padova, Cedam, 2005, p. 23, in-vece, il CICR deve la sua «derivazione, all’epoca, dalle mortificate mansioni del consi-glio dei ministri, soverchiato dal ruolo preminente del Duce come “capo del governo”,il quale tuttavia abbisognava di altri organi ristretti per delegare compiti, più che po-teri, soprattutto in sede tecnico-economica».
13IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
necessità, questa, che non fu avvertita solo in Italia: la “grandecrisi” del 1929, infatti, rese necessario un diretto intervento delloStato nell’economia. Nelle democrazie occidentali la gestionedelle politiche economiche fu assunta direttamente dai Governianziché dai Parlamenti e ciò comportò delle modificazioni nel-l’organizzazione e nella struttura dei Governi stessi, con la na-scita di nuovi organi (come accadde negli Stati Uniti e, appunto,in Italia) o con il rafforzamento del ruolo di alcune strutture go-vernative già esistenti (i Cabinet committees nel Regno Unito)26.
Un altro comitato istituito durante il fascismo fu il Comitatointerministeriale per l’autarchia27, deputato ad assumere le deli-berazioni necessarie alla concretizzazione di un sistema econo-mico di tipo autarchico28.
Caduto il regime, i comitati interministeriali non scompar-vero: altri comitati, infatti, furono costituiti prima dell’entrata invigore della Costituzione. È il caso, ad esempio, del già citatoCIP29, del Comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR)30 odel Comitato interministeriale per la previdenza agli statali31.
3. Il dibattito in Assemblea costituente
L’esperienza istituzionale fascista è stata considerata spessocome una anomalia nell’evoluzione dell’organizzazione costitu-zionale italiana32; non si può negare, tuttavia, da un lato, che, in
26 Si v., in proposito, S. MERLINI, Struttura, cit., pp. 110 ss., ID., Il Governo, cit.,pp. 184-187, D. SORACE, Il governo dell’economia, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di),Manuale, vol. III, cit., p. 115, ma anche S. CASSESE, La nuova costituzione economica, 3ªed. riveduta e aggiornata, Roma-Bari, 2004, pp. 15-18 e 173 ss.
27 Il Comitato interministeriale per l’autarchia fu istituito con il r.d.l. 32/1939.28 In questo senso V. FEROCI, Dal Comitato centrale intersindacale, al Comitato
corporativo centrale, alla Commissione suprema per l’autarchia, in AA.VV., Scritti giuri-dici in onore di Santi Romano, vol. III, Padova, Cedam, 1940, p. 620.
29 Istituito con il d.lg.lgt. 347/1944.30 Cfr. il d.lgs.lgt. 432/1945.31 Istituito con il d.l. 388/1946.32 In questo senso, ad es., P.A. CAPOTOSTI, Presidente del Consiglio dei ministri,
in Enciclopedia del diritto, vol. XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, p. 137, ma anche, con
14 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
virtù del principio di continuità dell’ordinamento, «la Repub-blica italiana rimane giuridicamente collegata – per paradossaleche ciò possa sembrare – all’ordinamento giuridico precedente il25 luglio del ’43»33; dall’altro, l’influenza (o, almeno per certiaspetti, l’incombere) di tale esperienza sulla genesi della Costitu-zione repubblicana34. Invero, per quanto riguarda, in particolare,la configurazione del Governo, la discussione in Assemblea co-stituente fu caratterizzata dalla preoccupazione, diffusa tra tuttele forze politiche, di un ritorno ad un regime di stampo fascista35,anche se, al fine di impedire il concretizzarsi di tale eventualità,si ipotizzarono soluzioni differenti, con riferimento sia alla formadi governo sia al ruolo da attribuire al Presidente del Consiglio36.Il dibattito, inoltre, fu influenzato dai numerosi riferimenti alle
specifico riferimento al ruolo del vertice dell’Esecutivo, E. CATELANI, Presidente delConsiglio dei ministri, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, vol. V,Milano, Giuffrè, 2006, p. 4432.
33 Così L. PALADIN, Diritto, cit., p. 102. A tal riguardo, esemplare è la discussionesulla sopravvivenza nell’ordinamento repubblicano – almeno sino all’approvazionedella l. 400/1988 – delle discipline inerenti l’organizzazione del Governo emanate du-rante il fascismo e nel periodo liberale: si v. infra, parte I, cap. I, par. 5.1.
34 … e, più in generale, degli eventi legati alla seconda guerra mondiale: cfr., alriguardo, G. DOSSETTI, I valori della Costituzione italiana, in Archivio giuridico FilippoSerafini, 1995, n. 1, part. pp. 7 ss. Una particolare influenza sull’ordinamento repub-blicano da parte dell’esperienza maturata durante il fascismo si può riscontrare nellaconfigurazione del sistema economico: si pensi ad alcune forme di intervento pubbliconell’economia (ad esempio la costituzione dell’IRI: r.d.l. 5/1933); ad alcune leggi chehanno continuato ad essere vigenti anche nell’Italia repubblicana (si pensi al codice ci-vile, al r.d.l. 375/1936, oppure alla l. 1150/1942); o, infine, allo sviluppo del regimedella c.d. riserva originaria, recepita nell’art. 43 Cost. (in questo senso S. CASSESE, Lanuova, cit., p. 15).
35 Secondo G. PASQUINO, Parlamento e Governo nell’Italia repubblicana, in Rivi-sta italiana di scienza politica, 2007, n. 1, p. 4, infatti, in Assemblea costituente aleg-giava il “complesso del tiranno”. Si v. anche M. CARTABIA, Governo, in S. CASSESE (di-retto da), Dizionario, vol. III, cit., p. 2828.
36 Cfr., in proposito, le osservazioni di G. AMATO, F. BRUNO, La forma di governoitaliana. Dalle idee dei partiti all’Assemblea costituente, in Quaderni costituzionali,1981, part. pp. 53 ss.; secondo M. VILLONE, Art. 94, in G. BRANCA (a cura di), Com-mentario della Costituzione, continuato da A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, Zanichelli-IlForo italiano, 1994, p. 241, il dibattito sul rapporto Parlamento-Governo, in partico-lare, fu volto «al passato piuttosto che al futuro».
15IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
esperienze costituzionali straniere: quella di Weimar, il modellobritannico e la forma di governo presidenziale statunitense37.
3.1. Sulla forma di governo in generale
In Assemblea costituente si confrontarono varie posizioni intema di forma di governo: furono sostenute, in particolare, sia latesi presidenziale38 sia quella assembleare39. La discussione, tutta-via, si concentrò essenzialmente sulla forma di governo parla-mentare, pur nella consapevolezza di dover prevedere dei corret-tivi capaci di garantire la stabilità del Governo e l’efficacia dellasua azione40.
37 Secondo U. DE SIERVO, Modelli stranieri ed influenze internazionali nel dibat-tito dell’Assemblea costituente, in Quaderni costituzionali, 1981, p. 281, però, i modelliistituzionali stranieri erano «più noti a parole che nella realtà a larga parte degli espo-nenti della nuova classe politica». Sull’influenza di tali modelli sul dibattito in Assem-blea costituente, si v. anche P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Le scelte costituzionali fondamen-tali dell’Italia e della Germania nel 1947-49 considerate dopo un quarantennio di attua-zione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1990, n. 1, pp. 3 ss., e T.E. FROSINI,Suggestioni anglosassoni sulla forma di governo della Repubblica italiana, in Diritto e so-cietà, 2001, n. 1, pp. 93 ss., che, anziché di modelli, preferisce parlare di “suggestioni”.
38 Si v. l’intervento di Calamandrei nella II Sottocommissione dell’Assemblea co-stituente, nella seduta del 5 settembre 1946, in La Costituzione della Repubblica nei la-vori preparatori della Assemblea Costituente, vol. VII, a cura del Segretariato generaledella Camera dei deputati, Roma, 1971, pp. 933-934. Si v., però, le osservazioni di T.E.FROSINI, Suggestioni, cit., pp. 98-99.
39 Cfr. gli interventi di La Rocca e Amendola nella II Sottocommissione dell’As-semblea costituente, nella seduta del 5 settembre 1946, in La Costituzione, vol. VII,cit., pp. 925-928 e 939.
40 A tal riguardo si v. le relazioni di Mortati (II Sottocommissione dell’Assem-blea costituente, seduta del 3 settembre 1946, in La Costituzione, vol. VII, cit., pp. 895ss.) e Conti (seduta del 4 settembre 1946, ivi, pp. 911-916) nonché, e soprattutto, l’or-dine del giorno presentato da Perassi nella II Sottocommissione dell’Assemblea costi-tuente, nella seduta del 4 settembre 1946, ivi, pp. 916-917 (su questo ordine del giornosi v. le osservazioni molto critiche di G. MIGLIO, Una Costituzione per i prossimitrent’anni, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 27). Secondo T.E. FROSINI, Suggestioni, cit., p.98, «più che disegnare un modellino di forma di governo, si puntava verso un sistemache potesse assicurare la governabilità, attraverso l’introduzione di una serie di mecca-nismi costituzionali, che fossero in grado di consentire al governo di rimanere salda-mente in carica al fine di poter esercitare, per l’intero mandato della legislatura, il pro-
16 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
Gli strumenti di stabilizzazione più interessanti appaionoquelli proposti da Tosato in merito al Presidente del Consigliodei ministri, che richiamano le scelte accolte nella Grundgesetz41.Tosato propose la nomina del Capo del Governo da parte delPresidente della Repubblica, dopo la designazione da parte delleCamere, sulla base di una lista predisposta dallo stesso Capodello Stato dopo le consultazioni. In merito alla rimozione delPresidente del Consiglio, invece, fu ipotizzata una mozione disfiducia che, se approvata a maggioranza assoluta, avrebbe com-portato la sostituzione del Presidente del Consiglio con il primofirmatario della mozione, se approvata a maggioranza semplice,avrebbe attribuito al Presidente della Repubblica il compito discegliere tra scioglimento e nomina del designato42. Nella formadi governo ipotizzata da Tosato, dunque, il ruolo del Presidentedella Repubblica non sarebbe stato meramente rappresentativo –anche perché se ne prevedeva l’elezione popolare43 – ma sem-brava richiamare il “custode della Costituzione” dell’esperienzadi Weimar44.
La scelta dell’Assemblea costituente per la forma di governoparlamentare incise anche sulle modalità di elezione del Presi-
prio indirizzo politico; realizzando così quegli obiettivi che lo stesso governo si eraprefissato e sui quali aveva ottenuto il consenso elettorale». Sui tentativi di razionaliz-zazione della forma di governo parlamentare classica si v. le osservazioni – a tratti sar-castiche – di V.E. ORLANDO, Studi intorno alla forma di governo vigente in Italia se-condo la Costituzione del 1948, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1951, pp. 22 ss.
41 In questo senso G. AMATO, F. BRUNO, La forma, cit., p. 67.42 Per le proposte di Tosato si v. gli atti della II Sottocommissione dell’Assem-
blea costituente, seduta del 5 settembre 1946, in La Costituzione, vol. VII, cit., pp.934-936.
43 Per le varie proposte in merito all’elezione del Presidente della Repubblica siv. gli interventi in Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 21 ottobre 1947 eseduta antimeridiana del 22 ottobre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., 1970, pp.3419 ss.
44 Secondo G. AMATO, F. BRUNO, La forma, cit., pp. 80-81, infatti, la proposta diTosato riproponeva il grande regolatore del gioco costituzionale di stampo weima-riano. Appare utile al riguardo un rinvio a C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung, Tü-bingen, Mohr, 1931, trad. it., Il custode della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1981, pp.203 ss.
17IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
dente della Repubblica: l’elezione di quest’ultimo da parte delParlamento, infatti, «sebbene non fosse l’unica possibile, risul-tava la più coerente con la forma di governo prescelta»45. La Co-stituente, dunque, preferì approvare un testo che – sostenutodalla maggioranza delle forze politiche – ha configurato il Presi-dente della Repubblica in termini compatibili con la forma di go-verno parlamentare46.
Per quanto riguarda, infine, gli strumenti di stabilizzazionedella forma di governo parlamentare, questi furono gradualmentesvuotati di significato47, garantendo al Parlamento e ai partiti inesso rappresentati un ruolo centrale nel sistema di governo48.
45 Così G.G. CARBONI, Art. 83, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a curadi), Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet, 2006, p. 1638.
46 Si v. la discussione in Assemblea costituente nelle sedute del 22, 23 e 24 otto-bre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., pp. 3429 ss.
47 Cfr., in particolare, le discussioni sul rapporto di fiducia fra Governo e Parla-mento: Assemblea costituente, seduta del 24 ottobre 1947, in La Costituzione, vol. IV,cit., pp. 3516 ss. Secondo L. ELIA, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, vol.XIX, Milano, Giuffrè, 1970, p. 659, in effetti, «in tema di razionalizzazione il costi-tuente è stato molto discreto»; nello stesso senso U. DE SIERVO, Modelli, cit., p. 291,che parla di «una forma di governo parlamentare con assai modeste innovazioni sulpiano della stabilizzazione e del rafforzamento dell’esecutivo», e S. GALEOTTI, Un go-verno scelto dal popolo: il Governo di legislatura, Milano, Giuffrè, 1984, p. 18, cheparla di “razionalizzazione zoppa”; critici anche V. CARUSI, Art. 94, in V. CRISAFULLI, L.PALADIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1990, p. 577, e M.OLIVETTI, La questione, cit., pp. 141 ss. Secondo V. CRISAFULLI, Stato Popolo Governo,Milano, Giuffrè, 1985, pp. 217-218, invece, gli artt. 94 e 95 Cost. conterrebbero «ac-curate cautele» al fine di garantire la stabilità e l’unità d’azione del Governo.
48 In questo senso T.E. FROSINI, Suggestioni, cit., pp. 100-101, A.M. SANDULLI, Lacostituente e la Costituzione italiana [1975], in ID., Scritti giuridici, vol. II, Diritto co-stituzionale, Napoli, Jovene, 1990, part. p. 183, ma anche G. AMATO, F. BRUNO, Laforma, cit., pp. 79-80, V. CARUSI, Art. 94, cit., pp. 577-578, e L. PRIMICERIO, Forma digoverno parlamentare e modelli di democrazia rappresentativa, Torino, Giappichelli,2002, pp. 111 ss. Occorre ricordare che, secondo G. BURDEAU, Le régime parlemen-taire, Paris, Editions internationales, 1932, trad. it., Il regime parlamentare, Milano,Edizioni di Comunità, 1950, passim, il regime parlamentare sarebbe fondato sull’equi-librio tra poteri e che la prevalenza dell’Esecutivo o del Legislativo comporterebbeun’alterazione di tale regime; secondo l’A., peraltro, «[il regime parlamentare] è unaforma duttile di governo nella quale rari sono i princìpi, nella quale ha maggiore im-portanza il richiamo all’esperienza ed alla concretezza che non alla lettera delle costi-
18 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
3.2. Sull’art. 92 Cost.
Per quanto riguarda l’articolazione del Governo, in Assem-blea costituente si confrontarono due tesi differenti: quella chesosteneva il principio monocratico e, di conseguenza, la necessitàdi attribuire un ruolo di rilievo al Presidente del Consiglio deiministri (Kanzlerprinzip), da un lato, e la tesi che sosteneva ilprincipio collegiale e, dunque, la preminenza del Consiglio deiministri (Kabinettsprinzip), dall’altro49. Non sembra avere avuto
tuzioni, tuttavia tale elasticità non deve far dimenticare che per essere considerata par-lamentare una costituzione deve adottare taluni princìpi giuridici direttivi dai qualiessa trae la sua qualificazione» (p. 104). D’altro canto, secondo C. MORTATI, L’ordina-mento, cit., pp. 36 ss., la forma di governo parlamentare non sarebbe caratterizzatadall’equilibrio tra poteri diversi, né la maggiore stabilità all’azione di governo potrebbeessere garantita da espedienti di tecnica legislativa: rileverebbero, invece, condizionigenerali quali il costume, la tradizione, la struttura sociologica, le particolarità psicolo-giche del popolo e il sistema dei partiti. A. MANNINO, Indirizzo politico e fiducia, Mi-lano, Giuffrè, 1973, part. p. 44, invece, sulla scorta del ruolo gradualmente assunto daipartiti, riteneva superata la forma di governo parlamentare italiana, perché il circuitofiduciario si era spostato dall’asse Governo-Parlamento a quello Governo-partiti. Si v.anche le osservazioni di T. MARTINES, Governo parlamentare e ordinamento democra-tico, Milano, Giuffrè, 1967, pp. VIII ss., F. MODUGNO, Poteri (divisione dei), in Novis-simo digesto italiano, vol. XIII, Torino, Utet, 1966, pp. 484-485, e S. LABRIOLA, Laforma di governo nella Costituzione repubblicana in Italia: temi per una revisione ed iprincipi di regime, in AA.VV., Scritti in onore di Aldo Bozzi, Padova, Cedam, 1992, pp.262 ss. Sulla superiorità delle organizzazioni partitiche nei confronti del Parlamento sirinvia a C. SCHMITT, Der Hüter, cit., p. 324; G. CAPOGRASSI, La nuova democrazia di-retta, Roma, Pinnaro, 1922, ora in ID., Opere, vol. I, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 537 ss.;G. LEIBHOLZ, Parteienstaat und repräsentative Demokratie. Eine Betrachtung zu Art. 21und 38 des Bonner Grundgesetzes, in H. RAUSCH (ed.), Zur Theorie und Geschichte derRepräsentativ-verfassung, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968, trad.it., Stato dei partiti e democrazia rappresentativa. Considerazioni intorno all’articolo 21 eall’articolo 38 della Legge Fondamentale di Bonn, in G. LEIBHOLZ, La rappresentazionenella democrazia, Milano, Giuffrè, 1989, part. pp. 386 ss.; C. ROSSANO, Partiti politici,in Enciclopedia giuridica, vol. XXII, Roma, Treccani, 2002, part. pp. 2-3. Sull’impor-tanza del sistema dei partiti nella definizione delle forme di governo, infine, cfr. L.ELIA, Governo, cit., pp. 638 ss., G. GUARINO, Il regime parlamentare, in Scritti dedicatiad Alessandro Raselli, vol. I, Milano, Giuffrè, 1971, ora in ID., Dalla Costituzione al-l’Unione europea, vol. III, Napoli, Jovene, 1994, pp. 218 ss., ma anche le osservazionidi C. MORTATI, La costituzione in senso materiale [1940], Milano, Giuffrè, 1998, p. 208.
49 In questo senso E. ROTELLI, La Presidenza, cit., p. 416.
19IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
grande eco nel dibattito in Assemblea costituente, invece, il prin-cipio di indipendenza dei singoli ministri (Ressortprinzip)50.
Il progetto di Costituzione elaborato dalla I Sezione della IISottocommissione per la Costituzione prevedeva che il Governofosse composto «del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, edei ministri»51. Il co. 2 dello stesso progetto, poi, disponeva: «IlPresidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, su pro-posta di questo, i ministri»52. Lo scopo di tale formulazione delladisposizione era quello di garantire la presenza all’interno delGoverno di una figura che fosse capace «di ridurre a unità orga-nica la pluralità dei ministri, di mantenere l’unità organica delGabinetto e di far sì che la politica necessariamente unitaria delGoverno sia concordemente e fedelmente perseguita da tutti imembri del Governo»53.
Questa formulazione sollevò immediatamente delle discus-sioni: infatti, La Rocca propose un emendamento volto a garan-tire la collegialità dell’Esecutivo, così da impedire che il Presi-dente del Consiglio assumesse una posizione diversa e premi-nente rispetto a quella degli altri membri del Governo54. In
50 Su tali principî si v. L. ELIA, Primo ministro (diritto comparato), in Novissimodigesto italiano, vol. XIII, Torino, Utet, 1957, pp. 864 ss., P.A. CAPOTOSTI, Governo,cit., p. 9, e A. PREDIERI, Presidente del Consiglio dei ministri, in Enciclopedia giuridica,vol. XXIV, Roma, Treccani, 1991, p. 8, nonché H.H. BRAUSWETTER, Kanzlerprinzip,Ressortprinzip und Kabinettsprinzip in der ersten Regierung Brandt, 1969-1972, Bonn,Eichholz Verlag, 1977, e R. MAYNTZ, Executive Leadership in Germany: Dispersion ofPower or “Kanzlerdemokratie”?, in R. ROSE, E.N. SULEIMAN (eds.), Presidents and Primeministers, Washington D.C., American Enterprise Institute, 1982, pp. 142-143.
51 Così il co. 1 dell’art. 86 del progetto di Costituzione.52 Art. 86, co. 2, del progetto di Costituzione.53 Così Tosato nell’intervento in Assemblea costituente, nella seduta pomeri-
diana del 23 ottobre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., p. 3503.54 Si v. l’emendamento proposto da La Rocca in Assemblea costituente, nella se-
duta pomeridiana del 23 ottobre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., pp. 3502-3503,che recava il seguente testo: «Il Governo della Repubblica è costituito dal Consigliodei Ministri. I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica». SecondoP. CALANDRA, Il Governo della Repubblica, Bologna, il Mulino, 1986, pp. 12-13, «v’eraanche della mitologia nel pensare che non dovesse esistere né una politica del PrimoMinistro né una dei singoli ministri, ma solo una politica generale del Governo, e che
20 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
merito a tale emendamento, tuttavia, Laconi chiarì che lo scopodello stesso non era quello di escludere la figura del Presidentedel Consiglio, bensì solo quello di configurare quest’ultimo comeun primus inter pares, evitando che vi fossero due distinti atti dinomina per il Presidente del Consiglio e per i ministri e che ilPresidente del Consiglio potesse «considerarsi rappresentanteunico di tutto il Governo»55. Nondimeno, la maggior parte delleforze politiche presenti in Assemblea costituente si espresse insenso contrario all’emendamento in questione, sia perché appa-riva necessario prevedere una figura direttiva e coordinatrice del-l’attività del Governo56, sia perché si riteneva che la direzione fi-nale della politica dovesse spettare sempre al Primo ministro57. Èda osservare, peraltro, che sia chi sosteneva la necessità di ridi-mensionare il ruolo del Presidente del Consiglio sia i sostenitoridella tesi opposta muovevano le loro considerazioni dalla preoc-cupazione dell’insorgenza di aspirazioni dittatoriali58.
Un ulteriore motivo di discussione sul ruolo da attribuire alPresidente del Consiglio dei ministri derivò dalla consapevolezzadiffusa che le maggioranze che avrebbero sostenuto i futuriGoverni sarebbero state politicamente composite e, dunque, che– almeno per le prime legislature repubblicane – si sarebberoavuti Governi di coalizione. Da tale convincimento, una parte
si espresse nell’affermazione che il Governo della Repubblica era composto dal Consi-glio dei Ministri, per impedire che il Gabinetto apparisse costituito di due elementi di-versi e distinti: il premier e i ministri».
55 Si v. l’intervento di Laconi in Assemblea costituente, nella seduta pomeridianadel 23 ottobre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., pp. 3505-3506. Appare utile, inol-tre, rinviare a V. ATRIPALDI, L’organizzazione costituzionale dello Stato nel dibattito allaCostituente: il contributo di Renzo Laconi, in V. ATRIPALDI, C. FICHERA, Dalla granderiforma alla politica delle istituzioni, Padova, Cedam, 1986, pp. 115 ss.
56 Si v. l’intervento di Ruini in Assemblea costituente, nella seduta pomeridianadel 23 ottobre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., p. 3505.
57 In questo senso l’intervento di Nitti in Assemblea costituente, nella seduta po-meridiana del 23 ottobre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., p. 3504.
58 Si v., ad es., gli interventi in Assemblea costituente di Fuschini e Vanoni, nellaseduta antimeridiana del 7 gennaio 1947 (in La Costituzione, vol. VIII, cit., 1971, ri-spettivamente pp. 1781-1782, e 1784).
21IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
dei costituenti dedusse l’inopportunità di attribuire un ruolo diprimazia al Presidente del Consiglio per evitare che questi po-tesse tentare di attuare la politica del proprio partito di riferi-mento anziché quella dell’intera coalizione59, aumentando i dis-sidi nella compagine governativa60. Altra parte dei componentidell’Assemblea costituente, invece, ritenne necessario attribuireal Presidente del Consiglio una autorità tale da consentirgli diconvogliare le diverse anime politiche della coalizione in ununico indirizzo61.
Al termine della discussione, l’emendamento proposto daLa Rocca fu respinto, mentre furono accolti gli emendamenti al-l’art. 86 del progetto volti ad eliminare la denominazione diPrimo ministro per lasciare solo quella di Presidente del Consi-glio62, nonché quello con il quale si inserì il Consiglio dei ministritra gli organi del Governo63.
3.3. Sull’art. 95 Cost.
Al fine di definire il ruolo del Presidente del Consiglio oc-corre accennare anche alla discussione su quello che sarebbe di-ventato l’art. 95 Cost.64.
59 Si v. l’intervento di Terracini, nella seduta pomeridiana del 4 gennaio 1947, inLa Costituzione, vol. VIII, cit., pp. 1774-1775.
60 Si v. l’intervento di La Rocca, nella seduta antimeridiana del 7 gennaio 1947,in La Costituzione, vol. VIII, cit., p. 1783.
61 Si v., in tale senso, gli interventi di Lussu, Tosato e Mortati nella seduta pome-ridiana del 4 gennaio 1947 (in La Costituzione, vol. VIII, cit., p. 1775) e di Paolo Rossinella seduta antimeridiana del 7 gennaio 1947 (ivi, p. 1783). Si v., al riguardo, le osser-vazioni di A. AMORTH, Analisi costituzionale del Governo, in M. GLISENTI, L. ELIA (acura di), Cronache sociali 1947-1951, Roma, Luciano Landi Editore, 1961, part. p. 627.
62 Cfr. l’emendamento proposto in Assemblea costituente da Costa, nella sedutapomeridiana del 23 ottobre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., p. 3508. Secondo V.CARUSI, Art. 92, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commentario, cit., p. 565, tale modificaservì a «temperare (...) un “primato presidenziale”, costantemente avversato dalle sini-stre», e aveva anche «un chiaro significato di reazione al regime anteriore».
63 Cfr. l’emendamento proposto in Assemblea costituente da Colitto, nella se-duta pomeridiana del 23 ottobre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., p. 3502.
64 È utile riportare il testo della disposizione costituzionale: «Il Presidente delConsiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Man-
22 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
L’art. 20 del progetto in discussione dinanzi alla I Sezionedella II Sottocommissione della Commissione per la Costituzione,infatti, disponeva che il Primo Ministro fosse responsabile dellapolitica generale del Governo e i ministri degli atti dei loro mini-steri, senza prevedere una responsabilità dei ministri per la poli-tica generale del Governo. Nel corso della discussione in II Sot-tocommissione, tuttavia, fu approvata la proposta di Perassi chemodificava sia l’art. 20 («Il Primo Ministro dirige la politica ge-nerale del governo») sia l’art. 19 («Il Primo Ministro e i ministrisono collegialmente responsabili della politica generale del go-verno e ciascuno di essi degli atti di sua competenza») del pro-getto65. Il comitato di redazione, poi, accolse sostanzialmente iltesto derivante dalla proposta di Perassi, seppure con una atte-nuazione del principio della responsabilità collegiale: «Il PrimoMinistro dirige la politica generale del governo e ne è responsa-bile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo ditutti i Dicasteri, promovendo e coordinando l’attività dei Mini-stri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Con-siglio dei ministri e personalmente degli atti dei loro Dicasteri»66.
La disposizione non subì radicali modifiche neanche nel di-battito in Assemblea plenaria – a parte, ovviamente, l’aggiuntadel co. 3 di quello che poi è divenuto l’art. 95 Cost.67 –, perchéanche in questo caso fu determinante la bocciatura dell’emenda-mento presentato da La Rocca.
tiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’atti-vità dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio deiministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordina-mento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’orga-nizzazione dei Ministeri».
65 Si v. tale proposta, nonché gli interventi di Tosato e Mortati, nel dibattito nellaII Sottocommissione della Commissione per la Costituzione nella seduta pomeridianadel 10 gennaio 1947, in La Costituzione, vol. VIII, cit., pp. 1823 ss.
66 Così l’art. 89 del progetto di Costituzione.67 Secondo E. ROTELLI, La Presidenza, cit., p. 430, nel contesto delineatosi du-
rante i lavori della Costituente, la disposizione in questione non «può trovare ostacolisulla sua strada e viene approvata, infatti, senza alcuna discussione specifica».
23IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
3.4. Sugli organi del Governo “non necessari”
È necessario, ora, esaminare i lavori dell’Assemblea costi-tuente in relazione alla possibilità di prevedere in Costituzioneorgani del Governo ulteriori rispetto al Presidente del Consiglio,ai ministri e al Consiglio dei ministri.
Occorre considerare, innanzitutto, che fu presentato un or-dine del giorno volto ad escludere la possibilità di prevedere mi-nistri senza portafoglio68. Tale ordine del giorno, però, fu re-spinto perché appariva opportuno consentire l’istituzione di taliorgani per curare «particolari problemi (…) per i quali non è ne-cessaria una organizzazione permanente amministrativa»69.
In secondo luogo, bisogna fare riferimento all’emendamentopresentato da Clerici che intendeva consentire l’istituzione di unConsiglio di Gabinetto70. Questo emendamento fu ritirato ma ladecisione non sembra motivata dalla volontà di impedire che taleorgano potesse essere costituito, bensì dalla considerazione che ilPresidente del Consiglio fosse abilitato ad istituire per dati scopicomitati ristretti di ministri e, di conseguenza, prevedere espres-samente in Costituzione tale organo appariva superfluo71.
Infine, va evidenziato che l’Assemblea costituente non vietòorgani diversi da quelli espressamente indicati nella Costituzione
68 Si v. l’ordine del giorno proposto da Nobile nella seduta pomeridiana del 10gennaio 1947 della I Sezione della II Sottocommissione della Commissione per la Co-stituzione, in La Costituzione, vol. VIII, cit., pp. 1833-1834.
69 Così Vanoni nel suo intervento nella I Sezione della II Sottocommissione dellaCommissione per la Costituzione nella seduta pomeridiana del 10 gennaio 1947, ilquale richiamava – come Einaudi – la tradizione britannica, favorevole alla previsionedi tale organo; si v. i due interventi in La Costituzione, vol. VIII, cit., p. 1834.
70 L’emendamento fu proposto nella seduta pomeridiana del 24 ottobre 1947, inLa Costituzione, vol. IV, cit., pp. 3553-3554.
71 Cfr. l’intervento di Tosato, nella seduta pomeridiana del 24 ottobre 1947, inLa Costituzione, vol. IV, cit., p. 3557, il quale richiamava anche la tradizione e l’espe-rienza inglesi. Si v., però, F. BAGNAI, Il consiglio di gabinetto: problemi di compatibilitàcon la Costituzione, analogie e differenze con i comitati di ministri ed i comitati intermi-nisteriali, in Diritto e società, 1991, part. pp. 242 ss., secondo il quale l’Assemblea co-stituente intendeva impedire la costituzione di un Consiglio di Gabinetto.
24 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
e che pure erano già noti alla prassi precostituzionale: i ministrisenza portafoglio in primis, ma anche i sottosegretari di Stato e,appunto, i comitati interministeriali72. Non a caso, è stato osser-vato che la «struttura del Governo prefigurata dalla Carta costi-tuzionale, pur contenendo indubbi e rilevantissimi elementi dinovità, rappresenta, peraltro, sotto certi profili, il punto termi-nale del processo di evoluzione della forma organizzativa dell’E-secutivo esistente in Italia durante il periodo di vigenza dello Sta-tuto albertino, anche se naturalmente molto diverso è il rapportointerorganico tra le diverse componenti»73.
4. La struttura del Governo in Costituzione: un primo com-mento
Come si è visto, in Assemblea costituente si confrontaronoessenzialmente due opposti modelli organizzativi di Governo:uno che privilegiava il principio monocratico e, quindi, inten-deva garantire un ruolo preminente al Presidente del Consiglioin seno all’Esecutivo; l’altro, basato sul principio collegiale, voltoa fare del Governo un organo nel quale nessuno dei componentipotesse assumere una posizione di maggior rilievo rispetto aglialtri o, al limite, garantendo al Presidente del Consiglio solo ilruolo di primus inter pares74.
La soluzione accolta in Costituzione in merito al Governo ealla sua struttura, tuttavia, non coincide pienamente con alcunadelle proposte presentate in Assemblea costituente dalle varieforze politiche, né pare accogliere in maniera univoca un deter-minato modello idealtipico di Governo75. Non sembra, comun-
72In questo senso P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 21, ma anche F. CUOCOLO, IlGoverno, cit., p. 201.
73Così P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 1.74In questo senso P.A. CAPOTOSTI, Presidente, cit., pp. 137-139, e E. ROTELLI, La
Presidenza, cit., pp. 477 ss.75 È sintomatica in proposito l’affermazione di G. AMATO, F. BRUNO, La forma,
cit., p. 84, secondo i quali, nella soluzione adottata dalla Costituente, «il Governo è
25IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
que, che da ciò possa ricavarsi l’opinione che le decisioni assuntedalla Costituente siano semplicemente il risultato di “veti incro-ciati” delle diverse forze politiche76. Appare invece condivisibilel’idea che la maggior parte delle disposizioni della Carta fonda-mentale sia frutto di un accordo con il quale si sono composte lediverse posizioni presenti in Assemblea costituente77. E questaaffermazione pare potersi riferire anche alle scelte della Costi-tuente in materia di Governo78.
esplicitamente uno e trino»; in senso analogo G. RIZZA, I rapporti fra gli organi del Go-verno ed il regolamento interno del Consiglio dei ministri, in Diritto e società, 1994, p.322, secondo il quale la Costituzione ha adottato un “mix” fra i tre poteri organizza-tivi del Governo. Secondo V. CARUSI, Art. 95, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commen-tario, cit., p. 588, il modello di Governo accolto in Costituzione sarebbe «contro-verso». Secondo P. VIRGA, Diritto costituzionale, 8ª ed., Milano, Giuffrè, 1976, p. 211,infine, per la composizione del Governo nel nostro ordinamento si è adottato un si-stema misto.
76 Secondo P. CIARLO, Art. 95, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Co-stituzione, continuato da A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano,1994, pp. 353-354, «[l]a soluzione finale adottata non appare (…) il frutto di un con-sapevole scambio politico, espressione di un meditato dosaggio di posizioni diverse;sembra piuttosto una soluzione raggiunta in modo un po’ occasionale anche a seguitodi repentini mutamenti di orientamento».
77 In questo senso V. ATRIPALDI, Il patto costituzionale in Assemblea costituente,in V. ATRIPALDI, C. FICHERA, Dalla grande, cit., part. p. 88, V. COCOZZA, Costituzione II)Costituzione italiana, in Enciclopedia giuridica, vol. X, Roma, Treccani, 1988, p. 2, E.CHELI, La riforma mancata, Bologna, il Mulino, 2000, p. 33, e G. SILVESTRI, La nascitadella Costituzione italiana ed i suoi valori fondamentali, in Rivista trimestrale di dirittopubblico, 2006, n. 3, p. 590, ma anche le osservazioni di G. DOSSETTI, Costituzione eriforme, in Quaderni costituzionali, 1995, n. 2, part. p. 258. Si v., inoltre, R. BIN, Checos’è la Costituzione?, in Quaderni costituzionali, 2007, n. 1, p. 22, secondo il quale,più che “di compromesso”, quella italiana sarebbe una Costituzione “di concilia-zione”. Appare utile, infine, un rinvio a C. SCHMITT, Verfassungslehre, Berlin, Duncker& Humblot, 1928, trad. it., Dottrina della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 48ss., ma anche al concetto di Costituzione delineato da G. JELLINEK, Allgemeine Staat-slehre, 3ª ed., Berlin, O. Häring, 1914, trad. it., G. JELLINEK, V.E. ORLANDO, La dottrinagenerale del diritto dello Stato, Milano, Giuffrè, 1949, pp. 93 ss., e alla voce redatta daA. SPADARO, Costituzione (dottrine generali), in S. CASSESE (diretto da), Dizionario, vol.II, cit., pp. 1630 ss.
78 Secondo G. ROLLA, Il Consiglio dei ministri tra modello costituzionale e prassi,in Quaderni costituzionali, 1982, n. 2, p. 382, infatti, «le disposizioni costituzionali, nelloro complesso, non sono considerabili né un coacervo di tatticismi, né una somma di
26 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
Come si è già visto, i costituenti erano senz’altro consapevoliche – almeno per le prime legislature repubblicane – i nascentiGoverni sarebbero stati sorretti da coalizioni eterogenee; non eracerto imprevedibile, tuttavia, che l’evoluzione della società e delsistema dei partiti avrebbe potuto condurre ad un sistema poli-tico differente e, quindi, alla necessità di strutture organizzativediverse che la Costituzione – strumento non certo contingentema destinato a durare nel tempo79 – doveva poter garantire e de-limitare al tempo stesso80. Non bisogna dimenticare, infatti, chescopo della Costituzione era anche quello di superare i limiti e le
“spezzoni” ideologici contrapposti, in quanto le anima una comune carica progettuale.Da cui non è alieno neppure il complesso di norme che disciplinano l’organizzazionee le attribuzioni del Governo».
79 Secondo T. MARTINES, Diritto costituzionale, 8ª ed., Milano, Giuffrè, 1994, p.128, infatti, «ogni costituzione nasce ed è posta per durare nel tempo, vale a dire chela sua vigenza non può avere limiti temporali prefissati. Una costituzione che, in ipo-tesi, prevedesse un limite di tal genere rappresenterebbe una contraddizione logica an-cor prima che giuridica». Con specifico riferimento alla Costituzione italiana, E.CHELI, La riforma, cit., p. 33, osserva che attraverso l’accordo (o il patto costituzionale)raggiunto in Assemblea costituente «si giunse alla definizione di un prodotto costitu-zionale misurato più sulle “lunghe distanze” della storia che su operazioni di scambioancorate alle vicende di breve e medio periodo della politica». Si v. anche G. SILVESTRI,La nascita, cit., p. 590, e A. CHIAPPETTI, La ricerca della Costituzione perduta, Torino,Giappichelli, 2001, p. 79, nonché C. SCHMITT, Verfassungslehre, cit., pp. 38 ss.
80 Secondo E. CATELANI, Art. 95, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a curadi), Commentario, vol. II, cit., p. 1842, la «genericità ed in parte l’ambiguità dell’art.95, 1° co., Cost. nel delineare il ruolo del Presidente del Consiglio, hanno rappresen-tato (…) il punto di forza e nello stesso tempo il limite di tale norma: da un lato infatti,la difficile determinazione del ruolo del Presidente del Consiglio rispetto agli altri or-gani che compongono il Governo ha consentito una capacità di adattamento della no-stra Costituzione all’evoluzione storica ed alle esigenze contingenti che nel corso deglianni si sono poste in rapporto a tale figura ed ai poteri del Presidente del Consiglio (sipensi in particolare al problema dell’adattamento del ruolo del Presidente durante igoverni di coalizione). Nello stesso tempo, tuttavia, l’assenza di chiarezza ha determi-nato anche la difficoltà per tale organo di garantire un’uniforme gestione della politicagenerale del Governo, essendo vincolato sia alla volontà dei singoli ministri, sia ai par-titi componenti la coalizione». Si v., però, le osservazioni di G. SILVESTRI, La nascita,cit., pp. 594-595. Più in generale, si v. il rapporto fra stabilità e mutabilità della Costi-tuzione delineato da C. MORTATI, Costituzione Dottrine generali e Costituzione della Re-pubblica italiana, in Enciclopedia diritto, vol. XI, Milano, Giuffrè, 1962, part. p. 185.
27IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
difficoltà di un Paese dilaniato dalla guerra e da un profondocleavage sociale e ideologico81, facilitando «l’affermazione di unasicura coscienza popolare»82, al fine di consentire la realizzazionedi una democrazia matura. Era necessario, dunque, dettare unadisciplina del Governo che fosse sufficientemente elastica daconsentire all’Esecutivo di adattarsi a quelle che sarebbero statele mutate esigenze di governo del Paese83, consentendo l’evolu-
81 Si v. le osservazioni di G. AMATO, Il dilemma del principio maggioritario, inQuaderni costituzionali, 1994, n. 2, pp. 178 ss., G. PITRUZZELLA, Forme di governo etrasformazioni della politica, Bari, Laterza, 1996, p. 37, e E. CHELI, La riforma, cit., pp.32-33.
82 Così Mortati nella seduta del 21 dicembre 1946 della II Sottocommissionedella Commissione per la Costituzione, in La Costituzione, vol. VII, cit., p. 1632, in re-lazione alle proposte di referendum. Giova riportare, inoltre, le parole di P. HÄBERLE,Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, ed. italiana a cura di J.LUTHER, Roma, Carocci, 2001, pp. 32-33: «La costituzione non è soltanto un ordina-mento giuridico per i giuristi, da interpretarsi secondo le regole antiche e modernedella loro arte. Serve essenzialmente anche da guida per i non giuristi, i cittadini. Percostituzione non si deve intendere soltanto un testo giuridico, “un compendio di re-gole” normative. La costituzione esprime anche una condizione di sviluppo culturaledi un popolo, serve da strumento dell’autorappresentazione culturale, da specchio delsuo patrimonio culturale e da fondamento delle sue speranze».
83 Secondo C. MORTATI, L’ordinamento, cit., pp. 21-22, infatti, non è possibiledeterminare in via generale la composizione dell’organo che assume la funzione di go-verno, perché questo conforma la sua composizione in maniera tale da renderla il piùpossibile idonea alla soddisfazione delle esigenze della sua funzione. Con specifico ri-ferimento alla forma di governo parlamentare, poi, l’A. osservava che l’ordinamentointerno del Governo «è strettamente legato al sistema dei rapporti esterni stabiliti fraParlamento e Gabinetto e, come questo, modellantesi, piuttosto che sugli schemi legi-slativi, sulla situazione politica di ogni singolo paese» (pp. 35-36). Secondo L. ELIA,Governo, cit., p. 640, «le norme sulla forma di governo (e particolarmente quelle rela-tive al governo parlamentare in senso proprio) sono a fattispecie aperta (entro certi li-miti) e cioè suscettibili di essere qualificate dal sistema dei partiti e integrate dalle re-gole convenzionali che ad esso fanno capo». V.E. ORLANDO, Studi, cit., p. 15, invece,osservava che, «nelle costituzioni e tanto peggio se rigide, la diffusione e le specifica-zioni normative sono pericolose e dannose». Si v. anche le osservazioni critiche di G.AMATO, F. BRUNO, La forma, cit., p. 85, nonché E. CUCCODORO, Collegialità ministeriale,comitati e vertici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1983, part. p. 826.
Più in generale, sulla elasticità delle disposizioni costituzionali si rinvia a C.MORTATI, La costituzione, cit., part. p. 117, G. CHIARELLI, Elasticità della Costituzione,in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1952, pp. 322 ss., G. TREVES, Duttilità della
28 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
zione e l’articolazione dello stesso Esecutivo anche sulla basedelle convenzioni sopravvenute tra i differenti soggetti politici84.
L’anfibolia delle disposizioni costituzionali sul Governo el’ampio dibattito svolto in Assemblea costituente hanno portatola dottrina a sostenere tesi differenti – in alcuni casi antitetiche –sul modello di Governo accolto in Costituzione85. Di volta involta, infatti, si è asserita la prevalenza del Kanzlerprinzip, delKabinettsprinzip o del Ressortprinzip nella organizzazione dell’E-secutivo, considerato che i tre principî organizzativi possonotutti trovare un appiglio nell’art. 95 Cost.86. Il rilievo e la varietàdi tali tesi rendono necessario riassumerne le principali.
Costituzione, in AA.VV., Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea costituente,vol. IV, Firenze, Vallecchi, 1969, ora in ID., Scritti giuridici, Milano, Giuffrè, 1982, pp.157 ss., V. COCOZZA, Costituzione, cit., pp. 2-3, S. BARTOLE, Interpretazioni e trasforma-zioni della Costituzione repubblicana, Bologna, il Mulino, 2004, part. pp. 441 ss., non-ché R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, München-Leipzig, Duncker & Hum-blot, 1928, trad. it., Costituzione e diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1988, part.pp. 151-152. Appare utile rinviare anche a G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, nuova ed.,Torino, Einaudi, 1992, part. cap. I.
84 Sebbene, come osservato da L. PALADIN, Governo italiano, in Enciclopedia deldiritto, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, p. 711, «giuridicamente (…) nulla vieta chealle regole puntuali ed “informali” dei rapporti [che si stabiliscono tra le componentidel Governo] subentrino disposizioni normative, più rispondenti agli scopi costituzio-nali del coordinamento e dell’unità di indirizzo». Anche perché – è appena il caso diaggiungere – tali regole, dettate da fonti di rango subcostituzionale, possono essereabrogate o modificate con maggiore semplicità rispetto a quelle dettate dalla Costitu-zione, qualora mutino nuovamente gli scopi o le necessità accennati. Per l’influenzasulla forma di governo delle regole convenzionali derivanti dal sistema dei partiti si v.L. ELIA, Governo, cit., part. pp. 639-640.
85 L. PALADIN, Governo, cit., pp. 675-676, infatti, parlava di “povertà” e “incer-tezza” delle indicazioni ricavabili dai testi vigenti in materia di Governo: «È general-mente condivisa, infatti, l’idea che la Costituzione scritta non abbia operato in questocampo una “razionalizzazione” completa, ma anzi sia stata redatta in maniera somma-ria ed aperta a divergenti applicazioni».
86 Secondo V. CARUSI, Art. 95, cit., p. 588, infatti, al Presidente del Consiglio deiministri «si attaglierebbe (…) secondo diversi punti di vista, sia la qualifica di “primusinter pares” (del decreto Zanardelli), sia quella intermedia di un “primus super pares”,sia ancora quella di un “Primo Ministro”, nella sostanza se non nel nome, in grado diaffermare la sua prevalente funzione sui Ministri e sullo Stesso Consiglio». Cfr. ancheS. MERLINI, Presidente del Consiglio e collegialità di Governo, in Quaderni costituzio-nali, 1982, n. 1, pp. 13 ss.
29IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
4.1. Il Governo come Consiglio dei ministri
Una prima ricostruzione dottrinale identifica il Governocon il Consiglio dei ministri. Secondo questa tesi, dai lavori dellaCostituente e dalla dizione letterale dell’art. 92 Cost. si evince-rebbe chiaramente che dal punto di vista strutturale il Governosi concreterebbe nel Consiglio dei ministri, perché la Costitu-zione afferma che il Presidente del Consiglio e i ministri “in-sieme” costituiscono il Consiglio dei ministri87. Non solo. Poichéil Consiglio dei ministri-Governo rappresenterebbe «la sede na-turale di elaborazione e di svolgimento della politica generale delGoverno»88, sarebbero incostituzionali tutte quelle alterazionidella struttura del Governo che consentissero l’esercizio del po-tere decisionale in sedi differenti da quella propria rappresentataesclusivamente dal Consiglio dei ministri89, tra le quali rientre-rebbero anche i comitati interministeriali90.
Questa tesi, però, non può essere condivisa.Innanzitutto, non sembra affatto che dai lavori dell’Assem-
blea costituente possa ricavarsi l’ipotizzata sovrapposizione traGoverno e Consiglio dei ministri: la netta reiezione del più voltecitato emendamento La Rocca, anzi, depone contro una configu-
87 A. RUGGERI, Il Consiglio dei ministri nella Costituzione italiana, Milano, Giuf-frè, 1981, pp. 25 ss. Cfr. anche P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., pp. 9-11, secondo ilquale i «meccanismi di responsabilità politica del Governo verso il Parlamento dimo-strano (…) la predominanza della responsabilità collegiale su quella individuale, conciò implicando peraltro una teorica prevalenza del Kollegialprinzip sugli altri modellidi organizzazione endogovernativa e, in particolare, su quello dell’autonoma compe-tenza ministeriale». Si rinvia, inoltre, a G. FALCON, Lineamenti di diritto pubblico, 8ªed., Padova, Cedam, 2001, p. 227, secondo il quale «il Governo è fondamentalmenteil Consiglio dei ministri, ed al Consiglio dei ministri vanno di massima riferiti tutti ipoteri che la Costituzione e le leggi affidano, senza nulla specificare, al “Governo”. Mail Consiglio è a sua volta un organo composto da altri organi, quali sono, anche indivi-dualmente presi, tanto il Presidente del Consiglio quanto i singoli ministri». Si v. an-che P. BARILE, Consiglio dei ministri, in Enciclopedia giuridica, vol. VIII, Roma, Trec-cani, 1991, p. 11, che considera il Consiglio dei ministri un «organo complesso, com-posto dell’organo monocratico Presidente e dell’organo collegiale Consiglio».
88 A. RUGGERI, Il Consiglio, cit., p. 69.89 A. RUGGERI, Il Consiglio, cit., pp. 157 ss.90 Cfr. ancora A. RUGGERI, Il Consiglio, cit., pp. 203 ss.
30 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
razione in termini di pura collegialità del Governo e a favoredella necessaria previsione della figura del Presidente del Consi-glio, indipendentemente dal maggiore o minore rilievo da attri-buire a quest’ultimo.
In secondo luogo, la tesi in commento contrasta con la pos-sibilità che sia proposta la mozione di sfiducia individuale: l’e-quivalenza tra Governo e Consiglio dei ministri, infatti, non con-sentirebbe di sfiduciare un singolo ministro, perché la responsa-bilità del Governo riguarderebbe l’organo collegiale91. Lasfiducia individuale – con l’obbligo di dimissioni per il ministroeventualmente sfiduciato – però, è prevista dal regolamento par-lamentare della Camera dei deputati e in via di prassi al Senatodella Repubblica92, ed è stata ritenuta ammissibile dalla Corte co-stituzionale93.
91 In dottrina è stata contestata la possibilità di sfiduciare un solo ministro: G.U.RESCIGNO, La responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 234 ss. (ma si v. anchel’analisi svolta in ID., La responsabilità politica del singolo ministro, in Studi parlamen-tari e di politica costituzionale, 1980, n. 47-48, pp. 5 ss.), L. PALADIN, Governo, cit., pp.696-698, L. VENTURA, Il Governo a multipolarità diseguale, Milano, Giuffrè, 1988, pp.45 ss., G.F. CIAURRO, Ministro, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVI, Milano, Giuffrè,1976, p. 525, C. CHIOLA, Uno strappo alla Costituzione: la sfiducia al singolo ministro,in Giurisprudenza costituzionale, 1986, pp. 810 ss., P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p.10; M. OLIVETTI, La questione, cit., pp. 129 ss., ma anche G. CUOMO, Unità e omoge-neità nel governo parlamentare, Napoli, Jovene, 1957, pp. 154-155, e C. ROMANELLI
GRIMALDI, Ministro, cit., p. 6; favorevoli, invece, P. VIRGA, La crisi e le dimissioni delGabinetto, Milano, Giuffrè, 1948, pp. 17 ss., T. MARCHI, Il Governo, in P. CALAMAN-DREI, A. LEVI (a cura di), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, vol. II, Fi-renze, Barbera, 1950, p. 142, P. MASINI, La mozione di sfiducia a singoli ministri, in Di-ritto e società, 1982, pp. 407 ss., M. VILLONE, Art. 94, cit., pp. 278 ss., P. CIARLO, Art.95, cit., pp. 388 ss., T. MARTINES, Diritto, cit., p. 480, e F. DONATI, La responsabilità po-litica dei ministri nella forma di governo italiana, Torino, Giappichelli, 1997. Si rinviaanche alle osservazioni di C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, 6ª ed., Torino,Utet, 1985, pp. 666-667.
92 Alla Camera la sfiducia individuale è disciplinata dall’art. 115 reg. Cam. (mo-dificato il 7 maggio 1986), mentre al Senato non è disciplinata dal regolamento, bensìattraverso l’interpretazione presidenziale e i pareri della giunta per il regolamento; inproposito ci si limita a rinviare a A. MANZELLA, Il parlamento, 3ª ed., Bologna, il Mu-lino, 2003, pp. 398-399.
93 Cfr. Corte costituzionale, sent. 7/1996, punti 6 ss. cons. dir., in merito alla sfi-ducia individuale nei confronti del ministro Mancuso, relativamente alla quale è stata
31IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Sembrano contrastare con la tesi della identificazione traGoverno e Consiglio dei ministri, inoltre, le aperture della Cortecostituzionale in tema di conflitti di attribuzione. La Consulta,infatti, sebbene consideri il Consiglio dei ministri come l’organolegittimato ad agire e resistere nei conflitti di attribuzione in rap-presentanza del potere esecutivo94, ha gradualmente riconosciutotale legittimazione anche al Presidente del Consiglio dei mini-stri95, al ministro della giustizia96 e – sembrerebbe – anche a sin-goli ministri97.
Il tenore letterale dell’art. 92 Cost., poi, non sembra espri-mere un indirizzo univoco, essendo sufficientemente elastico da
seguita una procedura ritenuta «anomala» (secondo la definizione di C. ROSSANO, Ma-nuale di Diritto pubblico, 2ª ed., Napoli, Jovene, 2007, p. 286), «particolarmente di-scutibile e poco lineare» (M. OLIVETTI, La questione, cit., p. 138). Su tale vicenda si rin-via anche a S. BARTOLE, Il caso Mancuso alla Corte costituzionale, in Giurisprudenza co-stituzionale, 1996, pp. 67 ss., S. NICCOLAI, Il conflitto di attribuzione e la politica, ivi,pp. 74 ss., M. CARDUCCI, Corte costituzionale e diritto parlamentare vivente, in Giuri-sprudenza italiana, 1996, col. 211 ss., e G.U. RESCIGNO, Il ‘caso Mancuso’ ovvero dellainesistenza dei casi di scuola, ovvero ancora del dovere dei giuristi di rispondere ai que-siti giuridicamente possibili, in Diritto pubblico, 1996, pp. 235 ss.
Si rinvia anche al caso della sfiducia individuale contro più ministri, presentatanel 1998 nei confronti degli allora ministri Napolitano e Flick e al commento di M.OLIVETTI, La mozione di sfiducia a più ministri: un mostro a più teste?, in Diritto pub-blico, 1999, n. 1, pp. 251 ss.
94 Cfr., ad es., Corte costituzionale, ord. 123/1979 e sent. 150/1981, punto 2cons. dir.
95 Corte costituzionale, ordd. 426/1997, 266/1998, 320/1999 e 321/1999, non-ché sentt. 110/1998, punto 2 cons. dir., 410/1998, punto 2 cons. dir., e 487/2000,punti 4.1 e 4.2 cons. dir.
96 Corte costituzionale, ord. 184/1992 e sent. 379/1992, punto 2 cons. dir.97 Si v. Corte costituzionale, ord. 470/1995 e sent. 7/1996, part. punto 3 cons.
dir., che, sebbene riguardi nuovamente il ministro della giustizia, sembra individuareuna situazione nella quale qualunque ministro potrebbe essere legittimato al conflittointerorganico, sebbene si tratti di una legittimazione sui generis, secondo E. MALFATTI,S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, 3ª ed., Torino, Giappichelli, 2011, p.238. Su questi profili si rinvia anche a A. CERRI, Corso di Giustizia costituzionale, 5ª ed.,Milano, Giuffrè, 2008, pp. 400-401 e 413-414, e alle osservazioni di V. CRISAFULLI, Le-zioni di diritto costituzionale, vol. II, 2, 5ª ed. riveduta e aggiornata, Padova, Cedam,1984, pp. 421-422.
32 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
prestarsi a differenti interpretazioni98. La disposizione, dunque,piuttosto che avvalorare la tesi della coincidenza tra Governo eConsiglio dei ministri, da un lato, sembra limitarsi ad indicare gliorgani necessari del Governo, non escludendo affatto la possibi-lità che siano costituiti anche organi ulteriori99; dall’altro, deveessere interpretata alla luce della prassi costituzionale e della le-gislazione di attuazione della Costituzione stessa100. Sulla scortadi tale evoluzione, appare agevole replicare alla tesi che vorrebbel’incostituzionalità di organi ulteriori rispetto a quelli indicatinell’art. 92 Cost. osservando che, nel tempo, sono sorti numerosiorgani “non necessari” del Governo, sviluppatisi dapprima perprassi e successivamente disciplinati da atti normativi101.
4.2. Il Governo a “multipolarità diseguale”
Un’ulteriore teoria considera il Governo come un organo a“multipolarità diseguale”102. Secondo questa tesi, i rapporti di
98 G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Co-stituzione, continuato da A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano,1994, p. 112, parla di «enunciati di per sé anfibologici». Secondo S. BARTOLE, Governoitaliano, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. VII, Torino, Utet, 1991, p. 639,peraltro, la tesi che si esamina, «[f]inendo per dare la prevalenza alla parte finale del1° co. dell’art. 92, e trascurando la più larga apertura con la menzione del Governo,(…) viene, tuttavia, a sottovalutare la prima parte di questa stessa disposizione chepure assegna un certo autonomo e distinto rilievo alle componenti monocratiche pre-senti all’interno del Governo».
99 Cfr. P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 1.100 Si v., in proposito, G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, cit., p. 112. Appare utile rin-
viare anche a C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi inItalia, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, p. 266.
101 Come si vedrà meglio infra, parte I, cap. I, par. 5.2.102 Il riferimento è a L. VENTURA, Il Governo, cit. Si v. anche ID., Ordinamento e
organizzazione del Governo, in AA.VV., Annuario 2001, cit., pp. 57 ss. Si v. altresì E.CHELI, Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia, Bologna, il Mulino, 1978, p.112, che parla di un governo “a direzione plurima dissociata” o “per ministeri”, non-ché P.G. LIGNANI, L’amministrazione centrale dello Stato, in G. SANTANIELLO (direttoda), Trattato di diritto amministrativo, vol. VI, Padova, Cedam, 1990, pp. 332-333, se-condo il quale l’espressione “governo per ministeri” può essere riferita sia all’aspetto
33IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
forza tra i membri del Governo sarebbero influenzati dalle cir-costanze politiche, dal sistema dei partiti e dalle caratteristichedella coalizione di Governo103. I ministri, di conseguenza, noncostituirebbero un complesso omogeneo, bensì una serie di poliche rappresentano nel Governo i partiti di riferimento, mentreun altro polo dell’Esecutivo sarebbe costituito dal Presidente delConsiglio104. I suddetti “poli”, peraltro, non sarebbero uguali,perché il loro peso politico, nonostante la formale parità giuri-dica, sarebbe influenzato dall’importanza del partito di apparte-nenza e del dicastero ricoperto105. Tale “multipolarità diseguale”,inoltre, si rifletterebbe anche in altri organi di governo, quali, adesempio, i comitati interministeriali106. Le decisioni politiche,dunque, sarebbero assunte in altre sedi – i vertici di partito o ilConsiglio di Gabinetto, nei quali vi sarebbe «una sorta di multi-polarità tra eguali» – e sarebbero semplicemente ratificate dalConsiglio dei ministri107.
La teoria in esame deriva evidentemente dall’analisi della si-tuazione politica e partitica italiana in un dato momento sto-rico108. Tuttavia, sebbene sia innegabile che l’ordinamento del
fisiologico del sistema di governo sia a quello patologico, che «consiste nella esaspera-zione della compartimentazione».
103 L. VENTURA, Il Governo, cit., pp. 127-128.104 L. VENTURA, Il Governo, cit., p. 137. Si v. anche le osservazioni di G.F.
CIAURRO, Ministro, cit., p. 525, P.G. LIGNANI, L’amministrazione, cit., p. 332, e quelle –estremamente critiche – di C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., p. 571.
105 In questo senso L. VENTURA, Il Governo, cit., pp. 139 ss.106 Cfr. ancora L. VENTURA, Il Governo, cit., pp. 137 e 156 ss.107 L. VENTURA, Il Governo, cit., pp. 137-138, nonché 167 ss. Secondo V. CARUSI,
Art. 92, cit., p. 566, il c.d. vertice di maggioranza rappresenterebbe una sede informaledi decisione, nella quale «si determina la composizione nonché il programma di go-verno, si adottano scelte rilevanti di indirizzo politico, trovano, spesso, composizioneconflitti ministeriali, e si decidono le stesse sorti del Governo»; il vertice in questione,dunque, darebbe vita ad una sorta di “sistema tricamerale” (cfr. G. ROLLA, Il Consiglio,cit., pp. 386 ss., nonché L. ELIA, Il «direttorio» nel governo di coalizione, in Giurispru-denza costituzionale, 1971, pp. 2813-2815).
108 Lo stesso L. VENTURA, Il Governo, cit., p. 128, infatti, osserva che l’art. 95Cost. «conferisce, sulla carta, una posizione autonoma al Presidente del Consiglio con
34 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
Governo non possa essere ricostruito solo sulla base dei dati nor-mativi, perché influenzato da elementi ulteriori, ricavare una teo-ria generale dall’esame di fatti contingenti non pare condivisi-bile: al cambiare delle circostanze che influenzano il modello, in-fatti, la teoria formulata non sarebbe più rispondente allarealtà109. Occorre considerare, inoltre, che, anche negli Esecutivisostenuti da coalizioni composite, il Governo – anziché esseresemplicemente l’esecutore della volontà dei partiti di maggio-ranza – può rappresentare l’organo capace di guidare la coali-zione, pretendendo anche il rispetto di «una certa disciplina po-litica nella esplicazione della funzione legislativa» da parte deiparlamentari della stessa maggioranza110.
4.3. Il Governo del primo ministro
Non è mancato, inoltre, chi ha sostenuto che, sebbene ilGoverno sia caratterizzato dalla compresenza del principio colle-giale e di quello monocratico, dall’art. 95 Cost. si evincerebbeche la Carta costituzionale attribuisce un ruolo di rilievo all’in-terno del Governo al Presidente del Consiglio dei ministri111. Il
poteri specifici che però nella situazione italiana non hanno potuto, non possono e, re-bus sic stantibus, non potranno essere esercitati, tutto sommato non per un pervicaceintento di violare la Costituzione, ma per una sorta di impossibilità originaria, in pre-senza di una pluralità dei partiti, della necessità dei governi di coalizione e per il di-fetto di alternanza causato dalla conventio ad excludendum». Si v., però, anche ID., Or-dinamento, cit., pp. 63 ss. Si rinvia, inoltre, alle considerazioni di S. RISTUCCIA, Ammi-nistrare e governare, Roma, Officina edizioni, 1980, pp. 65-66.
109 L. VENTURA, Il Governo, cit., p. 127, d’altronde, appare consapevole del fattoche dal mutare del sistema politico o di quello partitico derivino conseguenze sul ruolodegli organi del Governo. Si v. anche le osservazioni critiche di G. PITRUZZELLA, Artt.92-93, cit., p. 115.
110 In questo senso L. PRETI, Il Governo, cit., p. 179, e G. CUOMO, Unità, cit., pp.17-18 ma anche 91 ss.
111 Si v., ad es., C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., pp. 561 ss., G. RIZZA, Il Pre-sidente, cit., part. pp. 118 ss., ma anche P. BARILE, Corso di diritto costituzionale, 2ª ed.,Padova, Cedam, 1964, p. 131, T. MARTINES, Indirizzo politico, in Enciclopedia del di-ritto, vol. XXI, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 143 e 155-156, e A. PREDIERI, Presidente,cit., pp. 1 ss.
35IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
compito del Presidente del Consiglio di dirigere la politica gene-rale del Governo, assumendone la responsabilità, nonché quellodi promuovere e coordinare l’attività dei ministri al fine di man-tenere l’indirizzo politico ed amministrativo, infatti, pur nonconsentendo di strutturare i rapporti tra gli organi di Governo intermini propriamente gerarchici112, dovrebbero comunque ga-rantire un ruolo di supremazia del Presidente del Consiglio al-l’interno dell’Esecutivo113. Il ruolo prevalente del Presidente delConsiglio, inoltre, si desumerebbe da due ulteriori dati: i mini-stri, infatti, sono nominati dal Presidente della Repubblica, masu proposta del Presidente del Consiglio; gli stessi ministri, inol-tre, sarebbero responsabili nei confronti del Presidente del Con-siglio, tanto che, nell’ipotesi in cui dovesse esserci un contrastotra quest’ultimo e un ministro, il Presidente del Consiglio po-trebbe costringere il ministro stesso alle dimissioni per poi pro-cedere a un rimpasto della compagine ministeriale al fine di so-stituire il ministro dimissionario114.
Occorre osservare, peraltro, che alcuni sostenitori della teo-ria in questione hanno riconosciuto la mancata affermazione delprincipio monocratico nella prassi repubblicana, ma hanno con-siderato tale situazione una alterazione dell’assetto governativodelineato dal costituente115.
4.4. Il Governo come organo complesso
La tesi più diffusa è quella che considera il Governo comeun organo complesso. Secondo tale tesi, il Governo sarebbe un
112 C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., p. 565, e F. CUOCOLO, Il Governo, cit.,p. 216.
113 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., p. 561, G. RIZZA, Il Presidente, cit.,pp. 118 ss., e F. CUOCOLO, Il Governo, cit., pp. 216-217. Si v. anche le osservazioni diT. MARCHI, Il Governo, cit., pp. 133-134.
114 Si v., in questo senso, P. VIRGA, La crisi, cit., pp. 7 ss., e F. CUOCOLO, Il Go-verno, cit., pp. 161 ss.
115 In questo senso C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., pp. 563 ss.; dello stessoA. si v. anche Le forme di governo, Padova, Cedam, 1973, pp. 431-432.
36 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
organo costituzionale complesso, in quanto costituito da più or-gani costituzionali116: il Consiglio dei ministri, il Presidente delConsiglio dei ministri; i ministri117. Questi organi, peraltro, seb-bene costituzionalmente garantiti, sono tra loro differenti, quan-tomeno perché alcuni sono organi individuali (il Presidente delConsiglio e i singoli ministri), l’altro è un organo collegiale (ilConsiglio dei ministri)118. Questa tesi, oltre ad avere un notevolesostegno da parte della dottrina, sembra trovare una confermanella giurisprudenza della Corte costituzionale: secondo la Con-
116 Sulla nozione di organo costituzionale si v. S. ROMANO, Nozione e natura de-gli organi costituzionali e dello Stato [1898], in Scritti minori, vol. I, Milano, Giuffrè,1950, pp. 1 ss., E. CROSA, Gli organi costituzionali e il Presidente della Repubblica nellaCostituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1951, pp. 91 ss., e G.LONG, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, in Enciclopedia giuridica, vol.XXII, Roma, Treccani, 1990, pp. 1 ss., ma anche le osservazioni di C. MORTATI, La co-stituzione, cit., pp. 207-208. Per la discussa configurazione del ministro come organocostituzionale si v. L. ELIA, Problemi costituzionali dell’amministrazione centrale, Mi-lano, Giuffrè, 1966, ora in ID., Studi di diritto costituzionale (1958-1966), Milano, Giuf-frè, 2005, pp. 564 ss., G.F. CIAURRO, Ministro, cit., p. 514, e C. ROMANELLI GRIMALDI,Ministro, cit., pp. 3-4.
117 In questo senso T. MARCHI, Il Governo, cit., p. 127, L. PRETI, Il Governo, cit.,p. 10, P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Governo, in Novissimo digesto italiano, vol. VII, Torino,Utet, 1957, p. 1161, E. CHELI, Consiglio dei ministri, in Enciclopedia forense, vol. II,Milano, Vallardi, 1958, p. 479, M. PASQUINI, Governo, ivi, vol. III, p. 1025, F. CUO-COLO, Il Governo, cit., p. 157; G.F. CIAURRO, Ministro, cit., p. 515; S. LABRIOLA, Il Go-verno della Repubblica. Organi e poteri. Commento alla legge 23 agosto 1988, n. 400,Rimini, Maggioli, 1989, p. 51, V. CARUSI, Art. 92, cit., p. 564, M. CARTABIA, Governo,cit., p. 2828 e A. D’ANDREA, Art. 92, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a curadi), Commentario, vol. II, cit., p. 1779. La definizione di organo complesso è quella ge-neralmente accolta nella manualistica: si v., ex multiplis, P. BARILE, Corso, cit., p. 124,P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Diritto costituzionale, 7ª ed., Napoli, Jovene, 1965, pp. 451 ss.,S. CASSESE, R. PEREZ, Istituzioni di diritto pubblico, Roma, La Nuova Italia Scientifica,1989, p. 184, T. MARTINES, Diritto, cit., p. 412, S. MERLINI, Il Governo, cit., pp. 169 ss.,M. MAZZIOTTI DI CELSO, G.M. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, 3ª ed., Pa-dova, Cedam, 2005, p. 363, C. ROSSANO, Manuale, cit., p. 279, e C. COLAPIETRO, Il Go-verno e la Pubblica Amministrazione, in F. MODUGNO (a cura di), Lineamenti di dirittopubblico, 2ª ed.,Torino, Giappichelli, 2011, p. 365.
118 L. PALADIN, Diritto, cit., p. 405, infatti, parlava più precisamente di «organocomplesso ineguale, poiché le sue componenti non si trovano su un piano di parità, néquanto alla loro struttura, né quanto ai rapporti reciproci, né quanto ai compiti da esseesercitati».
37IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
sulta, infatti, «il Governo non si esaurisce nell’organo collegiale“consiglio dei ministri”, ma è organo complesso»119.
Secondo la tesi in questione, peraltro, gli organi indicati dal-l’art. 92 Cost. rappresenterebbero solo gli organi costituzional-mente “necessari” del Governo, essendo comunque possibileprevedere altri organi del Governo, definiti “non necessari” per-ché non espressamente richiesti dalla Costituzione120. Sarebbedunque possibile istituire altri organi del Governo, diversi daquelli elencati nell’art. 92 Cost., perché non espressamente vie-tati dalla stessa Carta costituzionale e sorti sulla base della prassio in forza di consuetudini, oppure introdotti nell’ordinamentocon disposizioni normative di rango subcostituzionale121.
4.5. Il Governo come sistema ordinato unitariamente
Una specificazione della teoria dell’organo complesso ap-pare quella che definisce il Governo come un sistema ordinatounitariamente. Il Governo, in altri termini, non sarebbe un or-gano composto da altri organi – necessari e non –, bensì un si-stema del quale i singoli organi «sono, tutti, espressione»122. Taleteoria, partendo dal riferimento all’art. 95 Cost., ritiene quindiche il «Governo, (…) pur essendo formato da organi struttural-mente e funzionalmente distinti, alcuni originariamente previstidalla Costituzione ed altri introdotti successivamente, costituisceun’unità politica»123.
119 Così Corte costituzionale, sent. 7/1975, punto 3 del cons. in fatto e in dir.120 In questo senso, ad. es., C. LAVAGNA, Istituzioni, cit., p. 652, P. GIOCOLI
NACCI, Articolazioni interne del Governo. Gli organi non necessari, Torino, Giappi-chelli, 1995, pp. 42-43, e G. FALCON, Lineamenti, cit., p. 227. P. CALANDRA, Il Governo,cit., p. 129, fa riferimento alla distinzione «tra Governo in senso stretto, composto dalConsiglio dei Ministri, dal Presidente e dai ministri e Governo in senso lato compostoda tre organi collegiali (Consiglio dei Ministri, Consiglio di Gabinetto, Comitati inter-ministeriali) e tre individuali (Presidente, ministri, sottosegretari)».
121 In questo senso V. CARUSI, Art. 92, cit., p. 571.122 Così A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, vol. I, 14ª ed., Na-
poli, Jovene, 1984, p. 355.123 Così G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, cit., p. 116. Si v. anche V. ONIDA, Costitu-
zione italiana, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario, vol. II, cit., pp. 1666-1667, se-
38 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
In altre parole, secondo la teoria in esame, la Costituzionenon individuerebbe un unico centro di decisione politica, ma silimiterebbe ad indicare gli organi di Governo necessari e i prin-cipî organizzativi minimi, lasciando alla prassi e alla normativasubcostituzionale la definizione più puntuale della struttura delGoverno e dei rapporti tra i suoi organi. Così intesi, gli assetti or-ganizzativi dell’Esecutivo potrebbero variamente configurarsisulla scorta delle diverse esigenze insorte nella prassi124.
5. Le fonti deputate alla disciplina dell’organizzazione del Go-verno
Dopo aver riassunto le differenti tesi sostenute in relazioneall’organizzazione del Governo, appare necessario verificarequali sono le fonti deputate alla definizione di tale organizza-zione, considerando, da un lato, che la relativa disciplina è det-tata sia da fonti atto sia da fonti fatto; dall’altro, che la tardivaapprovazione della disciplina legislativa prevista dall’ultimocomma dell’art. 95 Cost. ha reso necessario valutare la possibilesopravvivenza della disciplina prerepubblicana in tema di orga-nizzazione dell’Esecutivo.
5.1. La disciplina del periodo prerepubblicano
La tardiva approvazione della legge deputata a provvedereall’ordinamento della Presidenza del Consiglio ha reso necessarioverificare se, ai fini dell’organizzazione del Governo, potesse farsiriferimento alla disciplina approvata in materia in periodo liberalee fascista: in particolare al r.d. 466/1901 e alla l. 2263/1925125.
condo il quale il Governo «è configurato dalla Costituzione allo stesso tempo come or-gano collegiale (il consiglio dei ministri) e come insieme coordinato di organi mono-cratici».
124 Al riguardo si v. G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, cit., pp. 116-117.125 In proposito A. PREDIERI, Presidente, cit., p. 1, parla di «incertezza grandis-
sima sulla vigenza di parti normative precedenti [alla Costituzione]».
39IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La sostituzione della denominazione “Capo del Governo”con quella di “Presidente del Consiglio dei Ministri”126, infatti, èparsa avallare sia la mancata applicazione della l. 2263/1925dopo la caduta del fascismo, sia la possibilità di ritenere ancoraoperante in periodo repubblicano – sino all’approvazione della l.400/1988 – il c.d. decreto Zanardelli, modificato ed integrato invia consuetudinaria127. La l. 2263/1925, infatti, non avrebbeabrogato il r.d. 466/1901 ma solo modificato il quadro norma-tivo nel quale era chiamato ad operare128. Considerando abrogatala l. 2263/1925, dunque, il c.d. decreto Zanardelli avrebbe conti-nuato ad operare, sebbene nel rispetto del nuovo sistema costi-tuzionale129. Anche qualora la normativa prefascista sull’ordina-mento del Governo fosse stata ritenuta abrogata o derogata, oc-corre osservare che – almeno sino all’approvazione della l.400/1988 – in dottrina si è ritenuto di dovervi fare comunque ri-ferimento, perché, in assenza di una nuova disciplina approvatain attuazione dell’ultimo comma dell’art. 95 Cost., tale normativa
126 … ad opera del r.d.l. 136/1944, che, però, manteneva l’attributo di “PrimoMinistro Segretario di Stato”; su questo r.d.l. si v. E. ROTELLI, La Presidenza, cit., pp.413-414.
127 In questo senso P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 2; si v. anche L. PALADIN,Governo, cit., pp. 676-678, F. CUOCOLO, Consiglio dei ministri, in Enciclopedia del di-ritto, vol. IX, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 242 ss., e P. BISCARETTI DI RUFFÌA, Consigliodei ministri, in Novissimo digesto italiano, vol. IV, Torino, Utet, 1957, p. 146. SecondoL. PRETI, Il Governo, cit., p. 20, con «la caduta del regime fascista, ad onta che la leggedel 1925 non sia mai stata esplicitamente abrogata (è stata abrogata con R.D.L. 16maggio 1946 n. 136 solo la denominazione di Capo del Governo), il Primo Ministro èridiventato in pratica Presidente del Consiglio. Con l’entrata in vigore della Costitu-zione la figura giuridica del Premier è stata poi definita di nuovo in armonia con la tra-dizione parlamentare, sì che, almeno per questa parte, la legge del 1925 deve ritenersisicuramente abrogata, in quanto contrastante con lo spirito e con la lettera della Cartacostituzionale».
128 Appare utile rinviare alla agile distinzione tra abrogazione, modificazione ederoga illustrata da F. MODUGNO, Abrogazione, in Enciclopedia giuridica, vol. I, Roma,Treccani, 1988, p. 5.
129 Cfr. ancora P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 2, L. PALADIN, Governo, cit.,part. pp. 676-678, e L. PRETI, Il Governo, cit., p. 22, ma anche F. CUOCOLO, Il Governo,cit., pp. 119-120.
40 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
era considerata l’unica che potesse in qualche modo armoniz-zarsi con la Costituzione, a differenza di quella dettata durante ilregime fascista130.
La necessità di ricorrere al c.d. decreto Zanardelli era con-fermata altresì dalla giurisprudenza della Corte costituzionale,che ha ritenuto applicabili le norme del decreto, ad esempio, ri-guardo agli affari sui quali il Presidente del Consiglio dei ministriritenga opportuna la deliberazione dell’intero Consiglio131.
Pur presupponendo che la normativa precostituzionale inmateria di Governo fosse applicabile anche dopo l’approvazionedella Costituzione, restano i dubbi relativi ai profili di compati-bilità con la Costituzione stessa, nonché i problemi derivantidalla lacunosità della disciplina degli aspetti organizzativi e difunzionamento dell’Esecutivo132. Ciò consente di capire perché,in tema di organizzazione della struttura di governo, abbiano as-sunto grande importanza le consuetudini e le convenzioni133. La
130 Cfr. L. PALADIN, Diritto, cit., p. 380, il quale fa riferimento non solo al r.d.466/1901, ma anche alla l. 5195/1888, al r.d.l. 1100/1924 e alla l. 2263/1925, e G.GUARINO, L’ordinamento della Presidenza del Consiglio, in Rassegna parlamentare,1959, ora in ID., Dalla Costituzione, vol. II, cit., pp. 329-330, che richiama il r.d.466/1901, il r.d. 4936/1887 e il r.d.l. 1100/1924; si v. altresì E. GATTA, Presidenza delConsiglio dei ministri, in Novissimo digesto italiano, vol. XIII, Torino, Utet, 1957, p.730, secondo il quale – prima dell’approvazione della l. 400/1988 – i compiti istituzio-nali della Presidenza del Consiglio dei ministri erano «segnati sostanzialmente» dalc.d. decreto Zanardelli.
Bisogna anche ricordare che parte della dottrina ha ritenuto applicabile – al-meno sino all’approvazione della l. 400/1988 – pure parte della normativa sul Governodettata durante il periodo fascista: L. PRETI, Il Governo, cit., pp. 12 ss., G. RIZZA, IlPresidente, cit., pp. 86 ss., G.F. CIAURRO, Ministro, cit., p. 515, e, sembrerebbe, ancheG. CUOMO, Unità, cit., ad es. pp. 48-49, note 91 e 93.
Infine, è senz’altro utile rinviare ai rilievi di F. SORRENTINO, L’abrogazione nelquadro dell’unità dell’ordinamento giuridico, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,1972, n. 1, part. pp. 16 ss., riguardo alla reviviscenza di norme abrogate, ma anche aS. BARTOLE, Interpretazioni, cit., part., pp. 50 ss., relativamente ai rapporti tra Costitu-zione e legislazione anteriore.
131 Cfr. Corte costituzionale, sent. 7/1975, punto 3 cons. in fatto e in dir.132 Su alcuni di questi dubbi cfr. le osservazioni di A.M. SANDULLI, Il problema
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in Diritto e società, 1980, pp. 618 ss., non-
41IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
comprensione del funzionamento degli organi costituzionali edei loro rapporti, infatti, non trova nel testo della Costituzione lasoluzione di tutti i casi che, di volta in volta, è stato necessario af-frontare. Di conseguenza, è stato inevitabile fare ricorso a regolenon scritte. «Queste regole sono state battezzate nel modo piùdiverso; a volte ad esse è stato attribuito il nomen di consuetu-dine, altre volte quello di convenzione costituzionale»134. Questeultime, però, pongono delicati problemi nell’ordinamento ita-liano. In primo luogo, perché è particolarmente complesso di-stinguere chiaramente tra le diverse fonti fatto e, di conseguenza,capire se un determinato fatto normativo possa essere ricondottoalla fonte consuetudinaria, a quella convenzionale oppure aun’altra fonte fatto (ad esempio, ad una regola di correttezza co-stituzionale)135. In secondo luogo, perché le caratteristiche del-
ché J. BUCCISANO, Premesse per uno studio sul Presidente del Consiglio dei ministri, inRivista trimestrale di diritto pubblico, 1972, pp. 33 ss.
133 Secondo P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 3, infatti, la «proliferazione di re-gole convenzionali, oltre a dimostrare la insufficienza e la lacunosità della normazionein materia, può contribuire a dare indicazioni significative e rilevanti, a prescindere dalloro valore giuridico, sui comportamenti e sui rapporti fra soggetti politici che agi-scono, a diverso titolo, nell’area di governo».
134 Così G. DEMURO, Regole costituzionali non scritte tra diritto e altre scienze,Torino, Giappichelli, 2003, p. 1.
135 Su questi problemi e sulla “indifferenza qualitativa” tra consuetudini e con-venzioni costituzionali si rinvia a F. MODUGNO, Fonti del diritto, in Enciclopedia giuri-dica, vol. XIV, Roma, Treccani, 1989, pp. 10 ss., part. 16-17, e R. GUASTINI, Teoria edogmatica delle fonti, in A. CICU, F. MESSINEO (diretto da), Trattato di diritto civile ecommerciale, continuato da L. MENGONI, vol. I, tomo 1, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 645ss. Si v. anche M.S. GIANNINI, Sulla consuetudine, in Rivista internazionale di filosofiadel diritto, 1947, ora in ID., Scritti, vol. II, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 751-758, G. TRE-VES, Convenzioni costituzionali, in Enciclopedia del diritto, vol. X, Milano, Giuffrè,1962, pp. 524-528, N. BOBBIO, Consuetudine a) Teoria generale, in Enciclopedia del di-ritto, vol. IX, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 426 ss., C. ESPOSITO, Consuetudine (dir. cost.),ivi, pp. 456 ss., C. MORTATI, Costituzione, cit., pp. 197 ss., R. ORESTANO, Dietro la con-suetudine, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1963, n. 3, pp. 521 ss., G.U. RESCI-GNO, Le convenzioni costituzionali, Padova, Cedam, 1972, G. ZAGREBELSKY, Conven-zioni costituzionali, in Enciclopedia giuridica, vol. IX, Roma, Treccani, 1988, pp. 1 ss.,C. ROSSANO, La consuetudine nel diritto costituzionale, Napoli, Jovene, 1992, nonché V.CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, 1, 6ª ed. aggiornata a cura di F. CRI-
42 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
l’ordinamento costituzionale italiano e del relativo sistema poli-tico e partitico non consentono la formazione di conventions ofthe Constitution assimilabili per stabilità e capacità vincolante aquelle proprie dell’esperienza britannica136. Queste caratteristi-che delle fonti fatto inducono a ricorrere a norme scritte anchenella definizione dei profili organizzativi del Governo, sebbene,trattandosi di fonti di rango subcostituzionale, possano essereagevolmente superate o modificate attraverso successivi inter-venti normativi137.
Le difficoltà sin qui emerse in merito all’individuazionedelle fonti che regolano la struttura del Governo consentono di
SAFULLI, Padova, Cedam, 1993, pp. 176 ss., e F. SORRENTINO, Le fonti del diritto ammi-nistrativo, in G. SANTANIELLO (diretto da), Trattato di diritto amministrativo, vol.XXXV, Padova, Cedam, 2004, pp. 19-20 e 271 ss. Si v. anche G.U. RESCIGNO, Ripen-sando le convenzioni costituzionali, in Politica del diritto, 1997, n. 4, pp. 499 ss., e ID.,Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti, in Diritto pubblico, 2002, n. 3,pp. 803-806.
136 Sulla distinzione tra convenzioni come fonti di diritto interno e conventionsbritanniche si rinvia a V. CRISAFULLI, Lezioni, vol. II, 1, cit., pp. 195 ss., G. TREVES,Convenzioni, cit., pp. 526 ss., e R. BIFULCO, Le riflessioni della cultura giuspubblicisticasulle convenzioni costituzionali, in Diritto e società, 1992, pp. 31 ss., part. 44 ss., men-tre per un’opinione che considera le convenzioni come un fenomeno che avrebbe“portata generale” si v. C. MORTATI, La costituzione, cit., pp. 155 ss. Sulle motivazioniche rendono problematico assimilare nell’ordinamento italiano «la categoria delle con-venzioni costituzionali, concettualmente tradotta dal sistema parlamentare inglese», sirinvia a M. CARDUCCI, L’accordo di coalizione, Padova, Cedam, 1989, pp. 37-38. Sulruolo del sistema dei partiti nella definizione di regole convenzionali, invece, si v. L.ELIA, Governo, cit., pp. 638 ss., ma anche, più di recente, R. CHERCHI, Il governo di coa-lizione in ambiente maggioritario, Napoli, Jovene, 2006, part. pp. 76 ss. Sulle conven-tions, infine, si rinvia a A.V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Consti-tution [1885], Indianapolis, Liberty Classics, 1982, part. pp. 277 ss., I. JENNINGS, Ca-binet Government, 2ª ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1951, pp. 1 ss.,D.K. LEWIS, Convention. A Philosophical Study, Oxford, Blackwell, 1969, G. MAR-SHALL, Constitutional Conventions, Oxford, Clarendon Press, 2001, C.R. MUNRO, Stu-dies in Constitutional Law, 2ª ed., London, Butterworths, 2002, part. pp. 55 ss., C.TURPIN, A. TOMKINS, British Government and the Constitution, 6ª ed., Cambridge,Cambridge University Press, 2007, pp. 156 ss.
137 Si v., in proposito, le osservazioni di L. VENTURA, Ordinamento, cit., pp. 59-61, e P.A. CAPOTOSTI, Presidente, cit., pp. 134 ss., nonché quelle di E. ROTELLI, La Pre-sidenza, cit., pp. 452 ss., sulla formalizzazione della figura del Capo del Governo.
43IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
comprendere l’interesse suscitato dalla legge sull’ordinamentodella Presidenza del Consiglio dei ministri138.
5.2. La l. 400/1988
La legge prevista dal co. 3 dell’art. 95 Cost. è stata appro-vata con grave ritardo, nonostante i numerosi progetti di leggeproposti negli anni139, tanto da far ritenere che tale ritardo di-pendesse anche dal timore diffuso tra le forze politiche che lasua approvazione potesse rafforzare il ruolo e i poteri del Presi-dente del Consiglio, sottraendolo alle continue negoziazioni coni partiti cui era costretto140. La definizione e l’organizzazionedella struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio deiministri, infatti, rappresentano elementi utili – se non imprescin-dibili – per il rafforzamento del ruolo del Presidente del Consi-glio, che, attraverso il proprio apparato amministrativo, puòesercitare in maniera più incisiva i poteri assegnatigli dall’art. 95,co. 1, Cost.141. D’altro canto, le incertezze sul ruolo del Presi-dente del Consiglio dei ministri all’interno del Governo si riflet-tono inevitabilmente sulla configurazione della sua Presidenza142.
138 Appare utile rinviare alle osservazioni riportate in M.S. GIANNINI, Rapportosui principali problemi dell’Amministrazione dello Stato, in Rivista trimestrale di dirittopubblico, 1982, part. pp. 748-749.
139 Sui quali si v. G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, cit., pp. 118-119, nt. 9 e 10, e M.P.VIVIANI SCHLEIN, La Presidenza, cit., pp. 2740-2743. Sulla organizzazione della Presi-denza del Consiglio prima del 1988 si v. anche F. SEPE, La struttura amministrativadella Presidenza del Consiglio dei ministri, in Giornale di diritto amministrativo, 1999,n. 4, pp. 389-390.
140 Così S. BARTOLE, Governo, cit., pp. 651-652. In questo senso anche le osser-vazioni di G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, cit., p. 118. Secondo V. PIERGIGLI, L’istituzionedel segretariato generale nella legge di riforma della presidenza del Consiglio dei mini-stri, in Diritto e società, 1989, p. 53, il ritardo (definito dall’A. un «deplorevole com-portamento») sarebbe dovuto a «svariate ragioni di natura politica, burocratica e tec-nica». Secondo M. CAPURSO, È possibile un “Governo del primo ministro” in Italia?, inStudi parlamentari e di politica costituzionale, 1980, n. 49-50, p. 33, invece, si potevaanche correre il rischio di formalizzare nella legge gli aspetti peggiori dell’organizza-zione del Governo.
141 V. PIERGIGLI, L’istituzione, cit., pp. 56 ss.142 Si v., in proposito, C. D’ORTA, La riforma della presidenza del Consiglio, in
44 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
La riserva di legge prevista dalla citata disposizione costitu-zionale, pertanto, è stata concretizzata – almeno in parte143 –dalla l. 400/1988144.
Questa legge detta disposizioni inerenti la potestà normativadel Governo145, l’organizzazione amministrativa della Presidenzadel Consiglio dei ministri146 e il relativo personale147, nonché irapporti tra Stato, Regioni e Province autonome148.
Per quanto riguarda, invece, l’organizzazione dell’Esecutivo,la l. 400/1988 ribadisce che il Governo «è composto del Presi-dente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono
Giornale di diritto amministrativo, 2000, n. 1, p. 5, e A. PAJNO, La presidenza del Con-siglio dei ministri dal vecchio al nuovo ordinamento, in A. PAJNO, L. TORCHIA (a curadi), La riforma del Governo, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 37 e 44 ss.
143 L’art. 95, ult. co., Cost., infatti, prevede una riserva di legge sia per la disci-plina della Presidenza del Consiglio dei ministri sia per determinare il numero, le at-tribuzioni e l’organizzazione dei ministeri (V. CARUSI, Art. 95, cit., p. 600, infatti, parladi «duplice riserva di legge, non già quanto a finalità e natura degli atti (legislativi) pre-visti, ma quanto all’oggetto (e al campo materiale) di intervento, “Presidenza del Con-siglio” in un caso e “Ministeri” nell’altro»); mentre per il primo oggetto della riservaha provveduto la l. 400/1988, per la disciplina dei ministeri è stato necessario atten-dere il d.lgs. 300/1999. Cfr. infra, parte I, cap. I, par. 5.3.
144 Secondo S. LABRIOLA, Il Governo, cit., p. 33, si tratterebbe, per la sua natura,di una legge di attuazione costituzionale; nello stesso senso P.A. CAPOTOSTI, Governo,cit., p. 4, secondo il quale la l. 400/1988 «rappresenta comunque l’attuazione di unprecetto costituzionale»; contra F. BAGNAI, Il consiglio, cit., pp. 228-229. Sulla capacitàdella legge in questione di condizionare la legislazione successiva si v. G. PITRUZZELLA,Artt. 92-93, cit., pp. 120 ss., ma anche le osservazioni di F. MODUGNO, Validità (dir.cost.), in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 67-68; contra E.CATELANI, Art. 95, cit., pp. 1843-1844.
È necessario ricordare, inoltre, che, sulla scorta dell’art. 4 della l. 400/1988, èstato approvato il regolamento interno del Consiglio dei ministri: il d.p.c.m. 10 no-vembre 1993.
145 Capo III, artt. 14-17-bis della l. 400/1988. Si tratta dell’unico Capo dellalegge che non si occupa direttamente di profili organizzativi del Governo: in questosenso G.G. PALEOLOGO, L’attività normativa del Governo nella legge sull’ordinamentodella presidenza sul consiglio dei ministri, in Il Foro italiano, 1989, parte V, col. 344.
146 Capo IV, artt. 18-29 della l. 400/1988.147 Capo V, artt. 31-38 della l. 400/1988.148 Capo II, artt. 12-13 della l. 400/1988.
45IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
insieme il Consiglio dei ministri»149. La legge, poi, determina leattribuzioni sia del Consiglio dei ministri sia del suo Presi-dente150. Pur definendo in maniera più chiara le attribuzioni deidue organi151, la legge del 1988 non sembra stravolgere l’assettoconfiguratosi prima della sua approvazione152 e – soprattutto –pare volta a mantenere la coesistenza tra principio collegiale eprincipio monocratico così come delineato in Costituzione,senza affermare la prevalenza dell’uno o dell’altro153. La l.400/1988, tuttavia, sembra quantomeno rafforzare contestual-mente il ruolo del Consiglio dei ministri e del suo Presidente,
149 Così l’art. 1, co. 1, della l. 400/1988, che richiama quasi pedissequamentel’art. 92, co. 1, Cost.
150 Cfr. gli artt. 2-5 della l. 400/1988.151 In questo senso, sembrerebbe, P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., pp. 3-4.152 Secondo P. CIARLO, La legge sulla presidenza del consiglio e l’evoluzione della
forma di governo, in Il Foro italiano, 1989, col. 312, infatti, la l. 400/1988, «senza inci-dere in profondità sulla disciplina delle relazioni politiche, si limita (…) a razionaliz-zare, nel solco dell’esistente, alcuni aspetti dell’attività di governo e ad organizzare lapresidenza del consiglio». Di «consolidamento dell’esistente» parla M. CARDUCCI, Art.94, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario, vol. II, cit., p.1819. A conferma di ciò, S. BARTOLE, Governo, cit., pp. 652-653, individua numeroseassonanze tra la l. 400/1988 e il r.d. 466/1901. Secondo G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93,cit., p. 122, la l. 400/1988 «ha operato una razionalizzazione delle prassi e delle solu-zioni organizzatorie che si sono affermate nell’esperienza repubblicana, innovando si-gnificativamente rispetto all’ordinamento del Governo delineato dal decreto Zanar-delli». Secondo A. PAJNO, La presidenza, cit., p. 52, la legge in questione costituisceuna fotografia del passato ma anche «un ponte verso il futuro, perché, nel disciplinarela complessa situazione preesistente, ha introdotto notevoli elementi di flessibilità an-che in relazione ai profili riguardanti l’organizzazione ed il personale».
153 In questo senso S. LABRIOLA, Il Governo, cit., pp. 49-50, L. PALADIN, Versouna nuova legge generale sul governo, in Le Regioni, 1987, n. 3, pp. 303 ss., L. ARCI-DIACONO, Relazione generale, in AA.VV., Annuario 2001. Il Governo, Atti del XVI con-vegno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 novembre 2001, Padova, Cedam, 2002, pp. 36-39, A. RUGGERI, Il Governo tra vecchie e nuove regole e regolarità (spunti problematici),in AA.VV., Annuario 2001, cit., pp. 331-332, e E. CATELANI, Art. 95, cit., p. 1844. L.VENTURA, Il Governo, cit., p. 187, invece, parla di «consolidamento formale del princi-pio della collegialità governativa»; in senso analogo A. D’ANDREA, Art. 92, cit., p. 1782.A. PREDIERI, Presidente, cit., p. 7, infine, ritiene che la l. 400/1988 abbia «decisamenterafforzato la posizione» del Presidente del Consiglio.
46 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
tentando di contenere le spinte centrifughe dei singoli ministri el’influenza su questi ultimi dei partiti di riferimento154.
La legge n. 400, inoltre, ha riconosciuto espressamente le nu-merose figure organizzative del Governo diverse da quelle elen-cate dall’art. 92 Cost., ma già sviluppatesi in precedenza: il vicepresidente del Consiglio dei ministri155; i ministri senza portafo-glio156; i ministri ad interim157; i sottosegretari di Stato158; i com-missari straordinari del Governo159; il Consiglio di Gabinetto160; icomitati di ministri e interministeriali istituiti per legge161; nonchéla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni ele Province autonome di Trento e di Bolzano162.
La l. 400/1988, pertanto, fa espresso riferimento a organicollegiali del Governo ulteriori rispetto al Consiglio dei ministri:Consiglio di Gabinetto e comitati di ministri e interministeriali.Per quanto riguarda, in particolare, i comitati interministeriali, lalegge sembra volta a contenere e razionalizzare il sistema dei co-mitati, da un lato, garantendo al Consiglio dei ministri la possibi-lità di determinare un unitario indirizzo del Governo attraverso laprevisione di direttive alle quali gli stessi comitati devono atte-nersi163; dall’altro, attraverso il complessivo riordinamento del si-
154 In questo senso G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, cit., pp. 122, 141 e 176, L. PA-LADIN, Verso, cit., pp. 303 ss., ma anche P. CIARLO, La legge, cit., col. 312, secondo ilquale, però, il disegno di limitare il feudalesimo ministeriale resta incompiuto. Si v. an-che le perplessità di P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 4, e L. VENTURA, Il Governo, cit.,pp. 186 ss. Si rinvia, infine, a S. GAMBINO, La «razionalizzazione» del potere esecutivoin Italia, in Quaderni costituzionali, 1988, n. 3, pp. 554-555, e F. BATTINI, La Presidenzadel Consiglio dei ministri alla vigilia della riforma, in Rivista trimestrale di diritto pub-blico, 1998, n. 1, pp. 207 ss.
155 Art. 8 della l. 400/1988.156 Art. 9, co. 1 e 2, della l. 400/1988.157 Art. 9, co. 4, della l. 400/1988.158 Art. 10 della l. 400/1988.159 Art. 11 della l. 400/1988.160 Art. 6, co. 1 e 2, della l. 400/1988.161 Art. 5, co. 2, lett. h, art. 6, co. 3, e art. 7 della l. 400/1988.162 Art. 12 della l. 400/1988. Sulla Conferenza come organo ausiliario del Go-
verno si v. S. LABRIOLA, Il Governo, cit., pp. 131 ss.163 Art. 6, co. 3, della l. 400/1988.
47IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
stema dei comitati da parte del Governo164. La legge, però, nondetta disposizioni volte a definire il ruolo, la struttura e le fun-zioni di tali organi165.
La l. 400/1988, quindi, offre un riferimento normativo deivari organi “non necessari” del Governo, ma la sua approvazionenon comporta il superamento della prassi nella concreta defini-zione dei moduli organizzativi del Governo. In primo luogo, in-fatti, la legge n. 400 rende facoltativo il ricorso a tali strumentiorganizzativi, rimettendo all’Esecutivo il compito di valutare se,quali e quanti degli organi indicati dalla stessa legge istituire sullascorta delle concrete esigenze di governo166. In secondo luogo,alcune disposizioni della legge in questione sono sufficiente-mente generiche da lasciare all’Esecutivo il compito di definirecompiutamente le funzioni da attribuire all’organo167. Infine, gliorgani indicati dalla l. 400/1988 non rappresentano un numerusclausus, essendo possibile prevedere modalità organizzative ulte-riori, qualora siano considerate necessarie o, comunque, utili dal-l’Esecutivo (si pensi, ad esempio, ai vice ministri168).
In conclusione, si può osservare che la l. 400/1988 non hadettato una disciplina compiuta dell’organizzazione del Go-verno. Essa ha sicuramente ridotto il riferimento a prassi e con-suetudini, e ciò è particolarmente evidente se si considera che di-sciplina anche alcuni profili di organizzazione e funzionamentodegli organi del Governo che atterrebbero alla competenza diquesti ultimi169. Nonostante ciò, non è venuta meno la possibilità
164 Art. 7 della l. 400/1988. Su questi profili, tuttavia, si v. infra, parte II, cap. II,par. 3.
165 Si rinvia, in proposito, infra, parte II, cap. I, parr. 3. ss.166 Si v. le osservazioni di L. ARCIDIACONO, Relazione, cit., p. 39.167 Si pensi, ad es., all’art. 8, co. 1, della l. 400/1988, che attribuisce ai vice pre-
sidenti del Consiglio dei ministri solo la funzione di supplenza del Presidente.168 … che non erano previsti nel testo originale della legge: cfr. l’art. 10, co. 3 e
4, della l. 400/1988, come modificato dall’art. 1 della l. 81/2001.169 Si pensi, ad es., all’art. 4 della l. 400/1988, che detta delle disposizioni in
tema di convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri. Su que-sti profili si v. E. CATELANI, Art. 95, cit., p. 1843, nt. 30.
48 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
– o, forse, la necessità170 – di fare riferimento alle regole conven-zionali nella definizione dei moduli organizzativi dell’Esecutivo.Anche dopo la legge sull’attività di Governo, infatti, l’Esecutivoconserva un discreto margine di autonomia nella definizione de-gli strumenti organizzativi ritenuti più adatti o necessari sullascorta delle concrete esigenze sorte nella prassi o derivanti dal-l’evoluzione del sistema politico e partitico. Consentire al Go-verno di decidere con un certo grado di autonomia quali organinon necessari istituire e quali compiti attribuire ad essi, inoltre,consente all’Esecutivo di manifestare all’esterno – attraverso lasua organizzazione – i rapporti politici che lo caratterizzano171,agevolando il controllo dei cittadini sull’operato del Governo edella coalizione che lo sorregge. A tal riguardo, si consideri, adesempio, il caso dei vice presidenti del Consiglio dei ministri.L’attribuzione di tale incarico ad esponenti di spicco dei mag-giori partiti della coalizione di maggioranza172, infatti, se, da unlato, permette di rispettare gli equilibri interni alla stessa coali-zione, dall’altro consente ai cittadini di percepire in maniera im-mediata quali forze politiche costituiscono l’asse portante dellacoalizione di Governo e, quindi, di far valere la responsabilitàpolitica di tali partiti per l’attività di governo.
5.3. I successivi interventi normativi
Dopo la l. 400/1988, si sono avuti altri interventi normativivolti ad incidere nuovamente sulla Presidenza del Consiglio deiministri, nonché a riformare i ministeri, concretizzando la riservadi legge dettata dall’art. 95, co. 3, Cost. per la parte sulla qualenon era intervenuta la l. 400/1988, ovvero in relazione al nu-mero, alle attribuzioni e all’organizzazione dei ministeri.
170 Si v. infra, parte I, cap. I, par. 6.171 Si v. le osservazioni di L. ARCIDIACONO, Relazione, cit., pp. 39-40.172 Questa sarebbe l’unica spiegazione della nomina di un vice presidente se-
condo C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., p. 574. Nello stesso senso già P. BARILE,Corso, cit., p. 132.
49IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri,il nuovo ordinamento è stato introdotto con il d.lgs. 303/1999.
A differenza della legge del 1988, il d.lgs. 303/1999 sembrasuperare l’idea della coesistenza di principî differenti nella defi-nizione dell’istituzione Governo, tentando di rafforzare il princi-pio monocratico e, quindi, il ruolo del premier come centro eguida dell’Esecutivo173, grazie alla migliore definizione dei com-piti del Presidente del Consiglio174. Tale necessità deriva sicura-mente dalla riforma elettorale del 1993 e dal profondo muta-mento del sistema politico175, ma anche dall’evoluzione del pro-cesso di integrazione comunitaria176 e dal rilievo assunto dalleautonomie locali177. In un contesto simile, infatti, l’Esecutivo –oltre a dover garantire l’unità dell’azione politico-amministrativa
173 In questo senso A. PAJNO, La presidenza, cit., p. 69, e C. D’ORTA, La riforma,cit., p. 8, ma anche O. ROSELLI, La riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri:problematiche inerenti alle fonti del diritto, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatoriosulle fonti 1999, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 49 ss., e G. BERTI, Relazione generale,in AA.VV., Annuario 2001, cit., p. 184. Non ritiene, invece, che il decreto rafforzil’elemento monocratico nell’organizzazione del Governo L. VENTURA, Ordinamento,cit., pp. 66-67.
174 Cfr. gli artt. 2-5 del d.lgs. 303/1999. Il decreto, inoltre, attribuisce alla Presi-denza del Consiglio un compito di supporto del Presidente in merito alle funzioni diindirizzo e coordinamento, mentre gli altri compiti sono trasferiti ad altre amministra-zioni (in primis, ai ministeri). Così facendo, l’apparato amministrativo servente delPresidente del Consiglio si differenzia notevolmente da quello dei ministeri, acqui-sendo caratteristiche più simili a quelle dell’amministrazione di un organo costituzio-nale (anche per l’ampia autonomia organizzativa, contabile e di bilancio che il d.lgs.303/1999 riconosce alla Presidenza del Consiglio dei ministri): cfr., in proposito, C.D’ORTA, La riforma, cit., pp. 14-16, ma anche F. BATTINI, La presidenza del Consiglio: ilmodello organizzativo, in A. PAJNO, L. TORCHIA (a cura di), La riforma, cit., pp. 107 ss.,e B. CIMINO, Gli uffici di diretta collaborazione nella Presidenza del Consiglio dei mini-stri, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, n. 3, p. 679.
175 Si v. infra, parte III, cap. II.176 Si v. la l. 86/1989 (c.d. legge La Pergola) e successive modificazioni (in parti-
colare, la l. 128/1998). La legge La Pergola è stata sostituita dalla l. 11/2005 (c.d. leggeButtiglione).
177 Si v., in particolare, la l. 142/1990, abrogata dal d.lgs. 267/2000, e il d.lgs.112/1998, nonché, per il ruolo assunto dal sistema delle conferenze, il d.p.c.m. 2 luglio1996 e il d.lgs. 281/1997.
50 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
– si trova a dover svolgere un delicato compito di raccordo tradiversi livelli territoriali, che necessita di una adeguata defini-zione del suo indirizzo politico. Di conseguenza, appare inevita-bile rendere maggiormente efficaci le funzioni di indirizzo ecoordinamento ex art. 95, co. 1, Cost., rafforzando il ruolo el’apparato amministrativo di chi è chiamato ad esercitarle: il Pre-sidente del Consiglio dei ministri178.
Il d.lgs. 300/1999179, invece, ha concretizzato la riserva dilegge prevista dall’art. 95, co. 3, Cost., in tema di ministeri. An-che questo decreto sembra muoversi nel senso di un rafforza-mento del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri, so-prattutto in virtù della riduzione del numero di ministeri da essooperata180. Tale riduzione, infatti, in primo luogo, avrebbe do-vuto rendere più coeso l’Esecutivo; in secondo luogo, avrebbedovuto agevolare il raggiungimento di accordi tra i membri delGoverno sull’indirizzo politico da seguire; un numero ridotto diministeri, infine, dovrebbe garantire una più fedele ed efficaceconcretizzazione dell’indirizzo politico. Una organizzazione digoverno più coesa e meno frammentata, quindi, dovrebbe valo-rizzare il ruolo di coordinamento e promozione del Presidentedel Consiglio181.
Nonostante ciò, gli interventi normativi successivi si sonomossi secondo una ratio almeno in parte differente. Infatti, seb-
178 Si v. le osservazioni A. PAJNO, La presidenza, cit., pp. 69 ss., e C. D’ORTA, Lariforma, cit., p. 8. Appare utile un rinvio al d.p.c.m. 1 marzo 2011 (modificato dald.p.c.m. 21 giugno 2012), che riguarda l’ordinamento generale delle strutture dellaPresidenza del Consiglio.
179 Sui profili generali di tale decreto si rinvia a L. TORCHIA, Il nuovo ordina-mento dei ministeri: le disposizioni generali (articoli 1-7), in A. PAJNO, L. TORCHIA (acura di), La riforma, cit., pp. 125 ss., e G. D’AURIA, La nuova geografia dei ministeri, inGiornale di diritto amministrativo, 2000, n. 1, pp. 17 ss. Si v. altresì G. TARLI BARBIERI,Fonti del diritto e riforma dei ministeri, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sullefonti 1999, cit., pp. 69 ss.
180 L’art. 2, co. 1, del d.lgs. 300/1999, nel testo originale, infatti, prevedeva che iministeri fossero dodici.
181 In questo senso L. ARCIDIACONO, Relazione, cit., pp. 55-56.
51IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
bene sia parsa consolidarsi la tendenza a rafforzare il ruolo delPresidente del Consiglio182, è stato nuovamente aumentato il nu-mero di ministeri183 e si è introdotta una nuova figura di organi“non necessari”: i vice ministri184.
6. I principî di organizzazione del Governo tra fonti atto e fontifatto
Nelle pagine che precedono si è osservato che sulle disposi-zioni costituzionali in tema di Governo si sono sviluppate teoriedifferenti, che, di volta in volta, hanno ritenuto prevalente nelladefinizione dei rapporti endogovernativi il principio monocratico,quello collegiale oppure quello della indipendenza ministeriale.Tali teorie, seppure tendenzialmente contrastanti tra loro, nonpossono essere considerate prive di fondamento, perché è senz’al-tro possibile individuare nella storia repubblicana periodi neiquali i rapporti tra gli organi di Governo si sono delineati se-condo ognuno dei principî indicati. Appare innegabile, ad esem-pio, che per molti anni il ruolo dei singoli ministri – consideratialla stregua di delegati dei partiti all’interno del Governo – siastato estremamente rilevante e abbia costretto il Presidente delConsiglio ad un ruolo di mera mediazione tra le diverse forze po-litiche che sostenevano il Governo, giustificando, così, l’idea del
182 Si pensi, ad es., all’attribuzione alla Presidenza del Consiglio di alcune fun-zioni e dotazioni in precedenza di competenza di determinati ministeri (cfr., in parti-colare, art. 1, co. 2, 19, 19-bis e 19-quater, del d.l. 181/2006, convertito, con modifica-zioni, dalla l. 233/2006), oppure alla preminenza del Presidente del Consiglio in me-rito alle attribuzioni dei ministri senza portafoglio (cfr. art. 1, co. 22-ter, del d.l.181/2006). Su questi profili si rinvia infra, parte III, cap. II, par. 2.5.2.
183 Si v. l’art. 1 del d.l. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla l.317/2001, che ha aumentato il numero di ministeri a quattordici, nonché l’art. 1 delpiù volte citato d.l. 181/2006, che ha ulteriormente aumentato il numero di ministeri,portandoli a diciotto. Sulla formazione del Governo Prodi II si v. E. CATELANI, La no-mina del Governo Prodi e le anomalie della procedura, in www.forumcostituzionale.it.
184 Con la già citata l. 81/2001, art. 1, che ha modificato l’art. 10 della l.400/1988. (cfr. supra, parte I, cap. I, par. 5.2.).
52 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
“governo a multipolarità diseguale”. D’altro canto, è evidente chenei Governi guidati da Alcide De Gasperi l’Esecutivo abbia avutouna decisa connotazione monocratica185, dando credito alla teoriadel “governo del Primo ministro”; una tendenza, quest’ultima,che – sebbene in un contesto sociale, politico e culturale ben di-verso – è parsa riproporsi dopo la riforma elettorale del 1993.
Le teorie di cui si discute, dunque, non possono essere rite-nute infondate, perché hanno fornito una lettura corretta dellemodificazioni della struttura del Governo delineatesi nel corsodegli anni. Ciò che deve osservarsi, piuttosto, è che tali rilevantimodificazioni – pur tanto differenti tra loro – sono parse muo-versi sempre nell’ambito della legittimità costituzionale. Le teo-rie che si sono occupate della definizione dei rapporti intrago-vernativi potrebbero essere contestate solo laddove si ritenessedi individuare il modello di Governo di volta in volta ricostruitocome l’unico riconosciuto e voluto dalla Costituzione. Ma ten-tare di individuare nella Carta fondamentale, in particolare nel-l’art. 95 Cost., la prevalenza di un principio organizzativo sull’al-tro appare inutile e fuorviante. Come si è già osservato, la Costi-tuzione non sembra definire in maniera univoca quale principiodebba essere posto a fondamento dell’organizzazione del Go-verno, ma, al contrario, sembra lasciare volutamente dei marginidi elasticità, al fine di consentire la definizione delle modalità or-ganizzative dell’Esecutivo – all’interno dei confini dettati dallastessa Costituzione – sulla base dell’evoluzione delle prassi e deirapporti politici186.
185 Si v., al riguardo, A. AMORTH, Analisi, cit., pp. 626 ss., part. 632-633, L. ELIA,Governo, cit., part. pp. 657 ss., S. RISTUCCIA, Amministrare, cit., p. 65, S. MANGIAMELI,La forma di governo parlamentare, Torino, Giappichelli, 1998, p. 61, e R. CHERCHI, Ilgoverno, cit., p. 359, ma anche i dubbi di E. CATELANI, Art. 95, cit., p. 1841 e nt. 23.
186 Secondo L. ARCIDIACONO, Relazione, cit., pp. 31-32, infatti, «[i]nsistere (…)sulla presunta prevalenza nei rapporti intragovernativi del principio monocratico o diquello della collegialità, attribuendo la scelta alla volontà chiara del costituente, oltreche trascurare la storia della formulazione compromissoria dell’art. 95, significa affe-zionarsi ad una realtà astratta, senza tener conto che in tali rapporti sono immanente-mente presenti le regole della politica, il cui esercizio costituisce metodo di soluzione
53IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
In questo modo si comprende perché al mutare del sistemapolitico e partitico sia conseguita l’affermazione di un determi-nato modello organizzativo piuttosto di un altro. Si tratta, tutta-via, di una prevalenza che – a Costituzione invariata – non puòmai essere considerata definitiva: al mutare delle condizioni che ladeterminano, infatti, potrebbero nuovamente cambiare le regole(o le regolarità)187 che sostengono i rapporti infragovernativi.
delle eventuali divergenze ed intolleranza alla previsione di strumenti giuridici cogenti.L’ordinamento del Governo, da questo punto di vista, è influenzato non solo dal tipodi rapporto tra i partiti della maggioranza e dal grado di tensione in questa presente,ma da una serie di variabili che condizionano lo svolgimento di entrambi i principi sianelle misure che nelle contromisure adottabili dalle parti all’interno del Governo». G.GUARINO, Il Governo, in Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nell’esperienza giu-ridica italiana, Padova, Cedam, 1986, ora in ID., Dalla Costituzione, vol. V, cit., p. 407,osserva: «Il Governo, nella struttura costituzionale complessiva, occupa una situazionepeculiare, che dipende dal fatto che tutte le spinte dinamiche che si determinano nel-l’ordinamento finiscono per gravitare sul Governo. Il Governo è il nodo nel qualetutte le strade vanno qui concepite non come qualche cosa di rigido, di chiaramentedelineato, ma come traffico che spinge, si intasa e che, accavallandosi, fa pressione sulGoverno. Tutto ciò determina come conseguenza che anche i divari teorici, che ab-biano per oggetto il Governo, assumono una maggiore ampiezza. Il Governo è un cen-tro nel quale confluiscono, contrastandosi, tutte le spinte dinamiche del sistema. Imodi di interpretare questi fenomeni e di prendere posizione nella valutazione del-l’una o dell’altra spinta si riflettono sulle teorie, divaricandole». Nello stesso senso, se-condo G. PITRUZZELLA, Il Consiglio di gabinetto nel Governo italiano, in Rivista trime-strale di diritto pubblico, 1985, p. 647, «i rapporti endogovernativi non costituisconouna realtà statica e bloccata». S. CASSESE, Esiste un governo in Italia?, Roma, Officinaedizioni, 1980, p. 50, osserva che quello italiano è «un sistema di governo scritto sul-l’acqua, estremamente mutevole. È forse proprio questa la sua forza principale (…)».Si rinvia, infine, a V. CARUSI, Art. 94, cit., p. 566, secondo il quale vi sarebbe uno scartotra il modello accolto in Costituzione e il modello reale, «in quanto l’esperienza re-pubblicana evidenzia alterazioni, strutturali e funzionali, rispetto alle prescrizioni co-stituzionali sul Governo, riconducibili a cause insieme politiche e tecniche». Più in ge-nerale, sulla considerazione che i rapporti tra i diversi organi di governo siano condi-zionati sia dal prodursi di convenzioni sia da fattori di natura sociologica, si rinvia a M.DOGLIANI, Spunti metodologici per un’indagine sulle forme di governo, in Giurispru-denza costituzionale, 1973, pp. 214 ss., part. 232.
187 Appare senz’altro opportuno richiamare in questa sede la differenza tra “re-gole” e “regolarità”, sulla quale M. DOGLIANI, Indirizzo politico, Napoli, Jovene, 1985,G.U. RESCIGNO, Ripensando, cit., part. pp. 502 ss., e A. RUGGERI, Il Governo, cit., pp.318 ss. Si rinvia anche a M. CARDUCCI, L’accordo, cit., pp. 23 ss.
54 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
D’altro canto, gli interventi normativi di rango subcostitu-zionale non sembrano capaci di determinare una volta per tutteil modello organizzativo di Governo da seguire188, sebbene per-mettano di fissare comunque dei limiti al ricorso alle regole con-venzionali.
In primo luogo, infatti, tali interventi sembrano volti a rece-pire sul piano normativo modificazioni che si sono già sviluppatesul piano della prassi: si pensi, ad esempio, alla l. 400/1988, chenon assume una chiara posizione sulla prevalenza del principiomonocratico o di quello collegiale; oppure si consideri che i de-creti legislativi 300/1999 e 303/1999, che sembrano volti a favo-rire la primazia del Presidente del Consiglio dei ministri, giun-gono dopo la riforma elettorale maggioritaria; o, ancora, chel’aumento del numero di ministeri giunge dopo una nuovariforma elettorale e, comunque, quando più forte sembra l’insof-ferenza dei partiti al sistema maggioritario (si pensi, in partico-lare, al già citato d.l. 181/2006)189.
In secondo luogo, le disposizioni dettate da fonti di rangosubcostituzionale possono essere superate abbastanza agevol-mente con interventi normativi successivi: si consideri, in propo-sito, l’ampio ricorso alla delegazione legislativa190 e ai decretilegge191 nel dettare la disciplina dei ministeri.
Infine, tali fonti non definiscono in maniera stringente le re-gole di organizzazione dell’Esecutivo, né quelle che riguardano irapporti tra le componenti del Governo. È inevitabile, infatti,che, pur limitando l’autonomia organizzativa dell’Esecutivo, talifonti debbano comunque consentire al Governo di definire irapporti tra i suoi organi e la sua struttura in maniera adeguataalla necessità di concretizzare il proprio programma.
188 Secondo L. VENTURA, Ordinamento, cit., p. 68, anzi, «le esigenze politiche nontrovano efficiente argine in predisposizioni normative, seppur di tipo organizzatorio».
189 Si v. anche infra, parte III, cap. II.190 Ad es. il più volte citato d.lgs. 303/1999, ma anche i numerosi decreti legi-
slativi emanati in attuazione della l. 137/2002.191 Si pensi ai già citati decreti legge 217/2001 e 181/2006.
55IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Da quanto sopra affermato, appare dunque avvalorata l’opi-nione che il Governo possa determinare il suo funzionamento ela sua organizzazione sulla base dei principî di elasticità e di au-torganizzazione192. In altri termini, il Governo avrebbe la possi-bilità di determinare autonomamente – entro i limiti dettati dallaCostituzione – sia la sua struttura organizzativa, creando o sop-primendo organi “non necessari” sulla base delle esigenze in-sorte nella prassi, sia i rapporti tra i suoi organi, anche tra quellicostituzionalmente necessari.
Indipendentemente dal (discusso) riferimento a tali principî,occorre comunque riconoscere che il Governo è «un istituto che– ‘naturalmente’ – mal sopporta una precisa codificazione che neirrigidisca gli spontanei processi evolutivi e ne ritardi il corso, in-fluendo negativamente sulla sua funzionalità»193. Appare ovvio,quindi, che la Costituzione abbia dettato una disciplina elastica efluida, lasciando dei margini di adeguamento della struttura del-l’Esecutivo sulla scorta delle dinamiche politiche sviluppatesi trai soggetti istituzionali, purché tale adeguamento si compia all’in-terno dei limiti dettati dalla stessa Costituzione e in armonia conil sistema nel quale opera. Come si è già osservato, inoltre, inquest’ottica neppure gli interventi normativi successivi possonoirrigidire eccessivamente la capacità di adattamento dell’organo,perché è sempre possibile approvare ulteriori disposizioni di te-nore differente194.
192 Si v. G. QUADRI, I comitati di ministri [1965], Milano, Giuffrè, 1997, pp. 26ss., ID., Gabinetto economico (C.I.P.E.) e indirizzo politico economico, Milano, Giuffrè,1970, pp. 8 ss., 79, nt. 2, P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., pp. 7-8, V. ONIDA, A. D’AN-DREA, G. GUIGLIA, L’ordinamento costituzionale italiano, Torino, Utet, 1990, p. 272, eG.U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, 7ª ed., Bologna, Zanichelli, 2001, p. 405, che,però, manifesta delle perplessità proprio con riferimento ai comitati interministeriali.
193 Così P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 15. Più in generale, sull’impossibilitàdi configurare uno Stato all’interno del quale «le Gouvernement n’agirait que d’aprèsles prescriptions légales», si v. G. JELLINEK, L’État moderne et son droit [1913], parte II,Paris, L.G.D.J. Diffuseur, 2005, pp. 327 ss.
194 Secondo A. PREDIERI, Presidente, cit., p. 2, infatti, gli esami sulle prassi ine-renti l’Esecutivo «hanno messo in evidenza comportamenti degli operatori costituzio-
56 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
Da ciò consegue anche che l’art. 92 Cost. non risulta volto afornire l’elenco degli unici organi che devono comporre il Go-verno, bensì ad indicare quali organi devono necessariamentecomporlo, senza precludere la possibilità che il Governo si arti-coli ulteriormente sulla scorta delle esigenze sorte nella prassi195.Gli organi non necessari del Governo, infatti, pur non previstidalla Costituzione si sono comunque sviluppati ed affermati nel-l’esperienza istituzionale italiana, sino ad essere espressamenteprevisti dalla l. 400/1988. Anche per tali organi, peraltro, le pre-visioni legislative non sembrano definire in maniera compiuta larelativa disciplina.
Come si è già visto, infatti, tali disposizioni, innanzitutto,non obbligano il Governo a costituire tutti gli organi “non ne-cessari” previsti dalla legge, ma lasciano all’Esecutivo il compitodi valutare quali organi sia necessario od opportuno istituire. Insecondo luogo, la loro disciplina è sufficientemente duttile daconsentire una differente definizione delle loro modalità organiz-zative (in ordine al numero di organi, alla loro composizione ealle loro attribuzioni), sulla scorta di scelte politiche del Go-verno. La previsione legislativa di un certo tipo di organi “non
nali assai diversi, mutamenti di procedimenti, una serie di “anomalie” così cospicua dafar pensare che l’atipicità sia la regola comunque da confermare e che il modello siaestremamente elastico, con norme che sono, anche dopo il mutamento apportato dallal. 23 agosto 1988, n. 400, (…) un canovaccio in cui gli attori recitano a soggetto». Sirinvia anche a G. ZAGREBELSKY, La formazione del Governo nelle prime quattro legisla-ture repubblicane, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1968, pp. 805 ss.
195 Secondo P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 1, dunque, «si può affermare cheil Governo risulta composto, in Italia, non soltanto dagli organi necessari previsti dal-l’art. 92 Cost., ma anche dagli altri, per così dire, facoltativi, a carattere individuale ocollegiale, i quali (…) costituiscono una sorta di articolazione interna dell’istituzioneGoverno». P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 20, invece, osserva che la presenza di taliorgani, «esorbitando dalla previsione costituzionale, sarà praeter constitutionem (nongarantita costituzionalmente, quindi, com’è invece quella degli organi individuati dal-l’art. 92 Cost.) ma non contra constitutionem». Si rinvia, infine, a F. MODUGNO, Costi-tuzione I) Teoria generale, in Enciclopedia giuridica, vol. X, Roma, Treccani, 1988, p. 3,secondo il quale alcuni organi “non necessari” del Governo, quali i vice presidenti delConsiglio, i sottosegretari di Stato e i comitati di ministri, rappresenterebbero esempidi integrazioni convenzionali e consuetudinarie della Costituzione formale.
57IL GOVERNO E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
necessari”, inoltre, non esclude che possano istituirsi anche or-gani ulteriori (è quanto accaduto, ad esempio, per i vice ministrio per il portavoce del Presidente del Consiglio).
Le peculiarità degli organi “non necessari” del Governo sinqui descritte si attagliano anche ai comitati interministeriali, cheappaiono capaci di adeguare il loro ruolo all’interno dell’Esecu-tivo alle dinamiche dei rapporti endogovernativi196.
196 Come si cercherà di verificare in particolare infra, parte III, cap. II, par. 2.7.
58 PARTE PRIMA - CAPITOLO PRIMO
CAPITOLO PRIMO
I COMITATI INTERMINISTERIALI: PROFILI ISTITUZIONALI
E CENNI DI COMPARAZIONE
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’inquadramento costituzionale dei comitati intermi-nisteriali: le diverse ipotesi formulate dalla dottrina. – 2.1. I comitati inter-ministeriali come organi che rappresentano i ministri: organi collegiali am-ministrativi. – 2.2. Il principio del decentramento funzionale: i comitati in-terministeriali e l’art. 5 Cost. – 2.3. I comitati interministeriali e lecommissioni parlamentari. – 2.4. I comitati interministeriali come organi au-siliari del Presidente del Consiglio. – 2.5. I comitati interministeriali comecomitati di ministri. – 2.6. I comitati interministeriali come organi costitu-zionali. – 2.7. I comitati interministeriali come sedi della istituzionalizza-zione del c.d. concerto. – 2.8. I comitati interministeriali e le conferenze diservizi. – 2.9. I comitati interministeriali come forma di adeguamento dellastruttura del Governo. – 3. Il ruolo dei comitati interministeriali nell’inter-pretazione della dottrina. – 4. Classificazione dei comitati interministeriali. –5. L’organizzazione interna dei comitati interministeriali: composizione efunzionamento. – 6. L’attività e gli atti dei comitati interministeriali. – 7. Laresponsabilità politica per gli atti dei comitati interministeriali. – 8. L’inci-denza dei comitati interministeriali sui rapporti endogovernativi. – 9. Cennidi comparazione: l’utilizzo di comitati ristretti come modello diffuso di arti-colazione della struttura del Governo. – 9.1. Il modello paradigmatico: ilCabinet system britannico.
1. Premessa
Dopo aver analizzato la struttura del Governo, occorre esa-minare nel dettaglio quella particolare tipologia di organi “nonnecessari” dell’Esecutivo definita comitati interministeriali o di
ministri, prendendo in considerazione i relativi profili istituzio-nali, organizzativi e di funzionamento.
Ai fini dell’analisi che si sta sviluppando, inoltre, è necessa-rio svolgere alcune osservazioni in prospettiva comparata, soffer-mandosi con particolare attenzione sull’esperienza dei Cabinetcommittees britannici, che appare capace di offrire delle chiavi dilettura utili anche per la comprensione del sistema italiano deicomitati, nonché, più in generale, delle motivazioni che indu-cono ad utilizzare collegi ristretti di governo.
2. L’inquadramento costituzionale dei comitati interministeriali:le diverse ipotesi formulate dalla dottrina
Per valutare la legittimità costituzionale dei comitati inter-ministeriali occorre considerare due profili: il primo attiene allacompatibilità di tali organi con l’art. 92 Cost.; il secondo ri-guarda la loro partecipazione alla determinazione dell’indirizzopolitico del Governo.
In merito alla prima questione, si è già cercato di chiarire1
che l’art. 92 Cost. non detta l’elenco degli unici organi di cui sicompone il Governo, bensì solo quello degli organi necessari, la-sciando all’Esecutivo il compito di valutare la necessità o l’op-portunità di istituire organi ulteriori e di determinarne numero,struttura e compiti. Da questo punto di vista, i comitati intermi-nisteriali non dovrebbero sollevare particolari problemi: si tratte-rebbe di organi “non necessari” del Governo, che possono es-sere istituiti senza che siano stabiliti previamente e in via gene-rale limiti relativi alla fonte che li istituisce (si consideri, adesempio, che alcuni comitati sono istituiti per legge, mentre altricon d.p.c.m.), al loro numero, agli ambiti di competenza (l’espe-rienza dei comitati economici è stata certamente quella più rile-vante, ma i comitati interministeriali si sono occupati – e si oc-cupano – anche di sicurezza, integrazione comunitaria, qualità
1 Si v. supra, parte I, cap. I.
62 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
della regolazione, ecc.), alla loro composizione e al loro funzio-namento2.
Ben più complessa – e discussa –, invece, è la questione ine-rente il ruolo dei comitati interministeriali nella funzione di indi-rizzo politico. Per valutare il coinvolgimento di tali organi nellafunzione in questione, infatti, occorre ripercorrere le teorie chehanno tentato di ricostruire il ruolo dei comitati interministeriali.È opportuno premettere sin d’ora, tuttavia, che tali teorie, da unlato, sono state formulate con riferimento a un determinato mo-mento storico e, dunque, non tengono conto dell’evoluzione suc-cessiva di tali organi; dall’altro, che esse derivano – a volte, quan-tomeno – dall’analisi di un singolo e specifico comitato intermi-nisteriale e, quindi, si può dubitare della possibilità di estenderleall’intero sistema dei comitati, anche perché tale sistema si è svi-luppato in maniera tutt’altro che lineare, attraverso la costitu-zione di comitati con caratteristiche anche molto differenti traloro. Nonostante ciò, l’excursus delle teorie sviluppatesi in temadi comitati interministeriali appare utile per ricostruire l’evolu-zione di tali organi in merito al loro coinvolgimento nell’azionedi governo e può anche consentire di individuarne i tratti co-muni ed indefettibili.
2.1. I comitati interministeriali come organi che rappresentano iministri: organi collegiali amministrativi
Una prima teoria è quella – elaborata da Massimo SeveroGiannini – che considera i comitati interministeriali alla streguadi organi collegiali amministrativi3.
Questa teoria – sviluppata con espresso riferimento al CICR
– ritiene che il comitato interministeriale non sia un organo diorgani, bensì un organo di rappresentatività, nel quale «i ministri
2 Per una rassegna dei numerosi comitati interministeriali istituiti in Italia si v. in-fra, parte II, cap. II.
3 Il riferimento è a M.S. GIANNINI, Istituti di credito e servizi di interesse pubblico,in Moneta e credito, 1949, ora in ID., Scritti, vol. III, cit., 2003, pp. 59 ss.
63I COMITATI INTERMINISTERIALI
componenti siedono come uffici amministrativi, non già costitu-zionali». Di conseguenza, non vi sarebbe responsabilità politicadel comitato di fronte al Parlamento, perché responsabile poli-tico sarebbe solo il ministro del tesoro, che conserverebbe «laduplice veste di ufficio amministrativo e di ufficio costituzio-nale»4. Secondo questa teoria, dunque, il CICR non rientrerebbenella struttura del Governo nel senso sin qui considerato, ma do-vrebbe essere configurato alla stregua di un organo collegialeamministrativo, privo di qualunque rilievo costituzionale5.
Occorre osservare, tuttavia, che lo stesso Giannini chiarisceche l’ambito preso in esame è solamente quello del CICR, senzaescludere che altri comitati di ministri possano essere consideraticome organi costituzionali o costituzionalmente rilevanti6.
Peraltro, non pare condivisibile la radicale differenziazionetra il ruolo del ministro del tesoro e quello degli altri ministri chefanno parte del CICR: lo stesso Giannini, infatti, afferma che ilcompito di determinare l’indirizzo politico dell’ordinamentobancario non spetta al ministro, bensì all’intero comitato7. Ma,così ragionando, si riconosce che il ruolo del ministro del tesoronon può essere nettamente differenziato da quello degli altri mi-nistri che compongono il comitato, perché tutti concorrono alladefinizione dell’indirizzo politico. Inoltre, si afferma chiaramente
4 M.S. GIANNINI, Istituti, cit., p. 69, ma anche F. MERUSI, Le direttive governativenei confronti degli enti di gestione, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 95 ss., che fa riferimentoin particolare al CIP. Sulle ragioni che avrebbero indotto Giannini ad affermare la re-sponsabilità politica del solo ministro presidente del comitato si v. V. BACHELET, Comi-tati, cit., p. 770, e A. MATTIONI, Comitati interministeriali, in Enciclopedia giuridica, vol.VI, Roma, Treccani, 1998, p. 5.
5 V. BACHELET, Comitati, cit., p. 770.6 Secondo M.S. GIANNINI, Istituti, cit., p. 69, infatti, «il Comitato interministeriale
del credito non è pertanto un organo costituzionale, né costituzionalmente rilevante: eciò a differenza di altri Comitati di Ministri, temporanei (…), o permanenti (…)».
7 M.S. GIANNINI, Istituti, cit., pp. 68-69. Si v. anche le osservazioni di V. BACHE-LET, L’attività di coordinamento nell’amministrazione pubblica dell’economia, Milano,Giuffrè, 1957, ora in ID., Scritti giuridici, vol. III, Milano, Giuffrè, 1981, p. 134, nt.118, e P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 100-101.
64 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
che il comitato partecipa alla funzione di indirizzo politico,escludendo che il CICR possa essere considerato un mero organocollegiale amministrativo. Si riconosce, al contrario, che essorientra nella struttura del Governo, proprio in quanto partecipedella funzione di indirizzo politico.
Questa considerazione comporta un ulteriore corollario. Sela funzione di indirizzo è esercitata dall’intero comitato e nonsolo dal ministro che lo presiede, la responsabilità politica dellescelte dell’organo non potrebbe essere imputata al singolo mini-stro, bensì all’intero comitato8 o, comunque, a tutti i ministri chene fanno parte, seppure singolarmente considerati.
2.2. Il principio del decentramento funzionale: i comitati intermi-nisteriali e l’art. 5 Cost.
Una ulteriore tesi ricollega la nascita dei comitati intermini-steriali all’art. 5 Cost.9.
Secondo tale tesi, sebbene nella Costituzione manchi unesplicito riferimento ai comitati interministeriali, tali organi tro-verebbero il loro fondamento nel principio del decentramentofunzionale derivante dall’art. 5 Cost.10, il quale esigerebbe l’isti-tuzione di organi ad hoc per ogni speciale attività dello Stato11. Icomitati interministeriali, di conseguenza, rientrerebbero tra gliorgani che consentono l’adeguamento dell’apparato organizza-tivo alle esigenze funzionali dello Stato contemporaneo, tanto da
8 In questo senso P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 100-101.9 Il riferimento è a V. SICA, Comitati governativi, gestioni autonome e personalità
giuridica, in Rassegna di diritto pubblico, 1956, pp. 152-154, e ID., Le associazioni nellaCostituzione italiana, Napoli, Jovene, 1957, p. 14, nt. 20.
10 Sul collegamento tra il principio del decentramento funzionale e l’art. 5 Cost.si v. C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Co-stituzione, in ID., La Costituzione, cit., pp. 84-85, nonché R. BIFULCO, Art. 5, in R. BI-FULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario, vol. I, cit., pp. 147-148 ent. 123.
11 In questo senso C. ESPOSITO, Autonomie, cit., pp. 84-85.
65I COMITATI INTERMINISTERIALI
essere diffusi in numerosi ordinamenti «in una gamma di figureed attività diverse»12.
Questa tesi ha dato luogo a considerazioni profondamentedifferenti. Secondo parte della dottrina, infatti, la tesi, nata conriferimento ad un comitato “amministrativo”13, non si preste-rebbe a dettare indicazioni atte ad essere estese ai comitati chefanno parte della struttura del Governo, perché riferibili solo aicomitati che rappresentano degli organi collegiali amministra-tivi14. Secondo altra dottrina, invece, la tesi che ricollega i comi-tati interministeriali all’art. 5 Cost., richiamando i principî diauto-organizzazione e decentramento dell’Esecutivo, indurrebbealla considerazione che i comitati interministeriali servano a con-sentire l’adeguamento della struttura del Governo alle mutateesigenze insorte nella prassi, con la conseguente attribuzione atali organi della funzione di attuazione dell’indirizzo politico15.
2.3. I comitati interministeriali e le commissioni parlamentari
I comitati interministeriali sono stati anche accostati allecommissioni parlamentari16.
Secondo tale tesi, i comitati con funzioni meramente prepa-ratorie o istruttorie sarebbero paragonabili alle commissioni par-lamentari in sede referente, mentre gli altri comitati potrebbero
12 Cfr. V. SICA, Comitati, cit., pp. 152-154, e ID., Le associazioni, cit., p. 14, nt. 20.13 … si trattava del Comitato di attuazione di un piano per incrementare l’occu-
pazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori, previsto dalla l.43/1949.
14 In questo senso le osservazioni critiche di P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp.103-104.
15 In questo senso A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 7; si v. anche infra, parte II,cap. I, par. 2.9.
16 Si v. F. MERUSI, Le direttive, cit., pp. 103-104, e, già prima, G. GUARINO, L’or-ganizzazione del Governo e i Comitati interministeriali, resoconto ciclostilato a curadella segreteria del Centro di preparazione politico-amministrativa, Roma, 1954, citatoda V. BACHELET, Comitati, cit., p. 769, e P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 104, nt. 36.È opportuno rinviare anche a L. ELIA, Commissioni parlamentari, in Enciclopedia deldiritto, vol. VII, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 895 ss.
66 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
essere accomunati alle commissioni in sede deliberante17, sebbenesolo le commissioni parlamentari trovino il loro fondamentoespressamente in Costituzione (in particolare, nell’art. 72 Cost.).
Pur con tale fondamentale differenza, vi sarebbero delleanalogie che riguarderebbero essenzialmente i rapporti tra l’or-gano maggiore e quello minore: il primo organo sarebbe semprelibero di deliberare su una questione rientrante nelle competenzedell’altro; inoltre, l’organo minore potrebbe sempre rimettereuna questione di sua competenza all’organo che lo ricomprende.Nel caso specifico dei comitati interministeriali, un ministro dis-senziente potrebbe chiedere che la questione venga rimessa alConsiglio dei ministri, prima, però, che intervenga la delibera-zione formale del comitato, perché quest’ultima sarebbe vinco-lante per tutti i componenti del comitato18.
Tale tesi, tuttavia, è stata criticata sia in considerazione delladiversa composizione degli organi posti a confronto, sia per leloro competenze. Dal primo punto di vista, si è osservato che,mentre le commissioni parlamentari sono composte in manierada rappresentare proporzionalmente tutte le forze politiche pre-senti in Parlamento, nei comitati interministeriali non solo sonorappresentati esclusivamente i partiti di maggioranza ma, in casodi governi di coalizione, i singoli comitati potrebbero esserecomposti in maniera tale da rappresentare solo una parte dellacoalizione19. Per quanto attiene alle competenze, invece, si è os-servato che i comitati interministeriali istituiti con legge avreb-bero una competenza propria, non avocabile dal Consiglio deiministri, o, quantomeno, una competenza propria di un singoloministro e non dell’intero Consiglio dei ministri20.
17 La tesi è riportata da F. MERUSI, Le direttive, cit., p. 104, nonché V. BACHELET,Comitati, cit., p. 769, e P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 104, nt. 36.
18 Così F. MERUSI, Le direttive, cit., pp. 104 ss.19 In questo senso V. BACHELET, Comitati, cit., p. 770, F. ORFINO, I comitati in-
terministeriali, in La Funzione Amministrativa, 1965, n. 1, pp. 29-30, ma anche F. ME-RUSI, Le direttive, cit., pp. 104 ss.
20 V. BACHELET, Comitati, cit., pp. 769-770, e F. ORFINO, I comitati, cit., p. 29.
67I COMITATI INTERMINISTERIALI
2.4. I comitati interministeriali come organi ausiliari del Presi-dente del Consiglio
È opportuno, poi, dar conto della tesi che, sulla scorta del-l’esperienza britannica dei Cabinet committees21, considera i co-mitati interministeriali alla stregua di organi ausiliari del Presi-dente del Consiglio dei ministri22.
Secondo tale tesi i comitati in questione sarebbero deputatia svolgere la funzione di direzione e di coordinamento dell’atti-vità del Governo, in sostituzione o sotto l’immediato controllodello stesso Presidente del Consiglio, svolgendo un ruolo di au-silio nei confronti di quest’ultimo23.
Questa teoria, tuttavia, sembra cogliere il concreto atteg-giarsi dei comitati interministeriali solo in talune fasi storiche, manon pare valida in senso assoluto, perché tali organi hanno as-sunto ruoli diversi nel tempo a seconda del concreto delinearsidei rapporti infragovernativi.
2.5. I comitati interministeriali come comitati di ministri
Una ulteriore teoria considera i comitati interministerialicome organi composti da ministri24.
Secondo tale teoria, i comitati interministeriali sarebberocomposti da soggetti che – anche come membri dell’organo –mantengono la posizione giuridica di ministri, sia in ordine alleloro funzioni sia per quanto attiene alla loro responsabilità po-litica25.
21 Sulla quale si v. infra, parte II, cap. I, par. 9.1.22 Si v., in proposito, G. QUADRI, I comitati, cit., p. 5 e nt. 7, che richiama anche
G. TREVES, I comitati, cit., p. 223.23 Cfr. ancora G. QUADRI, I comitati, cit., p. 5.24 Le tesi è stata sostenuta da G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, 11ª
ed., Milano, Giuffrè, 1976, p. 309, e ripresa da P. GIOCOLI NACCI, Articolazioni, cit., p.37, e ID., Comitati di ministri e comitati interministeriali, in P. GIOCOLI NACCI, A. LOIO-DICE, Studi di diritto costituzionale, Bari, Cacucci, 1995, pp. 129-130.
25 G. BALLADORE PALLIERI, Diritto, cit., p. 309, F. ORFINO, I comitati, cit., p. 31,A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 4, e P. GIOCOLI NACCI, Articolazioni, cit., p. 37.
68 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
Così intesi, i comitati interministeriali rientrerebbero nel-l’organizzazione costituzionale del Governo: in primo luogo,perché composti di organi del Governo che – anche come mem-bri del comitato – continuano a svolgere le funzioni loro attri-buite normalmente come ministri; in secondo luogo, perché i co-mitati così composti parteciperebbero alla funzione di indirizzopolitico, in quanto organi chiamati a dare attuazione all’indirizzopolitico governativo26.
Occorre osservare, tuttavia, che i comitati interministerialipossono esercitare funzioni ulteriori rispetto a quelle proprie deisingoli ministri che li compongono, determinando, addirittura,«direttive politiche generali capaci di dare fondamento alle spe-cifiche attività amministrative dei singoli ministri»27; ciò pare deltutto incompatibile con la configurazione di tali organi semplice-mente come una sorta di riunione di singoli ministri.
2.6. I comitati interministeriali come organi costituzionali
Secondo un’altra teoria, i comitati interministeriali dovreb-bero essere considerati come organi costituzionali.
Così considerati, i comitati interministeriali non sarebberodelle articolazioni interne del Consiglio dei ministri, bensì «or-gani differenziati d’indirizzo settoriale, dotati cioè di particolaripoteri di direttiva ad efficacia esterna ed a contenuto politico»28.Poiché partecipano alla funzione di indirizzo politico, tali organidovrebbero essere considerati organi costituzionali, a differenzadei singoli ministri, che, quando non siedono in Consiglio dei
26 G. BALLADORE PALLIERI, Diritto, cit. p. 309, A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 4.27 Così A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 4. Si pensi, ad es., al CIP, che, come osser-
vava L. PALADIN, Diritto, cit., p. 429, era «chiamato ad esercitare collegialmente fun-zioni che in precedenza non spettavano ad alcun ministro, emanando provvedimentiamministrativi generali che si imponevano direttamente a tutti gli operatori economicidei settori così disciplinati».
28 Così E. CHELI, Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale, in StudiEconomico-Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, Padova,Cedam, 1966, p. 203.
69I COMITATI INTERMINISTERIALI
ministri, operano esclusivamente come organi di vertice di unaparticolare branca dell’amministrazione statuale, esercitando po-teri che, nella loro struttura, non si caratterizzano per una naturapolitica, bensì discrezionale e che, di conseguenza, «non sem-brano ricondursi tanto alla funzione d’indirizzo politico, quantoalla funzione d’indirizzo amministrativo»29.
Occorre osservare, tuttavia, che non appare da condividerel’idea di considerare i comitati interministeriali alla stregua di or-gani costituzionali, escludendo da tale categoria i ministri: nonsembra infatti che i poteri attribuiti ai due organi siano tali dagiustificare una simile differenziazione30. Inoltre, l’attribuzionedella qualificazione di costituzionale ad un organo non previstodalla Carta fondamentale e non necessario, che – di conseguenza– potrebbe anche non essere istituito, lascia quantomeno per-plessi31.
2.7. I comitati interministeriali come sedi della istituzionalizza-zione del c.d. concerto
Una ulteriore teoria considera i comitati interministerialicome la istituzionalizzazione del concerto fra ministri32.
Secondo tale teoria, poiché per l’assunzione di determinatiprovvedimenti è necessario un accordo tra più ministri (il c.d.
29 Cfr. ancora E. CHELI, Organi, cit., pp. 203-204.30 Così P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 109-110. Si può osservare, inoltre, che
secondo G.U. RESCIGNO, Corso, cit., pp. 404-405, i comitati interministeriali sono verie propri organi di Governo, sullo stesso piano dei singoli ministri. La riprova sta nelfatto che le questioni spettanti ad essi, se questi non esistessero, dovrebbero spettare oai singoli ministri o al Consiglio dei ministri.
31 Cfr. le osservazioni di P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 110. Decisamentecontrario alla qualificazione dei comitati interministeriali come organi costituzionali S.BARTOLE, Governo, cit., p. 661.
32 Il riferimento è a V. BACHELET, L’attività, cit., p. 131, ID., Comitati, cit., pp.764 ss., e P. BARILE, Corso, cit., p. 130, nonché G.U. RESCIGNO, Corso, cit., p. 404. Sem-bra aderire a tale impostazione anche F. BAGNAI, Il consiglio, cit., p. 239. Si rinvia, inol-tre, alla ricostruzione e all’analisi di P. CIARLO, Art. 95, cit., pp. 384 ss.
70 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
concerto33), è possibile prevedere che tale attività sia esercitataregolarmente e periodicamente in apposite riunioni tra i ministriinteressati: i comitati interministeriali a carattere permanente,appunto. In questo modo, i comitati interministeriali servireb-bero a rendere stabile l’attività di concerto tra i ministri34.
Tale modalità di concerto, tuttavia, si differenzierebbe daquella – per così dire – non istituzionalizzata per le modalità diassunzione del provvedimento: nel concerto sic et simpliciter, in-fatti, il provvedimento è assunto separatamente dai singoli mini-stri, dopo aver raggiunto l’accordo; nei comitati interministeriali,invece, il provvedimento è assunto dall’organo a maggioranza deisuoi componenti, vincolando anche quanti fossero eventual-mente dissenzienti. Le differenze tra le due modalità di concerto,d’altro canto, sarebbero prettamente formali, perché, anche nelconcerto, il mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti in-teressate comporterebbe la necessità di rimettere la risoluzionedella questione al Consiglio dei ministri, il quale deciderebbe co-munque a maggioranza35.
33 Sul “concerto” si v. A. MONACO, Concerto (Atti di), in Enciclopedia del diritto,vol. VIII, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 361 ss.
34 V. BACHELET, L’attività, cit., pp. 131-132, ID., Comitati, cit., pp. 764 e 771, P.BARILE, Corso, cit., p. 130, e F. MERUSI, Le direttive, cit., pp. 92 ss. Aderisce a tale tesianche P.A. CAPOTOSTI, Presidente, cit., p. 154, e ID., Governo, cit., p. 8.
35 In questo senso V. BACHELET, L’attività, cit., pp. 131-132, e ID., Comitati, cit.,pp. 771-772. F. MERUSI, Le direttive, cit., p. 94, però, osserva: «L’origine del comitatodi Ministri dal concerto aiuta ad intendere la natura particolare di questo collegio. Arigore non si tratta di un vero e proprio collegio, nel senso moderno del termine, oveè possibile distinguere la volontà dell’organo da quella dei componenti. Il comitato diMinistri è infatti uno strumento in grado di comporre un contrasto di interessi fra iMinistri, ma non di superarlo attraverso un atto autonomamente imputabile al colle-gio. Il dissenso di uno dei Ministri, così come il rifiuto di sottoscrivere l’atto di con-certo, integra la fattispecie di un conflitto interministeriale, risolvibile con l’interventodel Presidente del Consiglio o, persistendo il dissenso, con atto formale del Consigliodei Ministri. Si può pertanto concludere che i comitati di Ministri possono deliberaresoltanto alla unanimità e che ogni Ministro è dotato di una sorta di intercessio che puòesser superata con l’intervento di un organo esterno (Presidente o Consiglio dei Mini-stri)». Appare utile osservare che l’art. 1, n. 8, del r.d. 466/1901, prevedeva di sotto-porre al Consiglio dei ministri «[l]a risoluzione dei conflitti di competenza fra i diversi
71I COMITATI INTERMINISTERIALI
La previsione di tali organi, inoltre, tenderebbe a trasformarela direzione dei singoli dicasteri (di quelli più importanti, quanto-meno) da personale a collegiale, perché porrebbe accanto a unministro «un comitato che lo conforta del proprio consiglio o necondiziona in qualche modo l’attività con le sue decisioni»36.
Numerose sono le critiche rivolte a tale teoria37. Appare utile,in particolare, soffermarsi sulla asserita tendenza dei comitati agarantire una gestione collegiale dei dicasteri di maggiore impor-tanza. Innanzitutto, la gestione collegiale di un singolo ministeroappare difficilmente compatibile con l’art. 95, co. 2, Cost.: ogniministro con portafoglio, infatti, è individualmente responsabiledel dicastero cui è preposto ma – aderendo alla teoria di cui si di-scute – non potrebbe esercitarne la direzione da solo38. Tale si-tuazione potrebbe comportare l’eventualità che il ministro siachiamato a rispondere anche per atti del proprio ministero deter-minati dalla maggioranza degli altri ministri componenti il comi-tato, eventualmente anche in caso di suo dissenso. Inoltre, la ge-stione collegiale dei singoli ministeri potrebbe inficiare l’effi-cienza dell’attività di governo, perché, da un lato, ogni ministrodovrebbe occuparsi di più dicasteri anziché di uno solo; dall’al-tro, per l’assunzione delle decisioni di ogni ministero, sarebbe ne-cessario attendere l’assenso di più ministri, responsabili, peraltro,di settori differenti della pubblica amministrazione39. Occorre os-
Ministeri e la decisione delle questioni di competenza mista fra più Ministeri, quandoi Ministri non si accordino sulla relativa determinazione»; si v., ora, la l. 400/1988, art.2, co. 1, e art. 5, co. 2, lett. c-bis, come modificato dal d.lgs. 303/1999, art. 12, co. 2.
36 Così F. ORFINO, I comitati, cit., p. 34; nello stesso senso V. BACHELET, L’attività,cit., pp. 134-135, e ID., Comitati, cit., part. p. 773. Si v., altresì, le osservazioni di G. PI-TRUZZELLA, Il ministro in comitato interministeriale, in G. D’AURIA, P. BELLUCCI (a curadi), Politici e burocrati al governo dell’amministrazione, Bologna, il Mulino, 1995, pp.209-210, nonché S. BARTOLE, Assetto del Governo e relazioni intragovernative, in Qua-derni costituzionali, 1981, n. 2, p. 357.
37 Sulle quali si v. ampiamente P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 112 ss., G.QUADRI, I comitati, cit., pp. 9 ss., e P. CIARLO, Art. 95, cit., pp. 384 ss.
38 Si v., in proposito, P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 114.39 Cfr. le osservazioni di P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 114, e G. QUADRI, I
comitati, cit., pp. 10-11.
72 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
servare, infine, che la tendenza cui si è assistito sino alla riduzionedel numero di comitati è stata quella di creare un comitato perogni ministro: tale tendenza, però, non ha favorito la collegialitàdelle decisioni, ma ha rafforzato il potere politico di ogni ministroe la sua autonomia rispetto allo stesso Governo40.
In ogni caso, va sottolineato che la dottrina in questione,prevedendo l’assunzione di provvedimenti produttivi di effettiesterni da parte dei comitati interministeriali, sembra riconoscereil coinvolgimento di tali organi nella determinazione o, quanto-meno, nell’attuazione dell’indirizzo politico41.
2.8. I comitati interministeriali e le conferenze di servizi
La considerazione che i comitati interministeriali consen-tano il contestuale componimento di interessi differenti ha in-dotto parte della dottrina ad assimilare questi comitati alle con-ferenze di servizi42.
Le conferenze di servizi sono utilizzate «[q]ualora sia op-portuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblicicoinvolti in un procedimento amministrativo» o «per l’esamecontestuale di interessi coinvolti in più procedimenti ammini-strativi connessi»43. Le conferenze di servizi, quindi, servirebberoa semplificare l’azione amministrativa, componendo i diversi in-teressi coinvolti nel procedimento amministrativo. In senso ana-logo, i comitati interministeriali rappresenterebbero a livello po-litico ciò che le conferenze di servizi rappresentano a livello am-ministrativo. I comitati, pertanto, andrebbero inquadrati fra
40 Si v. P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 114-115; nel senso dell’incapacità deicomitati di garantire il coordinamento – almeno a livello settoriale – tra ministeri, entipubblici e poteri locali, G. ARENA, Ministeri, in G. GUARINO, Dizionario amministra-tivo, vol. II, 2ª ed. riveduta e accresciuta, Milano, Giuffrè, 1983, p. 1073.
41 In questo senso A. MATTIONI, Comitati, cit., pp. 7-8.42 A. RAVALLI, I comitati interministeriali. La cabina di regia nazionale, in Consi-
glio di Stato, 1996, n. 4, pp. 799 ss., e ID., I comitati interministeriali, in P. JARICCI (acura di), Studi di diritto pubblico dell’economia, Roma, Kappa, 2006, pp. 27 ss.
43 Cfr. l. 241/1990, art. 14, co. 1 e 3.
73I COMITATI INTERMINISTERIALI
quegli strumenti di semplificazione dei procedimenti finalizzatial perseguimento di interessi pubblici già individuati da normedi legge, caratterizzati da componenti sia tecniche sia di ordinepolitico in funzione di scelte strategiche e di controllo44.
Invero, sebbene vi siano dei punti di contatto tra i due fe-nomeni, non sembra si possa condividere una loro assimilazione,perché – a differenza del comitato interministeriale – la confe-renza di servizi non è un organo, bensì un semplice strumentoprocedimentale ed operativo. Essa, infatti, consiste nella riu-nione in un solo luogo o in una sola sede di uffici diversi o di di-verse amministrazioni, senza modificazione di competenze esenza un trasferimento di competenze o di poteri dai singoli par-tecipanti alla riunione (ovvero dagli uffici che essi rappresen-tano) ad una struttura collegiale. La conferenza, inoltre, anche seconsente valutazioni comuni, non dà luogo a provvedimenti uni-tari, perché le determinazioni concordate non si fondono in unadeliberazione unitaria45.
I comitati interministeriali e le conferenze di servizi, dun-que, rappresentano fenomeni le cui differenze sono tali da nonconsentirne l’assimilazione.
2.9. I comitati interministeriali come forma di adeguamento dellastruttura del Governo
Una ulteriore teoria – focalizzando l’attenzione sulla lorofunzione – ritiene che i comitati interministeriali servano ad ade-guare la struttura del Governo alle trasformazioni socio-econo-miche46.
44 A. RAVALLI, I comitati interministeriali, cit., p. 27.45 Così F.G. SCOCA, Conferenza di servizi, in Enciclopedia giuridica, vol. VIII,
Roma, Treccani, 1999, p. 2.46 Si v. G. QUADRI, I comitati, cit., ID., Gabinetto, cit., ID., Diritto pubblico dell’e-
conomia, 2ª ed., Padova, Cedam, 1980, pp. 165 ss., nonché G. TREVES, I comitati, cit.,pp. 221 ss., F. PIZZETTI, Comitati interministeriali, in Novissimo digesto italiano, app.,vol. II, Torino, Utet, 1980, pp. 57-58, A. MATTIONI, Comitati, cit., pp. 6-7, e, in ma-niera più critica, P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 115 ss.
74 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
Secondo tale teoria, poiché l’ordinamento del Governo nonè rigido, considerato che – come si è già visto47 – gli organi elen-cati dall’art. 92 Cost. rappresentano solo gli organi costituzional-mente necessari dell’Esecutivo, è possibile istituire altri organi“non necessari” al fine di adeguare la struttura del Governo alleesigenze di organizzazione emerse nella prassi in seguito a muta-menti politici o sociali. Tra questi organi devono ricomprendersianche i comitati interministeriali48. Tali comitati, dunque, avreb-bero il compito di svolgere funzioni che il Consiglio dei ministrio i singoli ministri non sarebbero in grado di esercitare, o po-trebbero esercitare solo con grande difficoltà, per varie ragioni.A volte, perché riguardano settori che richiedono un impegnocontinuato e un’assidua applicazione, e che quindi peserebberoeccessivamente sul poco tempo disponibile in Gabinetto; altrevolte perché sono in questione materie di natura eminentementetecnica e specializzata, per le quali il Consiglio dei ministri è im-preparato; in taluni casi, infine, perché si tratta di questioni cherichiedono un intervento immediato e deciso, difficile da partedi un organo delle dimensioni del Gabinetto49.
Da tale premessa si desume che i comitati interministerialipartecipano alla funzione di indirizzo politico, sebbene con ac-centi differenti.
Secondo parte della dottrina che sostiene la tesi di cui si di-scorre, infatti, i comitati interministeriali avrebbero il compito dideterminare l’indirizzo politico nelle materie di loro competenza,lasciando – di fatto – al Consiglio dei ministri la funzione di de-terminazione dell’indirizzo politico solo in via residuale, ovvero,solo in quelle materie che non rientrano nella competenza dei
47 Cfr. supra, parte I, cap. I.48 Cfr. le osservazioni di G. TREVES, I comitati, cit., p. 223, G. QUADRI, I comitati,
cit., part. pp. 26 ss., ID., Gabinetto, cit., pp. 8 ss., ID., Diritto, cit., pp. 178 ss., A. MAT-TIONI, Comitati, cit., pp. 6-7, e P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., part. p. 117.
49 Così G. QUADRI, I comitati, cit., p. 13. Secondo S. RISTUCCIA, Amministrare,cit., pp. 120-121, tuttavia, i comitati interministeriali sarebbero «serviti a far uscire dalConsiglio dei ministri alcuni poteri di governo, ma non già a trattenerli ed a usarli».
75I COMITATI INTERMINISTERIALI
vari comitati50. Negli altri casi il Consiglio dei ministri potrebbeintervenire solo eccezionalmente, su richiesta del Presidente delConsiglio, per risolvere questioni controverse, col rischio, però,di provocare una crisi di Governo51.
Altra parte della dottrina, invece, ritiene che i comitati inter-ministeriali non avrebbero il compito di determinare l’indirizzopolitico di settore, ma parteciperebbero comunque alla funzionedi indirizzo politico provvedendo alla sua attuazione. I comitatiinterministeriali, in altri termini, rappresenterebbero quelle arti-colazioni dell’Esecutivo necessarie per adeguare la struttura diquest’ultimo alle nuove modalità di attuazione dell’indirizzo poli-tico derivanti dalle modificazioni socio-economiche52.
50 In questo senso G. QUADRI, Diritto, cit., part. pp. 196-197, nonché ID., I co-mitati, cit., part. pp. 13 ss., 48 ss. e 181 ss., con riferimento al Consiglio supremo di di-fesa, che l’A. considera un comitato interministeriale (ma sulla configurazione di taleorgano alla stregua di un comitato interministeriale si v. infra, parte II, cap. II, par.2.1.), e ai comitati economici, e, ancora, ID., Gabinetto, cit., part. pp. 63 ss. Contra A.MANNINO, Indirizzo, cit., p. 82, nt. 4, secondo il quale «una simile tesi, che scardina ilsistema di competenze costituzionalmente attribuito agli organi del governo, non puòessere accettata. In ordine al CIPE, in particolare, la tesi che gli attribuisce il compitodi determinare l’indirizzo politico economico «in sostituzione del Consiglio dei mini-stri» (…) è contraddetta dalla sua stessa legge istitutiva del 27 febbraio 1967, n. 48, ilcui art. 16 stabilisce espressamente che le funzioni ad esso devolute devono esseresvolte «Ferme restando le competenze del consiglio dei ministri e subordinatamentead esse» (…). Al consiglio dei ministri è quindi affidato il compito di determinare l’in-dirizzo politico, nel quale è logicamente ricompreso anche quello economico, mentreal CIPE spetta quello di specificare concretamente le scelte effettuate in sede consi-liare: attività questa che riveste certamente un’importanza politica notevole, pur nonpotendo porsi in contrasto con le decisioni prese dal governo». Critico anche C. LAVA-GNA, Istituzioni, cit., p. 661, che ritiene «da respingere (…) l’opinione secondo la qualei Comitati, o quantomeno alcuni (in specie il CIPE), siano da considerare organi sosti-tutivi del Consiglio dei Ministri nei settori di loro competenza, o, peggio, che si so-vrappongano al Consiglio dei Ministri nell’esercizio del potere politico di indirizzo. De-vesi ritenere, al contrario, che essi debbano esercitare le loro funzioni nell’àmbito del-l’indirizzo politico-amministrativo riservato al Consiglio dei Ministri, sia in via generale,sia per singoli settori». Si v. anche le considerazioni critiche di L. PALADIN, Governo,cit., pp. 700-701, e i dubbi di P. GIOCOLI NACCI, Articolazioni, cit., pp. 39-40.
51 Così G. QUADRI, Gabinetto, cit., p. 75.52 Cfr. A. MATTIONI, Comitati, cit., pp. 6-7.
76 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
Una lettura della tesi in questione che si può definire inter-media, infine, ritiene che, pur spettando al Consiglio dei ministriil compito di determinare l’indirizzo politico, a tale funzione pos-sano partecipare – a determinate condizioni – anche i comitati in-terministeriali. Qualora ad un comitato interministeriale si pre-sentino problemi che, per il loro carattere di totale novità (o perqualsiasi altra ragione), non siano stati previamente ponderati al-l’atto dell’assunzione della piattaforma d’indirizzo politico gover-nativo (o per i quali, comunque, manchino decisioni d’indirizzoda parte del Consiglio), la questione non andrebbe necessaria-mente posta in Consiglio dei ministri, ma, in taluni casi – da va-lutarsi, di volta in volta, secondo criteri eminentemente politici –,il comitato potrebbe determinare direttamente le relative lineed’indirizzo. Ciò comporterebbe che, ove il Consiglio dei ministrinon sconfessasse tale decisione (innestando un meccanismo chepotrebbe condurre sino alla crisi di Governo), essa, per il princi-pio della collegialità, vincolerebbe l’intero Esecutivo53. Tale tesi,peraltro, sembra aver ricevuto l’avallo della l. 400/1988, secondola quale «[i] Comitati di ministri e quelli interministeriali istituitiper legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente delConsiglio dei ministri l’ordine del giorno delle riunioni. Il Presi-dente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni alConsiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Co-mitati debbono attenersi, nell’ambito delle norme vigenti»54.
Da quanto sin qui sintetizzato, appare evidente che anchenella tesi in questione – nonostante le non trascurabili differenzeemerse – si considerino i comitati interministeriali come organidell’Esecutivo chiamati a partecipare alla funzione di indirizzopolitico. Questa teoria, peraltro, pare quella più convincente. In-fatti, valutando il ruolo dei comitati interministeriali a partire dal
53 Così P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 127; nello stesso senso G. PITRUZZELLA,Artt. 92-93, cit., p. 176.
54 Così l’art. 6, co. 3, della l. 400/1988; si v. anche G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93,cit., pp. 126 e 176.
77I COMITATI INTERMINISTERIALI
modo in cui essi concretamente operano, la teoria in questionesembra cogliere la reale natura di tali organi: quella di organinon necessari del Governo idonei a consentire all’Esecutivo diadeguarsi alle molteplici esigenze socio-politiche da affrontare.Convincente appare anche la lettura del coinvolgimento dei co-mitati interministeriali nella funzione di indirizzo politico chepoco sopra si è definita “intermedia”. Anche in tale teoria, in-fatti, pare cogliersi il modo in cui concretamente viene determi-nato l’indirizzo politico in seno agli organi del Governo, senzauna rigida e preventiva suddivisione di ruoli ma rimettendo lesingole decisioni all’effettivo atteggiarsi dei rapporti infragover-nativi e alle specifiche esigenze politiche. Come si è visto, inoltre,si tratta di una tesi che pare avallata dalla l. 400/1988.
3. Il ruolo dei comitati interministeriali nell’interpretazionedella dottrina
Le tesi sin qui riassunte tratteggiano un quadro piuttosto ar-ticolato del ruolo e delle funzioni dei comitati interministeriali.Sembra di potersi affermare, tuttavia, che i comitati in questioneentrano a far parte della struttura del Governo, perché rappre-sentano un valido strumento di adeguamento di essa alle esi-genze politiche e organizzative dell’Esecutivo. In questo modo, icomitati interministeriali seguono – a loro volta – le sorti dell’or-ganizzazione governativa, assumendo ruoli differenti sulla scortadella preminenza assunta all’interno del Governo dai diversiprincipî organizzativi desumibili dalla Costituzione. Ciò aiuta acomprendere perché sono state sostenute opinioni tanto diffe-renti in merito al coinvolgimento dei comitati interministerialinella funzione di indirizzo politico.
Quando l’Esecutivo assume i tratti del “Governo a multipo-larità diseguale”, infatti, appare ovvio che i comitati intermini-steriali, ognuno dei quali rappresenta il “centro di potere” di undeterminato esponente di un partito della coalizione di maggio-ranza, finiscano – di fatto – col determinare l’indirizzo politico
78 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
del settore cui sono preposti, con la sola possibilità di un ricorsoal Consiglio dei ministri per dirimere eventuali contrasti tra levarie componenti dell’Esecutivo, seppure con il rischio di provo-care una crisi di Governo.
Invece, laddove nei rapporti endogovernativi prevalga ilprincipio collegiale, il coinvolgimento dei comitati interministe-riali nella funzione di indirizzo appare più contenuta, perché taliorgani vengono coinvolti solo nella attuazione di un indirizzo giàdeterminato dal Consiglio dei ministri o, comunque, assumonodeterminazioni che non sono sconfessate dal Consiglio stesso. Inquesta evenienza, peraltro, si potrebbe comunque osservare che,qualora il Consiglio dei ministri accetti le determinazioni assuntein sede di comitato, l’indirizzo politico di settore sarebbe deter-minato – in realtà – dallo stesso comitato.
Infine, se nell’organizzazione del Governo prevale il princi-pio monocratico, i comitati interministeriali – soprattutto se pre-sieduti dal Presidente del Consiglio dei ministri – sembrano as-sumere quasi un ruolo di mero ausilio nei confronti del premier.Anche in questo caso, peraltro, non è escluso un coinvolgimentodei comitati in questione nella funzione di indirizzo: essi potreb-bero comunque coadiuvare il Presidente del Consiglio nella pro-mozione e nel coordinamento dell’attività dei ministri, nonchénel mantenimento dell’unità di indirizzo politico e amministra-tivo del Governo.
In ogni caso, i comitati interministeriali – nonostante la va-rietà delle loro funzioni e degli ambiti di competenza – sonocoinvolti nella funzione di indirizzo politico55, sebbene con mo-
55 Si v., in merito, le osservazioni di J. BUCCISANO, Premesse, cit., p. 38. Già se-condo A. TESAURO, Istituzioni di diritto pubblico, vol. I, seconda ristampa della 1ª ed.,Torino, Utet, 1962, p. 307, d’altro canto, i «comitati interministeriali costituiti per finipolitici sono organi ausiliarî del presidente del Consiglio ovvero sostituiscono, per unadeterminata attività, il Consiglio dei ministri, acquistando la particolare figura degli or-gani direttivi politici che è propria del Cabinet nell’ordinamento inglese». Secondo E.SPAGNA MUSSO, Diritto costituzionale, 4ª ed., Padova, Cedam, 1992, pp. 555-556, i co-mitati interministeriali «se in via di fatto risultano nel settore di propria competenzasostitutivi del consiglio dei ministri, che finisce il più delle volte con il fungere da mero
79I COMITATI INTERMINISTERIALI
dalità differenti, sulla scorta dei concreti assetti politici e orga-nizzativi assunti dal Governo. D’altro canto, è stato corretta-mente osservato che il concetto e la titolarità della funzione diindirizzo politico non possono essere determinati in astratto unavolta per tutte, ma dipendono «dai singoli ordinamenti positivi edal loro concreto divenire»56. In questo senso, pare dunque av-valorata l’opinione secondo la quale i comitati interministerialifanno propriamente parte della struttura del Governo, perchéanche l’ampiezza del loro coinvolgimento nella determinazione onell’attuazione dell’indirizzo politico dell’Esecutivo dipende dal-l’adeguamento di tale struttura alle concrete esigenze di governo.
Una conferma di tale ipotesi sembra rappresentata dall’art.17, co. 3, della l. 400/1988, che – previa autorizzazione dellalegge – consente l’adozione di regolamenti interministeriali, pur-ché non dettino disposizioni contrarie a quelle dei regolamentiemanati dal Governo57. Infatti, consentendo ad un comitato in-terministeriale di adottare un regolamento di interesse di più mi-nisteri, sottoponendolo gerarchicamente ai regolamenti adottatidal Consiglio dei ministri, la legge sembra riconoscere al comi-tato l’esercizio di una funzione di attuazione dell’indirizzo poli-
organo di ratifica delle loro deliberazioni, sul piano giuridico appaiono subordinatiallo stesso consiglio esercitando attribuzioni di regola preparatorie rispetto alle delibe-razioni di quest’ultimo (…). Nondimeno, non si può nascondere che i rapporti preva-lenti in via di fatto fra comitati e consiglio dei ministri, nel mentre spossessano il se-condo del reale contenuto delle sue competenze, almeno nel caso del comitato inter-ministeriale di maggior rilievo, ossia per il CIPE (…), non hanno reale possibilità diessere corretti dalle attribuzioni giuridiche del consiglio dei ministri».
56 Così T. MARTINES, Indirizzo, cit., pp. 144-145; si v. anche G. GROTTANELLI DE’SANTI, Indirizzo politico, in Enciclopedia giuridica, vol. XVI, Roma, Treccani, 1989,part. p. 4, nonché M. DOGLIANI, Indirizzo, cit., part. pp. 194 ss.
57 Appare utile riportare integralmente la disposizione: «Con decreto ministe-riale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o diautorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottaticon decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione daparte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettarenorme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono esserecomunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
80 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
tico determinato dal Consiglio dei ministri, confermando il coin-volgimento di tali organi nella funzione di indirizzo politico58.D’altro canto, la disposizione citata non impedisce di emanareregolamenti interministeriali in assenza di regolamenti governa-tivi nella stessa materia; occorre ritenere, di conseguenza, che,qualora un comitato interministeriale adottasse un regolamentoin una materia nella quale manchi un regolamento governativo,sarebbe lo stesso comitato interministeriale a determinare l’indi-rizzo politico di settore, seppure – occorre presumere – con il ta-cito avallo del Consiglio dei ministri.
Se, dunque, appare confermato che i comitati interministe-riali facciano parte della struttura del Governo, occorre analiz-zare le tipologie di comitati e le loro funzioni, così da poter veri-ficare la loro influenza sui rapporti intragovernativi e sulla re-sponsabilità per i loro atti.
4. Classificazione dei comitati interministeriali
Occorre considerare, ora, le differenti tipologie di comitatiinterministeriali.
Una prima distinzione riguarda i comitati istituiti con leggee quelli istituiti con provvedimento del Presidente del Consigliodei ministri. Questa distinzione tra le fonti istitutive dei comitatirisulta anche dalla l. 400/1988, che fa riferimento ai comitati diministri istituiti con decreto del Presidente del Consiglio59, ai co-mitati di ministri in generale, «compresi quelli non istituiti conlegge»60, e ai comitati interministeriali istituiti con legge61. I co-mitati istituiti con decreto del Presidente del Consiglio trovereb-bero la loro legittimazione nel potere di indirizzo e coordina-mento del Presidente del Consiglio dei ministri ex art. 95, co. 1,Cost., consentendogli di istituire organi utili a tale scopo. La le-
58 A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 12.59 Cfr. la l. 400/1988, art. 5, co. 2, lett. h.60 Cfr. la l. 400/1988, art. 7, co. 1.61 Cfr. la l. 400/1988, art. 6, co. 3, e art. 7, co. 1.
81I COMITATI INTERMINISTERIALI
gittimità dei comitati istituiti con legge, invece, rientrerebbenella potestà di determinare l’organizzazione e le attribuzioni deiministeri che l’art. 95, co. 3, Cost. riserva alla legge62.
Da questa prima distinzione se ne può far discendere unaseconda: quella tra comitati con rilevanza esterna e comitati conrilevanza interna. In via di principio, infatti, i comitati costituiticon provvedimento del Presidente del Consiglio sarebbero or-gani meramente interni, perché dotati di funzioni esclusivamentepreparatorie, consultive o esecutive63. I comitati istituiti conlegge, invece, avrebbero rilievo esterno, perché competenti a de-liberare atti amministrativi o direttive capaci di vincolare soggettiestranei all’apparato amministrativo64.
Un’ulteriore differenza riguarda la durata di tali organi: sipotrebbero avere sia comitati temporanei, ossia costituiti per losvolgimento di un determinato compito, al termine del quale ces-sano di esistere65, sia comitati permanenti, istituiti senza stabi-lirne preventivamente la durata66.
62 In questo senso, G. TREVES, Comitato, cit., p. 595, F. CUOCOLO, Il Governo,cit., pp. 253 ss., V. BACHELET, Comitati, cit., pp. 766 ss., F. PIZZETTI, Comitati, cit., p.55. Cfr. altresì A. AMBROSI, Art. 92, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentariobreve alla Costituzione Paladin-Crisafulli, 2ª ed., Padova, Cedam, 2008, p. 842.
63 La natura meramente endogovernativa delle funzioni di questa categoria dicomitati si evincerebbe anche dalla l. 400/1988, art. 5, co. 2, lett. h.
64 In questo senso G. CUOMO, Unità, cit., pp. 57 ss., V. BACHELET, Comitati, cit.,p. 766, F. ORFINO, I comitati, cit., pp. 23-24, G. QUADRI, I comitati, cit., pp. 286 ss.,G.U. RESCIGNO, La responsabilità, cit., pp. 233-234, ID., Corso, cit., p. 404, F. MERUSI,Le direttive, cit., pp. 91-92, C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., p. 566, G. RIZZA, I co-mitati interministeriali: l’esperienza francese e quella italiana; le prospettive di riforma,in ID., Saggi, cit., pp. 165 ss., M. GIUSTI, Fondamenti, cit., p. 23. Si v. anche, con spe-cifico riferimento al CIP, V. SPAGNUOLO VIGORITA, R. MARRAMA, Prezzi (Disciplina pub-blica dei), in Novissimo digesto italiano, vol. V, Torino, Utet, 1957, p. 831. Sulla distin-zione indicata nel testo si v. le considerazioni critiche di P. CIRIELLO, Ordinamento, cit.,pp. 71 ss., e G. PITRUZZELLA, Il ministro, cit., pp. 177-178.
65 Si v. al riguardo le osservazioni di V. BACHELET, Comitati, cit., pp. 768-769. Sipotrebbe ipotizzare che il Comitato interministeriale per la revisione della spesa pub-blica (sul quale si v. infra, parte II, cap. II, par. 4.6.) sia un comitato temporaneo, de-stinato ad essere soppresso una volta conclusa la complessa attività di c.d. spendingreview.
66 Cfr. A. RAVALLI, I comitati interministeriali, cit., p. 34.
82 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
Una differenza relativa alla composizione dell’organo, in-vece, è quella tra comitati a composizione elastica e comitati acomposizione rigida. Per quanto riguarda questi ultimi, l’atto isti-tutivo prevede in maniera tassativa gli unici soggetti che entranoa far parte dell’organo; i comitati a composizione elastica, invece,sono quelli per i quali l’atto istitutivo prevede che dell’organodebbano far parte determinati soggetti ma anche che possanopartecipare soggetti ulteriori, individuati volta per volta67.
Sempre in merito alla composizione dei comitati – trala-sciando i comitati composti esclusivamente da tecnici o funzio-nari, che non hanno rilievo costituzionale68 – i comitati possonoessere composti esclusivamente da ministri o anche da funzio-nari, con le conseguenze in tema di responsabilità per gli atti del-l’organo che si esamineranno in seguito69.
Occorre occuparsi, infine, della differenza tra comitati inter-ministeriali e comitati di ministri. Le due denominazioni eranoutilizzate sia dalle norme istitutive dei diversi comitati70 sia dalladottrina71 già prima che la distinzione venisse ripresa dalla l.400/1988. Questa legge, infatti, fa riferimento sia ai comitati diministri sia a quelli interministeriali, prevedendo: che il Presi-dente del Consiglio dei ministri possa «disporre, con proprio de-creto, l’istituzione di particolari Comitati di ministri, con il com-pito di esaminare in via preliminare questioni di comune compe-tenza, di esprimere parere su direttive dell’attività del Governo esu problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio
67 In questo senso F. CUOCOLO, Il Governo, cit., p. 244, V. BACHELET, Comitati,cit., pp. 766-767, e F. ORFINO, I comitati, cit., pp. 24 e 28-29.
68 Così F. CUOCOLO, Il Governo, cit., pp. 243-244, che definisce i comitati in que-stione “burocratici”; cfr. anche V. BACHELET, Comitati, cit., pp. 765-766, che parla dicomitati “a livello funzionari”.
69 Cfr. infra, parte II, cap. I, par. 7.70 Si v., ad es., il già citato CIP e il Comitato di ministri per il Mezzogiorno (CI-
SMEZ) (sul quale si v. l’art. 1 della l. 646/1950, l’art. 1, co. 3, della l. 717/1965, l’art. 5del d.p.r. 1523/1967, e l’art. 1, co. 6, della l. 853/1971). Per la interscambiabilità delledue definizioni, infine, si consideri la legge istitutiva del Comitato interministeriale perla programmazione economica (CIPE) (l. 48/1967), che nel titolo definisce l’organo uncomitato di ministri, mentre nell’art. 16, co. 1, lo definisce comitato interministeriale.
83I COMITATI INTERMINISTERIALI
dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non ap-partenenti alla pubblica amministrazione»72; che «[i] Comitati diministri e quelli interministeriali istituiti per legge debb[a]notempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei mi-nistri l’ordine del giorno delle riunioni (…)»73; infine, che «[i]lGoverno è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di en-trata in vigore della presente legge, norme aventi valore di leggeordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri,compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati intermini-steriali previsti dalle leggi vigenti (…)»74.
Dalla disciplina richiamata sembra da escludere che le duetipologie di comitati possano essere distinte sulla scorta dell’attoistitutivo. Per quanto riguarda i comitati di ministri, infatti, lalegge prevede che il Presidente del Consiglio possa istituirne conproprio decreto, ma fa anche riferimento ai comitati di ministri«compresi quelli non istituiti con legge», lasciando intendere chei comitati di ministri possano essere istituiti anche con legge.Inoltre, poiché la legge sulla presidenza del Consiglio fa riferi-mento ai «Comitati di ministri e quelli interministeriali istituitiper legge», la congiunzione “e” induce a ritenere che entrambi itipi di comitati possano essere istituiti con legge. D’altro canto,sebbene la legge faccia riferimento esclusivamente ai comitati in-terministeriali istituiti con legge, non viene espressamenteesclusa la possibilità che i comitati interministeriali possano es-sere istituiti anche con atto governativo75.
Occorre ricordare, poi, che l’art. 6, co. 3, della l. 400/1988prevede: «I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituitiper legge devono tempestivamente comunicare al Presidente delConsiglio dei ministri l’ordine del giorno delle riunioni. Il Presi-
71 Ci si limita a rinviare a G. TREVES, I comitati, cit., pp. 221 ss., e V. BACHELET,Comitati, cit., pp. 763 ss.
72 Art. 5, co. 2, lett. h, della l. 400/1988.73 Art. 6, co. 3, della l. 400/1988.74 Art. 7, co. 1, della l. 400/1988.75 In questo senso P. GIOCOLI NACCI, Articolazioni, cit., part. pp. 26 ss.
84 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
dente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni alConsiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Co-mitati debbono attenersi, nell’ambito delle norme vigenti». La di-sposizione, quindi, sembra riferire ai soli comitati istituiti perlegge gli obblighi di informazione e i vincoli derivanti dalle diret-tive stabilite dal Consiglio dei ministri. Anche ritenendo che il se-condo periodo del comma sia riferito solo ai comitati istituiti perlegge indicati nel primo periodo della disposizione – sebbene siparli, nel secondo periodo, genericamente di comitati –, la dispo-sizione non esclude che il Consiglio dei ministri possa incideresull’attività dei comitati istituiti con decreto del Presidente delConsiglio. Occorre ritenere, invece, che il Consiglio dei ministripossa impartire disposizioni vincolanti anche per tali comitati: in-fatti, da un lato, il Consiglio dei ministri è l’organo deputato a de-terminare l’indirizzo politico del Governo e, quindi, può indicarele linee guida alle quali i comitati devono attenersi; dall’altro, poi-ché questi ultimi trovano la loro fonte istitutiva in un provvedi-mento amministrativo, un successivo atto amministrativo ema-nato dal Governo è sempre capace di vincolarne l’attività, po-tendo giungere, eventualmente, anche alla loro soppressione76.
L’unica differenza di rilievo tra i due tipi di comitati che tra-spare dalla l. 400/1988, dunque, si può rinvenire nell’art. 5, co.2, lett. h: questa disposizione, infatti, pare sottintendere che i co-mitati con mera rilevanza interna debbano essere comitati di mi-nistri, costituiti con decreto del Presidente del Consiglio77.
Stante le considerazioni sin qui svolte, sembra che tra le duetipologie di comitati non esista una distinzione rigorosamentedefinita78, sicché, le due denominazioni possono essere utilizzateper indicare sostanzialmente lo stesso fenomeno.
76 Nel senso che il Consiglio dei ministri possa vincolare anche l’attività deicomitati istituti con atto diverso dalla legge: P. GIOCOLI NACCI, Articolazioni, cit., pp.40 ss.
77 Analogamente, P. GIOCOLI NACCI, Articolazioni, cit., pp. 28 ss.78 In questo senso G.U. RESCIGNO, Corso, cit., p. 404, e S. BARTOLE, Governo,
cit., p. 640; secondo P.G. LIGNANI, L’amministrazione, cit., p. 327, nt. 57, «la distin-
85I COMITATI INTERMINISTERIALI
5. L’organizzazione interna dei comitati interministeriali: com-posizione e funzionamento
Occorre esaminare, ora, l’organizzazione interna dei comi-tati interministeriali, anticipando che la varietà delle soluzioni or-ganizzative utilizzate al riguardo rende difficoltoso definire cri-teri che possano essere ritenuti applicabili in via generale a tuttii comitati.
In primo luogo, bisogna considerare la loro composizione,perché i comitati possono avere una struttura elastica o rigida.Nel primo caso, l’atto istitutivo dell’organo prevede che possanofarne parte non solo i soggetti espressamente indicati ma anchealtri soggetti individuati volta per volta79. Dei comitati a compo-sizione rigida, invece, possono far parte solo i membri previstidall’atto istitutivo80.
Sempre in merito alla composizione, dei comitati intermini-steriali possono far parte solo ministri81 o anche soggetti estraneialla struttura del Governo, quali esperti o tecnici82.
Un ulteriore problema al riguardo attiene alla possibilità ri-conosciuta ai ministri componenti di un comitato di delegare adaltri soggetti la loro partecipazione alle riunioni dell’organo. Ilproblema – ovviamente – non si pone quando l’atto istitutivo del
zione fra le due denominazioni è atecnica e non tassativa, pur registrandosi una certatendenza ad un loro uso specializzato»; si v., però, la distinzione ipotizzata da S. LA-BRIOLA, Il Governo, cit., p. 153.
79 È il caso, ad es., del CIPE, alle riunioni del quale, oltre ai ministri che ne fannoparte in via permanente, possono partecipare, «con diritto di voto, anche i Ministri,non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggettodelle deliberazioni» (così la l. 144/1999, art. 2).
80 Ad es., ai sensi della legge istitutiva, facevano parte del Comitato intermini-steriale per la politica economica estera (CIPES) solo i ministri indicati: cfr. la l.227/1977, art. 1, co. 2 e 3.
81 … come nel caso del Comitato permanente per le partecipazioni statali (defi-nito anche CIPPSS): l. 1589/1956, art. 4.
82 Si consideri, ad es., che del CICR fa parte anche il Governatore della Bancad’Italia (cfr. l’art. 2, co. 1, del d.lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs.342/1999).
86 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
comitato prevede espressamente tale possibilità83; negli altri casisi potrebbe comunque ritenere che il ministro possa farsi sosti-tuire da un sottosegretario, previa attribuzione di una appositadelega84.
Per quanto attiene alla presidenza dell’organo, l’atto istitu-tivo può attribuirla al Presidente del Consiglio85 o ad un mini-stro86. Quando si prevede la possibilità del Presidente del Consi-glio di delegare ad altri la presidenza dell’organo, l’atto istitutivo– di solito – determina anche il soggetto cui delegare tale fun-zione, senza attribuire al premier l’esercizio di tale scelta87.
Per quanto riguarda il funzionamento dell’organo, non sem-bra possibile individuare dei caratteri comuni di organizzazione,per quanto generali. Le norme di organizzazione dei comitati, in-fatti, possono essere riscontrate nell’atto istitutivo dell’organo88,in un successivo provvedimento del Presidente del Consiglio o di
83 Per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica per lepolitiche di semplificazione e di qualità della regolazione, ad es., è espressamenteprevisto che ogni componente possa delegare la propria partecipazione all’organo adun vice ministro o ad un sottosegretario (cfr. il d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 2,co. 3).
84 In questo senso G. RIZZA, I comitati, cit., p. 173, e P. GIOCOLI NACCI, Artico-lazioni, cit., p. 45 e nt. 44. Secondo G. QUADRI, I comitati, cit., pp. 301 ss., quando ilcomitato deve emanare atti amministrativi, il ministro potrebbe farsi sostituire da unsottosegretario previa attribuzione di una formale delega; quando, invece, il comitatodeve svolgere attività di carattere politico, il ministro potrebbe ugualmente farsi sosti-tuire da un sottosegretario, tranne nel caso in cui si trattino questioni di particolare ri-levanza, valutazione – quest’ultima – rimessa al ministro, al Presidente del Consiglio oal Consiglio dei ministri.
85 Cfr., ad es., il CIPE: l. 48/1967, art. 16, co. 2.86 Si pensi al CIR (d.lgt. 432/1945, art. 2) o al CICR (art. 2, co. 1, del d.lgs.
385/1993, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 342/1999).87 Si v., ad es., il CIP (d.lgs.lgt. 347/1944, art. 1, co. 2), il CIPES (l. 227/1977, art.
1, co. 3), oppure il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica perle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione (d.p.c.m. 12 settembre2006, art. 2, co. 1).
88 Si considerino, ad es., le disposizioni del d.lgs. 385/1993, artt. 2, co. 3, e 8, co.2, in relazione alle modalità di funzionamento del CICR (cfr. anche infra, parte II, cap.II, par. 4.1.).
87I COMITATI INTERMINISTERIALI
un ministro89, in un atto dello stesso comitato90 o, ancora, de-vono essere ricostruite facendo riferimento ad ognuno di taliprovvedimenti od anche a provvedimenti diversi da quelli istitu-tivi dei singoli comitati interministeriali91. È possibile, altresì,che, pur essendo prevista la possibilità che il comitato emani unregolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento,tale regolamento non sia approvato92.
L’assenza di una compiuta regolamentazione delle modalitàdi funzionamento dell’organo, tuttavia, non consente comunquedi estendere ai comitati interministeriali i principî che regolanol’attività dei collegi amministrativi. Infatti, pur potendo avere an-che delle attribuzioni di carattere amministrativo, i comitati in-terministeriali si distinguono dai collegi amministrativi in virtùdella natura preminentemente politica delle loro attività; di con-seguenza, è necessario garantire a tali organi una certa elasticitànell’organizzazione delle loro modalità operative, senza vincolarlialle rigidità procedimentali dell’attività amministrativa93.
La composizione e le modalità di funzionamento dei comi-tati interministeriali, dunque, sono caratterizzate da un ampiogrado di elasticità, che consente di configurare ognuno di tali or-gani in maniera peculiare, così da renderli il più possibile adattial tipo di attività di governo cui sono deputati94.
89 Cfr. il d.p.c.m. 9 gennaio 2006, recante il regolamento per il funzionamentodel CIACE.
90 Si v. il regolamento del CIPE, adottato con delibera dello stesso comitato da-tata 9 luglio 1998.
91 Si pensi, ad es., alla l. 20/1994, art. 3, co. 1, lett. d.92 È quanto accaduto per lungo tempo al CIPE: cfr. infra, parte II, cap. II, par. 4.2.93 In questo senso P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 125-126. Sulle modalità di
funzionamento dei comitati interministeriali si rinvia anche a G. RIZZA, I comitati, cit.,pp. 171 ss. Come esempio delle modalità informali di funzionamento dei comitati si v.il contributo – estremamente critico – di E. GUICCIARDI, Il Comitato interministerialeprezzi: un “fuori legge”, in Giurisprudenza italiana, 1962, col. 277 ss. Appare utile rin-viare anche a G. SARTORI, Tecniche decisionali e sistema dei partiti, in Rivista italiana discienza politica, 1974, n. 1, pp. 27 ss., che ricostruisce le modalità di funzionamento edi assunzione delle decisioni all’interno di un sistema di comitati genericamente intesi.
94 Si v., al riguardo, le osservazioni di G. QUADRI, I comitati, cit., pp. 287-288, eP. BARILE, Consiglio, cit., p. 9.
88 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
6. L’attività e gli atti dei comitati interministeriali
Un profilo di particolare complessità che attiene ai comitatiinterministeriali è quello relativo alle loro funzioni. I comitati, in-fatti, non sono deputati a svolgere un solo e determinato tipo diattività, in quanto, nel loro concreto operare, è possibile riscon-trare una notevole varietà di attribuzioni95.
In primo luogo, i comitati interministeriali possono esserechiamati a svolgere delle attività di ausilio o preparatorie rispettoad altri organi del Governo. È il caso, ad esempio, delle funzionidi consulenza e proposta che il CISR esercita sugli indirizzi e sullefinalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza96;oppure dell’esame preventivo all’approvazione del Consiglio deiministri che il Comitato interministeriale per l’indirizzo e laguida strategica per le politiche di semplificazione e di qualitàdella regolazione svolge sulle iniziative normative con prevalentefinalità di semplificazione e, in particolare, del disegno di leggedi semplificazione97.
In secondo luogo, ai comitati interministeriali possono es-sere attribuite funzioni di carattere attuativo, che devono essereesercitate nell’ambito delle determinazioni assunte dal Consigliodei ministri, al fine di garantirne o verificarne la corretta esecu-zione, oppure per svolgere valutazioni rimesse al comitato dallostesso Governo. Si pensi, in proposito, alle attività di monitorag-gio attribuite al Comitato interministeriale per l’indirizzo e laguida strategica per le politiche di semplificazione e di qualitàdella regolazione98; oppure alla possibilità che il Governo rimettaalla valutazione del CIACE l’opportunità di apporre la riserva diesame parlamentare di cui all’art. 4 della l. 11/200599.
95 Si v., in proposito, S. RISTUCCIA, Amministrare, cit., p. 119.96 Cfr. la l. 124/2007, art. 5, co. 1. Sul CISR si rinvia infra, parte II, cap. II, par. 4.5.97 Così il d.p.c.m. 2 novembre 2006, art. 4, co. 3. Sul Comitato interministeriale
per l’indirizzo e la guida strategica per le politiche di semplificazione e di qualità dellaregolazione si rinvia infra, parte II, cap. II, par. 4.4.
98 Cfr. il d.p.c.m. 2 novembre 2006, art. 4, co. 4, lett. c.99 Cfr. il d.p.c.m. 9 gennaio 2006, art. 2, co. 1, lett. a. Sul CIACE cfr. infra, parte
II, cap. II, par. 4.3.
89I COMITATI INTERMINISTERIALI
In alcuni casi, tuttavia, le funzioni attribuite ai comitati in-terministeriali, pur dovendo esercitarsi nell’ambito degli indirizzifissati dal Governo, sembrano consentire a tali organi di parteci-pare alla determinazione della politica dell’Esecutivo nel settoredi competenza. A tal riguardo, il caso emblematico è rappresen-tato dal CIPE, al quale è attribuito – tra l’altro – il compito di de-finire le linee di politica economica da perseguire in ambito na-zionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specificiindirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale,delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiet-tivi prefissati, tenuto conto anche dell’esigenza di perseguire unosviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando leconseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica deirisultati; nonché il compito di definire gli indirizzi generali di po-litica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppodelle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle areedepresse, e verificarne l’attuazione, attraverso una stretta coope-razione con le Regioni, le Province autonome e gli enti locali in-teressati. Queste funzioni sembrerebbero attribuire al comitato ilcompito di definire l’indirizzo politico nelle materie di compe-tenza – sebbene «[n]ell’ambito degli indirizzi fissati dal Go-verno»100 –, rendendo dubbia la compatibilità di tali attribuzionicon l’art. 95 Cost. Per questo motivo, in dottrina si è cercato diricondurre l’attività del CIPE ad uno dei modelli di attuazionedell’indirizzo politico. In particolare, l’attività del CIPE è stataconsiderata come interpretativo-attuativa dell’indirizzo già deter-minato dal Consiglio dei ministri; di conseguenza, le direttiveemanate da quest’ultimo sarebbero dapprima interpretate dalcomitato e successivamente attuate attraverso l’emanazione diatti amministrativi direttamente produttivi di effetti giuridici.Così ricostruita, l’attività del CIPE non consentirebbe all’organouna libera definizione dell’indirizzo politico, perché tale attività
100 Così il d.lgs. 430/1997, art. 1, co. 1, lett. a e b. Sul CIPE si rinvia infra, parteII, cap. II, par. 4.2.
90 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
sarebbe delimitata dagli indirizzi generali individuati dal Go-verno, risultando compatibile con l’art. 95 Cost.101.
Ai comitati interministeriali, inoltre, sono attribuite funzionitipiche di coordinamento, a livello politico e amministrativo. Sipensi, ad esempio, al compito del CIPE di svolgere funzioni dicoordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istitu-zionali di programma e di altri strumenti di programmazione ne-goziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali di svi-luppo fissati dal Governo e del pieno utilizzo delle risorse desti-nate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale102. Siconsideri, altresì, il compito del Comitato interministeriale perl’indirizzo e la guida strategica per le politiche di semplificazionee di qualità della regolazione di coordinare l’attività di realizza-zione degli obiettivi del piano di azione in tema di semplifica-zione da parte dei singoli responsabili, o di svolgere funzioni diindirizzo, coordinamento e impulso delle amministrazioni delloStato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e dellaqualità della regolazione103.
Ai comitati, infine, possono essere attribuite funzioni mera-mente amministrative: si pensi, in proposito, alle autorizzazionirilasciate dal CICR per consentire di contrarre prestiti esteri intema di credito alle piccole e medie industrie o all’artigianato104.
La varietà delle funzioni attribuite ai comitati interministe-riali si riflette direttamente sugli atti che tali organi assumono. Lefunzioni di questi organi, infatti, cambiano in relazione agli scopiper i quali essi sono costituiti, con la conseguenza che nellostesso modo variano anche gli atti che possono essere assunti.Tale differenziazione nelle attribuzioni dei comitati interministe-riali consente di comprendere ulteriormente le difficoltà della
101 Si v. in proposito A. MATTIONI, Comitati, cit., pp. 8-10, e le difficoltà esplici-tate dall’A. relativamente alla necessità di riportare le competenze del CIPE all’internodi uno dei modelli di attuazione dell’indirizzo politico definito dal Governo.
102 Cfr. il d.lgs. 430/1997, art. 1, co. 1, lett. c.103 Cfr. il d.p.c.m. 2 novembre 2006, art. 4, co. 2 e 4.104 Cfr. la l. 949/1952, artt. 21, co. 1, e 38, co. 1.
91I COMITATI INTERMINISTERIALI
dottrina nella definizione della posizione dei comitati intermini-steriali all’interno della struttura del Governo105.
7. La responsabilità politica per gli atti dei comitati intermini-steriali
Un ulteriore problema che riguarda i comitati interministe-riali è quello della responsabilità politica per gli atti assunti dal-l’organo o per i comportamenti tenuti dai propri membri106, che,sulla scorta delle diverse teorie sviluppatesi in proposito, po-trebbe coinvolgere l’organo nella sua interezza, i suoi membri,chi lo presiede o l’intero Governo.
Si è sostenuto che, per gli atti posti in essere dai comitati in-terministeriali, la responsabilità politica potrebbe essere fatta va-lere solo nei confronti dell’intero comitato e non dei singoli mi-nistri che lo compongono107. Infatti, poiché i comitati sono degliorgani collegiali del Governo simili, nella struttura, al Consigliodei ministri, ad essi dovrebbero applicarsi gli stessi principî intema di responsabilità politica vigenti per il Consiglio. Quindi,anche per i comitati interministeriali varrebbe il principio dellasolidarietà ministeriale, con la conseguenza che i ministri mem-bri di un comitato sarebbero collegialmente e solidalmente re-sponsabili di fronte al Parlamento per l’azione politica del comi-tato108. Ogni ministro componente del comitato, inoltre, sarebbe
105 Secondo A. RAVALLI, I comitati, cit., p. 31, infatti, i comitati interministeriali«sono strutture indeterminate quanto a funzioni, compiti e composizione. La conse-guenza è che di essi si può più dire in termini descrittivi e meno in termini di sistema-zione giuridica».
106 Sulla constatazione che la responsabilità politica non derivi solo da atti chehanno una precisa configurazione giuridica ma anche da comportamenti di diverso te-nore si v. L. PRETI, Il Governo, cit., p. 9, nonché P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 56,e, più in generale, G.U. RESCIGNO, La responsabilità, cit., pp. 77 ss.
107 G. QUADRI, I comitati, cit., pp. 356 ss., ma anche ID., Gabinetto, cit., pp. 100ss., e ID., Diritto, cit., pp. 199 ss.
108 Così ancora G. QUADRI, I comitati, cit., p. 363.
92 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
responsabile delle decisioni di quest’ultimo, anche nell’ipotesi incui avesse votato contro la deliberazione109.
Questa impostazione, tuttavia, pare difficilmente compati-bile con il dettato costituzionale. L’art. 95, co. 2, Cost., infatti,prevede espressamente che i ministri siano responsabili collegial-mente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente de-gli atti dei loro dicasteri. Prevedere la responsabilità collegialedei ministri membri di un comitato per gli atti di quest’ultimo,invece, sembra configurare una tipologia di responsabilità poli-tica ministeriale ulteriore rispetto a quelle indicate dalla Costitu-zione, sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale di una so-luzione del genere110.
Più convincente appare la tesi secondo la quale potrebberoessere chiamati a rispondere degli atti del comitato i ministri chelo compongono, singolarmente considerati111. La partecipazionedei ministri ai comitati interministeriali, infatti, è stata conside-rata come una estensione dell’attività del dicastero cui il ministroè preposto. Invero, i ministri che partecipano ad un comitatonon sono individuati come persone fisiche, bensì come organiposti al vertice di uno specifico ministero che deve essere rap-presentato nel comitato112. L’attività dei ministri all’interno delcomitato, quindi, può essere considerata una proiezione dell’atti-
109 G. QUADRI, I comitati, cit., pp. 363-364; in questo senso anche V. BACHELET,Comitati, cit., p. 771. Contra C. LAVAGNA, Istituzioni, cit., p. 661.
110 Secondo F. CUOCOLO, Il Governo, cit., p. 255, infatti, i comitati interministe-riali non possono modificare i principî che regolano la responsabilità politica dei mi-nistri. Si v. anche G. TREVES, I comitati, cit., p. 231, ID., Comitato, cit., p. 596, M. MAZ-ZIOTTI, Il diritto al lavoro, Milano, Giuffrè, 1956, pp. 364-365, F. ORFINO, I comitati,cit., p. 31, e G. PITRUZZELLA, Il ministro, cit., p. 210, ma anche A. RUGGERI, Il Consi-glio, cit., pp. 213 ss., secondo il quale dagli atti dei comitati non deriverebbe nessunaresponsabilità politica, perché questi organi sarebbero incostituzionali.
111 In questo senso si v. G. TREVES, I comitati, cit., p. 231, ID., Comitato, cit., p.596, G. CUOMO, Unità, cit., pp. 64 ss., V. BACHELET, Comitati, cit., p. 771, F. ORFINO, Icomitati, cit., p. 31, A.M. SANDULLI, Governo e amministrazione, in Rivista trimestraledi diritto pubblico, 1966, p. 740, F. BAGNAI, Il consiglio, cit., pp. 239-240, P. GIOCOLI
NACCI, Articolazioni, cit., pp. 36 ss., e A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 11.112 Negli stessi termini V. BACHELET, Comitati, cit., p. 771.
93I COMITATI INTERMINISTERIALI
vità del dicastero cui il ministro è preposto e, di conseguenza,ogni singolo ministro membro di comitato potrebbe essere chia-mato a rispondere dinanzi al Parlamento per gli atti e per i com-portamenti tenuti in sede di comitato per responsabilità politicaindividuale, conformemente all’art. 95, co. 2, Cost.113. Non biso-gna dimenticare, infatti, che la responsabilità potrebbe derivarenon solo da un atto approvato dal comitato, ma anche dal com-portamento di un singolo ministro, volto, ad esempio, ad impe-dire l’assunzione di un determinato atto da parte dell’organo.
Contro la possibilità che si faccia valere la responsabilità in-dividuale del ministro per gli atti assunti in sede di comitato in-terministeriale, peraltro, non vale osservare che la conseguenzaparadossale potrebbero essere le dimissioni del ministro damembro del comitato ma non dalla carica di ministro114. Infatti,poiché – come si è già accennato – il membro di comitato eser-cita tale funzione in virtù del suo ruolo di ministro, l’eventualesfiducia individuale da parte del Parlamento o le sue dimissionicomporterebbero innanzitutto la sua decadenza dall’ufficio diministro e, solo come conseguenza, gli impedirebbero di parteci-pare alle attività del comitato; quest’ultimo compito, infatti, sa-rebbe assunto dal nuovo responsabile del dicastero.
Un’altra obiezione alla tesi della responsabilità individualedei ministri per gli atti dei comitati riguarda la possibilità chedell’organo facciano parte ministri senza portafoglio. Infatti, poi-ché questi ministri non sono posti a capo di un dicastero, non sa-rebbero gravati da responsabilità individuale e, di conseguenza,sarebbero irresponsabili delle attività svolte nell’ambito dei co-
113 Eventualmente, dunque, anche attraverso una mozione di sfiducia indivi-duale e non solo rispondendo ad interrogazioni ed interpellanze o presentando alleCamere periodiche relazioni sull’attività dei comitati interministeriali, come sostenutoda G. RIZZA, Il Presidente, cit., pp. 211-213, ID., I comitati, cit., pp. 167-168, e P. CI-RIELLO, Ordinamento, cit., p. 63. Per gli Autori citati, infatti, l’eventuale sfiducia neiconfronti di un ministro membro di un comitato finirebbe con il coinvolgere l’interoGoverno.
114 Si v. le osservazioni di P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 62-63.
94 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
mitati interministeriali115. Occorre considerare, però, che anche iministri senza portafoglio possono ottenere incarichi individualiche incidono sulla determinazione o sulla attuazione dell’indi-rizzo politico, per l’esercizio dei quali sembrerebbe illogico nonriconoscere una conseguente responsabilità politica. Tra questiincarichi devono ricomprendersi proprio la partecipazione o lapresidenza di un comitato interministeriale; nell’esercizio di talifunzioni, pertanto, sembra ovvio che anche i ministri senza por-tafoglio possano essere chiamati a rispondere dinanzi al Parla-mento116.
Un problema particolare in tema di responsabilità per gliatti dei comitati interministeriali riguarda la composizione di taliorgani: quando essi sono composti sia di ministri sia di tecnicipotrebbe sembrare improprio chiamare a rispondere i ministridegli atti assunti anche da soggetti non responsabili nei confrontidel Parlamento117. Nondimeno, alcune considerazioni consen-
115 P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 58-59, e L. VENTURA, Il Governo, cit., p.164, nt. 15. In proposito, è opportuno ricordare che un’ampia discussione si è svilup-pata in dottrina con riferimento alla presidenza del soppresso CISMEZ: secondo l’art. 23della l. 646/1950, infatti, il presidente di questo comitato – che poteva essere un mini-stro senza portafoglio designato dal Consiglio dei ministri – «risponde[va], innanzi alParlamento, dell’attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui defe-rita». Questa disposizione è parsa sintomatica di un processo di trasformazione dellafigura del ministro senza portafoglio e del sistema di governo, compatibile con il si-stema costituzionale (così V. BACHELET, Comitati, cit., pp. 772-773, e F. ORFINO, I co-mitati, cit., pp. 33-34). Per quanto riguarda più propriamente il tema della responsa-bilità per gli atti di tale comitato, parte della dottrina riteneva la disposizioneconforme alla Costituzione solo laddove si ritenesse possibile configurare una respon-sabilità individuale dei membri del comitato (in questo senso G. CUOMO, Unità, cit.,pp. 64-65, ma anche G. TREVES, I comitati, cit., pp. 231-232, ID., Comitato, cit., p. 596,e, sembrerebbe, C. LAVAGNA, Istituzioni, cit., p. 661); secondo altra parte della dot-trina, invece, la disposizione doveva considerarsi incostituzionale: cfr. M. MAZZIOTTI, Ildiritto, cit., pp. 364-365, e F. MERUSI, Le direttive, cit., pp. 114 ss. Si v. anche G.U. RE-SCIGNO, La responsabilità, cit., pp. 233-234 e nt. 41.
116 Così A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 11. Secondo G. QUADRI, I comitati, cit.,pp. 298-300, i ministri senza portafoglio sarebbero i più indicati a far parte dei comi-tati interministeriali e a presiederli.
117 Si v., infatti, le perplessità di P. BARILE, Consiglio, cit., p. 10.
95I COMITATI INTERMINISTERIALI
tono di superare tali perplessità. In primo luogo, ritenere re-sponsabile individualmente ogni ministro consente di distin-guere la sua responsabilità per gli atti e i comportamenti assuntiall’interno del comitato da quella derivante dagli atti assunti da-gli altri componenti118. In secondo luogo, i comitati che rientranonella struttura del Governo sono (e devono essere) composti pre-valentemente da politici119 e, comunque, devono attenersi alle di-rettive del Consiglio dei ministri, così che le decisioni in essi as-sunte possano comunque considerarsi espressione dell’indirizzopolitico dell’Esecutivo, tali da essere soggette a responsabilitàpolitica120. Infine, anche nel suo ruolo di capo di un dicastero, ilministro risponde politicamente degli atti del dicastero cui è pre-posto, sebbene dell’organizzazione ministeriale facciano partepure tecnici e funzionari, che non sono direttamente soggetti aduna responsabilità politica121 e nonostante la tendenza alla sepa-razione tra politica e amministrazione riduca l’ambito di applica-bilità del principio gerarchico all’interno dell’organizzazione mi-nisteriale122. A maggior ragione, il singolo ministro/membro dicomitato potrebbe essere chiamato a rispondere degli atti assuntida un collegio del quale fa parte insieme ad altri soggetti, indi-pendentemente dalla connotazione tecnica o politica di questi ul-timi.
Occorre considerare, inoltre, che la possibilità di far valerela responsabilità individuale dei membri dei comitati nonesclude un coinvolgimento dell’intero Governo. Infatti, se ap-
118 Si v. le osservazioni di G. CUOMO, Unità, cit., p. 66.119 Si v., in proposito, F. CUOCOLO, Il Governo, cit., p. 257, V. BACHELET, Comi-
tati, cit., p. 772, e P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 65.120 Al riguardo cfr. F. CUOCOLO, Il Governo, cit., pp. 256-257.121 In questo senso si v. F. ORFINO, I comitati, cit., p. 31, e E. CHELI, Ministeri e
ministri, in Enciclopedia forense, vol. IV, Milano, Vallardi, 1959, p. 1096. Appare utile,inoltre, rinviare a L. ELIA, Problemi, cit., pp. 546 ss., ma anche a G. AMATO, Nuove ten-denze nella formazione degli atti governativi di indirizzo, in Rivista trimestrale di dirittopubblico, 1970, pp. 93 ss., e L. ARCIDIACONO, Principio di gerarchia e principio collabo-rativo, in E. SPAGNA MUSSO (diretto da), Costituzione e struttura del Governo. Lariforma dei ministeri, parte II, Padova, Cedam, 1988, part. pp. 524 ss.
96 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
pare da escludere che per ogni atto dei comitati interministerialidebba essere chiamato a rispondere sempre e solo l’intero Ese-cutivo123, sembra evidente che le decisioni assunte dal comitatopossano coinvolgere – in talune circostanze – anche l’intero Go-verno124. Non bisogna dimenticare, infatti, che la partecipazionedei comitati alla formazione dell’indirizzo politico è comunquesubordinata al ruolo del Consiglio dei ministri, poiché quest’ul-timo potrebbe comunque intervenire per dettare le direttive allequali i comitati devono attenersi125 o, non intervenendo, po-trebbe tacitamente avallare le decisioni assunte in sede di comi-tato126. D’altro canto, alcuni atti dei comitati potrebbero essereassunti senza un concreto controllo da parte del Consiglio deiministri, nonostante essi abbiano l’obbligo di comunicare al Pre-sidente del Consiglio l’ordine del giorno delle riunioni127. Diconseguenza, appare opportuno lasciare al Parlamento il com-pito di valutare se attribuire la responsabilità di un determinato
122 La responsabilità politica del ministro, innanzitutto quella c.d. diffusa, infattinon dovrebbe venir meno neanche in seguito alle riforme volte a garantire la separa-zione tra politica e amministrazione (cfr., in proposito, infra, parte II, cap. II, par. 3.).
123 Si v., in questo senso, G.U. RESCIGNO, La responsabilità, cit., p. 238, G. RIZZA,Il Presidente, cit., pp. 212-213, ID., I comitati, cit., part. p. 168, F. MERUSI, Le direttive,cit., pp. 106-107, P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 55 ss., e L. VENTURA, Il Governo,cit., pp. 164-166 e nt. 15, nonché C. LAVAGNA, Istituzioni, cit., p. 661, secondo il quale,però, sarebbe possibile configurare anche – seppure raramente – una responsabilitàministeriale individuale dei soli ministri membri di singoli comitati «che non si sianodichiarati contrari a deliberazioni atte a compromettere il rapporto di fiducia verso ilParlamento».
124 In questo senso A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 11, e G. BALLADORE PALLIERI,Diritto, cit., pp. 309-310. Secondo P.A. CAPOTOSTI, Presidente, cit., p. 154, la respon-sabilità politica per gli atti di un comitato interministeriale dovrebbe riguardare il mi-nistro che lo presiede e i ministri che ne sono membri; essa, tuttavia, «finisce presso-ché inevitabilmente con il rifluire, pur avendo riferimento ad attività non propria-mente ministeriali, nell’àmbito della responsabilità individuale dei ministri in quantotali, provocando così, per effetto della regola della responsabilità ministeriale, contrac-colpi sull’intera struttura di Governo».
125 … ai sensi dell’art. 6, co. 3, della l. 400/1988.126 Cfr., in questo senso, le osservazioni di G. CUOMO, Unità, cit., part. p. 67.127 Così l’art. 6, co. 3, della l. 400/1988.
97I COMITATI INTERMINISTERIALI
atto o comportamento ad uno o più membri del comitato, al suopresidente o all’intero Esecutivo, nonché la valutazione relativaallo strumento di volta in volta ritenuto più idoneo a tale scopo.Il Parlamento, infatti, potrebbe ad esempio ritenere che la sfidu-cia nei confronti di un singolo ministro sia idonea a garantire ilmutamento dell’indirizzo politico auspicato, senza la necessità diaprire una crisi di Governo128.
È necessario occuparsi, ora della responsabilità del presi-dente del comitato interministeriale.
Qualora tale ruolo sia ricoperto dal Presidente del Consigliodei ministri, in questa duplice veste egli potrebbe svolgere la suafunzione di promozione e coordinamento dell’attività dei mini-stri e, di conseguenza, nei suoi confronti potrebbe essere fattavalere la responsabilità di cui all’art. 95, co. 1, Cost. È evidente,però, che per far valere la responsabilità del presidente di comi-tato/Presidente del Consiglio sarebbe necessario ricorrere allamozione di sfiducia ex art. 94 Cost., con l’inevitabile coinvolgi-mento dell’intero Esecutivo e la possibile apertura di una crisi diGoverno129.
Conseguenze diverse possono aversi nell’ipotesi in cui lapresidenza di un comitato sia attribuita a un ministro. In questocaso, infatti, il ruolo giuridico di tale ministro non si differenziada quello degli altri ministri: egli non dovrebbe esercitare la fun-zione di direzione e coordinamento in ordine alle decisioni da as-sumere in sede di comitato, ma dovrebbe limitarsi a dirigere eorganizzare l’attività interna dell’organo130. La presidenza di un
128 Si v. le osservazioni in tema di responsabilità individuale dei ministri di P.CIARLO, Art. 95, cit., p. 390, F. DONATI, La responsabilità, cit., part. p. 211, e M.L. MAZ-ZONI HONORATI, Diritto parlamentare, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 270-271, ma an-che L. PALADIN, Governo, cit., part. p. 698.
129 Cfr. G. TREVES, I comitati, cit., p. 232, L. PRETI, Il Governo, cit., pp. 44-45, A.MATTIONI, Comitati, cit., pp. 11-12, L. VENTURA, Il Governo, cit., p. 164, nt. 15, ma an-che le osservazioni di V. BACHELET, Comitati, cit., p. 772. Si v. altresì infra, parte III,cap. II, par. 2.7.
130 In questo senso F. ORFINO, I comitati interministeriali, cit., p. 33, e A. MAT-TIONI, Comitati interministeriali, cit., p. 12.
98 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
comitato interministeriale, tuttavia, pur non alterando la paritàgiuridica tra i ministri, consente il rafforzamento del ruolo poli-tico del ministro che assume tale presidenza rispetto agli altri mi-nistri, con la conseguente possibilità che questi possa anche inci-dere in maniera determinante sulle decisioni assunte in sede dicomitato131. Appare opportuno, di conseguenza, rimettere al Par-lamento il compito di effettuare le dovute valutazioni politiche,imputando la responsabilità politica al ministro/presidente di co-mitato non solo per le modalità di funzionamento dell’organo,ma anche – eventualmente – per le decisioni in esso assunte132.
8. L’incidenza dei comitati interministeriali sui rapporti endogo-vernativi
Un effetto che il sistema dei comitati interministeriali certa-mente produce è l’alterazione dei rapporti infragovernativi.
Per quanto riguarda, in primo luogo, il Consiglio dei mini-stri, la creazione di un articolato sistema di comitati intermini-steriali sembra ridurre il ruolo dell’organo collegiale di Governo,perché una parte delle sue funzioni viene comunque esercitatada tali comitati. Anche ritenendo che le determinazioni dei co-mitati interministeriali debbano ottenere l’avallo (seppure tacito)del Consiglio dei ministri, è comunque evidente che alcune deci-sioni del Governo nelle materie di interesse dei singoli comitatisono assunte in una sede decentrata rispetto allo stesso Consigliodei ministri, riducendo il ruolo di quest’ultimo133. Peraltro, comeè stato correttamente osservato, non è semplice determinare chisi avvantaggi concretamente di tale riduzione: «può essere ilPrimo ministro, ma potrebbe anche non esserlo, crescendo così
131 Per questi profili si v. infra, parte II, cap. I, par. 8.132 Si v. le osservazioni di A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 12, e V. BACHELET, Co-
mitati, cit., p. 772, nonché i dubbi di G. TREVES, I comitati, cit., p. 232.133 A. RUGGERI, Il Consiglio, cit., pp. 220 ss. Secondo S. CASSESE, Esiste, cit., p.
25, i comitati interministeriali rappresenterebbero uno degli strumenti attraverso iquali realizzare la “fuga” dal Consiglio dei ministri.
99I COMITATI INTERMINISTERIALI
il rilievo di singoli ministri o di alti burocrati o tecnocrati o, per-fino, di rappresentanti di interessi particolari»134.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, potrebberafforzare il suo ruolo all’interno dell’organizzazione di Governograzie ai comitati interministeriali, soprattutto qualora il numerodi comitati fosse contenuto ed egli ne avesse la presidenza. Inquesta eventualità, il Presidente del Consiglio si ritroverebbe apresiedere pochi organi composti di un numero ridotto di mini-stri deputati ad occuparsi di specifici settori dell’amministra-zione pubblica, acquisendo maggiori possibilità di influire sulladeterminazione dell’indirizzo politico di settore, nonché una mi-gliore capacità di coordinamento dell’attività dei ministri135.
Anche nei casi in cui il Presidente del Consiglio sia chia-mato a presiedere i comitati interministeriali, potrebbe comun-que non aversi un rafforzamento del suo ruolo. Infatti, soprat-tutto quando i comitati sono numerosi, il Presidente del Consi-glio può essere indotto a non partecipare alle loro riunioni,delegandone la presidenza ad un ministro136. Tuttavia, poiché inquesta evenienza il Presidente del Consiglio non può scegliere ilministro che lo rappresenta, perché quest’ultimo è individuato –di solito – in via generale dalla fonte normativa istitutiva di ognisingolo comitato, potrebbe essere proprio il ministro delegato agiovarsi della riduzione del ruolo del Consiglio dei ministri137. Il
134 Così L. ELIA, Primo, cit., p. 865. Nello stesso senso anche A. RUGGERI, Il Con-siglio, cit., pp. 212, 223-224, P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 8, ID., Presidente, cit.,pp. 154-155, nonché, in maniera molto critica, L. VENTURA, Il Governo, cit., pp. 160 ss.Appare utile, infine, un rinvio a N. BOBBIO, La democrazia e il potere invisibile, in Ri-vista italiana di scienza politica, 1980, n. 2, pp. 181 ss., part. 200 ss.
135 Secondo S. CASSESE, Esiste, cit., p. 23, infatti, il Presidente del Consiglioavrebbe assunto una posizione di primazia attraverso i comitati di ministri preposti adapparati di amministrazione di settore. Si v., inoltre, le osservazioni di C. MORTATI, Isti-tuzioni, tomo I, cit., p. 571, nonché L. ELIA, Primo, cit., p. 868.
136 S. BARTOLE, Governo, cit., p. 639.137 In questo senso A. PREDIERI, Presidente, cit., pp. 1 e 10, P.A. CAPOTOSTI, Pre-
sidente, cit., p. 154, L. VENTURA, Il Governo, cit., pp. 158-159, e G. PITRUZZELLA, Il mi-nistro, cit., pp. 191-192.
100 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
ministro che – di fatto – presiede un comitato, infatti, potrebbeassumere un ruolo di preminenza rispetto agli altri ministri even-tualmente rappresentati in comitato138 e, soprattutto, nei con-fronti dei ministri che non fanno parte di alcun comitato. In ma-niera analoga, i ministri che fanno comunque parte di un comi-tato – pur senza presiederlo – potrebbero assumere un ruolopolitico prevalente rispetto ai membri del Governo che non sonocomponenti di alcun comitato139. Ciò, evidentemente, comportauna alterazione anche nei rapporti tra i singoli ministri e il venirmeno dell’uguaglianza tra ministri, con la conseguenza che ogniministro tenti di ottenere l’istituzione di un comitato intermini-steriale da poter presiedere, così da creare un proprio ed auto-nomo centro di decisione politica140. Merita osservare, tuttavia,che la creazione di comitati interministeriali non sembra modifi-care la parità giuridica dei ministri, bensì la loro parità politica141.La presidenza di un comitato interministeriale, infatti, può ga-rantire un maggior peso politico di un ministro rispetto a quelli
138 Secondo P.G. LIGNANI, L’amministrazione, cit., p. 328, nt. 61, infatti, «[f]re-quentemente, il ministro cui spettano, di diritto o in via di delega, le funzioni di presi-dente, è il titolare del dicastero che funge da apparato di supporto tecnico e conosci-tivo del comitato. È intuitivo che in tale situazione il potere effettivo del ministro-pre-sidente nei confronti del comitato va ben oltre le funzioni presidenziali strettamenteintese».
139 Secondo G. PITRUZZELLA, Il ministro, cit., pp. 192 ss., tuttavia, tale rafforza-mento non sarebbe “automatico”. Sulla alterazione della par condicio tra ministri, si v.:G. CUOMO, Unità, cit., p. 49, G. TREVES, I comitati, cit., p. 225, F. ORFINO, I comitati,cit., p. 33, L. ELIA, Il «direttorio», cit., p. 2815, C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., pp.569-570, P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 79 ss., A. RUGGERI, Il Consiglio, cit., pp.210-211, P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 8, G. PITRUZZELLA, Il Consiglio, cit., pp. 667-668, L. VENTURA, Il Governo, cit., pp. 156 ss., V. BACHELET, Comitati, cit., p. 772, G. DE
VERGOTTINI, Per una razionalizzazione della collegialità nel Governo, in Le Regioni,1987, n. 3, part. p. 327, P. CIARLO, Art. 95, cit., p. 383, e P. GIOCOLI NACCI, Articola-zioni, cit., pp. 44-45.
140 Si v., in proposito, le osservazioni di S. CASSESE, Esiste, cit., p. 51, S. BARTOLE,Assetto, cit., p. 355, e P. CALANDRA, Il Governo, cit., part. p. 150.
141 In merito si v. G. PITRUZZELLA, Il Consiglio, cit., p. 666, e P. CIRIELLO, Ordi-namento, cit., pp. 81 ss. Per la distinzione tra parità giuridica e parità politica tra gliorgani costituzionali cfr. E. CHELI, Organi, cit., part. pp. 174-175.
101I COMITATI INTERMINISTERIALI
che non presiedono un organo analogo; questa differenza, però,si manifesterebbe anche in assenza del sistema dei comitati, per-ché deriva anche da altri fattori, quali il peso politico della per-sonalità chiamata a ricoprire l’ufficio di ministro (si pensi, adesempio, al leader di uno dei partiti di maggioranza), oppure ildicastero al quale il ministro è preposto (è innegabile, infatti, chealcuni ministeri svolgano un ruolo politico-amministrativo di ri-lievo maggiore rispetto ad altri)142.
Come si è visto, l’articolazione di un sistema di organi nonnecessari del Governo quali i comitati interministeriali incide suirapporti endogovernativi, ma, a parte questa valutazione di ca-rattere generale, appare impossibile determinare ex ante la realeportata di tale modificazione, perché il suo concreto atteggiarsidipende da numerosi fattori (l’articolazione del Governo, ilruolo del Presidente del Consiglio dei ministri, i rapporti politiciall’interno della maggioranza, ecc.) che ne consentono solo unaanalisi ex post e non definitiva.
9. Cenni di comparazione: l’utilizzo di comitati ristretti comemodello diffuso di articolazione della struttura del Governo
È necessario evidenziare, ora, che il ricorso a collegi ristrettidi governo non è un fenomeno che riguarda solo l’ordinamentoitaliano. Infatti, il ricorso ad organi del genere nell’organizza-zione dell’Esecutivo è un fenomeno ricorrente negli Stati con-temporanei, perché l’aumento delle competenze dello stato so-ciale rende necessario formare Governi con un numero di mem-bri sufficientemente numeroso da consentire un adeguatocontrollo politico delle varie branche della pubblica amministra-zione. Un numero ampio di componenti del Governo, deputati,
142 In questo senso G. PITRUZZELLA, Il ministro, cit., pp. 208-209, e ID., Il Consi-glio, cit., pp. 666-667, S. CASSESE, Esiste, cit., pp. 24-25, nonché P. CIRIELLO, Ordina-mento, cit., pp. 84 ss. Si v. anche S. BARTOLE, Assetto, cit., pp. 357-358, e P. DEL VE-SCOVO, Il Consiglio di Gabinetto. Un tentativo di rafforzamento del Governo, in Rivistatrimestrale di diritto pubblico, 1988, part. p. 911.
102 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
peraltro, ad occuparsi di materie anche piuttosto differenti traloro, favorisce inevitabilmente la creazione di collegi ristrettidello stesso Esecutivo, volti ad occuparsi di determinate materieo di gruppi omogenei di materie143. Tale fenomeno è sicuramentemolto diffuso144, in particolare in Stati che presentano una formadi governo parlamentare145, sicché, nelle prossime pagine si pren-derà in considerazione, seppure sinteticamente, il governo percomitati sviluppatosi nel governo parlamentare per eccellenza:quello britannico.
9.1. Il modello paradigmatico: il Cabinet system britannico
I Cabinet committees o Ministerial committees sono organidel Governo presenti nell’ordinamento britannico sin dal XIX se-colo, ma si sono sviluppati dopo la seconda guerra mondiale, for-mando un vero e proprio sistema146. Questi comitati si sono svi-
143 Si v., in proposito, le osservazioni di H.J. LASKI, A Grammar of Politics, 6ªed., London, George Allen & Unwin Ltd, 1967, pp. 358-359.
144 Sull’utilizzo di collegi ristretti di governo in ordinamenti stranieri si v., ad es.,i contributi pubblicati in R. ROSE, E.N. SULEIMAN (eds.), Presidents, cit., nonché E.SPAGNA MUSSO (diretta da), Costituzione e struttura del Governo. L’organizzazione delgoverno negli stati di democrazia parlamentare, Ricerca del Consiglio Nazionale delleRicerche, Padova, Cedam, 1982, e S. JAMES, British Cabinet Government, London andNew York, Routledge, 1994, p. 60, che ricorda come elaborati sistemi di comitati sianodiffusi, in particolare, in Canada, Australia e Nuova Zelanda, oltre che nei Governidell’Europa occidentale.
145 È interessante notare che il ricorso ad organi collegiali ristretti del Governosi riscontra anche nel semipresidenzialismo francese: cfr. A.G. DELION, Les conseils etcomité interministériels, in A.J.D.A., 1975, pp. 268 ss.; J. GICQUEL, Droit constitution-nel et institutions politiques, 14ª ed., Paris, Montchrestien, 1995, pp. 624-625; D. CHA-GNOLLAUD, J-L. QUERMONNE, Le gouvernement de la France sous la Ve République, Pa-ris, Fayard, 1996, pp. 306-307; D. TURPIN, Droit constitutionnel, 1ª ed., Paris, Qua-drige/Puf, 2003, pp. 521-522; F. HAMON, M. TROPER, Droit constitutionnel, 29ª ed.,Paris, L.G.D.J., 2005, p. 662; P. ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel,18ª ed., Paris, L.G.D.J., 2006, pp. 518-519; nonché G. RIZZA, I comitati, cit., pp. 140 ss.
146 Per una ricostruzione dell’evoluzione storica dei Cabinet committees e del-l’intero sistema di governo britannico si rinvia ai classici saggi di I. JENNINGS, Cabinet,cit., A.B. KEITH, The British Cabinet System, 2ª ed. by N.H. GIBBS, London, Stevens &Sons Limited, 1952, e J.P. MACKINTOSH, The British Cabinet, London, Stevens & Sons
103I COMITATI INTERMINISTERIALI
luppati in maniera informale e senza che i Governi rendesseronote la loro creazione, le loro funzioni o la loro concreta attività:le prime formali indicazioni al loro riguardo, infatti, si sono avutesolo a partire dal Governo guidato da Margaret Thatcher147.
I Cabinet committees sono collegi ristretti di ministri carat-terizzati da una composizione e un funzionamento improntatialla flessibilità148. Essi sono creati e soppressi dal Primo Ministro,il quale ne determina anche la composizione, il presidente e lefunzioni149. Possono essere suddivisi in standing committees e adhoc committees: questi ultimi sono costituiti per trattare pro-blemi specifici e cessano dalle loro funzioni quando hanno esau-rito il loro compito; gli standing committees, invece, duranoquanto il Governo che li ha creati, salvo che non siano confer-mati dal Governo successivo, si occupano stabilmente di deter-minate materie e possono avvalersi anche di sub-committees150.
Per quanto riguarda il valore delle loro decisioni, i Cabinetcommittees possono svolgere una funzione istruttoria nei con-fronti del Gabinetto, oppure possono assumere essi stessi le de-cisioni in determinate materie151, sebbene i ministri conservino ildiritto di appellarsi al Cabinet 152. La creazione di un sistema di
Limited, 1962. Il sistema dei committees britannici è stato ampiamente ripreso dalladottrina italiana che si è occupata di comitati interministeriali: si v., in particolare,l’accurata ricostruzione di G. QUADRI, I comitati, cit., pp. 61 ss.
147 Cfr. C. TURPIN, A. TOMKINS, British, cit., p. 402.148 Cfr., in merito, A.B. KEITH, The British, cit., p. 121.149 Sulle motivazioni che determinano la creazione, la composizione e la presi-
denza dei Cabinet committees si rinvia a S. JAMES, British, cit., pp. 61 ss.150 Per una classificazione dei Cabinet committees si v. S. JAMES, British, cit., pp.
62-63, e G.P. THOMAS, Prime Minister and Cabinet today, Manchester and New York,Manchester University Press, 1998, pp. 212-214.
151 Secondo G.P. THOMAS, Prime, cit., p. 211, infatti, «[t]he significance ofCabinet committees has grown and there is much controversy about whether they are avaluable aid to the system in the sense of taking the load of the Cabinet and allowing itto concentrate to the essentials, on the ‘major’ decisions, or whether they are a deviceused increasingly to bypass the Cabinet, to present it with decisions already made andgenerally to bolster the power of the Prime Minister».
152 In proposito, S. JAMES, British, cit., p. 59, osserva che tale eventualità «isfirmly discouraged». Si v. anche T. DAINTITH, A. PAGE, The Executive in the Consti-
104 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
Comitati, infatti, implica una devoluzione di autorità a tali organida parte del Cabinet, perciò le loro decisioni assumono lo stessovalore formale delle decisioni del Gabinetto153. È opportuno evi-denziare che le decisioni assunte dai Cabinet committees – la cuiattività è coperta da riservatezza154 – senza un successivo passag-gio nel Cabinet, impegnano ugualmente il Governo, il quale, per-tanto, risponde politicamente anche di tali decisioni155.
Attraverso l’utilizzo dei Cabinet committees, dunque, il Ca-binet dovrebbe potersi occupare solo delle questioni di maggioreimportanza, l’azione di governo dovrebbe diventare più agile edefficace – anche grazie al coordinamento tra i ministri interessatiad una data materia che i committees garantiscono – e il PrimoMinistro dovrebbe assumere un ruolo di maggiore preminenza,perché posto nella condizione di decidere confrontandosi neicommittees con un numero ridotto di ministri.
In effetti, il sistema di governo nel Regno unito ha assistito,soprattutto nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale,allo spostamento del decision-making power dal Gabinetto ad al-tri organi dell’Esecutivo, e, nello specifico, proprio ai Cabinetcommittees156. In seguito, però, si è passati all’utilizzo preminente
tution, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 53, secondo i quali «rights of appealto the full Cabinet are limited».
153 In questo senso S. JAMES, British, cit., p. 59, e C. TURPIN, A. TOMKINS, British,cit., p. 401. Cfr. altresì il Ministerial Code, 2010, par. 2.2, consultabile in www.cabine-toffice.gov.uk.
154 C. TURPIN, A. TOMKINS, British, cit., p. 402, G.P. THOMAS, Prime, cit., p. 212,ma anche A. TORRE, Il Cabinet system da Thatcher a Blair: leadership e Costituzione, inA. TORRE, L. VOLPE (a cura di), La Costituzione Britannica, vol. I, Torino, Giappichelli,2005, p. 353, nonché il Ministerial Code, cit., par. 2.1.
155 Così J. ALDER, Constitutional and Administrative Law, 3ª ed., Basingstokeand London, Macmillan Press Ltd, 1999, p. 253, nonché C. TURPIN, A. TOMKINS, Bri-tish, cit., pp. 376 ss. e 402. Si v. anche le osservazioni di H. BARNETT, Constitutionaland Administrative Law, 3ª ed., London and Sidney, Cavendish Publishing Limited,2000, p. 382, nonché il Ministerial Code, cit., par. 2.3. Sulla unanimity rule e sulla con-fidentiality rule si v. anche F. ROSA, Il controllo parlamentare sul governo nel RegnoUnito, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 15 ss.
156 Ad es., nei Governi presieduti da Clement Attlee e da John Major.
105I COMITATI INTERMINISTERIALI
di processi decisionali informali determinati dal Primo Ministro,che si svolgono al di fuori del Gabinetto ma anche degli stessiCabinet committees157. Ciononostante, anche Tony Blair – chepure ha fatto ricorso a modelli decisionali informali – ha ampia-mente utilizzato lo strumento dei committees: nel 2006, infatti,operavano ben 24 standing committees, di cui la metà presiedutidallo stesso Primo Ministro158, oltre ai sub-committees e agli adhoc committees.
La tendenza all’utilizzo di strumenti informali di governo hacomportato un ulteriore rafforzamento del ruolo del Primo Mi-nistro, nonché del Cabinet Secretariat e del Prime Minister’s Of-fice159. Ciò ha indotto parte della dottrina britannica a riteneresuperata l’idea tradizionale del Cabinet come «the most powerfulbody in the State»160. Tale opinione, però, appare forse affrettata,perché «[t]he role of the Cabinet in the working of central go-vernment is fluid and variable, and if Cabinet has suffered a de-cline it is not yet moribund»161. Invero, se si guarda all’attualecontesto politico inglese – che ha visto la formazione di un Go-verno di coalizione tra Conservatori e Liberaldemocratici, pre-
157 Ciò è accaduto innanzitutto ad opera di Margaret Thatcher, che ha preferitoil ricorso a gruppi di lavoro presieduti dallo stesso Prime Minister; durante i Governipresieduti da Tony Blair, poi, è prevalso il ricorso a riunioni ad hoc e discussioni bila-terali tra il Primo ministro e singoli ministri. Sulle modificazioni delle modalità di de-cision-making si rinvia a I. HOLLIDAY, Executives and Administrations, in P. DUNLEAVY,A. GAMBLE, R. HEFFERNAN, I. HOLLIDAY, G. PEELE (eds.), Developments in British Poli-tics 6, Basingstoke and New York, Palgrave, 2002, pp. 89 ss., C. TURPIN, A. TOMKINS,British, cit., pp. 395-397, nonché G. CARAVALE, Il Governo del premier nell’esperienzacostituzionale del Regno unito, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 59 ss.
158 L’elenco completo degli standing committees operanti nel 2006, dei loro pre-sidenti e delle materie di competenza può essere consultato in C. TURPIN, A. TOMKINS,British, cit., pp. 402-405.
159 Cfr. le osservazioni di G.P. THOMAS, Prime, cit., p. 216.160 Così W. BAGEHOT, The English Constitution [1867], London and Glasgow,
The Fontana Library, 1963, p. 68. Per la tesi che quello britannico non sia né un Primeministerial né un Cabinet Government, bensì un Governo caratterizzato dal c.d. coreexecutive si rinvia a I. HOLLIDAY, Executives, cit., pp. 88 ss.
161 Così C. TURPIN, A. TOMKINS, British, cit., p. 397.
106 PARTE SECONDA - CAPITOLO PRIMO
sieduto da David Cameron –162, si può osservare un revival delCabinet e dei suoi committees163. Indicativa di tale rinascita è lacreazione di un nuovo Cabinet committee (il Coalition commit-tee), che ha un rilievo notevole, perché il suo scopo è favorire erafforzare gli accordi tra i membri della coalizione, risolvendo glieventuali contrasti sorti fra gli stessi164.
La fluidità del ruolo del Governo britannico e della suastruttura, nonché la natura convenzionale delle norme che nereggono il funzionamento, dunque, non escludono che il ruolodel Cabinet e dei Cabinet committees nel sistema di governo bri-tannico possa mutare, considerato che tale ruolo dipende dallapersonalità e dallo stile politico del Prime Minister, nonché dallecontingenti circostanze politiche165.
162 Al riguardo si v., in italiano, M. OLIVETTI, Le elezioni del 6 maggio 2010 nelRegno Unito: Westminster adieu?, in Rassegna parlamentare, 2010, n. 3, pp. 747 ss.
163 Così R. HAZELL, B. YONG, Inside Story: How Coalition Government Works.Interim Report, 3 giugno 2011, pp. 1 ss., consultabile in www.ucl.ac.uk.
164 Il governo di coalizione ha creato un ulteriore organo ristretto, il CoalitionOperation and Strategic Planning Group (COSPG); quest’ultimo, però, non è propria-mente un Cabinet committee, bensì un gruppo di lavoro, comunque fondamentale ne-gli equilibri della coalizione di governo (cfr. R. HAZELL, B. YONG, Inside, cit., p. 4). L’e-lenco dei Cabinet committees attualmente costituiti, con l’indicazione della loro com-posizione e delle relative funzioni, è consultabile in www.cabinetoffice.gov.uk.
165 Secondo G.P. THOMAS, Prime, cit., p. 192, infatti, «[i]t is impossible to defini-tely state the role of the Cabinet and what its functions are. A great deal depends on thepersonalities involved and the political circumstances at any particular time».
107I COMITATI INTERMINISTERIALI
CAPITOLO SECONDO
I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2.1. Il Consiglio supremo di difesa come comitato inter-ministeriale: critica. – 2.2. Il Consiglio di Gabinetto come comitato intermi-nisteriale: critica. – 3. L’evoluzione del sistema dei comitati. – 4.1. I comitatiinterministeriali attualmente operanti: il CICR. – 4.2. Il CIPE. – 4.3. Il CIACE. –4.4. Il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle po-litiche di semplificazione e di qualità della regolazione. – 4.5. Il CISR. – 4.6. IlComitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica.
1. Premessa
Dopo aver esaminato gli aspetti teorici maggiormente pro-blematici che riguardano i comitati interministeriali complessiva-mente intesi, occorre analizzare i singoli organi, riassumendo itratti essenziali dei comitati soppressi e dedicando una maggioreattenzione ai singoli comitati ancora esistenti e a quelli di recenteistituzione. A tale analisi occorre premettere una breve disaminasu due organi che sono stati accostati da parte della dottrina alfenomeno dei comitati interministeriali: il Consiglio supremo didifesa e il Consiglio di Gabinetto.
2.1. Il Consiglio supremo di difesa come comitato interministe-riale: critica
Il Consiglio supremo di difesa è un organo previsto dall’art.87, co. 9, Cost., che si limita a disporre che esso è presieduto dal
Presidente della Repubblica ed è costituito secondo la legge1.Per quanto attiene ai suoi compiti, «[i]l Consiglio supremo di di-fesa esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla di-fesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l’orga-nizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la ri-guardano»2, provvedendo, altresì, ad esaminare le deliberazioniin materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo e approvatedal Parlamento3. L’organo si riunisce almeno due volte l’anno edè convocato dal Presidente della Repubblica tutte le volte che sene ravvisi la necessità, d’iniziativa dello stesso Presidente dellaRepubblica o su proposta del Presidente del Consiglio dei mini-stri4. Il Consiglio supremo di difesa è composto dal Presidentedella Repubblica, che lo presiede, dal Presidente del Consigliodei ministri, che ne è il vice presidente, da cinque ministri e dalCapo di stato maggiore della difesa5. Partecipa alle riunioni delConsiglio supremo di difesa anche il segretario dell’organo, chenon può essere scelto tra i componenti dello stesso6. Il Presi-dente della Repubblica, inoltre, può convocare alle riunioni delConsiglio anche altri ministri oppure degli esperti7.
Il Consiglio supremo di difesa solleva numerosi dubbi rela-tivi alla sua posizione nell’ordinamento, alla sua composizione ealle sue competenze. Per quanto riguarda, in particolare, le com-petenze, all’organo non sono attribuite solo funzioni consultive
1 La legge istitutiva dell’organo è la l. 624/1950; si rinvia, inoltre, al regolamentointerno dell’organo (approvato con il d.p.r. 251/1990) e a quello dell’ufficio di segre-teria (approvato con il d.p.r. 389/1992).
2 Così la l. 624/1950, art. 1, co. 2.3 Cfr. l’art. 1, co. 1, lett. a, della l. 25/1997.4 Cfr. la l. 624/1950, art. 7, e il d.p.r. 251/1990, art. 2.5 Cfr. la l. 624/1950, art. 2, co. 1, secondo il quale i ministri che compongono il
Consiglio supremo di difesa sono: il ministro per gli affari esteri; il ministro per l’in-terno; il ministro per il tesoro; il ministro per la difesa; il ministro per l’industria ed ilcommercio. Si v. anche il d.p.r. 251/1990, art. 5.
6 Cfr. la l. 624/1950, art. 2, co. 2. Si v. anche il d.p.r. 251/1990, artt. 12, 13 e 14,e il d.p.r. 389/1992, art. 1, co. 2.
7 Cfr. la l. 624/1950, art. 3, e il d.p.r. 251/1990, artt. 7 e 10.
110 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
ma anche la determinazione delle direttive in materia di difesa8.Così, ad un organo presieduto dal Capo dello Stato sembra es-sere attribuita la funzione di indirizzo politico nel settore delladifesa, con la conseguente possibilità, da un lato, di minare ilruolo super partes della più alta carica dello Stato, dall’altro, disottrarre al rapporto fiduciario Governo-Parlamento la responsa-bilità per gli atti assunti in seno a tale organo, anche perché gliatti assunti dal Presidente della Repubblica come componente diorgani collegiali rientrano tra quelli esenti da controfirma mini-steriale9.
Il contesto normativo così riassunto ha indotto parte delladottrina a considerare il Consiglio supremo di difesa un organodel Governo, assimilabile, in particolare, ad un comitato intermi-nisteriale volto alla definizione dell’indirizzo politico governativoin materia di difesa10. Questa tesi, tuttavia, non pare condivisibile.
8 Nonostante un’apposita commissione di studio avesse ritenuto l’organo comemeramente consultivo e, di conseguenza, avesse proposto l’abrogazione della secondaparte del co. 2, art. 1, della l. 624/1950, la disposizione è rimasta in vigore e con la giàcitata l. 25/1997 si sono anche ampliate le competenze dell’organo (cfr. Relazione dellaCommissione istituita dal Governo Goria per l’esame dei problemi costituzionali concer-nenti il comando e l’impiego delle Forze Armate, in Quaderni costituzionali, 1988, n. 2,pp. 318 ss.). S. LABRIOLA, Il comando supremo delle forze armate, in Studi parlamentarie di politica costituzionale, 1980, n. 49-50, p. 70, definiva “infelice” la formulazionedella legge sul Consiglio supremo di difesa. Sull’attribuzione all’organo della funzionedi indirizzo nel settore della difesa si v. G. DE VERGOTTINI, Art. 87, in G. BRANCA (acura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano,1978, pp. 257 ss., e A. MANZELLA, Il Capo di Stato in «Consiglio supremo di difesa», inQuaderni costituzionali, 1987, n. 2, part. pp. 235 ss.
9 Sulla esclusione della controfirma ministeriale per tali atti si v., ex plurimis, G.GUARINO, Il Presidente della Repubblica italiana, in Rivista trimestrale di diritto pub-blico, 1951, pp. 973-974, C. ESPOSITO, Saggio sulla controfirma ministeriale, in ID., Capodello Stato - Controfirma ministeriale, Milano, Giuffrè, 1962, p. 79, M.P. VIVIANI SCH-LEIN, Irresponsabilità del Capo dello Stato e controfirma ministeriale in Italia e in Fran-cia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1982, pp. 123-124, e C. ROSSANO, Presi-dente della Repubblica I) Diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica, vol. XXIV,Roma, Treccani, 2002, p. 5.
10 Considerano il Consiglio supremo di difesa un comitato interministeriale: G.TREVES, Comitato, cit., pp. 596-597, F. CUOCOLO, Il Governo, cit., pp. 247-248 (seb-bene non lo consideri un comitato interministeriale in senso proprio), G. QUADRI, I co-
111I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
In primo luogo, il Consiglio supremo di difesa è un organo previ-sto dalla Costituzione, a differenza dei comitati interministerialiche, come si è cercato di appurare, rappresentano degli organinon necessari del Governo. La presidenza dell’organo, poi, è at-tribuita – in quanto comandante delle Forze armate11 – al Presi-dente della Repubblica, che non è un esponente dell’Esecutivo.Infine, sebbene la composizione dell’organo induca a ritenere chele decisioni assunte rispondano all’indirizzo governativo, conside-rata la presenza alle riunioni del Presidente del Consiglio e di al-meno cinque ministri12, nonché per il rilievo assunto dal premierall’interno dell’organo in virtù del d.p.r. 251/199013, il Consigliosupremo di difesa – a differenza dei comitati interministeriali –non è soggetto alle direttive del Consiglio dei ministri, ma – aisensi della l. 624/1950 – potrebbe determinare i criteri e fissare ledirettive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività ine-renti la difesa nazionale, configurandosi come un organo non su-bordinato all’Esecutivo ma che, al contrario, potrebbe addiritturavincolare le decisioni del Governo in materia di difesa14. Sembradoversi escludere, pertanto, la possibilità di assimilare il Consigliosupremo di difesa ai comitati interministeriali.
mitati, cit., pp. 181 ss., C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., p. 568, T. MARTINES, Di-ritto, cit., p. 436, e, sembrerebbe, M. GIUSTI, Fondamenti, cit., p. 23. Contra V. BACHE-LET, Comitati, cit., pp. 764-765, G. BALLADORE PALLIERI, Diritto, cit., p. 310, F. ORFINO,I comitati, cit., p. 27, S. LABRIOLA, Consiglio supremo di difesa, in Enciclopedia giuridica,vol. VIII, Roma, Treccani, 1988, p. 4, G. FALCON, Lineamenti, cit., p. 237, G.M. SA-LERNO, B. MALAISI, Art. 87, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Com-mentario, vol. II, cit., p. 1702, e, da ultimo, R. BELLANDI, Il Consiglio supremo di difesa,Bologna, il Mulino, 2011, part. p. 40 e nt. 22, pp. 118-119.
11 In questo senso G. MOTZO, Consiglio supremo di difesa, in Enciclopedia del di-ritto, vol. IX, Milano, Giuffrè, 1961, p. 338.
12 In merito si v. le osservazioni di C. MORTATI, Istituzioni, tomo II, 9ª ed., Pa-dova, Cedam, 1976, pp. 656-657.
13 Cfr. G. GUIGLIA, Il regolamento di attuazione del Consiglio supremo di difesa ei rapporti tra Presidente della Repubblica e Presidente del consiglio dei ministri, in Qua-derni costituzionali, 1991, n. 1, pp. 126 ss.
14 Si v., per tali dubbi, V. BACHELET, Comitati, cit., pp. 764-765, A. TESAURO, Isti-tuzioni, cit., pp. 330-331, T. MARTINES, Indirizzo, cit., p. 156 nt. 88, G. FALCON, Linea-
112 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
2.2. Il Consiglio di Gabinetto come comitato interministeriale: cri-tica
Un altro organo che viene paragonato ai comitati intermini-steriali è il Consiglio di Gabinetto, disciplinato – in maniera assaiscarna – dalla l. 400/1988 ma costituito già nel 198315, nonostantein Assemblea costituente non fosse stato accolto l’emendamentopresentato da Clerici volto a prevederlo in Costituzione16.
Secondo la l. 400/1988, «[i]l Presidente del Consiglio deiministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall’articolo95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato daun Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed ècomposto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio deiministri»17. Il Consiglio di Gabinetto, dunque, è un comitato ri-stretto di ministri che coadiuva il Presidente del Consiglio nelladirezione della politica generale del Governo, nel mantenimentodell’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, nonché nellapromozione e nel coordinamento dell’attività dei ministri.
La composizione del Consiglio di Gabinetto è elastica ed èrimessa alla scelta del Presidente del Consiglio: questi, infatti,designa i ministri che normalmente entrano a far parte dell’or-gano e può anche decidere se «invitare a singole sedute del Con-
menti, cit., p. 237, G.M. SALERNO, B. MALAISI, Art. 87, cit., pp. 1702 ss., nonché F. DI-MORA, Art. 87, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario, cit., pp. 787 ss. Si v.,inoltre, A. BARONE, Il Consiglio supremo di difesa, in Diritto e società, 1982, part. pp.480-481, secondo il quale le direttive del Consiglio supremo di difesa si configurereb-bero alla stregua di proposte facoltative, non vincolanti per il Governo.
15 Il Consiglio di Gabinetto, infatti, era stato istituito il 5 agosto 1983, ma pos-sono rinvenirsi dei precedenti nei consigli ristretti di ministri (denominati, appunto,Consiglio di Gabinetto oppure Consiglio di Presidenza) istituiti negli anni immediata-mente precedenti l’approvazione della Costituzione. Si v., in proposito, G. GUARINO,Due anni di esperienza costituzionale italiana, in Rassegna di diritto pubblico, 1946, pp.73 ss., P. VIRGA, La crisi, cit., p. 47 e nt. 37, G. TREVES, I comitati, cit., p. 222, G. PI-TRUZZELLA, Il Consiglio, cit., pp. 641 ss., nonché F. BAGNAI, Il consiglio, cit., pp. 227-228, nt. 1 e 2, e le considerazioni di L. ELIA, Il «direttorio», cit., pp. 2813 ss.
16 Su tale emendamento si rinvia a quanto già osservato supra, parte I, cap. I,par. 3.4.
17 Così la l. 400/1988, art. 6, co. 1.
113I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
siglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro compe-tenza»18.
Come si è già accennato, anche il Consiglio di Gabinetto èstato considerato un comitato interministeriale a causa delle nu-merose assonanze tra le due tipologie di organi: la configura-zione come organi non necessari del Governo; la comune originedalla prassi e il successivo sintetico recepimento operato dallalegge sulla Presidenza del Consiglio; il nomen “comitato” utiliz-zato dalla l. 400/1988 per entrambi gli organi; l’elasticità dell’or-ganizzazione interna; i dubbi inerenti la violazione della par con-dicio tra ministri e la responsabilità per gli atti di tali organi19.
Le differenze esistenti tra Consiglio di Gabinetto e comitati,tuttavia, suggeriscono di tenere distinti i due organi. In primoluogo, mentre i comitati interministeriali sono istituiti per occu-parsi di specifici settori dell’amministrazione pubblica, il Consi-glio di Gabinetto è un organo costituito per coadiuvare il Presi-dente del Consiglio nell’intera attività di Governo e non di unsolo e specifico settore di questa20. Da questa prima osservazionediscende che il Consiglio di Gabinetto non è composto dai mini-stri competenti o interessati ad una data materia – come accade,di solito, per i comitati interministeriali –, bensì dagli esponenti
18 Cfr. la l. 400/1988, art. 6, co. 2.19 Considerano il Consiglio di Gabinetto un comitato interministeriale (o di mi-
nistri): G. TREVES, I comitati, cit., p. 222, G. CUOMO, Unità, cit., pp. 59 ss., F. CUOCOLO,Il Governo, cit., pp. 245 ss., il quale, però, ritiene l’organo inammissibile nel sistemacostituzionale italiano (si v. anche ID., Consiglio, cit., p. 242), E. FOLLIERI, Quadro po-sitivo dell’organizzazione amministrativa statale, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. RO-MANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA (a cura di), Diritto amministrativo, vol. I, 3ªed., Bologna, Monduzzi, 2001, p. 657, e, sebbene in maniera dubitativa, S. MERLINI, IlGoverno, cit., pp. 174 e 191-192.
20 In questo senso V. BACHELET, Comitati, cit., p. 765, F. ORFINO, I comitati, cit.,p. 28, S. LABRIOLA, Presidente della Repubblica, struttura del Governo, Consiglio di Ga-binetto, in Diritto e società, 1985, pp. 332-333, G. FOCACCIA, Consiglio di Gabinetto eorganizzazione del Governo, in Diritto e società, 1986, pp. 734-735, ID., Collegialità ri-stretta e razionalizzazione della struttura di governo, in Diritto e società, 1987, p. 315, F.BAGNAI, Il consiglio, cit., p. 229, e G.U. RESCIGNO, Consiglio di Gabinetto, in Enciclo-pedia del diritto, agg., vol. II, Milano, Giuffrè, 1998, p. 240.
114 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
di maggiore rilievo politico dell’Esecutivo, tanto da poter diven-tare – di fatto – l’organo all’interno del quale viene effettiva-mente determinato l’indirizzo politico governativo21. Inoltre, ilConsiglio di Gabinetto non solo è un organo non necessario delGoverno (come i comitati interministeriali) ma è anche un or-gano la cui istituzione è solo eventuale. Esso, infatti, può essereistituito dal singolo Presidente del Consiglio laddove – anche invirtù delle caratteristiche della maggioranza che sostiene il Go-verno – appaia utile o necessario un collegio ristretto che lo coa-diuvi nelle sue funzioni. I comitati interministeriali, invece, sonocostituiti sulla scorta del relativo atto istitutivo e continuano adoperare sino a quando questo non viene abrogato o sino al ter-mine indicato dallo stesso atto – ove si tratti di comitati tempo-ranei –, sicché gli esponenti di ogni Esecutivo fanno comunqueparte dei comitati interministeriali secondo quanto previsto dallostesso atto istitutivo.
3. L’evoluzione del sistema dei comitati
Dopo aver escluso l’assimilazione del Consiglio supremo didifesa e del Consiglio di Gabinetto ai comitati interministeriali,occorre occuparsi dei singoli comitati interministeriali, partendodalla ricostruzione dell’evoluzione dell’intero sistema formato datali organi.
Come si è visto, i primi comitati interministeriali furono isti-
21 Al riguardo si v.: L. PRETI, Il Governo, cit., pp. 32-33, V. BACHELET, Comitati,cit., p. 765, G. PITRUZZELLA, Il Consiglio, cit., pp. 659 ss., ID., Artt. 92-93, cit., pp. 142ss., L. PALADIN, Verso, cit., p. 306, G. FOCACCIA, Collegialità, cit., p. 315, G. DE VER-GOTTINI, Per una razionalizzazione, cit., pp. 326 ss., L. VENTURA, Il Governo, cit., pp.170 ss., S. LABRIOLA, Il Governo, cit., pp. 111 ss., V. ONIDA, A. D’ANDREA, G. GUIGLIA,L’ordinamento, cit., p. 269, F. BAGNAI, Il consiglio, cit., pp. 230-231, P. BARILE, Consi-glio, cit., p. 9, S. BARTOLE, Governo, cit., pp. 640-641, P. CIARLO, Art. 95, cit., pp. 395ss., T. MARTINES, Diritto, cit., pp. 413-414, G. FALCON, Lineamenti, cit., p. 231. Si rin-via anche a P. GIOCOLI NACCI, Articolazioni, cit., pp. 10 ss., il quale osserva che i mini-stri partecipano al Consiglio di Gabinetto iure proprio e non ratione officii, e a F. ME-RUSI, Le direttive, cit., p. 89.
115I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
tuti già durante il fascismo e si sono moltiplicati negli anni suc-cessivi. Questi organi avevano prevalentemente attribuzioni dicarattere tecnico nell’amministrazione pubblica dell’economia,perché consentivano di assumere decisioni di carattere premi-nentemente tecnico all’interno di organi collegiali più ristretti ri-spetto al Consiglio dei ministri, consentendo la partecipazionealle riunioni anche di esperti22. Pertanto, una prima giustifica-zione della proliferazione dei comitati interministeriali consisteproprio nel loro utilizzo come strumenti volti a garantire l’inter-vento pubblico nell’economia, insieme ad altri strumenti quali laprogrammazione, le partecipazioni statali, i piani, ecc.23. La mol-tiplicazione di tali organi, tuttavia, deriva anche dalla strutturadel Governo e dalle dinamiche dei rapporti politici. Relativa-mente al primo aspetto, l’alto numero di ministeri rendeva diffi-cile assumere agevolmente quelle decisioni che coinvolgevano lecompetenze di più dicasteri, così da rendere consigliabile la crea-zione di organi all’interno dei quali sedevano tutti i ministri in-teressati ad una data materia. Per quanto riguarda il secondoprofilo, il rilievo politico che il presidente di ciascun comitatopoteva assumere, induceva ogni ministro a pretendere la costitu-zione di un comitato interministeriale da presiedere, favorendo ilproliferare di centri di decisione separata, gestiti in maniera pres-soché autonoma da ogni ministro, tanto da giustificare la defini-zione critica di tale fenomeno come “feudalesimo ministeriale”24.
Paradigma di tale situazione può essere considerata la proli-ferazione di comitati interministeriali che si affiancavano (o,forse sarebbe più proprio affermare, si sovrapponevano) ai sin-
22 Si v., in proposito, M. GIUSTI, Fondamenti, cit., pp. 22-23.23 Dubbi sull’effettiva capacità dei comitati interministeriali (ma anche della
programmazione, delle direttive, della disciplina dei prezzi, delle partecipazioni statali,degli aiuti e delle incentivazioni) di stimolare e guidare il processo economico nazio-nale sono espressi da G. GUARINO, Pubblico e privato nella economia. La sovranità traCostituzione ed istituzioni comunitarie, in Quaderni costituzionali, 1992, n. 1, p. 61.
24 L’espressione è ripresa da G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, cit., p. 141. Analoga-mente C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., p. 571, paragonava il comportamento deiministri a quello di “signori feudali”.
116 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
goli ministeri. Si pensi, ad esempio, al binomio costituito dal mi-nistero dell’industria e dal Comitato interministeriale per il coor-dinamento della politica industriale (CIPI)25, oppure al ministeroper l’agricoltura e al Comitato interministeriale per la politicaagricola e alimentare (CIPAA)26, o, ancora, al ministero per le par-tecipazioni statali e al Comitato permanente per le partecipazionistatali (c.d. CIPPSS)27.
Per quanto riguarda nello specifico i comitati economici, inumerosi comitati interministeriali che si occupavano di econo-mia e finanza28 finivano con l’assumere determinazioni contra-stanti tra loro29, tanto da indurre ad assoggettarli alle direttive
25 Istituito dall’art. 1 della l. 675/1977 e soppresso dall’art. 1, co. 21, della l.537/1993. Sul CIPI si rinvia a M. LIBERTINI (a cura di), Legge 12 agosto 1977, n. 675, inLe nuove leggi civili commentate, 1978, pp. 613 ss., e E. D’ANIELLO, Modalità di deter-minazione degli indirizzi di politica industriale e sistema di governo delle agevolazioni fi-nanziarie nella legge n. 675 del 1977, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1978, pp.940 ss.
26 Istituito dall’art. 2 della l. 984/1977 e soppresso dall’art. 2, co. 1, della l.752/1986. Sul CIPAA si rinvia a G. ENDRICI, F. ZUELLI, Amministrazione pubblica dell’e-conomia, in F. VASSALLI, G. VISENTINI (a cura di), Legislazione economica, vol. II, Mi-lano, Giuffrè, 1979, pp. 400 ss., e S. CHIARI, Gli interventi nel settore agricolo, in D.SORACE (a cura di), I Comitati interministeriali economici, Bologna, il Mulino, 1991,pp. 91 ss.
27 Istituito con l’art. 4 della l. 1589/1956, e soppresso dal d.p.r. 554/1967. Sullasoppressione di tale comitato e, più in generale, sul sistema delle partecipazioni statalisi v. G. GUARINO, Leggi recenti e sistema delle partecipazioni statali, in Rivista trime-strale di diritto pubblico, 1968, pp. 1129 ss., S. CASSESE, Il controllo delle partecipazionistatali, ivi, 1980, pp. 1215 ss., e G. VESPERINI, I fondi di dotazione delle partecipazionistatali e l’approvazione da parte del CIPE della loro ripartizione: un episodio di mano-missione del «sistema», in Giurisprudenza commerciale, 1985, pp. 653 ss.
28 Tra i comitati interministeriali economici soppressi, oltre a quelli indicati nellenote precedenti, si ricordano: i già citati CIR (soppresso dall’art. 18 della l. 48/1967,istitutiva del CIPE), CIP (soppresso dalla l. 537/1993, art. 1, co. 21), CISMEZ e CIPES
(soppresso dalla l. 537/1993, art. 1, co. 21), nonché il Comitato interministeriale per laprogrammazione economica nel trasporto (CIPET) (istituito dall’art. 34, co. 3, della l.41/1986, e soppresso dalla l. 537/1993, art. 1, co. 21). Per una rassegna di tali comitatisi rinvia a G. QUADRI, I comitati, cit., pp. 202 ss., e P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp.154 ss.
29 In questo senso M.S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, ilMulino, 1977, p. 283.
117I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
del CIPE30, al fine di garantire un coordinamento tra tali organi.La creazione di un sistema di comitati “a cascata”31, tuttavia, nonsolo non riusciva a realizzare un effettivo coordinamento di talesistema, ma rendeva anche praticamente impossibile consentireuna chiara attribuzione di responsabilità per i loro atti32.
La situazione descritta ha indotto il legislatore – con la l.400/1988 – a delegare il Governo ad adottare, entro un annodalla data di entrata in vigore della stessa legge33, norme aventivalore di legge ordinaria volte a ridurre e riordinare i comitati diministri, compresi quelli non istituiti con legge, e i comitati in-terministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del CICR,puntando ad eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di compe-tenze, nonché a coordinare le attività inerenti a settori omogeneidi competenza anche se ripartiti fra più ministeri34. Nonostantela proroga del termine per procedere al riordino del sistema deicomitati, questa previsione della legge sulla presidenza del Con-siglio non è stata attuata, tanto che solo nel 1993 si è provveduto– direttamente con legge35 – a sopprimere una parte dei comitati
30 Si consideri, ad es., che il CICR, il CIP e il CIPI erano soggetti alle direttive delCIPE ai sensi del d.p.r. 626/1968, artt. 1 (abrogato dall’art. 1, co. 7, del d.l. 386/1991,convertito dalla l. 35/1992) e 2, e della l. 675/1977, art. 1, oppure che il CISMEZ (art. 5del d.p.r. 1523/1967) e il CIPES (art. 1 della l. 227/1977) erano costituiti nell’ambitodello stesso CIPE. Si rinvia, peraltro, alle perplessità manifestate da E. D’ANIELLO, IlComitato interministeriale per la programmazione economica, in Rivista trimestrale didiritto pubblico, 1973, pp. 113 ss.
31 L’espressione è utilizzata da P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 233, ed è ripresaanche da P. CIARLO, Art. 95, cit., p. 388. P. CALANDRA, Problemi e proposte sull’ordina-mento della Presidenza del Consiglio, in Quaderni costituzionali, 1982, n. 1, p. 36, in-vece, parlava di una «articolazione formalmente piramidale, imperniata su un rapportoConsiglio ministri-CIPE-comitati, vincolati da eventuali direttive».
32 In proposito si v. le osservazioni di P. CIARLO, Art. 95, cit., pp. 387-388, e P.CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 232 ss.
33 Termine prorogato al 31 dicembre 1989 dall’art. 6-ter, co. 4, del d.l. 245/1989,convertito dalla l. 288/1989.
34 Così la l. 400/1988, art. 7, co. 1. Si consideri, peraltro, che già la legge istitu-tiva del CIPE delegava il Governo a provvedere al riordino del sistema dei comitatioperanti in materia economico-finanziaria (cfr. l’art. 18 della l. 48/1967).
35 Si tratta della già citata l. 537/1993 (si v. in particolare l’art. 1, co. 21, 24 e 25).
118 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
allora esistenti36, intervenendo successivamente per riordinare ilcomplesso delle competenze dei comitati soppressi, con la loroattribuzione prevalentemente al CIPE37.
I motivi che hanno portato al ridimensionamento del si-stema dei comitati sono diversi.
Innanzitutto, il processo di integrazione comunitaria, condi-zionando le politiche economiche degli Stati membri dell’Unioneeuropea, ha limitato i margini per un intervento pubblico nell’e-conomia, rendendo necessario anche un ridimensionamentodella relativa organizzazione statale38. Questa situazione ha resopoco giustificabile la presenza di buona parte dei comitati inter-
Appare utile evidenziare sin d’ora che tale intervento normativo segue la riforma elet-torale in senso maggioritario (sulla quale si v. infra, parte III).
36 La l. 537/1993, art. 1, co. 21, infatti, prevedeva: «Sono soppressi il Comitatointerministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato in-terministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministerialeper la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitatointerministeriale per l’emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tuteladelle acque dall’inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitatointerministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comi-tato interministeriale per la lotta all’AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambidi materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestionefondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta ec-cezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Co-mitato interministeriale per l’indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventiper la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati in-terministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro de-legati». Il co. 25 dello stesso articolo, inoltre, prevedeva: «Con regolamento da ema-narsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cen-tottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definitel’organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informa-zioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli in-terventi nel settore della difesa del suolo».
37 Si v., in particolare, il d.p.r. 373/1994 e il d.lgs. 430/1997.38 Si v., in proposito, G. GUARINO, Pubblico, cit., part. pp. 54-55, nonché R. CA-
RANTA, Intervento pubblico nell’economia, in Digesto delle discipline pubblicistiche, agg.,Torino, Utet, 2000, pp. 371 ss. Si v. anche le osservazioni di A. D’ANDREA, Osservazioniconclusive, in ID. (a cura di), Verso l’incerto bipolarismo, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 632ss., e S. CASSESE, La riforma costituzionale in Italia, in Rivista trimestrale di diritto pub-blico, 1992, n. 4, p. 906.
119I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
ministeriali economici39 – che, come si è già visto, rappresenta-vano la maggioranza dei comitati stessi –, inducendo il legislatorea sopprimere i comitati con competenze economiche, salvo ilCIPE e il CICR40.
In secondo luogo, l’evoluzione della forma di governo e leriforme elettorali in senso maggioritario hanno favorito il raffor-zamento del ruolo del Presidente del Consiglio e il ridimensiona-mento del principio della indipendenza dei singoli ministri all’in-terno del Governo, tanto da rendere meno sostenibile la richiestada parte di ogni ministro di istituire un comitato da presiedere41.
In connessione con quest’ultimo motivo, si consideri ancheche la riduzione del numero di ministeri ha consentito di accor-pare le competenze prima distribuite tra molteplici dicasteri;questa situazione ha reso meno impellente la necessità di istituireorgani all’interno dei quali comporre i vari interessi in gioco42.
Un ulteriore motivo di riduzione del numero di comitati èravvisabile nella costituzione di numerose Autorità indipendenti,«viste come strumento con il quale il Governo interviene per ri-solvere problemi o evidenziare tutele che gli apparati esistenti,Comitati interministeriali compresi, si erano dimostrati non es-sere le strutture adeguate a gestire con l’agilità anche organizza-tiva necessaria»43.
39 Secondo G. GUARINO, Pubblico, cit., p. 46, infatti, i «Comitati potranno for-malmente rimanere in vita, ma è certo che le loro funzioni di indirizzo, nelle quali siesprimeva la loro peculiarità, sono venute di fatto a cessare. In una fase in cui persinola dimensione della organizzazione da fattore primario quale era deve oggi confor-marsi alle esigenze imposte dal mercato unificato, non si vede quali indirizzi possonoelaborarsi dai Comitati che non siano quelli del pressante adeguamento alle leggi delmercato unificato e della concorrenza tra sistemi».
40 Per i dubbi sollevati dalla mancata soppressione del CICR si rinvia infra, parteII, cap. II, par. 4.1.
41 Si consideri, a tal proposito, la già indicata soppressione dei comitati intermi-nisteriali che sembravano affiancarsi ai singoli ministeri.
42 In questo senso A. RAVALLI, I comitati interministeriali, cit., p. 30. Sulla ridu-zione del numero dei ministeri e sul loro successivo nuovo incremento si v. supra, parteI, cap. I, par. 5.3., e infra, parte III, cap. II, par. 2.5.3.
43 A. RAVALLI, I comitati interministeriali, cit., pp. 30-31.
120 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
Un altro fenomeno che ha contribuito alla riduzione del nu-mero di comitati interministeriali è quello relativo alla separa-zione tra politica e amministrazione. Infatti, se si ridefiniscono icompiti da attribuire alla politica ed alla burocrazia, assegnandoalla prima funzioni di indirizzo e controllo e alla seconda la con-creta gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ai comitatiinterministeriali dovrebbero essere sottratte le funzioni pretta-mente amministrative, con conseguente riduzione del loro nu-mero44. La tendenza alla separazione tra politica e amministra-zione – non sempre perseguita in maniera lineare45 –, peraltro,dovrebbe portare alla riduzione dei comitati a carattere preva-lentemente amministrativo, ma non di quelli che rientrano nel-l’organizzazione del Governo. Relativamente a questi ultimi, in-fatti, anziché una riduzione del loro numero, dovrebbe aversisolo una riduzione delle competenze prettamente amministrativeloro attribuite46. Ma la maggiore caratterizzazione politica cosìacquisita dovrebbe rappresentare una conferma dell’apparte-nenza dei comitati interministeriali alla struttura dell’Esecutivo47.
Sintetizzata l’evoluzione del sistema dei comitati intermini-steriali, occorre considerare ora nel dettaglio i singoli comitati at-
44 Si v., in proposito, A. RAVALLI, I comitati interministeriali, cit., p. 30.45 Si pensi, ad es., alla riforma degli uffici di diretta collaborazione dei ministri
conseguente al d.lgs. 165/2001, art. 14, co. 2. Secondo S. BATTINI, Gli uffici di staff deiministri: diversi ma uguali?, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, n. 3, p. 676,infatti, mentre «il vincolo di fiducia si afferma dove in teoria non dovrebbe (il verticedegli uffici di line), esso non si afferma dove in teoria dovrebbe (la base degli uffici distaff). Il risultato è l’applicazione di un principio uniforme, che interessa tutti gli ufficiamministrativi, indipendentemente dalla loro collocazione nella line o nello staff. E ilprincipio è il seguente: i vertici sono precari e politicizzati; la base è inamovibile. Chetale principio risponda al significato più autentico della distinzione tra politica e am-ministrazione, è da escludere. Che esso corrisponda alle intenzioni reali del legislatore,è difficile a dirsi. Che esso sia il risultato concreto dell’applicazione della disciplina diriforma, comincia ad apparire chiaro».
46 È quanto accaduto, ad es., al CIPE: cfr. infra, parte II, cap. II, par. 4.2.47 Secondo S. CASSESE, R. PEREZ, Istituzioni, cit., p. 187, i comitati interministe-
riali dovrebbero avere solo compiti di indirizzo, perché quelli di carattere amministra-tivo ne «appesantiscono l’attività».
121I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
tualmente operanti, indipendentemente dal momento in cui sonostati istituiti, al fine di ricostruire le caratteristiche dell’attuale si-stema di comitati. I comitati che saranno esaminati nelle pros-sime pagine, quindi, sono: il CICR, il CIPE, il CIACE, il Comitatointerministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politi-che di semplificazione e di qualità della regolazione, il CISR e ilComitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica.
4.1. I comitati interministeriali attualmente operanti: il CICR
Il primo comitato interministeriale tra quelli ancora operantidi cui occorre occuparsi è quello istituito da più tempo: il CICR.Come si è già visto, il CICR fu istituito già durante il fascismo48, mala sua disciplina è stata sensibilmente modificata nel 199349.
Il comitato è stato istituito al fine di costituire il vertice ditutto l’ordinamento costituzionale e amministrativo del credito edel risparmio50; occorre verificare, tuttavia, la sua attuale posi-zione nel sistema, alla luce delle numerose riforme e modifica-zioni seguite all’istituzione dell’organo.
Secondo quanto previsto dal d.lgs. 385/1993, art. 2, co. 1, ilCICR è composto dal ministro dell’economia e delle finanze, chelo presiede, dal ministro del commercio internazionale, dal mini-stro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal ministrodello sviluppo economico, dal ministro delle infrastrutture, dalministro dei trasporti e dal ministro per le politiche comunitarie;alle sedute, inoltre, partecipa il Governatore della Banca d’Italia.A singole riunioni dell’organo il presidente del comitato può in-vitare – a fini consultivi – altri ministri o «i Presidenti delle altre
48 … con il già citato r.d.l. 375/1936, convertito dalla l. 141/1938. Il comitato fusoppresso con il d.lgs.lgt. 226/1944 e nuovamente istituito con il d.lgs.c.p.s. 691/1947.Si rinvia anche a quanto già osservato supra, parte I, cap. I, par. 2.2.
49 Ad opera del d.lgs. 385/1993 e successive modificazioni.50 Così G. QUADRI, I comitati, cit., p. 248, al quale si rinvia anche per l’analisi del
ruolo e delle competenze dell’organo ai sensi della normativa degli anni 1940-50 (pp.248 ss.). Si v. altresì F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, il Mulino,2000, part. pp. 47 ss.
122 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cuivengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuitedalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, traspa-renza ed efficienza del sistema finanziario»51.
Per quanto riguarda il funzionamento, il CICR è abilitato adeterminare le norme concernenti la propria organizzazione e ilproprio funzionamento; in ogni caso, le sedute dell’organo sonovalidamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoimembri ed esso delibera con il voto favorevole della maggio-ranza dei presenti. Infine, le funzioni di segretario sono eserci-tate dal direttore generale del tesoro52.
Il CICR svolge numerose funzioni che possono essere rias-sunte nell’esercizio dell’alta vigilanza in materia di credito e ditutela del risparmio e nel compito di deliberare nelle materie at-tribuite alla sua competenza dal d.lgs. 385/1993 o da altre leggi53.Si pensi, ad esempio, ai compiti in materia di credito agevolato alsettore industriale54, oppure a quelli relativi alla attuazione di di-rettive comunitarie55. Tra le funzioni del comitato, sollevano nu-merosi dubbi quelle che si intrecciano con le competenze dellaBanca d’Italia. Il CICR, infatti, conserva il potere di emanare, suproposta della Banca d’Italia, deliberazioni in materia di vigi-lanza che possono incidere sui poteri – e sull’indipendenza –della stessa Banca d’Italia56. Un contenimento della subordina-
51 Cfr. il d.lgs. 385/1993, art. 2, co. 2, nonché l’art. 1 del regolamento del comi-tato, approvato con deliberazione del 3 maggio 1999. Appare opportuno riportare l’at-tuale composizione del comitato, anche alla luce della diversa denominazione dei mi-nistri: il ministro dell’economia e delle finanze (presidente); il ministro delle politicheagricole, alimentari e forestali; il ministro dello sviluppo economico; il ministro delleinfrastrutture e dei trasporti; il ministro per le politiche europee.
52 Cfr. il d.lgs. 385/1993, art. 2, co. 3 e 4, nonché il già citato regolamento in-terno.
53 Così il d.lgs. 385/1993, art. 2, co. 1.54 Cfr. il d.p.r. 902/1976, artt. 2 e 20.55 Cfr. il d.lgs. 253/2000, art. 3, e il d.lgs. 206/2005, art. 40. Al riguardo si v. F.
FENUCCI, Il governo del credito, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 241 ss.56 Si v., ad esempio, il d.lgs. 385/1993, art. 12, co. 5 e 6, art. 17, art. 19, co. 9, art.
38, co. 2, art. 49, co. 2, art. 53, co. 1 e 4, art. 55, art. 59, co. 1, lett. b, art. 60, co. 1,
123I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
zione della Banca d’Italia al CICR potrebbe ottenersi ritenendoche le proposte della Banca d’Italia previste per l’assunzionedelle deliberazioni del comitato debbano considerarsi vinco-lanti57. Anche in tale ipotesi, tuttavia, non bisogna dimenticareche contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’e-sercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal d.lgs.385/1993 è ammesso reclamo allo stesso CICR, da parte di chi viabbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla comunicazioneo dalla pubblicazione del provvedimento58. In questo modo, ilcomitato può continuare a mantenere una posizione sovraordi-nata rispetto alla Banca d’Italia, consentendo una – seppure li-mitata – influenza del Governo sui provvedimenti della Bancad’Italia in materia di vigilanza sugli enti creditizi.
Occorre considerare, peraltro, che la presidenza del comi-tato e il crescente ruolo assunto hanno fatto del ministro dell’e-conomia e delle finanze l’effettivo polo politico di un sistema bi-polare di governo della finanza pubblica59, il cui altro estremo ècostituito dalla Banca d’Italia60. Quest’ultima, infatti, nonostantei poteri del ministro e quelli residui del CICR, è riuscita ad assu-mere un ruolo di grande rilievo, sia per l’aumento delle propriecompetenze e per il consolidamento della propria posizione isti-tuzionale61, sia per la disponibilità pressoché esclusiva di infor-mazioni a carattere tecnico62, sia, infine, a causa del processo di
lett. b, art. 61, co. 2, art. 67, co. 1, che vincolano la Banca d’Italia ad operare in confor-mità alle deliberazioni adottate dal CICR.
57 Si v. a titolo di esempio: il d.lgs. 385/1993, art. 11, co. 4-ter, art. 127, co. 3; ild.lgs. 153/1999, art. 28, co. 3, lett. b; e il d.lgs. 253/2000, art. 3, co. 4, che richiedonola proposta della Banca d’Italia per l’assunzione dei provvedimenti del comitato.
58 Cfr. il d.lgs. 385/1993, art. 9.59 Si consideri, ad es., che, in caso d’urgenza, il ministro può sostituire il CICR,
dandone notizia al comitato nella prima riunione successiva, che deve essere convocataentro trenta giorni.
60 In questo senso P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 150 ss. Si v., in senso ana-logo, G. RIZZA, I comitati, cit., p. 154, e A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 18.
61 P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 149 ss.62 Così P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., p. 153.
124 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
integrazione comunitaria che ha portato la Banca d’Italia a farparte del Sistema europeo delle banche centrali.
Alla luce di tale contesto, appare auspicabile la soppressionedel CICR, con l’attribuzione dei suoi compiti residui al ministrodell’economia e delle finanze e alla Banca d’Italia63, così comeprevisto anche da un d.d.l. di iniziativa governativa presentatonella XV legislatura64. Tale ipotesi è suffragata anche dalla com-posizione del comitato. Da un lato, infatti, alle sedute del CICR
partecipa un soggetto che, pur rivestendo un ruolo di grande ri-levanza nel sistema del credito e del risparmio, non fa parte delGoverno: il Governatore della Banca d’Italia. Dall’altro, il CICR èl’unico comitato tra quelli esistenti la cui presidenza non sia at-tribuita al Presidente del Consiglio dei ministri. Tale scelta fucerto dettata dalla volontà di segnare una netta rottura con l’ori-ginaria configurazione dell’organo, che vedeva al suo vertice ilcapo del fascismo; oggi, tuttavia, l’assenza del Presidente delConsiglio tra i suoi componenti, distingue in maniera irriducibileil CICR dagli altri comitati ancora esistenti, contribuendo ad av-valorare la convinzione che sia opportuno sopprimerlo.
63 Sembra auspicare la soppressione del comitato anche A. MATTIONI, Comitati,cit., p. 18, mentre già F. FENUCCI, Il concorso del Comitato interministeriale per il cre-dito e il risparmio alla determinazione dell’indirizzo economico, Napoli, Liguori editore,1984, p. 169, faceva riferimento alla necessità di una “unione-ristrutturazione” di CIPE
e CICR.64 Il riferimento è al d.d.l. recante Disposizioni in materia di regolazione e vigi-
lanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi(A.S. 1366, XV legislatura), che prevedeva la delega al Governo per la soppressionedel CICR (art. 10, co. 1, lett. a) e l’attribuzione delle relative competenze al ministrodell’economia e delle finanze e alla Banca d’Italia (art. 10, co. 1, lett. i). L’art. 9 deld.d.l., inoltre, prevedeva la costituzione del Comitato per la stabilità finanziaria (CSF),del quale avrebbero dovuto far parte il ministro per l’economia e le finanze, destinatoa presiederlo, il Governatore della Banca d’Italia e il presidente della CONSOB; il presi-dente del CSF avrebbe potuto invitare ad intervenire a singole riunioni dell’organo ilpresidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, altri ministri e ulte-riori soggetti dei quali si fosse ritenuta opportuna la consultazione. Su tale d.d.l. si v.M. MANETTI, Un passo avanti verso la riforma delle autorità indipendenti, in Rassegnaparlamentare, 2007, part. pp. 307-308, e L. CASSETTI, Il Governo e la regolazione delmercato alla ricerca di nuovi equilibri, in www.federalismi.it, 11 luglio 2007, pp. 1 ss.
125I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
4.2. Il CIPE
Occorre occuparsi, ora, del CIPE, istituito dalla l. 48/196765,la cui disciplina è stata ripetutamente modificata. Il CIPE, data lasua composizione e le funzioni attribuitegli, era stato consideratocome un vero e proprio “Gabinetto economico”, ovvero, comel’organo deputato a determinare la politica dell’Esecutivo in ma-teria economica66. Tale considerazione era avvalorata da diverseragioni: in primo luogo, il comitato era composto di un numeropiuttosto elevato di ministri, vista la partecipazione all’organo ditutti i principali ministri, oltre al Presidente del Consiglio; in se-condo luogo, oltre alle funzioni proprie, al comitato erano stateattribuite anche le funzioni dei comitati interministeriali econo-mici soppressi; come si è già visto, inoltre, i comitati economiciche non erano stati soppressi erano soggetti alle direttive dellostesso CIPE. Le numerose modificazioni apportate all’organo, al-l’intero sistema dei comitati, nonché al sistema di Governo, tut-tavia, suggeriscono di esaminare il CIPE alla luce della sua attualedisciplina.
Ai sensi dell’art. 16, co. 2, della l. 48/1967, «[i]l Comitato èpresieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costi-
65 L’organo, tuttavia, era stato istituito già nel 1965 come Comitato di ministriper la programmazione economica: si v. in proposito G. QUADRI, Gabinetto, cit., p. 6,che individua l’atto istitutivo in un d.p.c.m. del 4 agosto 1965, e G. NEGRO, Conside-razioni in tema di composizione e funzionamento del CIPE, in Rivista trimestrale di di-ritto pubblico, 1976, p. 728, nt. 4, che, invece, data il provvedimento al 14 aprile 1965.La discordanza tra le date indicate dai due Autori dipende – probabilmente – dallacircostanza che l’indicato decreto istitutivo non è stato pubblicato sulla Gazzetta uffi-ciale.
66 Per l’opinione che considerava il CIPE alla stregua di un vero e proprio Gabi-netto economico, paragonabile all’esperienza del Wirtschaftskabinett tedesco, si rinviaa G. QUADRI, Gabinetto, cit., passim. Appare utile rinviare anche all’interessante analisidegli atti del CIPE svolta da E. PICOZZA, Profili giuridici del Comitato interministerialeper la programmazione economica (C.I.P.E.), con particolare riferimento all’attività, inRivista trimestrale di diritto pubblico, 1976, part. pp. 300 ss., dalla quale risulta evi-dente la complessità e la varietà delle funzioni cui il comitato era – e, almeno in parte,è ancora oggi – chiamato a svolgere. Si v., inoltre, D. SORACE (a cura di), I Comitati,cit., passim.
126 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
tuito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la pro-grammazione economica, che ne è Vice-presidente, e dai Ministriper gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l’industria ecommercio, per l’agricoltura e foreste, per il commercio con l’e-stero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il la-voro e la previdenza sociale, per i trasporti e l’aviazione civile,per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo nonchédal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno enelle zone depresse del Centro-Nord e dai Ministri dell’univer-sità e della ricerca e della pubblica istruzione»67. Alle riunioni delcomitato partecipano, «con diritto di voto, anche i Ministri, nonappartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le ma-terie oggetto delle deliberazioni»68, «il Ministro per gli affari re-gionali in qualità di Presidente della Conferenza Stato-Re-gioni»69, nonché «i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidentidelle Province autonome di Trento e Bolzano, quando venganotrattati problemi che interessino i rispettivi Enti»70, e, in occa-sione dell’esame di documenti programmatici di interesse gene-rale delle Regioni, il Presidente della Conferenza delle Regioni e
67 La formulazione originaria della disposizione che indica la composizione delCIPE è stigmatizzata da G. NEGRO, Considerazioni, cit., p. 728: «Così come la norma ècongegnata sembrerebbe quasi che il legislatore abbia voluto dare sanzione giuridica aqualche elemento di quegli accordi di centro-sinistra della prima metà degli anni ’60,nel cui quadro è lecito supporre sia stata assicurata a una determinata parte politica lagestione del Ministero del bilancio e del Comitato Interministeriale per la Program-mazione Economica».
Appare necessario indicare quali sono attualmente i ministri membri permanentidel comitato anche in considerazione della modificazione delle denominazioni dei mi-nistri: il Presidente del Consiglio dei ministri (presidente); il ministro dell’economia edelle finanze (vice presidente); il ministro degli affari esteri; il ministro dello sviluppoeconomico, infrastrutture e trasporti; il ministro del lavoro e delle politiche sociali; ilministro delle politiche agricole alimentari e forestali; il ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare; il ministro per i beni e attività culturali; il ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca; il ministro per gli affari europei; il ministroper gli affari regionali, turismo e sport.
68 Così la l. 144/1999, art. 2; cfr. anche la l. 48/1967, art. 16, co. 9.69 Così il regolamento interno: delibera CIPE 13 maggio 2010, art. 1, co. 2.70 Cfr. la l. 48/1967, art. 16, co. 9.
127I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
delle Province autonome71. Inoltre, alle sedute del CIPE «possonoessere invitati ad intervenire il Governatore della banca d’Italia,il Presidente dell’Istituto centrale di statistica, il segretario dellaprogrammazione»72. Infine, partecipa alle riunioni del comitato,con funzioni di segretario, un sottosegretario alla Presidenza delConsiglio dei Ministri, nominato con un d.p.c.m.73.
Per quanto riguarda le modalità di funzionamento, occorreconsiderare che il CIPE si avvale di una segreteria che è stata tra-sferita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che prov-vede ai compiti operativi e di amministrazione e alle esigenze dicoordinamento e di supporto tecnico delle istruttorie74, mentrein precedenza era istituita presso il ministero del tesoro, del bi-lancio e della programmazione economica75. Il CIPE, nell’eserci-zio delle sue funzioni, può costituire, con propria delibera, co-mitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell’esame e dellaformulazione di proposte su problemi e materie di particolarecomplessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi esecondo le modalità indicati dal regolamento interno76. In pro-posito, occorre ricordare – per la loro rilevanza – due apparatiinterni al CIPE: il Nucleo di consulenza per la regolazione dei ser-vizi di pubblica utilità (NARS), istituito presso la segreteria del
71 Cfr. l’art. 1, co. 5, del regolamento interno.72 Così la l. 48/1967, art. 16, co. 11.73 Cfr. la l. 48/1967, art. 16, co. 10, come modificato dall’art. 1, co. 2-quater, del
più volte citato d.l. 181/2006.74 Così il già citato d.l. 181/2006, art. 1, co. 2. Si v. anche i due d.p.c.m. del 21
giugno 2007, il primo di istituzione e il secondo di organizzazione del dipartimentoper la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché i succes-sivi d.p.c.m. 15 ottobre 2008 e 3 novembre 2010. Si v. altresì F. SPROVIERI, La riformadel CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica. I decreti 21 giu-gno 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in Rivista giuridica del Mezzogiorno,2007, n. 3/4, pp. 603 ss.
75 Cfr. il d.lgs. 430/1997, art. 1, co. 6, nonché la l. 48/1967, art. 16, co. 13.76 Così il d.lgs. 430/1997, art. 1, co. 3; si v. anche la l. 48/1967, art. 16, co. 12,
che consente al CIPE di costituire al suo interno sottocomitati per l’esame di problemispecifici, nonché la delibera CIPE 9 luglio 1998, art. 2. Per l’elenco delle commissioniattualmente operanti si v. il sito www.comitato.cipe.it.
128 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
CIPE con l’incarico di promuovere le linee-guida per la regola-zione dei servizi di pubblica utilità, di favorire l’omogeneizza-zione dei contratti di programma e di monitorarne gli effetti77;l’Unità tecnica-Finanza di progetto (UTFP)78, con il compito dipromuovere, all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’uti-lizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso acapitali privati e di fornire supporto alle commissioni costituitenell’ambito del CIPE su materie inerenti il finanziamento delle in-frastrutture79. Anche questi apparati sono stati trasferiti alla Pre-sidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finan-ziarie, strumentali e di personale80.
Sempre in merito alle modalità operative dell’organo, è ne-cessario ricordare che la l. 537/1993 prevede l’adozione di un re-golamento (ex art. 17, co. 2, della l. 400/1988) per la definizionedell’organizzazione e delle funzioni del CIPE81. Il regolamento at-tualmente vigente è stato adottato nel 201082 e determina le mo-dalità di funzionamento del comitato nonché la disciplina deisuoi atti.
Occorre occuparsi, ora, delle funzioni del CIPE.Per quanto riguarda la legge istitutiva del comitato, questa si
limita ad attribuirgli il compito di approvare il programma an-nuale di attività dell’Istituto centrale di statistica per quanto con-
77 Cfr. le delibere CIPE datate 8 maggio 1996 e 26 giugno 1996, nonché il rego-lamento interno del nucleo, adottato nella seduta del 3 novembre 1999 e successiva-mente modificato, in part. dai d.p.c.m. 25 novembre 2008 e 2 agosto 2010. Sul NARS sirinvia a P. BITETTI, La nascita del NARS e la sua collocazione istituzionale, in Economiapubblica, 2002, n. 4, pp. 7 ss.
78 Cfr. la l. 144/1999, art. 7; cfr. anche il regolamento dell’Unità, dettato con ild.m. 162/2003, nonché il d.p.c.m. 22 luglio 2008.
79 Così la l. 144/1999, art. 7, co. 2.80 Cfr. il più volte citato d.l. 181/2006, art. 1, co. 2, nonché il d.p.c.m. 31 gen-
naio 2007 e il d.p.c.m. 1 marzo 2011, art. 25.81 Cfr. la l. 537/1993, art. 1, co. 25; si v. anche il d.lgs. 430/1997, art. 1, co. 5.82 Si tratta della già citata delibera CIPE 13 maggio 2010. Per quanto riguarda,
invece, il periodo – piuttosto lungo – durante il quale il CIPE non ha avuto un proprioregolamento interno, si v. le osservazioni di G. NEGRO, Considerazioni, cit., pp. 746-747, nonché A. MATTIONI, Comitati, cit., pp. 17-18.
129I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
cerne le rilevazioni interessanti la programmazione economica83,nonché le funzioni di alcuni comitati soppressi, quali il CIR84. Perquanto attiene agli altri comitati soppressi, si consideri che alCIPE sono state devolute alcune delle funzioni del CIP85; la possi-bilità di determinare la politica tariffaria nazionale, però, è stataridimensionata sia dal processo di privatizzazione delle impresepubbliche sia dalla devoluzione agli enti locali di funzioni legi-slative e amministrative, in virtù della c.d. legge Bassanini86 edella riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione87. Diparticolare rilievo tra le attribuzioni del CIPE previste dalla leggeistitutiva appare il coinvolgimento dell’organo nella sessione dibilancio. Entro il 15 settembre di ogni anno, infatti, il comitatodeve approvare la relazione previsionale e programmatica, le re-lazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione deiprogetti di bilancio annuale e pluriennale88. Relativamente a talifunzioni, inoltre, il regolamento interno dell’organo prevede cheil CIPE si riunisca «almeno due volte l’anno, in occasione dellapresentazione della Decisione di finanza pubblica e dell’allegatoprogramma»89.
La maggior parte delle ulteriori attribuzioni del CIPE sonoattualmente determinate dal d.lgs. 430/1997. Nell’ambito degli
83 Così la l. 48/1967, art. 17, co. 1.84 Cfr. l’art. 18 della l. 48/1967. Secondo E. D’ANIELLO, Il Comitato, cit., p. 99,
le funzioni attribuite al CIPE dalla legge istitutiva avevano una vocazione “attendista”,dovendo «essere considerate dei contenenti in attesa di un contenuto, incerto sia nel-l’an che nel quando», mentre sarebbero state maggiormente significative le disposizioniinerenti ai preesistenti comitati interministeriali, cui il CIPE si sarebbe dovuto sostituireo la cui attività avrebbe dovuto coordinare con la propria.
85 Cfr. il d.p.r. 373/1994, art. 5, co. 1.86 Il riferimento è alla l. 59/1997.87 Si v., in proposito, l’interessante analisi di A. SENESI, A. TORRONI, Gli snodi
istituzionali: le competenze del CIPE e dei ministeri in materia di regolazione, in Econo-mia pubblica, 2002, n. 4, pp. 205 ss., nonché C. DE VINCENTI, Non solo energia e tele-comunicazioni: i problemi della transizione avviata nella regolazione delle altre utilities,ivi, pp. 13 ss.
88 Così la l. 48/1967, art. 16, co. 5.89 Così la delibera CIPE 13 maggio 2010, art. 1, co. 1.
130 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
indirizzi fissati dal Governo, il CIPE, sulla base di proposte delleamministrazioni competenti per materia, svolge importanti fun-zioni di coordinamento in materia di programmazione e di poli-tica economica nazionale, nonché di coordinamento della poli-tica economica nazionale con le politiche comunitarie90.
Ulteriori funzioni sono state attribuite al CIPE da leggi suc-cessive, ad esempio in tema di finanziamento degli investimentiper lo sviluppo delle aree sottoutilizzate e di promozione indu-striale91, oppure in materia di sostegno alle imprese e investi-menti in ricerche92.
È opportuno ricordare, altresì, che il presidente del CIPE
può richiedere, anche su proposta di amministrazioni statali o re-gionali, la trattazione collegiale di questioni che incidono sull’a-zione di politica economica del Governo93.
Per quanto riguarda, invece, i compiti di gestione tecnica,amministrativa e finanziaria che erano attribuiti al CIPE, questisono stati trasferiti alle amministrazioni competenti per materia,tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative fun-zioni94, assecondando la già indicata tendenza alla separazionetra attività politica e attività amministrativa95.
Al CIPE, quindi, sono state sottratte le competenze a carat-tere gestionale e amministrativo; inoltre, è stata espressamenteprevista la necessità di esercitare le proprie funzioni a caratteregenerale nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo. Nono-stante ciò, al comitato rimangono rilevanti funzioni in materia
90 Si v. il d.lgs. 430/1997, art. 1, co. 1, nonché quanto già osservato supra, parteII, cap. I, par. 6. Sulle funzioni del CIPE, soprattutto in materia di programmazionenegoziata, si v. G. DI GASPARE, Gli strumenti negoziali della governance esterna e dellagovernance istituzionale, Estratti da Studio realizzato per il progetto Governance delFormez (dicembre 2004), in www.amministrazioneincammino.luiss.it, pp. 1 ss.
91 Cfr. la l. 289/2002, artt. 61, 67 e 73.92 Cfr. la l. 311/2004, art. 1, co. 355-356, e il d.l. 35/2005, art. 6, convertito con
modificazioni dalla l. 80/2005, art. 1.93 Cfr. il d.lgs. 430/1997, art. 1, co. 4.94 Cfr. il d.lgs. 430/1997, art. 1, co. 2, come modificato dalla l. 144/1999, art. 3.95 In questo senso A. RAVALLI, I comitati interministeriali, cit., p. 35.
131I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
economica, non solo nell’attuazione degli indirizzi fissati dal Go-verno, ma anche nella predisposizione di indirizzi e, soprattutto,nel riparto e nella finalizzazione delle risorse. Quindi, sebbene ilCIPE non possa essere considerato – almeno allo stato attuale –un vero e proprio Gabinetto economico, perché l’esercizio delleproprie attribuzioni deve avvenire nel rispetto degli indirizzi de-terminati dal Governo96, appare comunque evidente il rilevanteruolo politico che esso continua a rivestire nell’attività di go-verno dell’economia97.
Le modificazioni indicate sembrano confermare la tesi dellaappartenenza del CIPE – e, si deve ritenere, dei comitati intermi-nisteriali in generale – alla struttura del Governo, consideratoche tali cambiamenti seguono quelli che – più in generale – at-tengono all’intero Esecutivo. La sottrazione al CIPE dei compitipiù prettamente tecnici, infatti, rientra nella tendenza alla sepa-razione tra politica e amministrazione da tempo perseguita, seb-bene in maniera non sempre lineare98. D’altro canto, la sottopo-sizione del comitato agli indirizzi del Governo rende evidente lavolontà di superare una struttura di governo composta da diversicentri autonomi di decisione politica, tentando di garantire l’u-nità di indirizzo e il coordinamento dell’azione di governo.
In linea con tali considerazioni occorre valutare altresì lospostamento della segreteria tecnica del CIPE. Come si è già ac-cennato, questa segreteria è oggi istituita presso la Presidenza delConsiglio dei ministri, mentre in precedenza era istituita presso ilministero dell’economia e delle finanze. Anche questo trasferi-mento (insieme a quello del NARS e dell’UTFP) può essere consi-derato indicativo di un profondo cambiamento. Infatti, «avvici-nando alla sede di indirizzo politico per eccellenza l’apparato
96 … tanto che le sue funzioni potrebbero essere considerate interpretativo-at-tuative dell’indirizzo politico dell’Esecutivo, come si è visto supra, parte II, cap. I,par. 6.
97 Secondo A. RAVALLI, I comitati interministeriali, cit., p. 37, infatti, il CIPE «rap-presenta l’effettivo “motore” della politica economica nazionale nel quadro comunita-rio e internazionale».
98 Cfr. quanto già affermato supra, parte II, cap. II, par. 3.
132 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
chiamato a provvedere ai compiti operativi e di supporto tecnicodelle istruttorie del Comitato, che è il luogo in cui si predisponeil contenuto della decisione politica, si intende dotare la Presi-denza del Consiglio di uno strumento idoneo a garantire lo svol-gimento effettivo delle funzioni di coordinamento in materia diprogrammazione e di politica economica nazionale»99. Garan-tendo, così, il rafforzamento del ruolo del Presidente del Consi-glio dei ministri all’interno della compagine governativa, a disca-pito di uno dei dicasteri – quello dell’economia – che, negli anni,ha visto crescere maggiormente il suo rilievo politico e la sua au-tonomia100.
4.3. Il CIACE
Come si è già visto, la preminente esperienza dei comitatieconomici pare superata, ma non si può dire lo stesso per l’uti-lizzo dello strumento dei comitati interministeriali. Nelle legisla-ture successive alla riforma elettorale del 1993, infatti, sono statiistituiti quattro nuovi comitati, che verranno qui di seguito ana-lizzati.
Cominciando dal comitato interministeriale per gli affari co-munitari europei (CIACE), esso è stato istituito con la l. 11/2005(c.d. legge Buttiglione). Questa legge detta le regole per la parte-cipazione dell’Italia al processo normativo comunitario, sosti-tuendosi alla precedente legge comunitaria, la l. 86/1989 (c.d.legge La Pergola).
La l. 11/2005 prevede l’istituzione del CIACE, che è «presie-duto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per
99 Così C. MARTINI, La «nuova» riforma dei ministeri, in Quaderni costituzionali,2006, n. 3, p. 553.
100 Il ministro dell’economia e delle finanze, infatti, è stato considerato una sortadi “superministro” proprio in virtù della sua concreta direzione del CIPE: in questosenso G. NEGRO, Considerazioni, cit., pp. 747 ss. Secondo E. D’ANIELLO, Il Comitato,cit., p. 98, invece, il rafforzamento del ministro all’interno del CIPE non poteva con-cretamente realizzarsi a causa dell’alto numero di ministri chiamati a far parte di taleorgano.
133I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degliaffari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministriaventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti edelle tematiche inseriti all’ordine del giorno»101. Inoltre, «[a]lleriunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interes-sano anche le regioni e le province autonome, possono chiederedi partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delleregioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o unpresidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e,per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delleassociazioni rappresentative degli enti locali»102.
Per quanto riguarda le modalità di funzionamento, il CIACE èistituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è con-vocato dal Presidente del Consiglio o dal ministro per le politiche
101 Così la l. 11/2005, art. 2, co. 1; si v. anche il d.p.c.m. 9 gennaio 2006, art. 3,co. 1. La composizione dell’organo è stata definita da P. GAMBALE, ‘Prima lettura’ delParlamento per le modifiche alla “Legge La Pergola”: una nuova cornice normativa perdefinire la partecipazione del “sistema Italia” nelle politiche UE?, in www.amministra-zioneincammino.luiss.it, p. 5, a “geometria variabile”; nello stesso senso M.E. PUOTI,L’attuazione degli strumenti di partecipazione alla fase ascendente di formazione dellanormativa comunitaria previsti dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11: il comitato intermini-steriale per gli affari comunitari europei (CIACE), il comitato tecnico permanente e i ta-voli di coordinamento, in Diritto e società, 2006, n. 3, p. 482. Non si può fare a menodi rimarcare, peraltro, quanto sia infelice la formulazione letterale della disposizionecitata, dalla quale si potrebbe desumere che, nel caso in cui il Presidente del Consigliopresieda il comitato, la contestuale presenza in comitato del ministro per le politichecomunitarie non sarebbe prevista. D’altro canto, la legge di cui si discorre non rap-presenta certo un esempio di buon drafting legislativo: sulle numerose “disomogeneitànormative” contenute nella legge si rinvia a M. CARTABIA, L. VIOLINI, Le norme gene-rali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulleprocedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Commento alla legge 4 febbraio 2005,n. 11, in Le Regioni, 2005, n. 4, pp. 480 ss., part. 484, M. GENTILE, Nasce il Ciace perconcordare le strategie di Governo, in Guida al diritto, 2005, n. 9, pp. 41-42, e, sia con-sentito, D. CODUTI, La partecipazione delle Regioni al processo normativo comunitario,con particolare riferimento alla c.d. fase discendente, in G. CARPANI, T. GROPPI, M. OLI-VETTI, A. SINISCALCHI (a cura di), Le Regioni italiane nei processi normativi comunitaridopo la legge n. 11/2005, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 106-107.
102 Così la l. 11/2005, art. 2, co. 2; cfr. anche il d.p.c.m. 9 gennaio 2006, art. 3,co. 3.
134 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
comunitarie103. Le altre modalità di funzionamento dell’organosono disciplinate con un regolamento adottato con d.p.c.m. 9gennaio 2006104. Per la preparazione delle proprie riunioni «ilCIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituitopresso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato epresieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suodelegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali oalti funzionari con qualificata specializzazione in materia, desi-gnati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando sitrattano questioni che interessano anche le regioni e le provinceautonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionalicompetenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convo-cato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in ac-cordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-tonome di Trento e di Bolzano»105. Le modalità di funzionamentodel comitato tecnico sono disciplinate con decreto del ministroper le politiche comunitarie del 9 gennaio 2006106. Il CIACE e il co-mitato tecnico, infine, si avvalgono di un ufficio di segreteriaunico per entrambi gli organismi107.
In merito alle funzioni del CIACE, occorre premettere che lalegge istitutiva richiama l’organo al rispetto delle competenze at-tribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consi-
103 Cfr. la l. 11/2005, art. 2, co. 1, e il d.p.c.m. 9 gennaio 2006, art. 3, co. 1.104 Come previsto dalla l. 11/2005, art. 2, co. 4. Il regolamento indicato nel testo
consente al CIACE di disciplinare le ulteriori modalità di funzionamento con proprioregolamento (cfr. il d.p.c.m. 9 gennaio 2006, art. 3, co. 7).
105 Così la l. 11/2005, art. 2, co. 4; cfr. anche il d.p.c.m. 9 gennaio 2006, art. 3,co. 4. Secondo M. CARTABIA, L. VIOLINI, Le norme, cit., p. 485, il comitato tecnico per-manente «sembra ripetere a livello nazionale l’idea del COREPER che prepara i lavoridel Consiglio dei Ministri europeo». Nello stesso senso anche M.E. PUOTI, L’attua-zione, cit., pp. 494 ss., e D. GIROTTO, Parlamento italiano e processo normativo europeo,Napoli, Jovene, 2009, p. 170.
106 Come previsto dalla l. 11/2005, art. 2, co. 4.107 Cfr. il d.p.c.m. 9 gennaio 2006, art. 4, e il d.m. 9 gennaio 2006, art. 5; si v. an-
che il d.p.c.m. 21 luglio 2011, art. 5.
135I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
glio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bol-zano108. Oltre a ciò, la l. 11/2005 si limita a disporre – in manierapiuttosto generica – che il CIACE è istituito «[a]l fine di concor-dare le linee politiche del Governo nel processo di formazionedella posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti co-munitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adem-pimento dei compiti» indicati dalla stessa legge109, mentre, peruna elencazione dettagliata delle funzioni del comitato, occorrefare riferimento al suo regolamento interno110.
Sintetizzando, sembra di potersi affermare che l’ampiezzadelle funzioni attribuite al CIACE dovrebbe consentirne un ampiocoinvolgimento nelle attività previste dalla legge comunitaria111.Il CIACE, infatti, da un lato, dovrebbe favorire il coordinamentodelle posizioni dei vari ministri coinvolti nelle politiche europee;dall’altro, dovrebbe facilitare l’adempimento degli obblighi co-munitari112. Il comitato, inoltre, dovrebbe consentire di coinvol-gere anche gli enti territoriali interessati – su loro richiesta113 –,
108 Cfr. la l. 11/2005, art. 2, co. 3. Secondo M. GENTILE, Nasce, cit., p. 40,«[p]otrà, tuttavia, rilevarsi difficoltoso, nella fase attuativa della norma in argomento,delimitare il concreto ambito operativo del Ciace, sì da evitare sovrapposizioni con icompiti istituzionali dei soggetti sopramenzionati». Si v. anche le perplessità di S. TRI-PODI, La fase indiretta della partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti co-munitari: alcune osservazioni sul ddl di riforma della legge «La Pergola», in www.fede-ralismi.it, 8 gennaio 2004, pp. 3-4, relativamente alla possibile sovrapposizione di com-petenze tra CIACE e Conferenza Stato-Regioni; nello stesso senso R. MASTROIANNI, Ilcontributo delle Regioni italiane all’elaborazione del diritto dell’Unione europea, in Il di-ritto dell’Unione europea, 2006, n. 2, pp. 436-437. Si rinvia, infine, a V. ANTONELLI, Iraccordi interistituzionali nella dialettica con l’Unione europea, in G. CARPANI, T.GROPPI, M. OLIVETTI, A. SINISCALCHI (a cura di), Le Regioni, cit., p. 67.
109 Così la l. 11/2005, art. 2, co. 1.110 Cfr. il d.p.c.m. 9 gennaio 2006, art. 2, co. 2, 3 e 4.111 In senso analogo M.E. PUOTI, L’attuazione, cit., p. 486.112 In questo senso M. CARTABIA, L. VIOLINI, Le norme, n. 11, cit., p. 485.113 La possibilità che gli enti territoriali partecipino alle riunioni del CIACE pre-
via richiesta di un loro partecipante, solleva il dubbio se la richiesta consenta automa-ticamente la partecipazione di tali enti alle riunioni dell’organo, oppure se la richiestasia sindacabile dal CIACE e, di conseguenza, la decisione ultima sulla possibilità di am-
136 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
sebbene solo attraverso un loro rappresentante114. La rappresen-tanza di Regioni e Province autonome, invece, potrebbe essereben più consistente nel comitato tecnico permanente, essendoconsentita in tale sede la partecipazione di tutti gli assessori re-gionali (e, si deve presumere, delle Province autonome) compe-tenti per materia115. Occorre osservare, tuttavia, che, nell’ipotesiin cui alle riunioni del comitato tecnico partecipassero tutti gliesponenti degli Esecutivi locali, le autonomie locali potrebberoessere sovrarappresentate rispetto al Governo nazionale e – inogni caso – l’organo avrebbe una composizione particolarmenteampia, tanto da poter risultare poco efficace nello svolgimentodella sua attività116.
mettere i rappresentanti degli enti locali alle sue riunioni spetti allo stesso comitato. Alriguardo si v. M.E. PUOTI, L’attuazione, cit., p. 491, F. PATERNITI, Nuove prospettivenella partecipazione “interna” delle Regioni alla fase ascendente dei processi decisionalicomunitari alla luce della legge n. 11/2005, in www.giustamm.it, 2005, n. 5, par. 3, non-ché i dubbi di M. GENTILE, Nasce, cit., pp. 41-42.
114 L. CALIFANO, Stato, Regioni e diritto comunitario nella Legge n. 11/2005, inQuaderni costituzionali, 2005, n. 4, p. 861, parla, al riguardo, di «timida apertura alleRegioni». In senso analogo C. DE SIMONE, La Camera approva il disegno di legge Butti-glione, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo del-l’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, in www.ri-vistaic.it, 25 luglio 2003. Secondo S. TRIPODI, La fase, cit., p. 3, «appare evidente comela posizione delle Regioni nell’ambito del CIACE risulterebbe marginale, essendo pre-vista la partecipazione di un solo rappresentante regionale a fronte di una nutrita com-pagine ministeriale. Il rischio, paventato dalle stesse Regioni, sarebbe quello di ripeterel’esperienza poco soddisfacente di un altro comitato interministeriale, il CIPE, in cuile modalità procedurali di convocazione delle riunioni e la rappresentanza numerica-mente minoritaria degli esponenti regionali non permettono alle Regioni di far valereuna posizione significativa». D’altro canto, come osserva M.E. PUOTI, L’attuazione, cit.,p. 483, il vero intervento delle Regioni nella fase ascendente del processo normativocomunitario non si concreta attraverso il CIACE, bensì attraverso le modalità previstedall’art. 5 della l. 11/2005.
115 Cfr. la l. 11/2005, art. 2, co. 4, e il d.m. 9 gennaio 2006, art. 4, co. 2.116 Per questi dubbi si rinvia a M. CARTABIA, L. VIOLINI, Le norme, cit., pp. 485-
487, e P.L. PETRILLO, Unione europea, Governo nazionale e Regioni nella c.d. «faseascendente» tra azioni di filtro e tentativi di coordinamento, in G. CARPANI, T. GROPPI,M. OLIVETTI, A. SINISCALCHI (a cura di), Le Regioni, cit., p. 35. Per la composizione delcomitato tecnico si rinvia al d.m. 9 gennaio 2006, artt. 2, 3 e 4.
137I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
Peraltro, poiché la mole di atti comunitari di cui il CIACE do-vrebbe occuparsi necessiterebbe di un’attività sostanzialmentecontinuativa del comitato interministeriale, si deve dedurre cheesso sia destinato ad occuparsi prevalentemente di determinaregli indirizzi generali in materia di politiche comunitarie, nonchédelle questioni di maggiore rilievo, mentre per la maggior partedelle questioni ordinarie il CIACE potrebbe limitarsi a ratificare ledecisioni assunte in sede di comitato tecnico (non a caso) per-manente117. In questo modo risulterebbe maggiormente rilevanteanche il ruolo delle Regioni, che possono far parte del comitatotecnico attraverso i propri assessori, competenti per le materie diinteresse regionale trattate dallo stesso organo tecnico. Il CIACE,pertanto, dovrebbe svolgere il ruolo di “cabina di regia e di mo-nitoraggio”118 delle fasi del procedimento decisionale comunita-rio, garantendo il coordinamento delle posizioni interessate el’efficienza dell’iter seguito119.
Per quanto attiene alla presidenza dell’organo, è necessarioriflettere sulla sua attribuzione al Presidente del Consiglio “o” alministro per le politiche europee. Anche laddove la presidenza eil potere di convocazione di tale comitato siano delegate al mini-stro120, la delega non esclude affatto il Presidente del Consigliodei ministri. Al di là della possibilità che egli revochi la delega,infatti, occorre considerare che il ministro per le politiche euro-
117 Si v. le osservazioni di M.E. PUOTI, L’attuazione, cit., p. 492.118 L’espressione è utilizzata da S. TRIPODI, La fase, cit., p. 2, e F. TUFARELLI, Art.
2, in G. BRENNA, S. STABILE, A. TROTTA, M. DE VITA, F. TUFARELLI, Commento alla legge4 febbraio 2005, n. 11, in G. CARPANI, T. GROPPI, M. OLIVETTI, A. SINISCALCHI (a curadi), Le Regioni, cit., p. 221, ma anche P. GAMBALE, ‘Prima lettura’, cit., p. 5.
119 Secondo P.L. PETRILLO, Unione, cit., p. 35, però, nella loro concreta attività«sia il CIACE che il suo comitato tecnico, non sono stati in grado di coordinare (e ra-zionalizzare) le posizioni italiane presso le istituzioni comunitarie, nonostante l’impe-gno dei responsabili dei servizi dedicati all’interno del Dipartimento. Al contrario essoha funzionato, efficacemente, come una sorta di “centro studi” dallo scarso impattopolitico, la sede ideale dove redigere rapporti e relazioni obbligatorie sulla base degliimpegni europei».
120 Si v. le osservazioni di M.E. PUOTI, L’attuazione, cit., p. 490.
138 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
pee è un ministro senza portafoglio, che il CIACE, il comitato tec-nico permanente ed anche l’ufficio di segreteria sono istituitipresso la Presidenza del Consiglio, e che il coordinatore di taleufficio è nominato dallo stesso Presidente del Consiglio su pro-posta del ministro. Più in generale, è necessario valutare il rap-porto che si instaura tra il Presidente del Consiglio e i ministrisenza portafoglio alla luce delle riforme più recenti. L’art. 9, co.2, della l. 400/1988, infatti, è stato modificato, disponendo che«[o]gni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anchein via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafo-glio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza delConsiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attri-buiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri,che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, ealla Presidenza del Consiglio dei Ministri»121. Tale modificazionepare configurare un chiaro rapporto di primazia del premier ri-spetto ai ministri senza portafoglio e un’ampia disponibilità inmerito alle funzioni loro delegate122.
La configurazione così delineata sembra consentire ugual-mente al Presidente del Consiglio di esercitare la sua funzione diindirizzo e di coordinamento anche nel settore delle politichedell’Unione europea, sebbene appaia evidente che un suo inter-vento diretto sarà limitato alle questioni di particolare rilevanza,lasciando la gestione ordinaria della materia ad un apparato chefa comunque capo alla Presidenza del Consiglio123.
Alla luce di quanto sin qui rilevato, è possibile svolgereun’ultima osservazione relativa al CIACE. La legge istitutiva del-l’organo ribadisce la necessità di rispettare le attribuzioni del
121 Cfr. la l. 400/1988, art. 9, co. 2, come modificato dall’art. 1, co. 22-ter, deld.l. 181/2006.
122 Cfr. infra, parte III, cap. II, par. 2.5.3.123 Si rinvia a P.L. PETRILLO, Unione, cit., pp. 36-37, secondo il quale appare ne-
cessario attribuire direttamente al Presidente del Consiglio il compito di coordinarel’azione comunitaria nazionale, magari attraverso la delega ad un sottosegretario allaPresidenza del Consiglio.
139I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
Consiglio dei ministri, e quest’ultimo è senz’altro l’organo depu-tato a decidere anche in merito alle determinazioni in tema di af-fari comunitari assunte dal CIACE. Tuttavia, poiché – come si ègià osservato – il CIACE potrebbe occuparsi in concreto solo dellequestioni di maggiore rilevanza e considerando che (quanto-meno) in tali occasioni il comitato potrebbe essere presiedutodal Presidente del Consiglio, non è da escludere che il Consigliodei ministri possa limitarsi a ratificare le decisioni assunte in co-mitato, tanto da lasciare a quest’ultimo organo il compito di de-terminare – di fatto – l’indirizzo politico in materia.
4.4. Il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strate-gica delle politiche di semplificazione e di qualità della regola-zione
Il secondo tra i comitati istituiti nelle legislature maggiorita-rie che occorre esaminare è il Comitato interministeriale per l’in-dirizzo e la guida strategica per le politiche di semplificazione edi qualità della regolazione124.
Il comitato «è presieduto dal Presidente del Consiglio deiMinistri, che può delegare le relative funzioni al Ministro per leriforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione»125. «Ilcomitato è composto dal Ministro per le riforme e l’innovazionenella pubblica amministrazione, dal Ministro per gli affari regio-nali e le autonomie locali, dal Ministro per le politiche europee,dal Ministro per l’attuazione del programma di Governo, dal Mi-nistro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze,dal Ministro per lo sviluppo economico e dal sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Segretario delConsiglio dei Ministri»126. Peraltro, ogni componente del comi-tato può delegare la propria partecipazione ad un vice ministro o
124 Istituito con il d.p.c.m. 12 settembre 2006, ma previsto dal d.l. 4/2006, art. 1,convertito dalla l. 80/2006.
125 Così il d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 2, co. 1.126 Cfr. il d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 2, co. 2.
140 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
ad un sottosegretario127. Alle riunioni del comitato, «in base agliargomenti da trattare, possono essere invitati altri Ministri, non-ché esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi deglialtri livelli di governo»128. È necessario precisare che l’art. 5 deld.p.c.m. 12 settembre 2006 prevede altresì l’istituzione di un c.d.Tavolo permanente per la semplificazione, una sede permanentedi consultazione alla quale sono chiamati a partecipare i rappre-sentanti delle categorie produttive, delle associazioni di utenti econsumatori, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunitàmontane e che è ugualmente presieduto dal Presidente del Con-siglio, salvo delega al ministro per gli affari regionali129.
In merito al funzionamento dell’organo, il comitato è isti-tuito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le funzionidi segretario sono svolte dal segretario generale della Presidenzadel Consiglio dei ministri130. Il segretario si avvale di una segre-teria composta da non più di tre unità di personale, costituitanell’ambito dell’ufficio del segretario generale, e può farsi assi-stere da componenti dell’Unità per la semplificazione, la qualeassicura anche il supporto tecnico al comitato131.
Per quanto riguarda le funzioni del comitato, il decreto necontiene un ampio elenco. In particolare, il comitato deve predi-sporre ogni anno un piano di azione per il perseguimento degliobiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di
127 Cfr. il d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 2, co. 3.128 Così il d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 2, co. 4.129 Cfr. il d.p.c.m. 8 marzo 2007, istitutivo del Tavolo permanente per la sempli-
ficazione.130 Cfr. il d.p.c.m. 12 settembre 2006, artt. 1 e 2, co. 5.131 Così il d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 3. Per quanto riguarda l’Unità per la
semplificazione si v. il d.l. 181/2006, art. 22-bis, e la l. 233/2006, nonché l’appositod.p.c.m., approvato sempre il 12 settembre 2006. Sull’Unità si v. F. PATRONI GRIFFI, Lepolitiche della qualità della regolazione in Italia, relazione al Convegno OECD-Formez,Roma, 8 novembre 2007, part. p. 3, nonché L. CARBONE, Qualità della regolazione ecompetitività: ricette diverse ma ingredienti comuni, Seminario su «Tecniche di produ-zione normativa e “better regulation”», Roma, 26 gennaio 2007, p. 6, entrambi con-sultabili in www.astrid.eu.
141I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
qualità della regolazione per l’anno successivo, individuando perciascun obiettivo i soggetti responsabili per il suo consegui-mento. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dalConsiglio dei ministri e trasmesso alle Camere. Il comitato coor-dina l’attività di realizzazione degli obiettivi del piano di azioneda parte dei singoli responsabili, verificando periodicamente illoro stato di attuazione. Al comitato sono altresì sottoposte, perun esame preventivo all’approvazione da parte del Consiglio deiministri, le iniziative normative con prevalente finalità di sempli-ficazione e, in particolare, del disegno di legge di semplifica-zione. Nei lavori parlamentari relativi a tale disegno di legge ilGoverno è rappresentato dal sottosegretario alla Presidenza delConsiglio e dal ministro per le riforme e l’innovazione nella pub-blica amministrazione. Il comitato, inoltre, svolge funzioni di in-dirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle am-ministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, delriassetto e della qualità della regolazione. Il comitato, infine, as-sicura il costante raccordo con gli altri soggetti istituzionali e congli altri livelli di governo in tema di semplificazione e di qualitàdella regolazione132.
Il comitato, quindi, appare volto ad assumere il ruolo di or-gano guida della politica della semplificazione e della qualitàdella regolazione, soprattutto se si considera che il piano diazione annuale in materia viene predisposto dallo stesso comi-tato per poi essere approvato dal Consiglio dei ministri. Nellostesso senso depone la sottoposizione all’esame del comitatodelle iniziative normative del Governo in materia, prima chesiano portate all’approvazione del Consiglio dei ministri. La cen-tralità che l’organo sembra acquisire in materia, inoltre, derivaanche dalle numerose funzioni di impulso, coordinamento, indi-rizzo e monitoraggio che il decreto gli attribuisce.
132 Così il d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 4. Sulle funzioni del comitato sirinvia a C. MEOLI, A che punto è la semplificazione?, in www.forumcostituzionale.it,pp. 15 ss.
142 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
All’interno del comitato un ruolo preminente si può ricono-scere al Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, nonostantel’ampio numero di ministri chiamati a far parte dell’organo e lapossibilità che la presidenza sia delegata dal premier al ministroper le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione,sembrano potersi riprendere anche in questa sede le osservazionigià svolte in merito al CIACE. Anche per il comitato per la sempli-ficazione, infatti, non solo il Presidente del Consiglio potrebbedecidere di non delegare le relative funzioni, ma – soprattutto – lastruttura del comitato pare incentrata tutta all’interno della Presi-denza del Consiglio dei ministri: l’organo è istituito presso la Pre-sidenza; le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dalsegretario generale della stessa Presidenza; la segreteria che lo as-siste è costituita all’interno della sua segreteria. Ma non solo. Ri-spetto al CIACE, il ruolo preminente del Presidente del Consiglioe della sua Presidenza appare rafforzato nel comitato per la sem-plificazione: in primo luogo, la sua disciplina è dettata con und.p.c.m.; in secondo luogo, si dispone che il comitato sia compo-sto normalmente anche dal sottosegretario alla Presidenza delConsiglio – segretario del Consiglio dei ministri; infine, si prevedeespressamente che dinanzi alle Camere, nel corso dei lavori parla-mentari relativi al disegno di legge di semplificazione, il Governopossa essere rappresentato dal sottosegretario alla Presidenza delConsiglio delegato dallo stesso Presidente del Consiglio133.
133 Secondo G. VESPERINI, Il governo della semplificazione. Il commento, in Gior-nale di diritto amministrativo, 2007, n. 3, p. 270, particolarmente importante «è l’os-servazione concernente l’assetto dei rapporti tra le varie articolazioni di questo com-plesso apparato politico e amministrativo. Al riguardo, di recente, è stata sostenuta latesi secondo la quale le recenti modifiche normative rappresenterebbero una tappa ul-teriore del “tira e molla” tra la presidenza del Consiglio dei ministri e il dipartimentodella funzione pubblica e sposterebbero, nuovamente, dopo le vicende seguite alla l. n.137/2002, il baricentro della guida delle politiche di semplificazione e di qualità di re-golazione dal secondo alla prima. L’esame della disciplina mostra, però, che la vicendaè più complessa e che l’attribuzione alla presidenza del Consiglio della guida delle po-litiche di semplificazione amministrativa e di qualità della regolazione è parziale e, co-munque, costituisce solo una componente di questo disegno. Costituisce una compo-
143I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
Anche il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guidastrategica per le politiche di semplificazione e di qualità della re-golazione sembra quindi confermare la tendenza a fare dei comi-tati interministeriali degli strumenti attraverso i quali il Presi-dente del Consiglio dei ministri può rafforzare il suo ruolo, eser-citando in maniera più efficace la sua funzione di indirizzo ecoordinamento dell’azione di governo.
Occorre osservare, peraltro, che, come per il CIACE, l’attri-buzione di un ruolo di un certo rilievo ad un ministro senza por-tafoglio sembra derivare più da necessità di carattere politico, le-gate alla ripartizione di incarichi governativi tra le differentiforze politiche della maggioranza, che alla volontà di attribuiredeterminate funzioni di governo ad un ministro. Non pare uncaso, infatti, che, qualora i ministri senza portafoglio non fosseroistituiti da un Esecutivo, le loro funzioni sarebbero esercitate dalPresidente del Consiglio attraverso un suo sottosegretario, consi-derato che gli apparati amministrativi che già oggi si occupano ditali funzioni sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio. Equesta, in realtà, appare la soluzione preferibile: un numero mi-nore di ministri, con l’attribuzione delle funzioni dei ministrisenza portafoglio al Presidente del Consiglio.
nente di questo disegno, perché il Presidente del Consiglio acquisisce poteri rilevantidi disciplina della organizzazione preposta alle politiche in materia (si ricordi, infatti,che con d.P.C.M. si istituiscono e disciplinano i compiti del comitato, dell’unità e deltavolo permanente); presso la Presidenza del Consiglio operano gran parte delle strut-ture competenti in materia; funzioni di impulso, guida e supporto di queste stessestrutture sono attribuite agli uffici della Presidenza del Consiglio. È parziale, però,perché, i poteri di indirizzo, coordinamento ed impulso delle amministrazioni delloStato e di raccordo con gli altri livelli di governo e con gli altri soggetti istituzionalinelle politiche in materia, sono intestati al comitato interministeriale, che il Presidentedel Consiglio si limita a presiedere direttamente o tramite delega al Ministro per leriforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione». Per una critica dell’ac-centramento in capo al Presidente del Consiglio delle politiche della qualità della re-golazione si rinvia a A. VALASTRO, La valutazione, cit. Si v. anche le osservazioni diA. MARI, L’organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione: misureurgenti e questioni di lungo periodo, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 6,pp. 585 ss.
144 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
4.5. Il CISR
Occorre occuparsi, ora, del Comitato interministeriale per lasicurezza della Repubblica (CISR)134. Prima di esaminarne la disci-plina, tuttavia, è opportuno ricordare che esso sostituisce il Co-mitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS).
Il CIIS era è stato istituito con la l. 801/1977 e la sua disci-plina integrata con il regolamento adottato nel 1994135. La crea-zione di tale comitato si inseriva nel più ampio quadro di ristrut-turazione dell’ordinamento dell’informazione e della sicurezzadello Stato136, che aveva portato alla configurazione di un sistemabasato sui seguenti organi: il Presidente del Consiglio; il CIIS; ilcomitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza(CESIS); il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SI-SMI); il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SI-SDE); un comitato parlamentare costituito da quattro deputati equattro senatori137. Nel contesto di tale riforma, il CIIS sembravaassumere la veste di organo consultivo del Presidente del Consi-glio, anche se il regolamento del comitato aveva attribuito al CIIS
il compito di emanare alcuni pareri vincolanti in materia di no-mine e di organico, che apparivano volti a contenere proprio ladiscrezionalità del Presidente del Consiglio. Nonostante tali at-tribuzioni, non era parso venir meno il ruolo preminente di que-st’ultimo: in primo luogo, perché la segreteria del comitato eraistituita presso la Presidenza del Consiglio138; in secondo luogo,
134 Cfr. la l. 124/2007, art. 2.135 … con il d.p.r. 756/1994.136 L’intera l. 801/1977, in realtà, avrebbe rappresentato «non altro che una
tappa di un processo più impegnativo», secondo M. RODRIQUEZ, Segreto di Stato e ser-vizi di sicurezza nella legge di riforma, in Diritto e società, 1978, p. 165.
137 Cfr. la l. 801/1977, artt. 3, 4, 6 e 11. Su quest’ultima disposizione in partico-lare si v. G. ARENA, Le attribuzioni del Parlamento in materia di servizi per le informa-zioni e la sicurezza in Italia e negli Stati uniti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,1978, pp. 485 ss.
138 Ai sensi dell’art. 2, co. 3, del d.p.r. 756/1994, infatti, l’ufficio di segreteria delCIIS aveva sede presso la segreteria generale del CESIS, che era posto alle dirette di-pendenze del Presidente del Consiglio (cfr. la l. 801/1977, art. 3). Secondo S. CASSESE,
145I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
per la discrezionalità di cui il Presidente del Consiglio disponevanella gestione dello stesso comitato; infine, perché nel contestodella l. 801/1977 il premier pareva assumere un ruolo preponde-rante – forse addirittura nei confronti del Consiglio dei mini-stri139 – in ordine al coordinamento e alla direzione della politicadell’informazione e della sicurezza140. Il CIIS, di conseguenza, ap-pariva destinato ad assumere essenzialmente il ruolo di organo diconsulenza e proposta nei confronti del Presidente del Consigliodei ministri141.
Riassunti i tratti essenziali del CIIS e del contesto normativonel quale si inseriva, è necessario passare ad esaminare il CISR.
Occorre premettere che anche il nuovo intervento norma-tivo è volto a ridefinire completamente la disciplina del segretodi Stato, nonché il c.d. Sistema di informazione per la sicurezzadella Repubblica142. Quest’ultimo, in particolare, è composto dalPresidente del Consiglio dei ministri, dal CISR, dalla c.d. Autoritàdelegata143, ove istituita144, dal Dipartimento delle informazioni
Esiste, cit., part. p. 41, infatti, questa previsione rappresentava un elemento indicativodell’affermazione progressiva del ruolo della Presidenza del Consiglio.
139 Si v., però, le osservazioni di P. CIRIELLO, Ordinamento, cit., pp. 250-251.140 A. MATTIONI, Comitati, cit., p. 19, invece, sembrava ritenere maggiormente
incisivo il ruolo del CIIS, anche nel vincolare l’azione del Presidente del Consiglio inmateria di informazioni e sicurezza.
141 Secondo G. POTENZA, L’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei mini-stri, in Diritto e società, 1980, p. 759, l’intera l. 801/1977 costituiva un significativo se-gnale dell’evoluzione della posizione del Presidente del Consiglio dei ministri, «chesempre più si allontana dalla posizione di primus inter pares per assumere una posi-zione di supremazia con la concentrazione di poteri e delle relative responsabilitàpresso il Presidente del Consiglio». Secondo M. SAVINO, Solo per i tuoi occhi? Lariforma del sistema italiano di intelligence, in Giornale di diritto amministrativo, 2008,n. 2, p. 124, nt. 18, la tendenza all’accentramento del potere di indirizzo in materia,proseguita anche con la l. 124/2007, risalirebbe a Corte costituzionale, sent. 86/1977.
142 Al riguardo si v. C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, Iservizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano, Giuf-frè, 2008.
143 Cfr. la l. 124/2007, art. 3.144 Per l’istituzione della Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica si v.
i d.p.c.m. 26 ottobre 2007 (Governo Prodi II), 22 maggio 2008 e 16 luglio 2008 (Go-
146 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezzaesterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna(AISI)145. La legge prevede anche l’istituzione di un comitato par-lamentare per la sicurezza della Repubblica (c.d. COPASIR), com-posto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro ventigiorni dall’inizio di ogni legislatura dai presidenti dei due ramidel Parlamento in proporzione al numero dei componenti deigruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanzaparitaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo contodella specificità dei compiti del Comitato146.
Per quanto riguarda la composizione del CISR, esso «è pre-sieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è compostodall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affariesteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Mi-nistro della giustizia dal Ministro dell’economia e delle finanze edal Ministro dello sviluppo economico»147. Inoltre, il «Presidentedel Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedutedel Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto divoto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori del-l’AISE e dell’AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui divolta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione allequestioni da trattare». Occorre soffermarsi, tuttavia, sulla presi-denza del comitato. La l. 124/2007 prevede che il Presidente delConsiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, possa delegarele funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva sol-
verno Berlusconi IV). Al riguardo pare utile un rinvio a M. FRANCHINI, Brevi note sullafigura della «Autorità delegata» nella legge di riforma del sistema nazionale delle infor-mazioni per la sicurezza (legge n. 124 del 2007), in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi,vol. I, Napoli, Jovene, 2010, pp. 527 ss.
145 Cfr. la l. 124/2007, art. 2.146 Sul comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica si v. gli artt. 30-
38 della l. 124/2007.147 Cfr. la l. 124/2007, art. 5, co. 3, come modificato dalla l. 121/2008, art. 1, che
ha convertito con modificazioni il d.l. 81/2008. Critico sulla composizione del comi-tato M. SAVINO, Solo, cit., p. 125.
147I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
tanto ad un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario diStato (Autorità delegata)148. Poiché la presidenza del CISR nonrientra tra le funzioni attribuite in via esclusiva al Presidente delConsiglio149, essa può essere delegata ad un ministro senza por-tafoglio o ad un sottosegretario, i quali devono esercitarla nel ri-spetto dei vincoli previsti dalla legge per tutte le altre funzioniloro delegate. L’Autorità delegata, infatti, non può esercitare fun-zioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dalPresidente del Consiglio dei ministri a norma della l. 124/2007.Il Presidente del Consiglio dei ministri deve essere costante-mente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di eserci-zio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di diret-tiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di al-cune di esse150.
Per quanto riguarda le modalità del suo funzionamento, ilCISR è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,mentre le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal di-rettore generale del DIS, che deve essere un dirigente di prima fa-scia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, nominato e re-vocato in via esclusiva dal Presidente del Consiglio dei ministri151.
Passando alle funzioni del comitato, si può osservare cheesse sono definite in maniera piuttosto sintetica. Il CISR ha ilcompito di svolgere funzioni di consulenza, proposta e delibera-
148 Cfr. la l. 124/2007, art. 3, co. 1.149 L’elenco di tali funzioni è fornito dall’art. 1, co. 1, della l. 124/2007: «Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva: a) l’alta direzione e laresponsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse eper la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzionea suo fondamento; b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato; c) la conferma del-l’opposizione del segreto di Stato; d) la nomina e la revoca del direttore generale e diuno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione perla sicurezza; f) la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per iservizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per lasicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30».
150 Cfr. la l. 124/2007, art. 3, co. 1-bis e 3.151 Cfr. la l. 124/2007, art. 5, co. 1 e 4, e art. 4, co. 5.
148 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
zione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica del-l’informazione per la sicurezza; provvede, inoltre, ad elaboraregli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nelquadro della politica dell’informazione per la sicurezza, nonchéa deliberare sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS ei servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci pre-ventivi e consuntivi152. Numerose disposizioni della legge, poi,attribuiscono all’organo una funzione deliberativa o consultivanei confronti del Presidente del Consiglio, soprattutto in materiadi nomine153. Infine, occorre ricordare che in tutti gli atti aventiforza di legge l’espressione CIIS si intende riferita al CISR154.
Dopo averne riassunto i caratteri basilari, pare di potersi af-fermare che il nuovo comitato costituito nell’ambito del sistemadi sicurezza nazionale non sembra distinguersi in maniera so-stanziale dal suo predecessore. La disciplina dell’organo, infatti,ricalca – fondamentalmente – i tratti essenziali del sistema prece-dente e dell’evoluzione che esso aveva vissuto. Il CISR, dunque, siconfigura quale organo di consulenza del Presidente del Consi-glio dei ministri in materia di sicurezza nazionale. Infatti, proprioquest’ultimo sembra continuare a mantenere un ruolo assoluta-mente centrale all’interno di tale sistema: svolge un ruolo deter-minante per quanto riguarda la disciplina del segreto di Stato155;gli sono attribuite funzioni che può esercitare in via esclusiva; lefunzioni che può delegare rimangono pienamente nella sua di-sponibilità; i pareri che richiede al CISR non sono vincolanti; haampi poteri di nomina; l’AISE e l’AISI sono strettamente legate alPresidente del Consiglio156; infine, il DIS, un organo che assume
152 Cfr. la l. 124/2007, art. 5, co. 1 e 2.153 Si v. la l. 124/2007, art. 4, co. 3, lett. d e f, co. 5, art. 6, co. 7, art. 7, co. 7, art.
8, co. 2, art. 29, co. 2 e 3, lett. b, art. 43, co. 1.154 Così la l. 124/2007, art. 44, co. 4.155 Si v., al riguardo, gli artt. 39-42 della l. 124/2007, e A. PACE, L’apposizione del
segreto di Stato nei principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007, in Giurispru-denza costituzionale, 2008, n. 5, pp. 4041 ss.
156 Cfr. artt. 6 e 7 della l. 124/2007.
149I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
una posizione di rilevo all’interno del nuovo sistema della sicu-rezza, è costituito presso la Presidenza del Consiglio e diretto daun funzionario nominato e revocato dal Presidente del Consiglioe sembra volto a coadiuvare il premier nello svolgimento dei suoicompiti d’indirizzo amministrativo157.
Il ruolo di netta preminenza del Presidente del Consiglio al-l’interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Re-pubblica si riflette, ovviamente, anche nei rapporti tra il primo eil CISR. Come si è già visto, infatti, il comitato sembra assumeresostanzialmente un ruolo di mero ausilio e consulenza nei con-fronti del Presidente del Consiglio, non solo perché i pareri cheesprime non sono vincolanti, ma anche perché l’istituzione del-l’organo presso la Presidenza del Consiglio e l’attribuzione dellefunzioni di segretario ad un funzionario di nomina presidenzialeappaiono rafforzare l’influenza della Presidenza del Consiglio sul-l’attività dello stesso CISR. È appena il caso di aggiungere che l’i-potizzata possibilità di delegare la presidenza del comitato ad unministro senza portafoglio non pare in grado di intaccare il ruolopreminente del Presidente del Consiglio, sia per le considerazionidi carattere generale svolte, al riguardo, in merito al CIACE158 e alComitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica perle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione159, siaperché, con riferimento specifico al CISR, si è già avuto modo diosservare che la legge prevede espressamente che le funzioni de-legate rimangano nella disponibilità del Presidente del Consiglio.
4.6. Il Comitato interministeriale per la revisione della spesa pub-blica
Occorre dar conto, infine, del comitato istituito dal Go-verno Monti: il Comitato interministeriale per la revisione della
157 Cfr. la l. 124/2007, art. 4, come modificato dal d.l. 78/2009, convertito dallal. 102/2009, e M. SAVINO, Solo, cit., p. 125.
158 Cfr. supra, parte II, cap. II, par. 4.3.159 Cfr. supra, parte II, cap. II, par. 4.4.
150 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
spesa pubblica, istituito con il d.l. 52/2012, convertito con modi-ficazioni dalla l. 94/2012160.
Come si vedrà in seguito161, il Governo presieduto da MarioMonti è nato nella XVI legislatura col sostegno della gran partedelle forze politiche presenti in Parlamento al fine di affrontarele difficoltà dell’Italia derivanti dalla grave crisi economico-fi-nanziaria internazionale. Tra le misure ritenute prioritarie a talescopo è stata individuata quella della riduzione della spesa pub-blica. A tal fine, il Governo ha provveduto alla istituzione – conil citato d.l. 52/2012 – di un commissario straordinario per la ra-zionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi (art. 2),nonché di un apposito comitato interministeriale (art. 1).
Esaminando le caratteristiche del Comitato interministerialeper la revisione della spesa pubblica alla luce della sua sinteticadisciplina, occorre considerarne innanzitutto la composizione. Ilcomitato è «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministrie composto dal Ministro delegato per il programma di Governo,dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-zione e dal Ministro dell’economia e delle finanze o vice Mini-stro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Con-siglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri». Lacomposizione del comitato non è elastica, ma il Presidente delConsiglio può modificarla con un suo decreto, «sentite le com-missioni parlamentari competenti»162. Occorre porre in evidenzache nel comitato non è prevista una rappresentanza delle auto-nomie locali. Se, per un verso, ciò non sorprende, consideratoche il Governo Monti è nato per assumere misure di contrasto
160 Il comitato, prima dell’approvazione della legge di conversione, è stato giàesaminato in D. CODUTI, Comitati interministeriali e di ministri, in Digesto delle disci-pline pubblicistiche, agg., Torino, Utet, 2012, pp. 199-200.
161 Sulla crisi del Governo Berlusconi IV e la nascita del Governo Monti nellaXVI legislatura si v. infra, parte III, cap. 2, par. 2.1.5.
162 La necessità di consultare le commissioni parlamentari competenti non eraprevista dal d.l. 52/2012 ma è una delle modificazioni apportate dalla legge di conver-sione.
151I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
alla crisi economica nel limitato tempo a disposizione sino allafine della legislatura, per altro verso, poiché le misure volte acontrastare la crisi economica si sostanziano nella riduzione dellerisorse a disposizione (anche) delle Regioni e degli enti locali,una qualche forma di rappresentanza delle autonomie locali inseno al comitato poteva essere opportuna.
Passando a considerarne le funzioni, il comitato è destinatoa svolgere «attività di indirizzo e di coordinamento, in partico-lare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasfe-rimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi of-ferti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle speseper acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell’uso degli im-mobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presi-dente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012». In sede diconversione, al comitato è stato attribuito un ulteriore compito.Il comitato, infatti, deve dapprima presentare al Governo unaproposta per la predisposizione di un programma per la riorga-nizzazione della spesa pubblica; il programma è successivamentepresentato dall’Esecutivo al Parlamento; entro venti giorni dalladata di entrata in vigore della legge di conversione, il comitatodeve definire le modalità di predisposizione del suddetto pro-gramma e della relativa attuazione e, per il tramite della Presi-denza del Consiglio dei Ministri, darne comunicazione al Parla-mento, al fine dell’espressione del parere da parte delle commis-sioni parlamentari competenti per i profili finanziari, entrotrenta giorni dalla trasmissione163.
Il comitato, inoltre, svolge un ruolo di controllo nei con-fronti del commissario straordinario previsto dallo stesso decretolegge. Infatti, il commissario straordinario è tenuto a presentare,entro quindici giorni dalla nomina, un programma di lavoro alcomitato interministeriale e il comitato ha il compito di verificare
163 Cfr. il d.l. 52/2012, art., 1, co. 1-bis e 1-quater, introdotti dalla legge di con-versione.
152 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
l’attuazione di tale programma sulla scorta delle relazioni mensilipresentate dallo stesso commissario straordinario164.
Come si è visto, la disciplina del Comitato interministerialeper la revisione della spesa pubblica è piuttosto sintetica ma taleintervento normativo appare significativo, perché, nonostante lapropensione al ridimensionamento del numero di comitati inter-ministeriali di cui si è parlato nelle pagine precedenti, l’episodioevidenzia come tali organi rappresentino una risorsa per l’orga-nizzazione dell’Esecutivo, anche quando si caratterizza comeGoverno “tecnico” e, dunque, non vi sia l’esigenza di garantirel’equilibrio delle forze politiche di maggioranza all’interno dellacompagine governativa. La composizione del comitato, inoltre,conferma la tendenza che vede nei comitati interministeriali or-gani attraverso i quali si rafforza il ruolo del premier. L’organo,infatti, è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è compostoda un numero assai ridotto di ministri, nonché da un sottosegre-tario alla Presidenza del Consiglio; si relaziona al Parlamento tra-mite la stessa Presidenza del Consiglio; la sua composizione,inoltre, può essere modificata dallo stesso premier con un suo de-creto. È interessate osservare che in sede di conversione in leggedel decreto si è previsto che, qualora il Presidente del Consigliointendesse modificare la composizione del comitato, dovrebbesentire le commissioni parlamentari competenti. Sebbene sidebba ritenere che il parere delle commissioni parlamentari nonsia vincolante, è significativo che il Parlamento cerchi di esserecoinvolto anche nelle decisioni inerenti l’organizzazione internadell’Esecutivo. Ciò si giustifica certamente con le peculiarità del-l’Esecutivo tecnico e delle circostanze nelle quali esso è nato, mapotrebbe essere anche indicativo di un tentativo del Parlamentodi recuperare terreno nei confronti dell’Esecutivo proprio in unmomento in cui le dinamiche maggioritarie dei rapporti Go-verno-Parlamento sembrano maggiormente in crisi.
164 Così il d.l. 52/2012, art. 3, co. 2. In sede di conversione si è previsto altresìche il programma e le relazioni mensili indicate nel testo siano inviate anche alle com-petenti commissioni parlamentari.
153I COMITATI INTERMINISTERIALI ISTITUITI IN ITALIA
Per ogni ulteriore valutazione sull’organo sarà necessarioesaminare il suo concreto funzionamento. Tale ultimo aspettosarà utile anche per comprendere se il Comitato interministerialeper la revisione della spesa pubblica sia destinato ad operare sta-bilmente oppure se, rappresentando uno degli strumenti con iquali far fronte alla contingenza economica, sarà soppresso dopoil superamento della fase più critica della crisi economico-finan-ziaria165.
165 La l. 94/2012 ha comunque prorogato l’efficacia delle disposizioni del d.l.52/2012 citate nel testo sino al 31 dicembre 2014.
154 PARTE SECONDA - CAPITOLO SECONDO
CAPITOLO PRIMO
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA E LE RIFORME ELETTORALI
IN SENSO MAGGIORITARIO
SOMMARIO: 1. Il principio maggioritario: una premessa di carattere terminologico.– 2. I sistemi elettorali e i loro effetti. – 3.1. I sistemi elettorali in Italia: dal-l’Unità d’Italia alla Repubblica. – 3.2. La crisi del proporzionalismo. – 3.3.La riforma maggioritaria del 1993. – 3.4. Il voto degli italiani all’estero. –3.5. La riforma elettorale del 2005.
1. Il principio maggioritario: una premessa di carattere termino-logico
Occorre occuparsi, ora, dei sistemi elettorali “maggioritari”,introdotti nell’ordinamento italiano dalla riforma elettorale del19931, e delle conseguenze che il principio maggioritario ha pro-dotto sul sistema di governo italiano2. Prima di svolgere questaanalisi, sono necessarie delle osservazioni preliminari sul princi-pio maggioritario e, in particolare, talune precisazioni di ordineterminologico.
1 Sul principio maggioritario nell’ordinamento italiano prima della riforma elet-torale del 1993 si rinvia a C. FUSARO, Principio maggioritario e forma di governo, ed.provvisoria, Firenze, Università degli Studi di Firenze, 1990, pp. 45 ss.
2 Secondo C. CHIOLA, Presidente della Repubblica e formazione del Governo, in M.LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bologna, il Mulino, 1997,p. 100, si tratterebbe di un principio nuovo nell’ordinamento italiano, che, essendo in-trodotto senza una riforma costituzionale, dovrebbe muoversi in aree non coperte daprevisioni costituzionali. Appare utile rinviare a F. MODUGNO, Principi generali dell’or-dinamento, in Enciclopedia giuridica, vol. XXIV, Roma, Treccani, 1991, pp. 1 ss.
L’espressione “principio maggioritario” è spesso utilizzatacome sinonimo di altre: “principio della maggioranza”; “regolamaggioritaria” o “di maggioranza”; “criterio maggioritario” o“della maggioranza”; “maggioritarismo”3. Come è stato corretta-mente osservato4, l’indifferenza nell’impiego di queste espres-sioni dipende dal rilievo che in ognuna di esse assume il riferi-mento alla comune radice, ravvisabile nel termine “maggiore”.Con tali espressioni si fa riferimento ad uno dei criteri utilizzabiliper la formazione della volontà all’interno di una collettività dipersone eguali da un punto di vista giuridico5: quello in base al
3 In questo senso C. FUSARO, Principio, cit., p. 13, e G.U. RESCIGNO, Principiomaggioritario, in Enciclopedia giuridica, vol. XXIV, Roma, Treccani, 1998, p. 1.
4 Da G.U. RESCIGNO, Principio, cit., p. 1.5 Sul principio di eguaglianza come presupposto del principio maggioritario si v.
E. RUFFINI, Il principio maggioritario. Profilo storico [1927], 3ª ed., Milano, Adelphi,2002, pp. 11-12, C. FUSARO, Principio, cit., pp. 13-14, e A. BARBERA, C. FUSARO, Mag-gioranza, principio di, 1. Diritto, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. V, Roma, Trec-cani, 1996, pp. 400-401 e 407, ma anche le considerazioni di G. TRIPOLI, Osservazionisul principio maggioritario e sui suoi limiti, in Rivista internazionale di filosofia del di-ritto, 1983, pp. 642 ss. Si v., però, i dubbi espressi da G.U. RESCIGNO, Principio, cit., p.14, e G. AMBROSINI, Sistemi elettorali, Firenze, Sansoni, 1946, pp. 13-14.
Ai fini dell’applicazione del principio maggioritario, inoltre, è necessaria una di-screta omogeneità sociale, perché in una società troppo conflittuale il principio mag-gioritario, anziché essere utilizzato come strumento di risoluzione delle controversie,può diventare una «tecnica di sopraffazione» ad uso della maggioranza: in questosenso O. KIRCHHEIMER, Weimar - und was dann? Analyse einer Verfassung, in Politikund Verfassung, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1964, trad. it., Analisi di una Costi-tuzione. Weimar - E poi?, in ID., Costituzione senza sovranità, Bari, De Donato, 1982,pp. 52-53, ma si v. anche A. LIJPHART, Patterns of Democracy. Government Forms andPerformance in Thirty-Six Countries, New Haven, London, Yale University Press,1999, trad. it., Le democrazie contemporanee, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 51 ss. Sulleconnessioni tra omogeneità sociale e principio maggioritario si v. anche P.G. GRASSO,Rilevanza costituzionale del sistema elettorale nell’ordinamento repubblicano, in Dirittoe società, 1995, n. 4, pp. 448-449, T.E. FROSINI, Sovranità popolare, principio maggiori-tario e riforme istituzionali, in Diritto e società, 1995, n. 4, pp. 462 ss., ID., Suggestioni,cit., p. 108, M. OLIVETTI, Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni, Bologna, ilMulino, 2002, part. p. 45; sulla omogeneità come presupposto del normale gioco delleistituzioni democratiche si v. D. SCHINDLER, Verfassungsrecht und soziale Struktur, Zü-rich, Schulthess, 1932, trad. it., Diritto costituzionale e struttura sociale, a cura di R. BI-FULCO, Padova, Cedam, 1999, p. 106; sulla identificazione dell’eguaglianza democra-tica come omogeneità, infine, si rinvia a C. SCHMITT, Verfassungslehre, cit., pp. 293 ss.
158 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
quale la volontà della parte maggiore dei suoi componenti pre-vale sulle altre, vincolando alla decisione assunta anche le mino-ranze6. Così sintetizzato, il maggioritario rappresenta una regoladi efficienza7, perché consente ad una collettività di decidere, su-perando «l’irriducibile dissenso individuale»8 e, di conseguenza,l’impossibilità di raggiungere sempre l’unanimità nell’assunzionedelle decisioni9.
6 In questo senso O. VON GIERKE, Über die Geschichte des Majoritätsprinzips, inP. VINOGRADOFF (ed.), Essays in Legal History, London, Edinburgh, Glasgow, OxfordUniversity Press, 1913, trad. it., Sulla storia del principio di maggioranza, in Rivistadelle società, 1961, p. 1103, E. RUFFINI, Il principio, cit., pp. 11 ss., F. GALGANO, Prin-cipio di maggioranza, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, p.547, C. FUSARO, Principio, cit., pp. 13-14, G.U. RESCIGNO, Democrazia e principio mag-gioritario, in Quaderni costituzionali, 1994, n. 2, pp. 187 ss., ID., Principio, cit., pp. 1-2, e P. RESCIGNO, La lezione di Edoardo Ruffini sul principio di maggioranza, in Rivistatrimestrale di diritto e procedura civile, 1978, p. 815. Si v. anche M. CAPURSO, Sistemaparlamentare, principio di maggioranza e consenso delle minoranze negli ordinamenti de-mocratici e l’esperienza italiana, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1981,part. p. 234.
7 Riprendendo l’espressione di G. TRIPOLI, Osservazioni, cit., p. 629, lo si po-trebbe definire anche «un mero espediente».
8 L’espressione è di F. GALGANO, Principio, cit., p. 548.9 Come osservato da E. RUFFINI, Il principio, cit., p. 104, «il maggioritario è nelle
deliberazioni collettive l’unico principio dinamico (…), mentre tutti gli altri sono prin-cipi statici. Le collettività devono adottarlo, se non vogliono essere condannate a piéti-ner sul place (…)». Secondo M. OLIVETTI, Art. 1, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLI-VETTI (a cura di), Commentario, vol. I, cit., p. 20, quindi, per risolvere il problema dellamodalità di adozione delle decisioni da parte di un’entità composta da una pluralità dipersone, il “principio democratico” si declina come “principio maggioritario”; sullaconnessione tra principio maggioritario e l’art. 1 Cost. si v. altresì C. MORTATI, Art. 1,in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, continuato da A. PIZZO-RUSSO, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1975, pp. 30-32. Secondo C. FUSARO,Principio, cit., p. 155, il principio maggioritario «si propone (…) come principio orga-nizzativo e operativo funzionale alla piena esplicazione del principio democratico nellasua versione contemporanea identificantesi nella sovranità popolare». Si v. anche le os-servazioni di A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, Torino, Einaudi, 1993, pp. 29-30, e A. BARBERA, C. FUSARO, Maggioranza, cit., pp. 410-411, nonché quelle piuttostocritiche di G. TRIPOLI, Osservazioni, cit., pp. 649 ss., sulla sovrapposizione dei concettidi democrazia e di principio maggioritario, e S. RODOTÀ, Il tema: principio maggiorita-rio e «nuovi interessi», in Politica del diritto, 1981, n. 1, pp. 5-7, sui limiti di tale prin-
159L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
La formazione di una maggioranza e di una o più minoranzeall’interno di un collegio, conduce alla possibilità di distingueretra “regola” e “principio” maggioritari. Se, infatti, per assumerele varie decisioni all’interno di un collegio si aggregano volta pervolta maggioranze differenti, occorre parlare di “regola” maggio-ritaria, riferendosi alla previsione di una determinata modalitàprocedurale attraverso la quale il collegio assume le proprie de-cisioni. Qualora, all’interno di un collegio – soprattutto se poli-tico o rappresentativo –, la maggioranza che approva o respingele decisioni è sempre la stessa, appare invece più proprio parlaredi “principio” maggioritario, perché esso non indica solamenteuna modalità operativa del collegio, ma anche che, al suo in-terno, esistono una maggioranza e delle minoranze stabili, cherappresentano determinati gruppi sociali presenti nella colletti-vità che tale collegio ha eletto10.
Un’ulteriore differenza emerge quando il maggioritario nonè utilizzato per assumere delle decisioni all’interno di un colle-gio, bensì per eleggere. Infatti, mentre nel primo caso la dicoto-mia principale è tra principio di maggioranza e unanimità, nel se-condo il principio maggioritario si contrappone al principio pro-porzionale11.
cipio nel garantire la tutela di valori nuovi, che non trovano forme adeguate di prote-zione costituzionale.
10 In questo senso la distinzione delineata da G.U. RESCIGNO, Principio, cit., p.10. Analogamente si potrebbe osservare, riprendendo A. BARBERA, C. FUSARO, Maggio-ranza, cit., p. 399, che la regola della maggioranza costituisce una regola per decidere,mentre il principio maggioritario costituisce una regola per governare. Appare utilerinviare anche alle osservazioni di G. CORSO, Individuo, decisione collettiva, principiomaggioritario, in AA.VV., Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, vol. I, Milano,Giuffrè, 1988, part. pp. 252 ss.
11 Si v., in questo senso, C. FUSARO, Principio, cit., pp. 17 ss., e A. BARBERA, C.FUSARO, Maggioranza, cit., p. 405. Secondo G.U. RESCIGNO, Principio, cit., pp. 11 ss.,invece, non è possibile contrapporre i due principî ma solo i due differenti sistemi elet-torali. In primo luogo, infatti, il sistema elettorale proporzionale non esclude il princi-pio maggioritario, ma lo esige, perché il collegio eletto in modo proporzionale neces-sita del principio di maggioranza per decidere. In secondo luogo, il sistema elettoraleproporzionale è – al pari del sistema elettorale maggioritario – una delle possibili rea-
160 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
Poiché, come si è già detto, il principio maggioritario di cuisi discute è stato introdotto nell’ordinamento italiano proprio invirtù della modifica del sistema elettorale, prima di verificare at-traverso quale percorso si è giunti alla riforma elettorale, è ne-cessario premettere alcuni cenni sui differenti sistemi elettorali esugli effetti che – tendenzialmente – essi possono produrre sul si-stema partitico, sul funzionamento degli organi di vertice dell’or-dinamento e sui loro rapporti.
2. I sistemi elettorali e i loro effetti
Un sistema elettorale può essere definito come un com-plesso di regole e di procedure che disciplinano le modalità concui gli elettori esprimono il loro voto, le possibilità che i partitipresentatisi alle elezioni ottengano o meno rappresentanza parla-mentare, nonché le modalità con cui i voti vengono tradotti inseggi12. Quando si parla di sistemi elettorali, tuttavia, non ci si ri-ferisce solo alle procedure attraverso le quali il corpo elettoralepuò eleggere dei rappresentanti, ovvero, ai meccanismi che con-sentono di tradurre i voti in seggi13, ma anche alla c.d. legisla-zione elettorale di contorno. Il riferimento è a tutte quelle dispo-sizioni che assumono importanza nel funzionamento dei disposi-tivi per la preposizione di individui ad incarichi autoritativi: ilridisegno delle circoscrizioni, l’eventuale rilievo dato all’astensio-nismo, le limitazioni all’elettorato attivo e passivo, la disciplinadell’informazione politica e della propaganda elettorale, i con-
lizzazioni del principio di maggioranza; secondo l’A., dunque, il criterio proporzionalerappresenterebbe «la soluzione nuova, che spiazza in qualche modo il principio mag-gioritario anche se ne costituisce pur sempre una realizzazione».
12 Così G. PASQUINO, I sistemi elettorali, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di),Manuale, vol. II, cit., p. 67. Si v. anche M. GALLAGHER, P. MITCHELL, Introduction toElectoral Systems, in ID. (eds.), The Politics of Electoral Systems, Oxford, Oxford Uni-versity Press, 2006, p. 3.
13 G. PASQUINO, I sistemi, cit., p. 68, definisce questi meccanismi, in maniera piùpropria, formule elettorali; nello stesso senso C. FUSARO, Elezioni, in S. CASSESE (di-retto da), Dizionario, vol. III, cit., p. 2168.
161L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
trolli sulle modalità di finanziamento dei partiti, sul loro statopatrimoniale e sulle campagne elettorali dei singoli candidati14.
Sono state proposte numerose classificazioni in merito sia aisistemi elettorali15 sia alle formule elettorali16 a dimostrazione dicome, su questo tema, sia «possibile esercitare la fantasia»17. Unadelle classificazioni più note18 utilizza un criterio statistico-mate-matico che conduce alla seguente distinzione: a) sistemi maggio-ritari estremi (come il plurality system, che contraddistingue ilmondo anglosassone); b) sistemi maggioritari corretti (quale ildoppio turno o ballottaggio19, utilizzato, ad esempio, in Francia);c) sistemi proporzionali corretti (voto limitato, voto singolo nontrasferibile, sistemi con clausola di esclusione dal riparto deiseggi di gruppi o partiti che non raggiungano una percentualeminima di suffragi, sistemi con collegi plurinominali di piccoledimensioni); d) sistemi proporzionali estremi: scrutinio di lista incollegi plurinominali e utilizzazione dei resti in sede di collegiounico nazionale, o scrutinio di lista in un unico collegio che co-pre l’intero territorio statale.
Ciò nondimeno, un criterio generale di classificazione puòessere individuato in quello che distingue tra sistemi elettorali
14 Cfr., in proposito, C. FUSARO, Le regole della transizione, Bologna, il Mulino,1995, p. 94.
15 Si v., a titolo di esempio, C. LAVAGNA, Istituzioni, cit., pp. 504-505, secondo ilquale si avrebbero «tre sistemi fondamentali di rappresentanza politica (ai quali si ag-giungono, tuttavia, numerose forme miste, impure o corrette): quelli maggioritari,quelli a rappresentanza relativa delle minoranze e quelli proiettivi o proporzionali».
16 Ad es. G. PASQUINO, I sistemi, cit., p. 69, parla di formule a maggioranza as-soluta (majority), formule a maggioranza relativa (plurality) e formule proporzionali.
17 Così O. MASSARI, G. PASQUINO (a cura di), Rappresentare e governare, Bologna,il Mulino, 1994, p. 10.
18 Il riferimento è a D. FISICHELLA, Elezioni (sistemi elettorali), in Enciclopediadel diritto, vol. XIV, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 649-650. Questa nota classificazione èripresa anche da altri Autori: cfr., ad es., S. FURLANI, Elezioni, in Enciclopedia giuridica,vol. XII, Roma, Treccani, 1989, p. 1, e L. PALADIN, Diritto, cit., p. 295.
19 G. PASQUINO, I sistemi, cit., pp. 69-70, fa notare che, quando si utilizzano for-mule elettorali a maggioranza assoluta, è necessario introdurre dei correttivi, per evi-tare situazioni di stallo nelle quali nessun candidato riesce ad ottenere il seggio.
162 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
maggioritari e sistemi elettorali proporzionali20. Questa distin-zione non è di poco conto, perché a ciascun sistema elettoralecorrisponde uno specifico “senso politico”21, che comporta con-seguenze differenti sulla rappresentanza delle forze presenti nellacollettività nazionale, sul sistema partitico e sulla forma di go-verno. Si può affermare, pertanto, che questi differenti sistemielettorali portano alla formazione di due modelli (idealtipici) didemocrazia contrapposti22: la democrazia maggioritaria e quellaconsensuale23.
20 Secondo A. LIJPHART, Patterns, cit., p. 164, infatti, nonostante siano necessarieulteriori importanti distinzioni, la dicotomia tra il sistema proporzionale e quello uni-nominale maggioritario rappresenterebbe, in realtà, la linea di divisione fondamentalenella classificazione dei sistemi elettorali. Questa distinzione è comunemente usatanella manualistica italiana: cfr. ad es. C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., p. 447; T.MARTINES, Diritto, cit., pp. 276-277; P. CARETTI, U. DE SIERVO, Istituzioni di diritto pub-blico, 4ª ed., Torino, Giappichelli, 1999, pp. 141-142; M. MAZZIOTTI DI CELSO, G.M.SALERNO, Manuale, cit., pp. 271 ss.; C. ROSSANO, Manuale, cit., p. 244.
21 Si riprende l’espressione di H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie,Tübingen, Mohr, 1929, trad. it., Essenza e valore della democrazia, in ID., La democra-zia, 5ª ed., Bologna, il Mulino, 1984, p. 99.
22 Anche se solo quello basato sulla proporzionale tenderebbe ad avvicinarsi almassimo ideale di democrazia, secondo G.U. RESCIGNO, Democrazia, cit., pp. 218 ss.Secondo M. DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel I. Les grands sy-stèmes politiques, 1955, trad. it., I sistemi politici, Bari, Laterza, 1978, p. 113, però, ri-tenere il sistema proporzionale l’unico equo perché consente di “fotografare” l’opi-nione pubblica, significa porre erroneamente il problema. «I diversi sistemi elettoralinon sono strumenti passivi che si limitano a registrare semplicemente l’opinione pub-blica: essi contribuiscono a formarla, a modellarla in modo e forme diverse secondo isistemi stessi; sono per l’opinione pubblica una specie di stampo, degli strumenti adoppio uso: sono contemporaneamente macchine fotografiche e cinematografiche. Inquesto modo influiscono notevolmente sulla formazione dei “sistemi di partiti” e l’esi-stenza di un certo tipo di sistema di partiti spinge a sua volta verso un sistema eletto-rale ad esso adeguato». Come ricorda D. FISICHELLA, Elezioni, cit., pp. 652 ss., inoltre,rappresentanza democratica significa rappresentatività ma anche responsabilità, un si-stema elettorale, di conseguenza, deve essere in grado di garantire un opportuno equi-librio tra entrambi tali aspetti; sulle relazioni tra rappresentatività e responsabilità si v.anche, dello stesso A., Elezioni e democrazia, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 339 ss.
23 Si riprende la distinzione delineata da A. LIJPHART, Patterns, cit., part. pp. 27ss., tra il modello Westminster (o maggioritario) e quello consensuale. Appare utile ri-chiamare anche M. DUVERGER, Institutions, cit., pp. 71 ss., che distingue tra democra-
163L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
È necessario, dunque, riassumere i diversi effetti che pos-sono essere prodotti dall’adozione dell’uno o dell’altro sistemaelettorale, premettendo che tale operazione è volta semplice-mente a porre in evidenza i tratti emblematici dei rispettivi mo-delli idealtipici, perché nella loro pratica applicazione tali mo-delli si riscontrano variamente contaminati e producono gli ef-fetti più disparati in base alle differenti realtà nelle quali sitrovano ad operare24.
In linea di massima, si può affermare che nei sistemi eletto-rali di tipo proporzionale i seggi sono distribuiti tra i partiti inproporzione alla percentuale dei voti ottenuti, mentre nei sistemimaggioritari il seggio è assegnato al candidato che ottiene lamaggioranza (relativa, assoluta, qualificata) dei voti. Di solito, leformule proporzionali sono applicate in circoscrizioni plurinomi-nali (che sono quelle circoscrizioni nelle quali si eleggono con-temporaneamente più rappresentanti), mentre le formule mag-
zie “dirette” e “indirette”, nonché S. FABBRINI, S. VASSALLO, Il governo, Bari, Laterza,1999, pp. 9 ss., che distinguono tra democrazie “competitive” e “consensuali”, S. CEC-CANTI, La forma neoparlamentare di governo alla prova della dottrina e della prassi, inQuaderni costituzionali, 2002, n. 1, p. 109, per la distinzione della forma di governoparlamentare in due sottotipi (non-maggioritario e maggioritario o, meglio, neoparla-mentare), e L. PRIMICERIO, Forma, cit., pp. 80 ss., sia per la distinzione tra parlamenta-rismo “responsabile” e parlamentarismo “rappresentativo”, sia per le caratteristichedel modello intermedio di parlamentarismo. Si rinvia, infine, a O. CHESSA, La demo-crazia maggioritaria nell’interpretazione costituzionale della forma di governo, in Dirittopubblico, 2004, n. 1, pp. 19 ss., part. 38-39, dove si afferma che l’espressione “demo-crazia maggioritaria” deve ritenersi «impropria nella misura in cui accredita l’idea checi si trovi di fronte ad un modello o concezione generale di democrazia, mentre inrealtà individua soltanto un sottotipo del governo parlamentare».
24 Si pensi, ad es., all’influenza sul rendimento di alcuni fattori indicati da A.LIJPHART, Patterns, cit., pp. 174 ss., quali il numero degli eletti e degli elettori. D’altrocanto, come osservano A. BARBERA, C. FUSARO, Maggioranza, cit., p. 411, sebbene ilprincipio maggioritario non costituisca una necessità logica e non garantisca gli esitisostanziali migliori, sulla base dell’esperienza empirica, sembra assicurare meglio diogni altro la possibilità di perseguire valori irrinunciabili come l’accettazione della di-versità dell’altro, il principio di eguaglianza e il principio democratico. Appare utilerinviare altresì a M. VOLPI, Le forme di governo contemporanee tra modelli teorici edesperienze reali, in Quaderni costituzionali, 1997, n. 2, pp. 247 ss.
164 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
gioritarie in circoscrizioni uninominali (nelle quali si elegge unsolo candidato), utilizzando una scheda elettorale che riporta ilnome del candidato. La proporzionale, quindi, soddisfa meglio ilprincipio di rappresentatività, perché è in grado di riprodurrepiù fedelmente, nell’assemblea parlamentare, il corpo elettorale,consentendo la rappresentanza anche dei partiti minori25. Con isistemi di tipo maggioritario, invece, si realizza la rappresentanzadella maggioranza e delle minoranze più forti26.
La scelta dell’uno o dell’altro sistema elettorale comportaconseguenze anche sul sistema dei partiti: un sistema multiparti-tico richiede di per sé un sistema elettorale proporzionale men-tre un sistema maggioritario presuppone un sistema bipartitico27
o, quanto meno, bipolare28. Questo accade perché, per conqui-stare il seggio in un sistema maggioritario, è necessario convin-cere l’elettorato incerto, ovvero quella parte dell’elettorato che sicolloca su posizioni moderate e meno caratterizzate ideologica-mente. Tale esigenza scoraggia lo scissionismo partitico, favoriscele aggregazioni, impedisce l’affermarsi dei partiti anti-sistema29.
25 Secondo H. KELSEN, Vom Wesen, cit., pp. 99 ss., il sistema proporzionale(ideale) sarebbe l’unico a consentire che ogni partito sia rappresentato da un numerodi eletti corrispondente alla sua consistenza numerica, cioè che ogni partito, nelle ele-zioni, possa affermarsi in virtù della propria forza.
26 Secondo S.M. CICCONETTI, Sistemi elettorali e sistemi dei partiti, in Rivista tri-mestrale di diritto pubblico, 1996, n. 4, p. 992, in un sistema maggioritario, non go-verna chi ha avuto la maggioranza dei voti, bensì la minoranza che ha avuto più votirispetto a tutte le altre minoranze in competizione; di tenore analogo le osservazioni diG.U. RESCIGNO, Principio, cit., pp. 12-13. Secondo M. OLIVETTI, Art. 1, cit., p. 20, pe-raltro, la circostanza che le maggioranze politiche negli organi rappresentativi siano ilpiù delle volte espressione di minoranze del corpo elettorale deriverebbe anche dal de-clinante tasso di partecipazione alle elezioni, nonché dall’effetto premiante per igruppi numericamente più consistenti che è prodotto da quasi tutti i sistemi elettorali,«inclusi buona parte dei c.d. sistemi proporzionali».
27 S.M. CICCONETTI, Sistemi, cit., part. pp. 993 e 998-999.28 Cfr. le osservazioni di S. BARTOLE, Democrazia maggioritaria, in Enciclopedia
del diritto, agg., vol. V, Milano, Giuffrè, 2001, p. 348.29 Secondo D. FISICHELLA, Elezioni, cit., pp. 656-657, in un sistema maggiorita-
rio, i partiti anti-sistema non riescono ad affermarsi perché sono partiti estremisti, ca-ratterizzati da una forte carica ideologica.
165L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
Il sistema proporzionale, invece, poiché tende a rappresentaretutti i gruppi politici, consente le tendenze disaggreganti, favori-sce la connotazione ideologica dei partiti30 e permette anche l’af-fermazione di forze politiche che tendono a distruggere il regimeesistente per instaurare un nuovo ordine31.
In relazione al sistema dei partiti, pertanto, si può affermareche i sistemi elettorali proporzionali tendono ad eleggere un par-lamento multipartitico, più o meno frammentato a seconda delgrado di proporzionalità, mentre i sistemi maggioritari tendonoad eleggere parlamenti meno frammentati32. La varietà delleforze politiche presenti in parlamento comporta notevoli pro-blemi in ordine alla governabilità: un parlamento eletto con unaformula elettorale proporzionale costringerà all’aggregazioneforze più o meno eterogenee, nel tentativo di costituire un’al-leanza che abbia i numeri sufficienti per governare. I governi dicoalizione, così formatisi, sono meno stabili, perché quanto mag-giore è il numero dei partiti che concorrono alla formazionedella coalizione stessa, tanto più elevata è la probabilità di unsuccessivo abbandono di uno di essi, con conseguente sfalda-mento della maggioranza. L’ampiezza della coalizione, inoltre,rende necessario concordare preliminarmente, tra le varie com-ponenti della maggioranza, le decisioni da assumere33 e questaattività di composizione tra le varie posizioni risulta ancora piùdifficoltosa a causa della connotazione ideologica dei partiti34. Afronte di un simile contesto partitico anche l’unità della compa-gine ministeriale è minata, perché i ministri non si comportano
30 D. FISICHELLA, Elezioni, cit., p. 659, nota che, in un sistema in cui i partitisono molto numerosi, si avverte la necessità di distinguersi per giustificare la propriaautonoma esistenza e ciò porta ad assumere intransigenti posizioni ideologiche.
31 Sulla connessione tra sistemi elettorali e sistemi partitici si rinvia anche alle os-servazioni di A. LIJPHART, Patterns, cit., pp. 185 ss.
32 In questo senso O. MASSARI, G. PASQUINO (a cura di), Rappresentare, cit., pp.15-16.
33 Così S.M. CICCONETTI, Sistemi, cit., p. 993.34 In questo senso D. FISICHELLA, Elezioni, cit., p. 661. Sui sistemi di questo tipo
si v. anche M. DUVERGER, Institutions, cit., pp. 151 ss.
166 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
come membri di un organismo unitario, bensì come esponentidelle varie delegazioni dei partiti al governo35, con la conse-guenza che l’azione di governo risulta meno tempestiva e menoincisiva. Nei sistemi politici che fanno uso delle formule eletto-rali maggioritarie, invece, si riscontra il massimo di stabilità go-vernativa ed una notevole efficacia decisionale36. I sistemi mag-gioritari, infatti, eleggono parlamenti meno frammentati che nonsono obbligati (o lo sono meno) a creare governi di coalizione37,perché la ripartizione dei seggi tra i partiti è tale che non vi puòessere nessun equivoco sulla maggioranza, una maggioranzaunita e omogenea, della quale il governo è diretta espressione38.Una simile coesione permette maggiore stabilità (nel senso chel’esecutivo riesce a durare per l’intera legislatura) e un’azione digoverno efficace, tanto da porre la maggioranza di governo nellecondizioni di poter rispettare gran parte degli impegni assuntinei confronti dell’elettorato39.
La possibilità di rispettare il proprio programma elettoralesi ricollega ad un altro aspetto sul quale si producono effetti di-versi in base al sistema elettorale utilizzato: la responsabilità delleforze politiche. Il principio maggioritario, infatti, comporta unacorrispondenza diretta tra maggioranza dell’elettorato, maggio-ranza parlamentare e Governo40. In un sistema maggioritario,quindi, gli elettori hanno la possibilità di influenzare in maniera
35 Cfr. ancora le osservazioni di D. FISICHELLA, Elezioni, cit., p. 661.36 In questo senso G. PASQUINO, I sistemi, cit., p. 82, e L. PRIMICERIO, Forma, cit.,
pp. 71 ss. Tuttavia, G.U. RESCIGNO, Democrazia, cit., pp. 218-219, pur riconoscendoche, in generale, i sistemi elettorali maggioritari aumentano l’efficienza e la stabilità, ri-tiene che a tale aumento di governabilità si pervenga riducendo il tasso di democrazia.
37 In questo senso G. GUARINO, Il regime, cit., p. 218, e O. MASSARI, G. PASQUINO
(a cura di), Rappresentare, cit., p. 16.38 Infatti per D. FISICHELLA, Elezioni, cit., p. 660, si può affermare che, con un
sistema maggioritario, più che un parlamento si elegge un governo.39 Cfr. S. BARTOLE, Democrazia, cit., p. 348. Sulla diffusa opinione che i modelli
maggioritari siano più efficienti di quelli consensuali, si v. le osservazioni critiche di A.LIJPHART, Patterns, cit., pp. 279 ss.
40 In questo senso M. PATRONO, Maggioritario in erba, Padova, Cedam, 1995,p. 31.
167L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
praticamente diretta la formazione del governo ed anche la no-mina del suo vertice41, ma, soprattutto, riescono a capire in capoa quali forze politiche vada attribuita la responsabilità dell’azionedi governo o di quella dell’opposizione42 e, di conseguenza, alleelezioni sono in grado di imporre la “resa dei conti” a maggio-ranza ed opposizione per l’attività svolta durante la legislaturaprecedente43. In un sistema basato sulla proporzionale, invece,
41 Ai sistemi elettorali maggioritari si accompagnano spesso forme di governopresidenziale ma, in ogni caso, secondo S. BARTOLE, Democrazia, cit., p. 348, l’esecu-tivo si ritiene direttamente investito dal popolo, almeno per quanto riguarda l’indivi-duazione del suo capo che, di solito, è il leader del partito o dello schieramento dimaggioranza e si contrappone al leader dell’opposizione, al quale «è riconosciuta unaposizione di formalizzata istituzionalizzazione».
42 Secondo H. KELSEN, Vom Wesen, cit., p. 94, «il principio maggioritario – nel-l’ambito del parlamentarismo – (…), all’atto pratico, si mostr[a] conciliabile con laprotezione della minoranza. La maggioranza, infatti, presuppone, per definizione, l’e-sistenza di una minoranza e, in conseguenza, il diritto della maggioranza presupponeil diritto all’esistenza di una minoranza. Da ciò risulta non tanto la necessità, quanto lapossibilità di proteggere la minoranza contro la maggioranza». Al fine di garantire taleprotezione, diventa opportuno introdurre uno statuto dell’opposizione parlamentare,che riconosca formalmente le garanzie e le prerogative della minoranza, affinché que-sta possa svolgere le sue funzioni di garanzia e di controllo e, nello stesso tempo, possadare visibilità alla propria azione politica (in attesa di divenire, a sua volta, maggio-ranza). Tuttavia, si v. anche la differenza tra il principio maggioritario temperato (o an-glosassone) e quello continentale europeo delineata da T. MARTINES, Governo, cit., pp.174-175. Tra gli Autori che si sono occupati dello statuto dell’opposizione dopo lariforma elettorale del 1993 si rinvia a P. ARMAROLI, Statuto dell’opposizione e democra-zia maggioritaria, in Rassegna parlamentare, 1995, n. 3, pp. 259 ss., S. LABRIOLA, Prin-cipio maggioritario e statuto dell’opposizione parlamentare, in Diritto e società, 1995, n.3, pp. 339 ss., e ID., Note sullo statuto costituzionale dell’opposizione, in Diritto e so-cietà, 2000, n. 2, pp. 209 ss., F. SCIOLA, Lo Statuto dell’Opposizione parlamentare nel-l’ordinamento italiano, Firenze, Noccioli, 2001. Sulla necessità di tale strumento di ga-ranzia dell’opposizione anche a livello regionale, dopo la riforma del Titolo V dellaParte II della Costituzione, si v. G. RIVOSECCHI, Il principio maggioritario tra statuti re-gionali e regolamenti consiliari, ovvero della difficile transizione verso un modello di de-mocrazia decidente, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2005, n. 2, part. pp. 126 ss.,ID., Organizzazione e funzionamento dei Consigli regionali: principio maggioritario, sta-tuti regionali e regolamenti consiliari, in R. BIFULCO (a cura di), Gli statuti di secondagenerazione, Torino, Giappichelli, 2006, part. pp. 151 ss., e P.L. PETRILLO, Nuovi sta-tuti regionali e opposizione, in Quaderni costituzionali, 2005, n. 4, pp. 829 ss.
43 Così S. BARTOLE, Democrazia, cit., p. 348.
168 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
l’elettorato non è in grado di influire direttamente sulla compo-sizione del governo, perché la formazione della maggioranza di-pende dal parlamento, che è libero di combinarla in vari modi44.Inoltre, risulta difficile l’imputazione soggettiva della responsabi-lità politica, perché il corpo elettorale non riesce a stabilire aquale delle numerose forze che compongono la maggioranza digoverno vada attribuita una determinata decisione. Gli elettori,peraltro, hanno difficoltà anche a valutare l’operato dell’opposi-zione: quest’ultima, infatti, non è completamente estromessadalle decisioni dell’esecutivo, perché la precarietà dell’alleanzache lo sostiene induce ad un continuo dialogo delle forze di mag-gioranza con i partiti di opposizione45. In tale contesto, si puòavere altresì una perdita di credibilità politica delle istituzionirappresentative e la sostituzione della responsabilità giuridica aquella politica, con conseguente crescita di peso e d’influenza delpotere giurisdizionale rispetto agli altri poteri dello Stato46.
Gli effetti tipici di un sistema maggioritario, tuttavia, pos-sono essere prodotti anche da un sistema proporzionale corretto(ad esempio, in Spagna), mentre potrebbero non verificarsi lad-dove – pur utilizzando sistemi maggioritari puri – il contesto par-titico non sia caratterizzato dalla presenza di due partiti nazionaliforti (si pensi, ad esempio, alle esperienze canadese o indiana).Tali risultati, quindi, dipendono da molte variabili (il tipo discheda elettorale utilizzato, l’esistenza o meno di circoscrizioni ela loro ampiezza, il modello di società nella quale il sistema elet-torale va ad operare) ma un ruolo fondamentale nella produ-zione di questi effetti è ricoperto dai sistemi di partito e dai si-stemi elettorali. Tutto ciò spiega perché la scelta di un sistemaelettorale non è mai dettata da ragioni semplicemente tecnichema è anche (e soprattutto) il frutto di calcoli di parte, legati allasopravvivenza di singoli partiti o coalizioni, oppure alla possibi-
44 Così D. FISICHELLA, Elezioni, cit., p. 660.45 Anche a tale proposito si v. le considerazioni di A. LIJPHART, Patterns, cit.,
part. pp. 307-308.46 Così S.M. CICCONETTI, Sistemi, cit., p. 994.
169L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
lità di determinare i risultati elettorali in maniera favorevole peril proprio schieramento47.
3.1. I sistemi elettorali in Italia: dall’Unità d’Italia alla Repubblica
Appare necessario, ora, verificare in quale modo si è giuntialla riforma elettorale del 1993, anche perché ciò dovrebbe con-sentire di comprendere meglio quali risultati si attendevano daessa.
Dalla concessione dello Statuto albertino alla nascita dellaRepubblica si sono succeduti in Italia numerosi sistemi elettorali,sia maggioritari sia proporzionali48. Dopo la caduta del fascismo,in particolare, fu necessario predisporre le norme tecniche perl’elezione dell’Assemblea costituente: a tale scopo fu previsto unsistema elettorale proporzionale a liste concorrenti49.
Per quanto riguarda il sistema elettorale da adottare nella na-scente Repubblica italiana, invece, non mancarono in Assembleacostituente le discussioni inerenti sia il tipo di sistema elettorale sial’opportunità di ancorarlo alla Costituzione. Nel corso dei lavoridella Costituente, infatti, furono presentati, in particolare, due or-dini del giorno: uno volto a prevedere che la Camera dei deputatidovesse essere eletta in base al criterio proporzionale50; l’altro teso
47 In questo senso M. DUVERGER, Institutions, cit., p. 105, ma anche G. PA-SQUINO, I sistemi elettorali, cit., p. 84, C. FUSARO, Elezioni, cit., p. 2169, e F. LANCHE-STER, Riforme elettorali e forma di governo: riflessioni sulle innovazioni istituzionali e ipericoli delle «democrazie a basso rendimento», in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di),Riforme elettorali, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 31, che definisce il sistema elettorale«uno strumento tecnico ad alta valenza politica».
48 Sulla storia dei sistemi elettorali in Italia si rinvia a G. SCHEPIS, Elezioni (Sto-ria dei sistemi elettorali in Italia), in Enciclopedia del diritto, vol. XIV, Milano, Giuffrè,1965, pp. 663-666, e P.L. BALLINI, Le elezioni nella storia d’Italia dall’Unità al fascismo,Bologna, il Mulino, 1988.
49 Si v. il d.lgs.lgt. 74/1946, ma anche il d.lgs.lgt. 23/1945, che estese il suffragioelettorale alle donne.
50 Si tratta dell’ordine del giorno presentato da Giolitti nella seduta del 23 set-tembre 1947, in La Costituzione, vol. IV, cit., p. 2986. Negli anni immediatamente suc-cessivi all’entrata in vigore della Costituzione, C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella
170 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
a garantire l’elezione del Senato della Repubblica con un sistemamaggioritario uninominale51. Tra i costituenti, tuttavia, sembravapiuttosto diffusa la convinzione di dover adottare un sistema elet-torale di tipo proporzionale. Secondo Costantino Mortati, infatti,l’Italia del dopoguerra, dato il contesto di polarizzazione ideolo-gica, non sarebbe stata in grado di reggere l’impatto di un’appli-cazione rigida del modello maggioritario; per questo motivo pro-pose la costituzionalizzazione del sistema proporzionale52. Ancheun altro costituente, Piero Calamandrei, che pure si ispirava allarepubblica presidenziale americana e all’esperienza istituzionaleinglese, dava per scontato che la legge elettorale per la rappresen-tanza parlamentare dovesse essere quella proporzionale53. Nono-stante tale dibattito, non si inserirono in Costituzione disposizioniin materia di sistemi elettorali, limitandosi a prescrivere, negli artt.56 e 58, che il suffragio dovesse essere universale e diretto54.
L’Assemblea costituente, nello stabilire che la forma di go-verno dovesse essere parlamentare, approvò delle norme costitu-zionali riguardanti la formazione del Governo suscettibili di es-
Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1952, n. 4, pp. 849 ss.,facendo riferimento anche a questo ordine del giorno, riteneva che il sistema propor-zionale non fosse solo preferito ma addirittura voluto ed imposto dalla Carta costitu-zionale. Secondo l’A., dalle disposizioni costituzionali (in particolare dagli artt. 3, 48 e49 Cost.) discenderebbe un divieto assoluto di adottare sistemi elettorali maggioritaripuri o relativi. La Costituzione, quindi, consentirebbe una scelta solo nell’ambito deidiversi tipi di sistema elettorale proporzionale, anche per permettere quella differen-ziazione tra i due rami del Parlamento che la stessa Costituzione richiede. Si v. anchela “rilettura” di tale teoria operata da S. LABRIOLA, Il principio maggioritario e la Costi-tuzione repubblicana: rilettura in termini di attualità, in Studi parlamentari e di politicacostituzionale, 1995, n. 1, pp. 51 ss., nonché M. LUCIANI, Riforme elettorali e disegnocostituzionale, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Riforme, cit., pp. 96 ss.
51 Cfr. l’ordine del giorno presentato da Nitti nella seduta del 7 ottobre 1947, inLa Costituzione, vol. IV, cit., pp. 3084 ss.
52 Si v., al riguardo, A. BARBERA, S. CECCANTI, La lenta conversione maggioritariadi Costantino Mortati, in Quaderni costituzionali, 1995, n. 1, pp. 67-68.
53 Cfr., in proposito, T.E. FROSINI, Suggestioni, cit., pp. 98-99.54 Su tali articoli si rinvia a C. FUSARO, M. RUBECHI, Art. 56, in R. BIFULCO, A. CE-
LOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario, vol. II, cit., pp. 1129 ss., e – sia consen-tito – D. CODUTI, Art. 58, ivi, pp. 1155 ss.
171L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
sere qualificate dal sistema dei partiti e integrate dalle regoleconvenzionali che ad esso fanno capo55. Si tentava di mettere alcentro del sistema costituzionale il Parlamento e i partiti politici,perché, in una democrazia nata dalle ceneri di un regime autori-tario, il popolo-corpo elettorale e il Governo destavano dellepreoccupazioni, in quanto difficilmente controllabili, e il lororaggio d’azione andava ridimensionato. Per realizzare tale dise-gno era necessario un sistema elettorale di tipo proporzionale:un sistema che impedisse il formarsi di un rapporto di fiducia di-retto fra corpo elettorale e Governo e, nello stesso tempo, capacedi impedire un’investitura popolare dei Governi, trasferendotutto il potere politico dai cittadini ai partiti56.
In effetti, la Costituente adottò, per l’elezione della Cameradei deputati, un sistema proporzionale a liste concorrenti, simile– sebbene con alcune varianti – a quello utilizzato per l’elezionedell’Assemblea costituente57. Per l’elezione del Senato, invece, siprevide un sistema elettorale misto, consistente nella votazione incollegi uninominali, all’interno di ogni singola Regione (in ottem-peranza all’art. 57 Cost., che richiede che il Senato sia eletto «abase regionale»), con proclamazione dei candidati che avesseroottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65% dei vo-tanti nel collegio. Nell’ipotesi in cui non fosse raggiunta tale so-glia, il riparto avveniva in maniera proporzionale58. Tuttavia, poi-ché la soglia del 65% era raggiunta solo in rare ipotesi, anchequesto sistema funzionava – di fatto – in maniera proporzionale59.
55 Come si è già visto supra, parte I, cap. I, parr. 3. ss.56 In questo senso T.E. FROSINI, Suggestioni, cit., pp. 100-101. L’A. richiama B.
MIRKINE-GUEZTÉVITCH, Les nouvelles tendences du droit constitutionnel, Paris, M.Giard, 1931, p. VII. Si v. anche S. SICARDI, Maggioranza e opposizione nella lunga ed ac-cidentata transizione italiana, in AA.VV., Annuario 2001, cit., p. 135, secondo il qualeil Governo è stato «[v]oluto debole dal costituente perché non gli venisse la tentazionedi spadroneggiare o, magari chissà, di forzare il quadro costituzionale».
57 Cfr. la l. 6/1948.58 Cfr. le leggi 29/1948 e 64/1958.59 Come ricorda A. SPREAFICO, Il rendimento dei sistemi elettorali: il caso italiano,
in Quaderni costituzionali, 1981, n. 3, p. 502, sebbene in Assemblea costituente sia pre-
172 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
Un tentativo di correzione in senso maggioritario del si-stema elettorale alla Camera si ebbe nel 1953, con la previsionedi un sistema elettorale volto a garantire un premio di maggio-ranza per la lista o il gruppo di liste collegate che avesse ottenutocomplessivamente, in tutto il Paese, una quantità di voti validisuperiori alla metà del complesso dei voti validi espressi per tuttele altre liste; qualora questa ipotesi non si fosse verificata, si sa-rebbe applicato il sistema elettorale del 194860. In realtà, il pre-mio di maggioranza previsto dalla legge non puntava a creareuna maggioranza, bensì a rafforzare una maggioranza che giàc’era: rappresentava un premio “alla” maggioranza e non “per”la maggioranza. Si trattava di una riforma voluta da Alcide DeGasperi nel tentativo di introdurre una forma di governo a legit-timazione diretta, sul modello anglosassone, senza intervenire sultesto costituzionale. Questa legge fu aspramente contestata dalleopposizioni, tanto da essere definita “legge truffa” e, in pratica,non trovò applicazione, perché il quorum richiesto non fu rag-giunto. Il mancato raggiungimento del quorum e la polemica op-posizione a tale sistema elettorale ne favorirono l’abrogazione61,avvalorando l’idea che l’Italia non potesse essere governata ri-correndo all’applicazione elettorale del principio di maggio-
valsa la tesi del bicameralismo, i criteri di differenziazione tra le due Camere adottatiriguardano elementi marginali (limiti di età più elevati per l’elettorato attivo e passivo,presenza di un limitatissimo numero di membri non elettivi, consistenza numerica piùridotta del Senato), oppure non sono stati mai concretamente applicati (ad es., la di-versa durata del Senato rispetto alla Camera, soppressa dalla l. cost. 2/1963). Il puntoche meglio avrebbe potuto determinare una netta distinzione fra le due Assemblee èrappresentato dal diverso sistema d’elezione, ma l’introduzione del quorum del 65%faceva sì che il meccanismo dell’elezione uninominale funzionasse solo in pochissimicollegi, mentre negli altri il sistema applicato era simile al sistema proporzionale usatoper la Camera, salvo per la sostituzione della ripartizione su base regionale a quella cir-coscrizionale e l’adozione del metodo d’Hondt al posto di quello del quoziente rettifi-cato con la formula Imperiali.
60 Cfr. la l. 148/1953. In proposito si rinvia a M.S. PIRETTI, La legge truffa, Bolo-gna, il Mulino, 2003.
61 Cfr. la l. 615/1954. Si v. anche alcune successive modificazioni al sistema elet-torale del 1948 nel d.p.r. 361/1957.
173L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
ranza, bensì solo con la proporzionale e i conseguenti Governi dicoalizione62.
Invero, occorre considerare che nell’Italia del dopoguerra sitentava di radicare la Repubblica in una società attraversata dauna profonda frattura sociale ed ideologica: da una parte si tro-vavano i ceti proletari, rappresentati dal Partito comunista-PCI,convinti che alla Resistenza dovesse seguire la rivoluzione; dal-l’altra c’erano ceti borghesi che non condividevano i valori e leprocedure della democrazia. In questo contesto il principio mag-gioritario non poteva essere percepito come un veicolo di effi-cienza democratica, bensì come un “principio nemico”, unmezzo per soffocare le minoranze63. La scelta del maggioritario,quindi, avrebbe potuto isolare all’opposizione la minoranza, rin-vigorendo le posizioni estremiste. Il maggioritario, infatti, neces-sita di una democrazia compiuta, già posseduta nella coscienzadei cittadini come singoli. In una democrazia già realizzata, ilvoto favorevole ad un partito o ad un programma è espressionedi una adesione concessa da un cittadino maturo da un punto divista politico64. Ma questa non era la realtà dell’Italia del dopo-guerra. L’aver optato per la proporzionale e per il modello con-sensuale che ne è derivato65 ha contribuito alla pacificazione so-
62 Su questa vicenda si rinvia alla ricostruzione di T.E. FROSINI, Suggestioni, cit.,pp. 101-104.
63 In questo senso G. AMATO, Il dilemma, cit., p. 179. Come osserva P. CIARLO,Art. 95, cit., p. 366, infatti, «[i]l principio maggioritario puro divide la collettività indue settori».
64 Si v., in questo senso, A. BARBERA, S. CECCANTI, La lenta, cit., p. 71, nonché M.PATRONO, Maggioritario, cit., pp. 13 ss., e quanto già osservato supra, parte III, cap. I,par. 1.
65 Secondo H. KELSEN, Vom Wesen, cit., p. 100, infatti, «[n]el caso ideale di ele-zione proporzionale, non ci sono vinti, poiché non c’è ricorso alla maggioranza. Per es-sere eletti non è infatti necessario ottenere una maggioranza di voti, ma è sufficienteottenere un “minimo” il cui calcolo costituisce la caratteristica della tecnica propor-zionale. Se si considera il risultato complessivo delle elezioni, se il corpo rappresenta-tivo, formatosi attraverso l’elezione proporzionale, viene confrontato, come unità, colcorpo elettorale come totalità, in un certo senso si potrà riconoscere – il che viene tal-volta considerato come l’essenza della proporzionale – che tale rappresentanza è stata
174 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
ciale66; ha permesso di colmare civilmente il cleavage che divi-deva le diverse ideologie; è servito ad educare il Paese alla de-mocrazia; ha portato alla stabilità istituzionale. Questo modello èstato indiscutibilmente efficace. Lo è stato fino a quando non haraggiunto il suo scopo, facendo venire meno le ragioni che loavevano reso storicamente necessario e sono divenute evidenti lesue disfunzioni67.
3.2. La crisi del proporzionalismo
La politica di coalizione in Italia, nel periodo che precede lariforma elettorale del 1993, può essere distinta in base alla di-versa composizione partitica dei governi succedutisi nel corsodegli anni. È possibile, in questo modo, distinguere quattro mo-menti: il centrismo, il centro-sinistra, la solidarietà nazionale e ilpentapartito68. Tratto comune di queste fasi era quello di trovarsidi fronte ad una “democrazia bloccata”69, caratterizzata dal ruolocentrale ricoperto dalla Democrazia cristiana-DC e dalla conven-tio ad excludendum del PCI dall’area della legittimità70. In questa
eletta coi voti di tutti e contro i voti di nessuno, cioè all’unanimità. Ciò non vale, na-turalmente che per il caso ideale». Si v. anche G. SARTORI, Tecniche, cit., p. 20, secondoil quale «[n]elle società conflittuali (…) la rappresentanza proporzionale può diventareuna garanzia essenziale».
66 Si rinvia, in proposito, alle osservazioni di P.G. GRASSO, Rilevanza, cit., pp.450-451.
67 In questo senso le osservazioni di G. AMATO, Il dilemma, cit., p. 181. SecondoC. FUSARO, Principio, cit., p. 176, «la rinuncia all’applicazione estensiva del principiomaggioritario ha condotto negli anni l’ordinamento italiano forse non a eludere macerto a dare attuazione troppo asfittica al principio democratico e a limitare forte-mente la sovranità popolare, virtualmente espropriandola di ogni potere effettivo d’in-dirizzo politico».
68 Questa è la distinzione delineata da S. FABBRINI, S. VASSALLO, Il governo, cit.,p. 102.
69 L’espressione – invero piuttosto diffusa per indicare queste fasi della storiapolitica ed istituzionale italiana – è ripresa da B. CARAVITA, M. LUCIANI, Oltre la «de-mocrazia bloccata»: ipotesi sui meccanismi elettorali, in Democrazia e diritto, 1982, n. 6,p. 93.
70 Su tale convenzione si rinvia a L. ELIA, Governo, cit., p. 639, nt. 20, e pp. 655ss., nonché a M. OLIVETTI, Forme di Stato e forme di governo, in S. MANGIAMELI (a cura
175L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
situazione il ruolo di forza di governo era assunto sistematica-mente dalla DC, che formava coalizioni diverse alleandosi, divolta in volta, con i partiti socialisti (Partito socialista-PSI e Par-tito socialdemocratico-PSDI) o con quelli laici (Partito liberale-PLI e Partito repubblicano-PRI) ed escludendo dal governo delPaese i partiti considerati anti-sistema (PCI e Movimento sociale-MSI)71. In un sistema siffatto, non potevano mancare conse-guenze relative sia all’assenza di alternanza sia alla necessità difar convivere, nelle coalizioni di governo, forze politiche anchemolto diverse tra loro.
Riguardo alla prima questione, l’alternanza fra partiti o fracoalizioni di partiti diversi al governo favorisce il ricambio dellaclasse politica, imponendo il ritiro accelerato dei rappresentantiche perdono le elezioni. La mancanza di alternanza, invece, con-duce a partiti molto burocratizzati, ad una carriera politica lentae fondata su un impegno a tempo pieno e che tende a produrreun ceto burocratico che non conosce attività professionali di-verse dall’impegno politico, che non ha alternative occupazio-nali, che è isolato dalle tendenze della società civile e che finisceper presentarsi come corpo separato da quest’ultima72.
di), Diritto costituzionale, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, p. 56. Secondo C. MEZZA-NOTTE, R. NANIA, Riforme e Costituzione, in Democrazia e diritto, 1982, n. 6, pp. 20-22,la conventio ad excludendum avrebbe avuto un effetto deleterio perché, prevedendoche una delle forze costituenti, esclusa dalle alleanze di governo, non poteva assumerea pieno titolo il ruolo di opposizione istituzionale (perché può vantare legittimazionepiena al ruolo di opposizione solo chi è riconosciuto, dalle altre parti, come astratta-mente dotato dei requisiti di forza di governo), avrebbe contribuito ad appiattire il si-stema istituzionale sul sistema politico. Tuttavia, secondo gli Autori, sarebbe più im-portante la conventio ad integrandum, consistente nel reciproco riconoscimento, daparte di tutti i soggetti dell’arco costituzionale, della comune appartenenza al mede-simo sistema di valori. Sarebbe quest’ultima la convenzione fondante, quella che haimpedito l’interruzione dell’esperienza costituzionale.
71 Cfr., in merito, S. FABBRINI, S. VASSALLO, Il governo, cit., pp. 102-103.72 In questo senso G. PASQUINO, Partiti, società civile e istituzioni, in ID. (a cura
di), Il sistema politico italiano, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 19-20, e G. GUARINO,Questione morale, Costituzione, riforme, in Studi e documenti, 1988, n. 14, ora in ID.,Dalla Costituzione, vol. IV, cit., pp. 147-148. Secondo C. FUSARO, Le regole, cit., p. 34,
176 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
Con riferimento alla stabilità di governo, la necessità di for-mare Esecutivi fondati su maggioranze eterogenee comporta chel’accordo tra forze politiche tutte insostituibili possa essere rag-giunto solo a patto che il Presidente del Consiglio dei ministri simuova come garante dell’equilibrio tra i partiti73, piuttosto checome capo della maggioranza parlamentare. Inoltre, i programmi
si è assistito nella democrazia italiana all’affermazione progressiva di un vero e proprioParteienprivileg: non solo nel senso di attribuire ai partiti in quanto tali tutta una seriedi prerogative; ma anche nel senso di favorire lo stabilirsi fra di essi di rapporti e rela-zioni che nel tempo finiscono con il passare attraverso la classica divisione fra partiti digoverno e partiti di opposizione. Si sviluppano, in questo modo, rapporti grazie ai qualii cosiddetti “quadri” dei diversi partiti finiscono per assomigliarsi tutti per stile di vita,comportamenti, frequentazioni, tanto da essere percepiti, tutti insieme, come “diversida sé” dalla pubblica opinione. Un sistema di privilegio ai partiti che viene accolto nellalegislazione elettorale, come osservano S. GAMBINO, G. MOSCHELLA, Regole elettorali, si-stema politico e forma di governo. Il caso italiano, in S. GAMBINO (a cura di), Forme digoverno e sistemi elettorali, Padova, Cedam, 1995, pp. 42 ss. In proposito, G. PITRUZ-ZELLA, Forme, cit., p. 49, parla di «degenerazione oligarchica» del parlamentarismo ita-liano. Sulla classe politica in generale osservazioni analoghe, sebbene di tenore ben piùcritico, erano state espresse già da J. BENTHAM, A Fragment on Government, a cura diJ.H. BURNS, H.L.A. HART, London, The Athlon Press, 1977, trad. it., Un frammento sulgoverno, a cura di S. MARCUCCI, Milano, Giuffrè, 1990, part. pp. 240-241, secondo ilquale «l’interesse particolare dei governanti è in opposizione diretta a quasi tutto ciòche è buono, ad ogni riforma, ad ogni considerevole miglioramento, anche all’arrestodella serie di abusi a tutti i livelli e, quindi, su quasi tutti i punti, all’interesse universale(…). La conseguenza che ne deriva è una unione – una unione perenne e indissolubile– tra i pochi governanti di tutte le classi, per difendere sé stessi e difendersi l’un l’altrocontro tutti quei tentativi che, proprio per il servizio reso all’interesse universale, agi-scono quindi necessariamente in opposizione a quel particolare e sinistro interesse. Diquesta associazione, quale che sia lo stato delle parti, gli uomini che governano, quellidi tutte le parti, sono i membri: membri, uniti insieme contro l’interesse universale daquel particolare e sinistro interesse, di cui ognuno di essi è partecipe: perché, quale chepossa essere il conflitto di due sinistri interessi tra di loro, l’ostilità di entrambi control’unico interesse giusto e vero è molto più estesa ed immutabile. Si faccia un serio at-tacco ad uno dei punti, su cui si fonda questo sistema di corruzione, di rapina e di op-pressione, nel quale essi hanno un interesse comune: allora la mutua ostilità svanisce el’alleanza contro l’avversario comune prende il suo posto».
73 Secondo S. FABBRINI, S. VASSALLO, Il governo, cit., p. 154, il Presidente del Con-siglio, più che da capo del Governo, ha dovuto agire da mediatore (bargaine) tra i par-titi della coalizione, quando non da prestigiatore (juggler), per disinnescare le tensionitra di essi. Nello stesso senso le osservazioni di A. PAJNO, La presidenza, cit., p. 41.
177L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
dei singoli governi, preparati dai futuri capi dell’Esecutivo, de-vono essere rivisti e approvati dagli esperti dei partiti che si uni-scono a formare la maggioranza74. In tale contesto politico, l’a-zione di governo risulta poco incisiva e le crisi di governo sonofrequenti, anche perché possono portare ad un rimescolamentodelle compagini ministeriali più favorevole a determinati partitidi governo75.
Alle disfunzioni del sistema si aggiungeva, a partire daglianni sessanta, la consapevolezza di una crisi di rappresentanzache si manifestava nella proliferazione di movimenti collettivi,che esprimevano una decisa autonomia della società civile daipartiti politici76, e, negli anni successivi, in una notevole crescitadell’astensionismo77. Inoltre, la partecipazione politica si trasfor-mava anche a causa del mutare della società: col tempo, infatti, ilegami di classe si fanno più tenui; i confini tra gli strati socialidiventano labili; diminuiscono le spinte solidaristiche alla basedel processo di integrazione delle masse nei grandi partiti che siritrovano, così, con una base elettorale eterogenea78.
Questo cambiamento, tuttavia, non comportava l’immediatodeclino dei partiti di massa, perché le forze politiche riuscivano
74 Così G. AMATO, Un governo nella transizione. La mia esperienza di Presidentedel Consiglio, in Quaderni costituzionali, 1994, n. 3, pp. 356-357.
75 Come osserva G. VESPERINI, I governi del maggioritario, in ID. (a cura di), I go-verni del maggioritario, Roma, Donzelli editore, 1998, p. 4, «[i] cinquanta governi chesi succedono in Italia dal 1948 al 1993, durano, in media, pochi mesi e hanno un ren-dimento insoddisfacente».
76 Si v., al riguardo, le osservazioni di M. ILARDI, La crisi di potere del partito po-litico, in Democrazia e diritto, 1979, n. 2, pp. 292 ss.
77 Secondo S. COLARIZI, Storia dei partiti nell’Italia repubblicana, Bari, Laterza,1994, p. 545, però, la crescita delle astensioni viene sottovalutata, perché considerataun fenomeno fisiologico delle democrazie moderne. Più in generale, si rinvia a E.W.BÖCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, in Quaderni costituzionali, 1985, n. 2, pp.227 ss., part. 259, secondo il quale, sebbene le conseguenze dell’assenza della rappre-sentanza democratica possano essere nei singoli casi molteplici e di tipi diversi, «[o]ggisi manifestano principalmente nella maggiore presenza di iniziative da parte dei citta-dini (Bürgerinitiativen), ma anche nell’allontanamento dai partiti politici o dalla poli-tica tout court».
78 Si v., al riguardo, le considerazioni di G. PITRUZZELLA, Forme, cit., pp. 60 ss.
178 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
a conservare le loro posizioni continuando ad erogare beneficiagli elettori79. Nel corso degli anni, infatti, i partiti politici ave-vano rafforzato la loro presenza nella società, attraverso l’occu-pazione sistematica delle istituzioni, degli apparati e degli entipubblici. L’attribuzione di cariche in base all’appartenenza aipartiti di governo può essere considerata fisiologica nei sistemipolitici in cui si verifica l’alternanza, in quanto finalizzata a sta-bilire un nesso tra scelte di governo e loro attuazione fedele edincisiva da parte di managers, dirigenti e funzionari. Ma, nei si-stemi in cui non c’è alternanza delle forze politiche al governo,tale occupazione si risolve nel tentativo, attuato dalle forze poli-tiche di governo, di rafforzarsi attraverso la lottizzazione di ogniambito pubblico80. L’occupazione progressiva della società edelle aree di potere da parte dei partiti determinava una crisi dirigetto, un rifiuto e un’insofferenza per la “partitocrazia” dif-fusi81; la reazione a questo malessere si esplicitava in pressanti ri-chieste di riforme istituzionali82, volte, principalmente, a ridurre
79 Così ancora S. COLARIZI, Storia, cit., p. 544, ma si v. anche G. PITRUZZELLA,Forme, cit., pp. 56 ss.
80 In questo senso la ricostruzione di G. PASQUINO, Partiti, cit., pp. 14-15; in pro-posito, G. AMATO, Un governo, cit., p. 357, parla di «spoil system moltiplicato, perva-sivo e senza confini» che non trascura nessuna area destinata a rimanere neutrale; ana-logamente S. COLARIZI, Storia, cit., p. 541, parla di «privatizzazione partitica delloStato», dalla quale non è esclusa neanche l’opposizione comunista. Si rinvia anche alleosservazioni di M. VOLPI, Ingegneria elettorale e crisi di rappresentatività, in Democra-zia e diritto, 1982, n. 6, p. 131, e E. CHELI, La riforma, cit., p. 49, nonché alla ricostru-zione di G. GUARINO, Questione, cit., pp. 141 ss.
81 Così D. NOCILLA, L. CIAURRO, Rappresentanza politica, in Enciclopedia del di-ritto, vol. XXXVIII, Milano, Giuffrè, 1987, p. 605.
82 Tuttavia, secondo F. LANCHESTER, L’innovazione istituzionale difficile: il dibat-tito sulla rappresentanza politica agli inizi della XI legislatura, in Rivista trimestrale didiritto pubblico, 1992, n. 4, p. 910, «[r]isulterebbe (…) fuorviante e miope credere chela polemica sulle cosiddette “riforme istituzionali” sia una completa novità: di innova-zioni istituzionali (ed in particolare di quelle elettorali) si è parlato e si continua a di-scutere in Italia in modo più o meno acceso sin dai primi mesi del 1948, sulla base del-l’immediata insoddisfazione per un compromesso considerato da alcuni soggetti poli-tici non più corrispondente ai rapporti di forza esistenti nel Paese a causa delfunzionamento anomalo dello stesso modello democratico».
179L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
l’autonomia dei partiti politici e ad accentuare la partecipazionedei cittadini alle decisioni che li riguardano.
Le proposte di riforma riguardavano vari settori: la pubblicaamministrazione; i regolamenti parlamentari; il principio bicame-rale; lo statuto del potere giudiziario; il sistema delle autonomie;la forma di governo; il sistema elettorale.
La modifica del sistema elettorale, in particolare, appariva ilmezzo più semplice attraverso il quale modificare la “costitu-zione reale”83 e anche lo strumento con il quale risolvere alcunedelle inefficienze del sistema. Si pensava, nello specifico, all’ado-zione di un sistema elettorale che potesse aumentare la governa-bilità84 e consentisse di superare il modello di “democrazia bloc-cata”85. Le varie proposte di modifica del sistema elettorale, tut-
83 Secondo G. SARTORI, Le riforme istituzionali tra buone e cattive, in Rivista ita-liana di scienza politica, 1991, n. 3, p. 375, la riforma del sistema elettorale «è un primadi tutto il resto; e anche se il resto (la riforma costituzionale) non viene, la riforma delsistema elettorale serve anche da sola». Nello stesso senso B. CARAVITA, M. LUCIANI, Ol-tre, cit., p. 94, che, però, considerano la riforma del sistema elettorale anche il mezzopiù pericoloso. Secondo V. BARNATO, I referendum elettorali: analisi dei quesiti, in Ri-vista trimestrale di diritto pubblico, 1992, n. 3, p. 727, modificare la legge elettorale si-gnifica, per un verso, mettere in discussione uno degli elementi su cui fonda la proprialegittimazione un certo assetto politico, per altro verso, significa realizzare in senso piùpropriamente istituzionale una riforma di struttura. Tuttavia, come osserva G.LEIBHOLZ, Crisi della rappresentanza e sistemi elettorali (intervista a cura di F. LANCHE-STER), in Quaderni costituzionali, 1981, n. 3, p. 488, «sebbene il sistema elettorale siamolto importante, fondamentale è la “mentalità” dell’intero popolo». Sicché, secondoA. PANEBIANCO, Contorno istituzionale e buon governo, in il Mulino, 2012, n. 2, pp. 217ss., le riforme istituzionali e, in particolare, quella della legge elettorale, sono comun-que destinate ad essere inefficaci in Italia, perché ostacolate dalle tradizioni culturalidel Paese.
84 Sul concetto di governabilità, tuttavia, si v. le osservazioni di M. VOLPI, Inge-gneria, cit., p. 130.
85 In questo senso B. CARAVITA, M. LUCIANI, Oltre, cit., p. 106, ma anche F. CUO-COLO, Disomogeneità politica e tendenze nello sviluppo della forma di governo italiana,in Quaderni costituzionali, 1981, n. 2, p. 339. Invece, secondo A. SPREAFICO, Il rendi-mento, cit., p. 511, sarebbe particolarmente utile riformare il meccanismo elettoraledel Senato per trasformarlo effettivamente in un «Senato delle regioni». Si rinvia, in-fine, alle osservazioni di S. GAMBINO, Riforme elettorali e modelli di democrazia, inwww.federalismi.it, 9 gennaio 2006, pp. 5-6.
180 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
tavia, pur puntando alla soluzione delle disfunzioni del sistemaitaliano, non convergevano verso un univoco modello di riforma:sia la dottrina sia le forze politiche puntavano su ipotesi diriforma differenti, anche perché, come si è già accennato, lascelta di un sistema elettorale non è un’operazione semplice-mente tecnica ma con una forte caratterizzazione politica86. Leproposte di riforma elettorale, quindi, erano molte87, ma i mag-giori consensi convergevano verso una riforma del sistema elet-torale in senso maggioritario, in quanto ritenuto il sistema piùadatto a garantire la governabilità, il rendimento e l’efficacia delgovernare88. Infatti, se la proporzionale è stata fondamentale perfar crescere un minimo comune denominatore democratico inuna società eterogenea, quale era quella italiana del dopoguerra,già negli anni settanta si avvertiva la necessità di «osare il saltoverso le regole della democrazia maggioritaria»89, al fine di con-solidare la democrazia contro la disaffezione e la perdita di cre-dibilità dei poteri legittimi.
Il dibattito sulle riforme diventava centrale anche nella di-scussione in Parlamento con l’istituzione, nel 1983, della primaCommissione parlamentare bicamerale per le riforme istituzio-nali (c.d. Commissione Bozzi) che, tuttavia, si occupava solo
86 Secondo G. PASQUINO, Suggerimenti scettici agli ingegneri costituzionali, in ilMulino, 1979, n. 5, p. 757, infatti, nessuna riforma del sistema elettorale può essere con-siderata semplicemente un’operazione tecnica: essa «è una scelta politica nel senso piùpregnante del termine». Cfr. anche quanto già osservato supra, parte III, cap. I, par. 2.
87 Se ne veda una rassegna in G. SARTORI, Le riforme, cit., pp. 376 ss.88 Si v., in proposito, A. PANEBIANCO, Riforme contro i partiti? Un commento, in
Rivista italiana di scienza politica, 1991, n. 3, pp. 409 ss.; G. SARTORI, Le riforme, cit.,pp. 375 ss.; D. FISICHELLA, Recenti sviluppi del dibattito sulla riforma elettorale in Ita-lia, in Quaderni costituzionali, 1981, n. 3, pp. 515-517. Secondo G. PASQUINO, Suggeri-menti, cit., pp. 777-778, solo un sistema maggioritario a doppio turno è in grado di faremergere maggioranze solide; l’A., tuttavia, ritiene che l’adozione di un sistema eletto-rale diverso da quello proporzionale potrebbe non essere in grado di favorire l’alter-nanza e, inoltre, potrebbe far crescere l’astensionismo. Si rinvia anche alle osservazionidi S. PASSIGLI, Riforme istituzionali e governo: un commento, in Rivista italiana discienza politica, 1991, n. 3, pp. 419 ss.
89 Così A. BARBERA, S. CECCANTI, La lenta, cit., p. 92.
181L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
marginalmente della riforma del sistema elettorale e, comunque,con l’obiettivo di mantenere la proporzionale o, addirittura, po-tenziarla90. Inoltre, a causa del disaccordo tra le forze politiche,la Commissione concludeva i suoi lavori senza raggiungere risul-tati concreti91.
Sempre negli anni ottanta si susseguivano eventi che travol-gevano il sistema politico italiano. Da un lato, sembrava esserci ildefinitivo superamento delle divisioni ideologiche – soprattutto alivello internazionale – che avevano determinato certi assetti poli-tici92. Dall’altro, cominciava a delinearsi quello che, con l’inchie-sta “Mani pulite” e lo scandalo di “Tangentopoli”, sarebbe diven-tato scontro aperto tra potere politico e potere giudiziario. La
90 Così A. PAPPALARDO, La nuova legge elettorale in Parlamento: chi, come e per-ché, in Rivista italiana di scienza politica, 1994, n. 2, p. 289. Sulla Commissione Bozzisi rinvia anche a C. FICHERA, La politica delle istituzioni in fase non costituente, in V.ATRIPALDI, C. FICHERA, Dalla grande, cit., pp. 23 ss., V. ATRIPALDI, C. FICHERA, Oltre laCommissione Bozzi, ivi, pp. 37 ss., e C. FUSARO, Forma di governo e principio maggiori-tario. La Commissione Bozzi e le strategie istituzionali dei partiti, in AA.VV., Scritti inonore di Aldo Bozzi, Padova, Cedam, 1992, pp. 214 ss.
91 Secondo M. OLIVETTI, La Commissione Bicamerale sulle riforme costituzionali:profili storico-istituzionali e rilievi di ordine procedimentale, in Iustitia, 1997, n. 2, p.148, infatti, le proposte della Commissione Bozzi «furono lasciate cadere dai partitipolitici, paralizzati, sulla questione istituzionale da una rete di veti reciproci». Si ri-portano anche le osservazioni – venate di amarezza – di D. NOCILLA, L. CIAURRO, Rap-presentanza, cit., p. 604: «I partiti, le cui degenerazioni e disfunzioni sono spesso all’o-rigine della crisi odierna, si sono impadroniti del dibattito, donde l’impressione di unadifficile autoriforma dell’attuale assetto di potere; le proposte si intersecano l’una conl’altra e si ha il sospetto che spesso esse siano avanzate più nel tentativo di trovare unaposizione diversa ed originale rispetto a quella degli altri, che per reale convinzionesulla loro idoneità a conseguire il fine che si vuole raggiungere». Scettico anche G.AMATO, I sistemi elettorali in Italia: le difficoltà del cambiamento, in Quaderni costitu-zionali, 1981, n. 3, p. 532, secondo il quale «il sistema è imperfetto e meriterebbe diessere cambiato, ma probabilmente non cambierà». Si v. anche i timori di G. GUARINO,Superdimensionamento della classe politica e disfunzioni del sistema, in Studi parlamen-tari e di politica costituzionale, 1984, ora in ID., Dalla Costituzione, vol. IV, cit., p. 87,secondo il quale la classe politica potrebbe scorgere nelle riforme «una eccellente oc-casione per rafforzare il proprio potere».
92 … è senz’altro sufficiente ricordare, in proposito, il crollo del muro di Ber-lino, nel 1989.
182 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
magistratura, infatti, iniziava a scoprire quel sistema di illegalitàdilagante che negli anni si era consolidato, indagando anche su al-cuni tra i più importanti esponenti politici del Paese; nello stessotempo, i politici tentavano di difendere quello stesso sistema, in-sabbiando o bloccando le indagini93. La diffusione degli scandalipolitici, però, travolgeva i partiti, delegittimava il ceto politico escatenava un’ondata antipartitica nel Paese: cresceva l’astensioni-smo; aumentavano i consensi verso forze politiche nuove (come laLega nord); e, soprattutto, si tentava di cambiare il sistema grazieai referendum elettorali (prima quello del 1991 sulla preferenzaunica, poi quello del 1993 sul sistema elettorale per il Senato).
Questa situazione spingeva il Parlamento ad istituire, nel1992, una seconda Commissione parlamentare bicamerale per leriforme istituzionali (c.d. Commissione De Mita-Iotti). TaleCommissione aveva il compito di elaborare un progetto organicodi revisione costituzionale relativo alla Parte II della Costitu-zione, nonché progetti di legge sui sistemi elettorali per le Ca-mere e i Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario94.Anche durante i lavori della Commissione De Mita-Iotti si con-frontarono posizioni diverse ma, a differenza di quanto accadutoper la Commissione Bozzi, si bruciarono le tappe procedurali,indipendentemente dai risultati conseguiti, a causa della pres-
93 Cfr. le osservazioni di S. COLARIZI, Storia, cit., pp. 546 ss., G. PITRUZZELLA,Forme, cit., pp. 77 ss., e i dubbi di A. CHIAPPETTI, La ricerca, cit., p. 99. Appare utilerinviare anche a D. NELKEN, Il significato di Tangentopoli: la risposta giudiziaria allacorruzione e i suoi limiti, in L. VIOLANTE (a cura di), Legge, diritto, giustizia, Storia d’I-talia, Annali 14, Torino, Einaudi, 1998, pp. 597 ss.
94 Cfr. l’art. 1, co. 1, della l. cost. 1/1993; sulla Commissione e la sua legge isti-tutiva si v. R. MORETTI, Il progetto di legge costituzionale sulla commissione parlamen-tare per le riforme istituzionali: appunti sul testo approvato dal Senato, in Il Foro ita-liano, 1992, n. 10, col. 391 ss., E. CUCCODORO, I limiti della commissione per le riformeistituzionali, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1992, n. 97-98, pp. 75 ss.,C. DE FIORES, La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e l’art. 138 Cost.:paradossi di una riforma, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, n. 2, pp. 1541 ss., S.CECCANTI, Una Bicamerale in chiaroscuro, in Quaderni costituzionali, 1995, pp. 317 ss.,e C. TROILO, La ricerca della governabilità. La forma di governo nelle proposte dellaCommissione Bicamerale e del Comitato Speroni, Padova, Cedam, 1996.
183L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
sione esercitata dalla pendenza del referendum95. Tuttavia, anchequesta Commissione, nonostante la rapida conclusione dei lavoricon un voto di approvazione dei criteri direttivi della propostapresentata dal relatore Mattarella, terminava i suoi lavori con unnulla di fatto, perché non si raggiungeva realmente un accordofra i partiti96.
3.3. La riforma elettorale del 1993
L’approvazione del referendum abrogativo sulla legge eletto-rale per il Senato, svoltosi il 18 aprile 1993, induceva il Parla-mento ad affrontare – sollecitamente – il tema della modifica delsistema elettorale. La riforma delle leggi elettorali, in realtà, ap-pariva di difficile attuazione sia per le divisioni politiche del Par-lamento97 sia per la pressione esercitata sullo stesso dalle inchie-ste giudiziarie che coinvolgevano vari parlamentari e importantidirigenti di partito. A rendere più complessa la situazione con-tribuiva il dibattito – in atto ormai da anni – sulla necessità diprocedere ad un’organica revisione della Parte II della Costitu-
95 Secondo A. PAPPALARDO, La nuova, cit., pp. 291-292, la seconda Bicamerale èstata fortemente influenzata dal referendum per il Senato: è stata varata nel luglio del1992, in concomitanza con il deposito di richieste e firme per il referendum stesso; si èinsediata nel settembre successivo, prima del controllo della Corte di Cassazione sullefirme; ha cominciato i suoi lavori dopo il parere positivo della Cassazione. Sempre inrelazione alla pressione esercitata dal referendum sulla classe politica, N. ZANON, Il«patto Segni» e il diritto costituzionale della rappresentanza politica, in Quaderni costi-tuzionali, 1993, n. 1, pp. 195 ss., ricorda l’esperienza del c.d. patto Segni: centinaia dicandidati alle elezioni politiche aderirono al patto per la riforma elettorale impegnan-dosi, nel caso in cui fossero stati eletti, a promuovere e sostenere ogni iniziativa utileall’approvazione di riforme coerenti con quanto previsto dai referendum elettorali, conpriorità rispetto ad ogni vincolo di partito o disciplina di gruppo.
96 Cfr., in proposito, A. PAPPALARDO, La nuova, cit., pp. 292-293.97 Le proposte di legge presentate in Parlamento, come ricorda A. PAPPALARDO,
La nuova, cit., p. 293, furono diciassette. L’alto numero delle proposte conferma la na-tura fittizia del voto finale alla Bicamerale. Tra le varie forze politiche, la DC puntavaad un sistema plurality, il Partito democratico della sinistra-PDS ad un sistema unino-minale a due turni, i partiti minori, infine, tentavano di mantenere uno spazio propor-zionale che ne garantisse la sopravvivenza.
184 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
zione. Era diffusa, infatti, l’opinione che la modifica del sistemaelettorale fosse solo una parte dell’ampio cambiamento cheavrebbe dovuto riguardare le regole istitutive della forma di go-verno in Italia98. Ciò nonostante, la nuova disciplina per l’ele-zione della Camera e del Senato era approvata, «con imprevistarapidità dopo tante tergiversazioni»99, il 4 agosto 1993100.
Per entrambe le Camere erano approvati sistemi elettoraliprevalentemente maggioritari: il 75% dei seggi, infatti, era asse-gnato con un sistema maggioritario a turno unico ai candidatiche ottenevano la maggioranza, anche relativa, dei voti validi(c.d. first past the post), senza la previsione di un quorum strut-turale, né di un quorum per l’elezione101. Il rimanente 25% deiseggi, invece, era attribuito secondo il principio proporzio-
98 In questo senso A. PIZZORUSSO, I nuovi sistemi elettorali per la Camera dei de-putati e per il Senato della Repubblica, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Riforme,cit., pp. 128-129.
99 Così F. CUOCOLO, Istituzioni di diritto pubblico, 12ª ed., Milano, Giuffrè, 2003,p. 227. Secondo S. GAMBINO, G. MOSCHELLA, Regole, cit., pp. 27-28, la riforma del si-stema elettorale «può considerarsi (…), più che il risultato del lungo confronto poli-tico istituzionale – a volte anche di livello – sul tema della ristrutturazione della rap-presentanza politica, l’esito di un rapido e vivificatore processo di trasformazione delsistema politico e del rapporto tra rappresentanza, istituzioni e società civile ascrivibilesoprattutto alla grave crisi di rappresentatività e di legittimazione democratica in cuiversano oggi i soggetti costituzionali sostanziali che (andando molto al di là della pre-visione dell’art. 49 Cost.) hanno detenuto fino ad oggi il monopolio della rappresen-tanza: i partiti politici. L’impressione che si ricava (…) è che la forma partito lungi dalconfigurarsi quale “soggetto della trasformazione” abbia subito (suo malgrado) scelteimposte da una società civile non più disponibile ad accettare gli effetti dell’occupa-zione partitica delle istituzioni». Secondo G. SILVESTRI, Trasformazione del sistema elet-torale e prospettive di riforma, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Riforme, cit., p.146, peraltro, la riforma del sistema elettorale «è nata in un clima di disincantata stan-chezza». Infine, sulle motivazioni che possono indurre i partiti ad approvare riformeelettorali che non vorrebbero si v. R.S. KATZ, Why Are There So Many (or So Few)Electoral Reforms?, in M. GALLAGHER, P. MITCHELL (eds.), The Politics, cit., pp. 73-75.
100 Cfr. la l. 276/1993, per il Senato, e la l. 277/1993, per la Camera, che modi-ficavano, rispettivamente, la l. 29/1948 e il d.p.r. 361/1957. Sulla riforma elettorale del1993 e i suoi primi effetti si rinvia a S. BARTOLINI, R. D’ALIMONTE, Maggioritario manon troppo, Bologna, il Mulino, 1995.
101 Cfr. il d.p.r. 361/1957, art. 1, co. 3, come modificato dalla l. 277/1993, art. 1,e la l. 29/1948, art. 2, come sostituito dalla l. 276/1993, art. 1.
185L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
nale102, ma attraverso meccanismi differenti – ed anche piuttostocomplessi – per Camera e Senato103.
Il sistema elettorale introdotto nel 1993 rappresentava unasoluzione di compromesso tra le tante proposte sulle quali si eradiscusso in Parlamento104; la normativa che ne era derivata risul-tava «complessa ed intricata, tanto da risultare un unicum nel pa-norama dei sistemi elettorali vigenti nei maggiori Paesi democra-tici»105, sebbene in linea con una diffusa propensione ad utiliz-zare formule elettorali miste, nel tentativo di conciliare i vantaggidei sistemi maggioritari con quelli dei sistemi proporzionali106.
Per integrare la normativa elettorale, si era anche introdotta,per la prima volta in Italia, una disciplina unitaria dell’attivitàpolitica in vista delle elezioni107, un vero e proprio “sistema elet-torale di contorno”108.
È utile ricordare, inoltre, che, sempre nel 1993, veniva ap-provata la legge sull’elezione diretta del Sindaco e del Presidentedella Giunta provinciale109 e, con la riforma costituzionale del
102 Cfr. il d.p.r. 361/1957, art. 1, co. 4, come modificato dalla l. 277/1993, art. 1,e la l. 29/1948, artt. 2 e 17, co. 2, come sostituiti dalla l. 276/1993, artt. 1 e 3.
103 Cfr. il d.p.r. 361/1957, artt. 77, 83 e 84, come modificati dalla l. 277/1993,artt. 4 e 5, e la l. 29/1948, art. 10, come sostituito dalla l. 276/1993, art. 4.
104 Secondo R. D’ALIMONTE, A. CHIARAMONTE, Il nuovo sistema elettorale ita-liano: quali opportunità?, in Rivista italiana di scienza politica, 1993, n. 3, p. 514, infatti,il sistema elettorale del 1993 sarebbe stato «il frutto di un complesso gioco di accordie di veti incrociati tra gli schieramenti presenti nell’arena parlamentare».
105 Così F. CUOCOLO, Istituzioni, cit., p. 227.106 Così C. FUSARO, Le regole, cit., p. 89. Sulla tendenza a ricorrere a sistemi elet-
torali misti si v. anche M.S. SHUGART, Comparative Electoral System Research: The Ma-turation of a Field and New Challenges Ahead, in M. GALLAGHER, P. MITCHELL (eds.),The Politics, cit., pp. 33 ss.
107 … con la l. 515/1993.108 Così C. FUSARO, Media, sondaggi e spese elettorali: la nuova disciplina, in Ri-
vista italiana di scienza politica, 1994, n. 3, p. 427, al quale si rinvia anche per una ana-lisi di tale disciplina.
109 Cfr. la l. 81/1993, sulla quale si rinvia a F. LANCHESTER, Il nuovo attraverso ilvecchio: la legge n. 81/1993 sull’elezione degli Enti locali, in Nomos, 1993, n. 2, pp. 137ss., M. SCUDIERO, L’elezione diretta del sindaco tra riforme istituzionali e trasformazionedel sistema politico, in Le Regioni, 1993, n. 3, pp. 635 ss., A. BARBERA, Elezione diretta
186 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
1999, si prevedeva l’elezione diretta anche del Presidente dellaGiunta regionale110. Nella riforma dei sistemi elettorali del Parla-mento e degli enti locali, infatti, sembrava di poter intravedereun disegno comune: spingere nel senso di una più penetrante in-fluenza del corpo elettorale nella nomina degli Esecutivi e sulcontrollo del loro operato111.
3.4. Il voto degli italiani all’estero
Una riforma costituzionale di cui occorre dare conto èquella che ha riguardato gli artt. 48, 56 e 57 Cost. Innanzitutto,con la l. cost. 1/2000, si è aggiunto un comma all’art. 48 Cost., alfine di garantire l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’e-stero112. In seguito, con la l. cost. 1/2001 si è proceduto alla mo-difica degli artt. 56 e 57 Cost., disponendo che dodici dei sei-centotrenta deputati siano eletti nella circoscrizione Estero e seidei trecentoquindici senatori elettivi siano assegnati alla circo-scrizione Estero113. Si tratta di una riforma alla quale occorre ac-
del Sindaco, Rimini, Maggioli, 1993, e F. GABRIELE, Le nuove norme sull’elezione e sullecompetenze degli organi dei Comuni e delle Province, Bari, Cacucci, 1994.
110 Il riferimento è alla l. cost. 1/1999; ma si v. anche la l. 43/1995, che «preve-deva che le liste regionali sarebbero state guidate da un “capolista”, che avrebbe do-vuto svolgere de facto il ruolo di candidato alla Presidenza della Giunta regionale»,come osserva M. OLIVETTI, Nuovi, cit., p. 214.
111 T.E. FROSINI, Suggestioni, cit., part. pp. 105-106, ritiene queste riforme utiliper diffondere una nuova cultura politico-istituzionale: la cultura del buon governo,scelto dai cittadini e responsabile di fronte agli stessi; un governo periodicamente sog-getto al giudizio degli elettori, che possono agire su di esso per il tramite del voto, chepuò essere di premio o di sanzione, ovvero di rinnovo o di negazione della fiducia. Siv. anche A. DI GIOVINE, F. PIZZETTI, Nuove leggi elettorali e sistema politico, in Giuri-sprudenza costituzionale, 1993, p. 4149.
112 Si riporta il testo del co. 2 dell’art. 48 Cost.: «La legge stabilisce requisiti emodalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicural’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere,alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondocriteri determinati dalla legge». Sul vigente art. 48 Cost. si rinvia a E. GROSSO, Art. 48,in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario, vol. I, cit., pp. 961 ss.
113 Sugli artt. 56 e 57 Cost. si v. i già citati C. FUSARO, M. RUBECHI, Art. 56, cit.,pp. 1129 ss., nonché ID., Art. 57, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di),
187L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
cennare in questa sede perché, non solo ha consentito di ricono-scere una rappresentanza simbolica ma significativa dei cittadiniitaliani residenti all’estero, ma, poiché in talune legislature lecoalizioni di governo in Parlamento hanno potuto contare suuna maggioranza di seggi particolarmente esigua, anche i parla-mentari eletti in rappresentanza degli italiani all’estero sono ri-sultati determinanti per la sopravvivenza degli Esecutivi.
3.5. La riforma elettorale del 2005
Nonostante tale riforma, il sistema elettorale è stato nuova-mente modificato nel 2005 con una legge proporzionale114, che,in virtù di taluni accorgimenti tecnici, conserva sostanzialmentegli effetti maggioritari prodottisi dopo la riforma del 1993115.
Commentario, vol. II, cit., pp. 1143 ss. Si rinvia, altresì, a E. GROSSO, Il voto all’estero:tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalità, in Quaderni costituzionali, 2002, n.2, pp. 346 ss., G.E. VIGEVANI, Il voto all’estero: interrogativi sulla «riserva indiana» peri candidati, ivi, pp. 348 ss., C. FUSARO, Il voto all’estero: quando i costituzionalisti […]non ci stanno, ivi, pp. 351 ss., e T.E. FROSINI, Una nota sull’elettorato (passivo) degli ita-liani all’estero, in www.forumcostituzionale.it.
114 Ad opera della l. 270/2005, che ha modificato le norme per l’elezione di en-trambe le Camere, innovando la disciplina dettata, in particolare, dal d.p.r. 361/1957per la Camera dei deputati e dal d.lgs. 533/1993 per il Senato della Repubblica. Ap-pare utile considerare che anche la Regione Toscana, che, dopo la riforma del Titolo V,ha approvato una organica legge elettorale regionale (la l. reg. Toscana 25/2004, sullaquale si v. G. TARLI BARBIERI, La forma di governo nel nuovo statuto della Regione To-scana: prime osservazioni, in Diritto pubblico, 2004, n. 2, pp. 737 ss., e F. SCIOLA, Noteminime sulla forma di governo in Toscana tra statuto e legge elettorale, in www.federa-lismi.it, 2 giugno 2005, pp. 1 ss.), ha previsto un sistema elettorale per molti versi si-mile alla l. 270/2005. Questa convergenza nelle scelte politiche nazionali e locali po-trebbe essere indicativa della tendenza dei partiti al recupero di posizioni nella defini-zione e gestione delle candidature. Infatti, nonostante la Regione Toscana abbiaprevisto anche un procedimento – facoltativo – di selezione dei candidati (le c.d. pri-marie, sulle quali si rinvia infra, parte III, cap. II, par. 2.5.1.), nella prima applicazionedi tale sistema, i risultati delle primarie sono stati disattesi nella composizione delle li-ste elettorali a causa di sopravvenuti accordi tra i partiti politici.
115 Secondo A. D’ANDREA, Partiti politici ed evoluzione della forma di governonell’ordinamento italiano, in www.forumcostituzionale.it, relazione del 5 novembre2005, infatti, «[v]errebbe da dire che nulla vi è di proporzionale» nel sistema elettoralepredisposto da tale legge; nello stesso senso C. DE FIORES, Rappresentanza politica e si-
188 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
Il sistema elettorale delineato dalla l. 270/2005 è un sistemaproporzionale a “liste bloccate”116, con i candidati che possonopresentarsi contestualmente in più collegi117. Il sistema elettoralepunta comunque a garantire il mantenimento della struttura bi-polare del sistema partitico sviluppatasi dopo il 1993, con delledisposizioni che tendono a favorire l’aggregazione in coalizioni.
stemi elettorali in Italia, in www.costituzionalismo.it, 16 ottobre 2007, par. 14. G. RI-VOSECCHI, Ritorno al diritto non scritto? A proposito di un contributo allo studio dellaconsuetudine, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, osserva che la l. 270/2005,«a dispetto della teorica configurazione di legge proporzionale con premio di maggio-ranza, sembra radicalizzare un brutale principio maggioritario di coalizione». Appareutile, infine, riprendere le parole di G.U. RESCIGNO, Principio, cit., p. 12, secondo ilquale: «se poniamo al centro dell’attenzione non tanto il meccanismo di voto inquanto tale, ma il risultato che esso realizza o tende a realizzare, allora è maggioritario(viene chiamato maggioritario) ogni sistema elettorale che dà o può dare un forte pre-mio in seggi al gruppo che ha ottenuto la maggioranza relativa (e ovviamente dà o puòdare ai gruppi minoritari molto meno seggi rispetto al criterio proporzionale)».
116 Cfr. il d.p.r. 361/1957, art. 4, co. 2 (come sostituito dalla l. 270/2005, art. 1,co. 2), art. 18-bis, co. 3 (come sostituito dalla l. 270/2005, art. 1, co. 6), art. 84, co. 1(come sostituito dalla l. 270/2005, art. 1, co. 13); il d.lgs. 533/1993, art. 14, co. 1 (comesostituito dalla l. 270/2005, art. 4, co. 6), art. 9, co. 4 (come sostituito dalla l. 270/2005,art. 4, co. 3), art. 17, co. 7 (come sostituito dalla l. 270/2005, art. 4, co. 8).
117 Cfr. il d.p.r. 361/1957, art. 9, co. 1, modificato dalla l. 270/2005, art. 1, co. 7.Secondo S. CECCANTI, I “nuovi” sistemi elettorali: regolarità, anomalie, utilizzazioni pre-viste e impreviste, in www.federalismi.it, 20 ottobre 2005, pp. 1-3, la configurazione diliste bloccate sarebbe opportuna, perché avvicinerebbe il sistema elettorale italiano aquelli europei, impedendo una concorrenza tra candidati della stessa lista che po-trebbe scardinare qualsiasi coerenza interna ai partiti. Tuttavia, il sistema italiano pre-senta una grave anomalia: «invece di liste bloccate corte, di tre o quattro nomi, qui leliste sono costituite di varie decine in collegi di dimensione regionale o, in qualchecaso alla Camera, semi-regionale. Per questo l’elettore non potrà sulla scheda verifi-care i nomi dei candidati, a differenza di quanto accade in Germania e in Spagna e diquanto accadeva con la quota proporzionale del Mattarellum». Per quanto riguarda lecandidature multiple, invece, l’A. osserva, opportunamente, che queste consentono aipartiti di garantire comunque l’elezione delle oligarchie di partito, indipendentementedall’andamento del voto; il meccanismo delle candidature multiple, inoltre, induce acandidare pressoché ovunque come capolista il leader della coalizione, rafforzando leliste di cui egli è espressione a discapito delle altre liste della coalizione. Si v. anche idubbi espressi da S. GAMBINO, Riforme, cit., pp. 19-20, A. DI VIRGILIO, Legge elettoralecorreggere i difetti per chiudere un ciclo, in il Mulino, 2007, n. 1, pp. 65 ss., e R.CHIEPPA, Non basta una qualsiasi modifica alla legge elettorale, in Iustitia, 2007, n. 2,pp. 135 ss.
189L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
La legge, infatti, prevede sia delle soglie di sbarramento118 sia unpremio di maggioranza che sono tesi chiaramente a favorire lecoalizioni, scoraggiando la presentazione – o, comunque, l’affer-mazione elettorale – di liste isolate119. Per coalizzarsi, inoltre, leliste devono indicare un programma elettorale comune, nonchéun soggetto indicato come leader unico dell’intera coalizione120.
Il premio di maggioranza, peraltro, è attribuito secondo cri-teri differenti tra Camera e Senato. Nell’elezione della Camera, ilpremio di maggioranza è attribuito a livello nazionale: la mag-gioranza dei seggi dell’Assemblea è assegnata alla coalizione chea livello nazionale ha avuto più voti121. Al Senato, invece, il pre-mio di maggioranza è attribuito “su base regionale”: la maggio-ranza dei seggi spettanti alla singola Regione è assegnata alla listao – come è più probabile – alla coalizione che ha ottenuto lamaggioranza dei voti in quella specifica Regione122. Questa diffe-renza nell’attribuzione del premio di maggioranza non è di pococonto, perché può favorire la formazione di maggioranze diversealla Camera e al Senato123.
118 Cfr. il d.p.r. 361/1957, art. 83, co. 1 (come sostituito dalla l. 270/2005, art. 1,co. 12); il d.lgs. 533/1993, art. 16 (come sostituito dalla l. 270/2005, art. 4, co. 7).
119 In questo senso anche le osservazioni di S. DURANTI, J. SAWICKI, La nuovalegge per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (legge 21dicembre 2005, n. 270), in www.federalismi.it, 26 gennaio 2006, p. 6. Si v. anche leosservazioni critiche di S. CECCANTI, La legge elettorale nel contesto delle trasformazionidel diritto parlamentare e della Costituzione e il connubio tra stabilità e inefficienza, inwww.federalismi.it, 23 febbraio 2006, pp. 1 ss., e S. GAMBINO, Riforme, cit., pp. 20-21.
120 Cfr. il d.p.r. 361/1957, art. 14-bis, co. 3 (introdotto dalla l. 270/2005, art. 1,co. 5), al quale rinvia anche il d.lgs. 533/1993, art. 9, co. 3 (come sostituito dalla l.270/2005, art. 4, co. 3). Secondo S. GAMBINO, Riforme, cit., p. 20, queste previsioni sa-rebbero del tutto inadeguate a garantire il raggiungimento dell’obiettivo della gover-nabilità.
121 Cfr. il d.p.r. 361/1957, art. 83, co. 2 (come sostituito dalla l. 270/2005, art. 1,co. 12). Sul meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza alla Camera deideputati si v. le osservazioni molto critiche di C. FUSARO, La questione dei voti dellaValle d’Aosta nella legge proporzionale con premio in attesa di promulgazione, inwww.forumcostituzionale.it, 19 dicembre 2005.
122 Cfr. il d.lgs. 533/1993, art. 17, co. 2 (come sostituito dalla l. 270/2005, art. 4,co. 8).
123 In questo senso S. CECCANTI, I “nuovi”, cit., p. 4, e P.L. PETRILLO, La nuova
190 PARTE TERZA - CAPITOLO PRIMO
La nuova legge elettorale, dunque, pur non consentendo aicittadini di votare uno specifico candidato alla Camera o al Se-nato attraverso il voto di preferenza, tende a garantire la sceltaper uno schieramento partitico che possa diventare maggioranzaparlamentare capace di sostenere il nuovo Governo, nonché, inmaniera praticamente diretta, l’individuazione del soggetto desti-nato ad assumere la carica di Presidente del Consiglio, in caso diaffermazione elettorale della sua coalizione124.
Come si è già accennato, quindi, sebbene utilizzi una for-mula elettorale proporzionale, il sistema elettorale delineatodalla l. 270/2005 conferma sostanzialmente gli effetti maggiori-tari prodottisi dopo la riforma elettorale del 1993. È necessario,di conseguenza, verificare quali siano tali effetti.
legge elettorale per la Camera ed il Senato, in www.rivistaic.it, 1 febbraio 2006. Se-condo T. GROPPI, Forma di governo e sistemi elettorali in Italia, in www.astrid.eu, 25gennaio 2007, p. 17, alla luce delle elezioni del 2006, «il premio di maggioranza subase regionale si è rivelato una vera lotteria». Secondo S. BARTOLINI, R. D’ALIMONTE, Ilmaggioritario dei miracoli, in S. BARTOLINI, R. D’ALIMONTE (a cura di), Maggioritarioper caso, Bologna, il Mulino, 1997, p. 355, tuttavia, un “Parlamento diviso”, con duemaggioranze diverse tra Camera e Senato era un’ipotesi probabile anche nelle elezionidel 1996, ovvero quelle tenutesi ancora col sistema elettorale del 1993; che ciò non sisia concretamente avverato, secondo gli Autori, sarebbe un “miracolo”.
124 Secondo S. DURANTI, J. SAWICKI, La nuova, cit., p. 2, infatti, «gli estensoridella nuova legge elettorale hanno dovuto operare un difficile sforzo di sintesi, al finedi contemperare le pressioni per il ripristino di sistemi di lista a impianto proporzio-nale – alquanto diffuse presso gran parte del ceto politico (…) – con l’esigenza, inveceancora avvertita presso alcuni settori dell’opinione pubblica, di non disperdere per lomeno una delle caratteristiche coessenziali al vecchio sistema in prevalenza maggiori-tario: quella di preservare una struttura bipolare del sistema partitico, tale da consen-tire la predeterminazione di una maggioranza parlamentare in grado di sorreggere ilgoverno (contestualmente all’indicazione di un “unico capo della coalizione”)». E.MOSTACCI, Un maggioritario in abito proporzionale: perplesse considerazioni su alcuniaspetti essenziali del nuovo sistema elettorale, disegnato dalla legge n. 270 del 21 dicem-bre 2005, in Nomos, 2005, n. 3, p. 100, invece, ritiene che il sistema elettorale del 2005appaia «finalizzato a legittimare tout court un sistema politico storicamente determi-nato». Sulle motivazioni “partigiane” della modifica del sistema elettorale, che confer-mano la grande valenza politica delle scelte relative ai sistemi elettorali, si rinvia a S.CECCANTI, I “nuovi”, cit., pp. 4-5, e S. GAMBINO, Riforme, cit., pp. 21 ss.
191L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ELETTORALE IN ITALIA
CAPITOLO SECONDO
L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO SUL GOVERNO
E SUI COMITATI INTERMINISTERIALI
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2.1. Gli effetti delle riforme elettorali in senso mag-gioritario sul sistema dei partiti. – 2.1.1. La XII legislatura. – 2.1.2. LaXIII legislatura. – 2.1.3. La XIV legislatura. – 2.1.4. La XV legislatura. –2.1.5. La XVI legislatura. – 2.1.6. Il sistema partitico nelle legislature mag-gioritarie: una valutazione di sintesi. – 2.2. Le modifiche dei regolamentiparlamentari. – 2.3. Il rapporto tra Esecutivo e maggioranza parlamentarenell’attuazione del programma di governo. – 2.4. Il procedimento di for-mazione del Governo. – 2.5.1. La modificazione del ruolo del Presidentedel Consiglio dei ministri: in seguito ai mutamenti elettorali e politici. –2.5.2. La modificazione del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri:in seguito alle riforme normative. – 2.5.3. Il rafforzamento della ruolo delPresidente del Consiglio fra tendenze contrastanti. – 2.6. Gli organi “nonnecessari” del Governo. – 2.7. Il caso specifico dei comitati interministe-riali.
1. Premessa
Dopo aver ricostruito l’evoluzione dei sistemi elettorali inItalia e le vicissitudini che hanno portato alla riforma elettoralemaggioritaria, occorre verificarne gli effetti sul Governo e sullasua struttura. Prima di tale analisi, è tuttavia necessario esami-nare come le riforme elettorali maggioritarie hanno inciso sul si-stema dei partiti, sull’organizzazione del Parlamento e sui rap-porti tra quest’ultimo e l’Esecutivo, perché si tratta di modifica-zioni complessivamente atte ad influire sul Governo.
2.1. Gli effetti delle riforme elettorali in senso maggioritario sul si-stema dei partiti
Occorre considerare, innanzitutto, i mutamenti che leriforme elettorali maggioritarie hanno prodotto nel sistema par-titico e nelle dinamiche elettorali, che concorrono a determinarela struttura del Governo e i rapporti endogovernativi, prendendoin considerazione le singole legislature successive alla riformaelettorale del 1993.
2.1.1. La XII legislatura
I mutamenti di cui si discorre, in realtà, si sono manifestatigià prima dello svolgimento delle prime elezioni maggioritarie,quelle del 1994. Le forze politiche e i singoli candidati, infatti,hanno dovuto cambiare il modo con cui presentarsi al corpoelettorale: le forze politiche si sono coalizzate nella parte mag-gioritaria, ma hanno mantenuto la propria individualità nellaparte proporzionale della Camera1; è nata una nuova forza poli-tica capace di attirare un importante consenso elettorale (ForzaItalia-FI); si sono create coalizioni in parte diverse per area geo-grafica2. Il nuovo sistema elettorale ha comportato anche un evi-dente effetto di polarizzazione degli schieramenti: quelle forma-zioni politiche di centro che non hanno voluto scegliere conchiarezza con quale coalizione schierarsi sono state fortementeridimensionate in termini di seggi3.
1 Infatti, come ricorda R. D’ALIMONTE, L’uninominale incompiuto, in il Mulino,1994, n. 1, p. 55, la legge elettorale del 1993 incorporava due logiche distinte: quellamaggioritaria, che impone di «correre» insieme presentando candidature comuni;quella proporzionale, che premia chi «corre» da solo.
2 In proposito, A. DI VIRGILIO, Uniti si vince? Voto e politica delle alleanze, in ilMulino, 2001, n. 4, p. 637, parla di «alleanze a geografia variabile». Secondo C. FU-SARO, Le regole, cit., p. 108, questa scelta è giustificata dall’interesse comune di con-quistare il maggior numero di consensi senza perderne a causa di un’alleanza sgraditaai rispettivi elettorati.
3 In proposito A. LEVI, La Seconda Repubblica in movimento, in il Mulino, 1994,n. 3, p. 445, parla della nascita di una «Italia bipolare», nella quale, però, sembra af-
194 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
Le elezioni del 1994 hanno visto l’affermazione dello schie-ramento di centro-destra (sebbene non avesse la maggioranza alSenato4) e la nascita di un Governo presieduto da Silvio Berlu-sconi. Ma il primo Governo nato da elezioni svolte con un si-stema elettorale maggioritario ha avuto vita breve: nel dicembredel 1994 è stata presentata una mozione di sfiducia (sottoscrittaanche dalla Lega nord, uno dei partiti della maggioranza) che haportato alla caduta del Governo Berlusconi I5. I partiti che ave-vano contribuito alla caduta del Governo, inoltre, nonostante ladiscussione sulla necessità di tornare rapidamente alle urne, ave-vano una consistenza parlamentare sufficiente ad impedire loscioglimento anticipato delle Camere e a sostenere un nuovo Go-verno. Grazie all’impulso del Presidente della Repubblica, infatti,nasceva un Governo “tecnico”, presieduto da Lamberto Dini6. Lanascita di un nuovo Governo in corso di legislatura è un chiaroindice del mancato passaggio ad un sistema maggioritario, per-ché, in un sistema maggioritario, la caduta del Governo presie-duto dal leader dello schieramento che ha vinto le elezioni do-vrebbe portare allo scioglimento delle Camere. Nel 1995, invece,
fermarsi «un “bipolarismo imperfetto”, dove ognuno dei due “poli” porta dentro di séforti contraddizioni, che ne indeboliscono la coesione». Secondo S. CECCANTI, Riformeistituzionali: passato e futuro, in il Mulino, 1994, n. 5, p. 839, il sistema politico italianosi mette «in cammino verso il bipolarismo». Nello stesso senso A. BARBERA, La formadi governo in transizione, in Quaderni costituzionali, 1995, n. 2, p. 212: «tra le elezionipolitiche del marzo 1994 e le regionali del 1995 abbiamo assistito ad una crisi proba-bilmente definitiva dei tentativi di resurrezione di un “terzo polo” centrista e ad un’ac-celerazione della bipolarizzazione». Tale tendenza è stata confermata anche nelle ele-zioni successive: cfr. S. SICARDI, Maggioranza, cit., p. 111.
4 Tuttavia, secondo C. FUSARO, Le regole, cit., pp. 117-118, la mancanza di unamaggioranza al Senato non sarebbe stata la causa preminente della caduta del Go-verno.
5 Secondo A. MANZELLA, La forma di governo in transizione, in Quaderni costitu-zionali, 1995, n. 2, p. 231, la caduta del Governo rappresenterebbe una delle grandidelusioni del maggioritario, perché paleserebbe il mancato raggiungimento dell’obiet-tivo della governabilità.
6 Un Governo che R. CHERCHI, Le crisi di Governo tra Costituzione ed effettività,in www.costituzionalismo.it, 12 settembre 2011, p. 8 non num., definisce anche “ditregua”.
195L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
il Presidente della Repubblica, consentendo la nascita del Go-verno Dini, non ha certo favorito la transizione alla democraziamaggioritaria7. Inoltre, il nuovo Esecutivo è nato con l’appoggiodelle forze politiche uscite sconfitte dalle precedenti elezioni e diuno dei partiti della precedente maggioranza, dando luogo al fe-nomeno del c.d. ribaltone, che ha influito sia sul dibattito politicodegli anni successivi sia sulle riforme costituzionali8.
Le vicende della prima legislatura maggioritaria evidenzianoil mancato passaggio ad un sistema di tipo maggioritario, anchese gli effetti di un sistema elettorale non possono essere valutatinel breve periodo9. Le nuove leggi elettorali, comunque, hannoprodotto sin dalle prime elezioni effetti considerevoli sul sistemapolitico: la nascita di FI, la “svolta” del MSI, trasformatosi – nel1994 – in Alleanza nazionale-AN10, la collocazione del Partito po-
7 Si v., in proposito, le osservazioni di C. CHIOLA, Presidente, cit., part. p. 116,che parla di linea “continuista” seguita dal Presidente Scalfaro. Secondo S. BARTOLE,La forma di governo in transizione, in Quaderni costituzionali, 1995, n. 2, p. 253, il Pre-sidente della Repubblica si era ritagliato un ruolo di garanzia e di indirizzo in attesache il quadro politico finisse di stabilizzarsi; secondo G. PASQUINO, Parlamento, cit.,pp. 18-19, invece, il Governo Dini «sembrò contenere elementi, con ogni probabilitànon voluti dal Presidente [della Repubblica], di semi-presidenzialismo. Infatti, il Go-verno Dini dipendeva quasi allo stesso modo dal sostegno esplicito del Presidente edalla fiducia del Parlamento». Si rinvia, infine, alle osservazioni di L. ARCIDIACONO, Re-lazione, cit., pp. 23 ss., sui principî che giustificherebbero il ritorno a nuove elezioni incaso di rottura della coalizione che ha vinto elezioni maggioritarie, e a quelle di diversotenore di L. VENTURA, Ordinamento, cit., pp. 61 ss. Si v., infine, il “confronto” tra E.BALBONI, Scalfaro e la transizione: ha fatto quel che doveva, in Quaderni costituzionali,1999, n. 2, pp. 390 ss., e C. FUSARO, Scalfaro e la transizione: non ha fatto quel che po-teva, ivi, pp. 396 ss.
8 Si pensi alla l. cost. 1/1999 e alla forma di governo regionale basata sull’ele-zione diretta del Presidente della Giunta con conseguente applicazione del principioaut simul stabunt aut simul cadent, che rappresenta il meccanismo “antiribaltone” pereccellenza.
9 Invero, le elezioni del 1994 non possono essere considerate indicative perché,come ricorda A. DI VIRGILIO, Uniti, cit., p. 637, rappresentano la «prima volta delnuovo sistema elettorale» e si svolgono in un contesto di volatilità elettorale e di mu-tamento partitico.
10 Un mutamento analogo si era già avuto nel 1991 con l’altro partito anti-si-stema della storia repubblicana italiana: il PCI, trasformatosi in PDS (in seguito Demo-
196 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
polare-PPI all’interno dello schieramento di centro-sinistra, in-fatti, sono tutti elementi che indicano un riallineamento del si-stema politico italiano in senso bipolare e maggioritario, in attesadi un completo passaggio ad un sistema maggioritario11.
2.1.2. La XIII legislatura
Nelle successive elezioni del 1996 si è assistito al successodella coalizione di centro-sinistra e alla nascita di un Governopresieduto da Romano Prodi. Questa affermazione elettorale èparsa rappresentare un passo in avanti nella transizione italiana,in particolare perché comincia a delinearsi l’alternanza al Go-verno fra opposti schieramenti12. Il passaggio ad un sistema mag-gioritario, tuttavia, risulta ancora incompleto: le nuove leggi elet-torali non sono riuscite a ridurre la frammentazione dei partiti; ipoli non hanno raggiunto un sufficiente grado di coesione in-terna13; la mobilità parlamentare è stata particolarmente ele-vata14. Nella XIII legislatura, inoltre, si sono succeduti quattro
cratici di sinistra-DS), con la contestuale nascita del Partito della rifondazione comu-nista-PRC.
11 In questo senso C. FUSARO, Le regole, cit., pp. 122-123. Si v. anche M. MAZ-ZOLENI, I sistemi partitici regionali in Italia dalla prima alla seconda Repubblica, in Rivi-sta italiana di scienza politica, 2002, n. 3, p. 468.
12 La “messa in moto” del meccanismo dell’alternanza di governo fra oppostischieramenti sarebbe stato l’unico risultato di grande importanza ottenuto nelle ele-zioni del 1996 secondo M.L. SALVADORI, Breve storia della lunga transizione, in il Mu-lino, 1998, n. 5, p. 864.
13 Si v. le osservazioni di G. PITRUZZELLA, Forme, cit., p. 149, e G. BOCCACCINI,Più partiti in nome del bipartitismo, in Quaderni costituzionali, 2000, n. 3, p. 631.
14 Come ricorda L. VERZICHELLI, Cambiare casacca, o della fluidità parlamentare,in il Mulino, 2000, n. 2, p. 274, il fenomeno del transfughismo parlamentare, già par-ticolarmente rilevante durante la XII legislatura, è stato ancora più evidente nella XIIIlegislatura. Su tale fenomeno si rinvia anche a L. STROPPIANA, La riforma dei regola-menti parlamentari: un processo non ancora concluso?, in Quaderni costituzionali, 2000,n. 1, part. pp. 114-116, L. BEDINI, Disincentivi regolamentari alla mobilità parlamen-tare, in Quaderni costituzionali, 2000, n. 2, pp. 408-410, A. MANNINO, L’abuso della mo-bilità parlamentare: ripensare il divieto del mandato imperativo, in Quaderni costituzio-nali, 2001, n. 1, pp. 135-137, e N. ZANON, Il transfughismo parlamentare: attenti a toc-care quel che resta del libero mandato, ivi, pp. 137-140.
197L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
Governi, perché, dopo quello presieduto da Romano Prodi e ca-duto in seguito alla reiezione di una questione di fiducia15, sisono avuti due Esecutivi presieduti da Massimo D’Alema e unoguidato da Giuliano Amato. Questi fattori, complessivamenteconsiderati, evidenziano il mancato raggiungimento degli obiet-tivi che si auspicava di conseguire grazie alla riforma elettorale.
2.1.3. La XIV legislatura
Le elezioni del 2001 vedono una classe politica ormai pre-parata alla competizione secondo le regole delle nuove leggi elet-torali: entrambe le coalizioni, ad esempio, sfruttano le c.d. listecivetta, oppure inseriscono il nome del candidato premier sullascheda elettorale16. Le elezioni del 13 maggio 2001 sono vintenuovamente dal centro-destra e la netta maggioranza ottenutadalla coalizione proietta il suo leader, Berlusconi, alla guida del-l’Esecutivo17. Il Governo così costituito non vive una legislatura
15 Come ricorda M. VOLPI, La natura della forma di governo dopo il 1994, inAA.VV., Annuario 2001, cit., p. 163, quella del Governo Prodi I era stata, sino a quelmomento, «l’unica autentica crisi parlamentare verificatasi nella storia repubblicana».Questo ed altri episodi delle legislature maggioritarie – tra cui la già ricordata sfiduciaindividuale al ministro Mancuso – hanno indotto M. OLIVETTI, Le dimissioni del Go-verno Prodi e la formazione del Governo D’Alema. Cronaca di una crisi annunciata, inGiurisprudenza costituzionale, 1998, n. 5, pp. 2998-2999, a rilevare «il paradosso percui gli istituti del parlamentarismo razionalizzato hanno conosciuto una inattesa fiori-tura proprio nella fase di maggiore crisi della forma di governo parlamentare». Sullatravagliata esistenza del Governo Prodi I appare utile un rinvio anche a M. OLIVETTI,Le dimissioni rientrate del Governo Prodi, in Giurisprudenza costituzionale, 1997, n. 5,pp. 3141 ss.
16 Cfr., in questo senso, le osservazioni di A. DI VIRGILIO, Uniti, cit., p. 641, maanche M. GORLANI, Le elezioni del 13 maggio 2001, in A. D’ANDREA (a cura di), Lo svi-luppo bipolare della forma di governo italiana, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 204 ss.
17 Come ricorda M. OLIVETTI, La transizione continua, in Quaderni costituzionali,2001, n. 3, p. 621, nell’attribuzione dell’incarico di formare il Governo, sono state con-fermate le «regole convenzionali forgiate dalla prassi degli anni della proporzionale econformi alla logica della democrazia “mediata”». Su queste regole, però, si è sovrap-posto l’effetto maggioritario prodotto dalla legge elettorale: la chiara affermazione elet-torale ha posto il leader della coalizione vincente (il cui nome era indicato nel simbolodella coalizione presentato nei collegi uninominali di Camera e Senato) in una posi-zione particolare, «quasi di Primo ministro eletto».
198 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
semplice: la maggioranza di governo non è coesa e si succedono,in realtà, due Governi presieduti sempre dal leader del centro-destra18. La coalizione che ha vinto le elezioni, tuttavia, riesce agovernare praticamente per l’intera legislatura, mantenendo allaPresidenza del Consiglio lo stesso premier, tanto da essere ingrado di approvare anche la – particolarmente controversa –riforma della Parte II della Costituzione19. Nella XIV legislatura,quindi, si assiste ad una sorta di stabilizzazione del sistema mag-gioritario: come era già accaduto in quella precedente, la legisla-tura ha una durata “fisiologica”, e, in più, per l’intera legislaturail ruolo di Presidente del Consiglio è ricoperto dal leader dellacoalizione che ha vinto le elezioni.
Nonostante questo ulteriore passaggio nella stabilizzazionein senso maggioritario del sistema politico, la maggioranza protempore, data sfavorita nei sondaggi per le imminenti elezioni,modifica nuovamente il sistema elettorale, con la già citata l.270/2005.
2.1.4. La XV legislatura
Anche con tale riforma, tuttavia, la tendenza maggioritaria èparsa confermata. Alle elezioni del 2006, infatti, le forze politi-che si sono consolidate sostanzialmente in due schieramenti con-trapposti, i cui leaders erano considerati alla stregua di veri epropri candidati alla carica di Presidente del Consiglio. Perquanto riguarda il risultato delle elezioni, gli elettori hanno nuo-vamente punito la maggioranza uscente, favorendo l’alternanzaal Governo e la vittoria dello schieramento di centro-sinistra.
18 Nel passaggio tra i due Governi, tuttavia, si sarebbe «infranto il sogno del bi-polarismo italiano come forma realizzata di democrazia maggioritaria», secondo O.MASSARI, La crisi di governo e il bipolarismo difettoso, in il Mulino, 2005, p. 442.
19 Si tratta del progetto (A.S. 2544-D, XIV legislatura) approvato dalla sola mag-gioranza di centro-destra e bocciato dal referendum costituzionale del 25 e 26 giugno2006. Su questo discusso progetto di riforma ci si limita a rinviare a L. ELIA, La Costi-tuzione aggredita, Bologna, il Mulino, 2005, e F. BASSANINI (a cura di), Costituzione:una riforma sbagliata, Firenze, Passigli, 2005.
199L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
Tuttavia, come era stato paventato sin dai primi commenti allanuova legge elettorale, mentre il premio di maggioranza a livellonazionale ha attribuito alla coalizione vincente una chiara mag-gioranza alla Camera, al Senato lo schieramento di centro-sini-stra ha potuto contare su una maggioranza assai risicata, con leconseguenti difficoltà in termini di governabilità e la necessità diricorrere frequentemente alla questione di fiducia20. Il GovernoProdi II, infatti, è caduto – dopo il voto contrario del Senato suuna risoluzione sulla quale era stata posta la questione di fiducia– nel gennaio 2008.
Il Presidente della Repubblica, dopo aver constatato l’im-possibilità di formare un nuovo Governo quantomeno al fine diapprovare una nuova legge elettorale, scioglieva le Camere21, po-nendo termine ad una legislatura di breve durata, che offre co-munque alcuni spunti sugli effetti delle riforme elettorali mag-gioritarie.
La XV legislatura, infatti, ha confermato il rilievo del leaderdi coalizione destinato – in caso di affermazione elettorale delproprio schieramento – a ricoprire la carica di Presidente delConsiglio. Si tratta di un rilievo che pare ulteriormente raffor-zato dalla impossibilità di sostituirlo con un’altra personalità po-litica al fine di formare un nuovo Esecutivo in caso di crisi di go-verno. La legislatura, tuttavia, pone anche in evidenza i limitidelle riforme maggioritarie. Le vicende della XV legislatura, in-fatti, confermano che le leggi elettorali maggioritarie favorisconouna “artificiosa” aggregazione dei partiti in grandi coalizionielettorali, che, però, si sfaldano dopo le elezioni, minando l’effi-cacia dell’azione di governo e la tenuta stessa degli Esecutivi.
20 Occorre osservare, peraltro, che, anche dopo le prime elezioni maggioritarie,nel 1994, la coalizione che aveva vinto le elezioni, quella di centro-destra, si dovevaconfrontare con difficoltà analoghe al Senato.
21 Sulla caduta del Governo Prodi II e per un parallelo con il Governo Berlu-sconi IV si v. N. MACCABIANI, Il ruolo del Presidente della Repubblica a fronte delle dif-ficoltà interne alle maggioranze parlamentari di centro-sinistra e di centro-destra durantela XV e la XVI legislatura, in www.rivistaic.it, 18 gennaio 2011, pp. 1 ss.
200 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
2.1.5. La XVI legislatura
Nel 2008 le elezioni si sono svolte sulla base di un quadropartitico che appariva semplificato: il centro-destra era compostoessenzialmente dal Popolo delle libertà-PDL (nel quale eranoconfluiti FI e AN) e dalla Lega nord, il centro-sinistra vedeva l’al-leanza tra Partito democratico-PD (nel quale erano confluiti i DS
e la Margherita) e Italia dei valori-IDV, mentre l’Unione di cen-tro-UDC si presentava da sola, al di fuori della logica bipolare22.Le elezioni hanno visto la netta affermazione della coalizione dicentro-destra, il che, tra l’altro, ha permesso un iter di forma-zione del nuovo Governo particolarmente celere. Nonostanteciò, la maggioranza parlamentare non ha brillato per la sua coe-sione, scontando ben presto le conseguenze delle frizioni tra ilprincipale partito della coalizione, il PDL, e la Lega nord. I mag-giori problemi politici per la tenuta della maggioranza, tuttavia,sono derivati dal dissidio tra i due co-fondatori del PDL, il leaderdella coalizione e Presidente del Consiglio dei ministri SilvioBerlusconi e il presidente della Camera dei deputati GianfrancoFini, che erano stati anche i leaders dei due partiti confluiti nelPDL. Tale scontro ha avuto il suo esito nel 2010 con la fuoriuscitadal PDL del presidente della Camera dei deputati e di un gruppodi parlamentari poi confluiti nei nuovi gruppi parlamentari diFuturo e libertà per l’Italia-FLI, schierati all’opposizione e alleaticon l’UDC e l’Alleanza per l’Italia-API nel c.d. Terzo polo23.
22 Ma, come osservano S. BARTOLINI, A. CHIARAMONTE, R. D’ALIMONTE, Maggio-ritario finalmente? Il bilancio di tre prove, in S. BARTOLINI, R. D’ALIMONTE (a cura di),Maggioritario finalmente?, Bologna, il Mulino, 2002, p. 365, dopo le prime tre elezionimaggioritarie, «[d]i elezione in elezione le due coalizioni di centro-destra e di centro-sinistra hanno assunto un ruolo e una visibilità tali da renderle chiaramente identifica-bili come le sole credibili alternative di governo».
23 Anche nella XVI legislatura il fenomeno della mobilità parlamentare è statoparticolarmente evidente: oltre a FLI e API, gruppi parlamentari aggregatisi intorno adue parlamentari che, in precedenza, erano importanti esponenti del centro-destra edel centro-sinistra (rispettivamente Gianfranco Fini e Francesco Rutelli), si consideri,ad es., la formazione dei gruppi parlamentari Iniziativa responsabile e Coesione nazio-nale, che, composti di parlamentari di varia provenienza politica, hanno sostenuto ilGoverno Berlusconi IV sino alle dimissioni dell’allora premier.
201L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
Dopo varie vicissitudini, l’aggravarsi della crisi economico-finanziaria internazionale e il suo impatto sulla tenuta dei contipubblici italiani hanno condotto alla crisi del Governo Berlu-sconi IV, con modalità piuttosto atipiche. Infatti, l’8 novembre2011 il Presidente del Consiglio, dopo un vertice con esponentidel Governo e della maggioranza, si recava al Quirinale. Al ter-mine dell’incontro con il Capo dello Stato, una nota della Presi-denza della Repubblica comunicava che il Presidente del Consi-glio annunciava l’intenzione di dimettersi, ma solo dopo l’appro-vazione della legge di stabilità24. Agli organi di informazione ilpremier ribadiva l’impegno a dimettersi, la volontà di non candi-darsi alle elezioni successive e la convinzione che la soluzionedella crisi di governo consistesse nel ritorno alle urne.
Nonostante il paventato ritorno alle elezioni come soluzionepropria della crisi di un “Governo maggioritario”, dopo le di-missioni del Presidente del Consiglio “indicato” in campagnaelettorale si è avuta la formazione di un nuovo Governo, “tec-nico”, presieduto da Mario Monti, nato secondo modalità pecu-liari almeno quanto quelle relative alle dimissioni di Berlusconi.A tale riguardo, sia sufficiente considerare che il Presidente dellaRepubblica ha dovuto trovare – seppure informalmente – unasoluzione alla crisi di governo prima ancora che essa si aprisseformalmente con le dimissioni del Governo in carica. Senza po-ter ripercorrere in questa sede tutti i passaggi che hanno portatoalla nascita del Governo Monti25, è opportuno evidenziare alcuni
24 Il comunicato può leggersi in www.quirinale.it.25 In questa sede non è possibile ricostruire nel dettaglio i singoli aspetti della
crisi di governo della XVI legislatura; in proposito si rinvia a A. RUGGERI, Art. 94 dellaCostituzione vivente: “Il Governo deve avere la fiducia dei mercati” (nota minima a com-mento della nascita del Governo Monti), in www.federalismi.it, 23 novembre 2011, pp.1 ss., I. NICOTRA, Il Governo Monti (Napolitano): l’Unione europea e i mercati finanziarispingono l’Italia verso un semipresidenzialismo mite, in www.federalismi.it, 14 dicem-bre 2011, pp. 1 ss., D. PICCIONE, Anatomia di una crisi di governo, in Rassegna parla-mentare, 2011, n. 4, pp. 925 ss., N. MACCABIANI, M. FRAU, E. TIRA, Dalla crisi del IVGoverno Berlusconi alla formazione del I Governo Monti, in www.rivistaic.it, 22 feb-braio 2012, pp. 1 ss., e M. OLIVETTI, Governare con l’aiuto del presidente, in il Mulino,2012, n. 2, pp. 233 ss.
202 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
aspetti che differenziano le vicende della XVI legislatura dal mo-dello della c.d. democrazia maggioritaria.
Innanzitutto, il Governo Monti non deve la sua investituraall’esito delle elezioni, perché si tratta di un Governo “tecnico”,ovvero composto di tecnici e funzionari non eletti in Parla-mento26. Per la nascita di tale Governo, infatti, non è stato de-terminante il risultato elettorale, bensì – in un momento partico-larmente delicato per il Paese – l’operato del Presidente dellaRepubblica, che ha dovuto tenere conto delle pressioni interna-zionali, dell’Unione europea e dei mercati finanziari. Il nuovoEsecutivo, inoltre, ha ottenuto l’appoggio della maggior partedelle forze politiche presenti in Parlamento e, in particolare, deiprincipali partiti delle due coalizioni politiche confrontatesi nelleprecedenti elezioni (il PD e il PDL), che, dunque, hanno tempo-raneamente abbandonato l’atteggiamento di radicale contrappo-sizione che ha caratterizzato i rapporti tra i due schieramentinelle legislature maggioritarie27.
La XVI legislatura ha peraltro confermato tutti i limiti del-l’attuale assetto “maggioritario”: la scarsa coesione della maggio-ranza parlamentare, che ha indotto il Governo Berlusconi IV alsistematico ricorso al binomio decretazione d’urgenza-questionedi fiducia, nonostante l’ampia maggioranza ottenuta in seguitoalle elezioni del 2008; la ridotta efficacia dell’azione del Go-verno, il quale, soprattutto dal 2010, è parso del tutto incapacedi far fronte alla crisi economico-finanziaria; l’accentuata mobi-lità parlamentare.
Si tratta di caratteristiche tutt’altro che inedite nelle legisla-ture del maggioritario, le cui caratteristiche è a questo punto op-portuno riassumere.
26 … fa eccezione proprio il Presidente del Consiglio, nominato senatore a vitaex art. 59, co. 2, Cost. dal Presidente della Repubblica pochi giorni prima di riceverel’incarico di formare il nuovo Esecutivo.
27 All’opposizione, invece, si sono posizionate le due forze politiche “minori”dei due schieramenti: Lega nord e IDV.
203L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
2.1.6. Il sistema partitico nelle legislature maggioritarie: una valu-tazione di sintesi
Volendo considerare complessivamente le modificazione delsistema politico dopo le riforme elettorali maggioritarie, si puòevidenziare in primo luogo che i partiti politici si sono dislocatisull’asse destra-sinistra, creando un sistema partitico sostanzial-mente bipolare28. In secondo luogo, tutte le forze politiche pos-sono aspirare a guidare il Paese, senza la possibilità di mantenerealcuna conventio ad excludendum29, considerata anche la scom-parsa del partito che aveva costantemente governato il Paese –seppure coalizzato con altre formazioni politiche – prima del1993, la DC. Inoltre, si sono formati schieramenti partitici alter-nativi, che si presentano uniti (almeno) alle elezioni e sono ingrado di sottoporre al corpo elettorale un programma condiviso,nonché un candidato – di fatto – alla Presidenza del Consiglio30.
28 Secondo T. GROPPI, Forma, cit., p. 16, anzi, «la tendenza alla bipolarizzazioneè risultata enfatizzata» dalla legge elettorale del 2005, mentre M. OLIVETTI, Appuntisulle trasformazioni della forma di governo italiana, in Il Filangieri, Quaderno 2006, p.108, parla di «bipolarizzazione della competizione politica, ormai quasi perfetta, nelsenso che non esistono soggetti esterni alle coalizioni». Si rinvia anche alle analisi di A.PAPPALARDO, Il sistema partitico italiano fra bipolarismo e destrutturazione, in G. PA-SQUINO (a cura di), Dall’Ulivo al governo Berlusconi, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 199ss., e A. D’ANDREA, Considerazioni sull’evoluzione del bipolarismo nel sistema di go-verno in Italia, in ID. (a cura di), Lo sviluppo, cit., pp. 329 ss.
29 Sebbene entrambi gli schieramenti puntino a delegittimarsi vicendevolmente,come osservano M. VOLPI, La natura, cit., p. 157, e S. SICARDI, Maggioranza, cit., p.148, giustificando la definizione dell’attuale sistema politico italiano come “bipolari-smo rusticano”, nella riuscita immagine di A. BARBERA, Sussidiarietà e bipolarismo“mite”, Relazione al Convegno promosso dall’Intergruppo parlamentare per la sussi-diarietà, Sala Zuccari - Senato della Repubblica, 29 marzo 2007, in www.forumcostitu-zionale.it. Come osserva R. CHERCHI, Il governo, cit., pp. 52 ss., la carenza di reciprocoaffidamento tra i soggetti politici è uno dei sintomi della torsione decisionista della cul-tura politica, contribuendo alla destabilizzazione delle convenzioni costituzionali.
30 Così A. BARBERA, Quattro domande dopo il referendum elettorale, in Quadernicostituzionali, 2000, n. 3, p. 626. Come osserva S. SICARDI, Maggioranza, cit., p. 119,nonostante le due coalizioni non siano caratterizzate da grande coesione, quella di «unconfronto bipolare tra due schieramenti in lizza per ottenere la maggioranza ed espri-mere il governo (…) è l’immagine che è stata veicolata dai media e crescentemente
204 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
Infine, è aumentato il tasso di responsabilità politica, tanto chealle elezioni sono puntualmente “puniti” i partiti che hanno co-stituito la maggioranza di governo uscente31.
Ciò che non è cambiato, invece, è rappresentato dall’ineffi-cacia dell’azione di Governo, dalla scarsa coesione degli schiera-menti politici in Parlamento e dall’alto numero delle forze politi-che presenti in Parlamento32. Per ottenere una riduzione del nu-mero dei partiti, infatti, oltre alla riforma elettorale, sarebbenecessaria anche una riforma dei regolamenti parlamentari volta,innanzitutto, ad aumentare il numero di membri delle Camerenecessari per la costituzione di un gruppo parlamentare, con la
percepita dagli elettori». Sull’equilibrio instabile nel quale convivono partiti e coali-zioni si v. R. D’ALIMONTE, Italy: A Case of Fragmented Bipolarism, in M. GALLAGHER,P. MITCHELL (eds.), The Politics, cit., pp. 269 ss. Appare utile rinviare al concetto di“accordo di coalizione” ricostruito da M. CARDUCCI, L’accordo, cit., e, in particolare,alla distinzione tra coalizioni “pre-elettorali” e coalizioni “governative-parlamentari”(pp. 40 ss.); si v. anche R. CHERCHI, Il governo, cit., pp. 193 ss.
31 Con specifico riferimento alle elezioni del 1996, G. PITRUZZELLA, Forme, cit.,p. 37, osserva: «gli elettori hanno potuto trasformare in voto il giudizio sul rendimentodi un governo, e del suo leader, precedente». L. ELIA, L’evoluzione della forma di go-verno, in AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. II, cit., p. 254, osservava: «L’e-sperienza di tre elezioni (1994, 1996, 2001) dimostra che le leggi elettorali del ’93adempiono al loro ufficio di favorire l’avvicendamento di formazioni politiche diverseal governo (…)». Si v. anche S. PRISCO, «Il Governo di coalizione» rivisitato, ivi, vol. III,pp. 205-206. Appare utile, infine, rinviare all’analisi delle modificazioni del comporta-mento elettorale in Italia, comparato con analoghe esperienze straniere, svolta da R.W.RONZA, Dalle appartenenze subculturali al mercato elettorale: il dibattito sui paradigmiinterpretativi del comportamento di voto in Italia, Sudafrica e Canada, in Rivista italianadi scienza politica, 2007, n. 2, pp. 175 ss.
32 Come osserva T. GROPPI, Forma, cit., p. 16, infatti, anche con la l. 270/2005 «ècontinuata la tendenza alla frammentazione delle forze politiche». Secondo S. LA-BRIOLA, Per una storia breve di un lungo decennio, in www.costituzionalismo.it, 11 otto-bre 2004, p. 4 non num., peraltro, l’aumento del numero dei partiti rende di fatto «il-lusorio l’approdo al bipolarismo». La frammentazione partitica e la delegittimazione re-ciproca dei due schieramenti giustificherebbero la definizione del bipolarismo italianocome “imperfetto” secondo M. VOLPI, La natura, cit., pp. 156-157. Si v. anche le osser-vazioni di S.M. CICCONETTI, Il mutamento di fatto della forma di governo italiana, inAA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. II, cit., pp. 14 ss., e quelle di L. CARLAS-SARE, Maggioritario, in www.costituzionalismo.it, 23 aprile 2008, pp. 1 ss., sugli obiettividichiarati e quelli effettivamente perseguiti con l’introduzione del maggioritario.
205L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
conseguente riduzione di risorse e “visibilità” per i gruppi mi-nori. Senza una riforma in tale senso, infatti, le forze politiche diminori dimensioni possono presentarsi unite alle elezioni, al finedi superare le soglie di sbarramento previste dalla legge eletto-rale, ma possono tornare a dividersi immediatamente dopo leelezioni, costituendo autonomi gruppi parlamentari all’internodelle Assemblee33.
Inoltre, anche se il sistema partitico è stato profondamentemodificato dalle riforme elettorali, l’assetto costituzionale conti-nua a vivere una intensa fase di instabilità e transizione dellaquale tuttora non si riesce ad intravedere la conclusione34. Sitratta di una constatazione che appare per certi versi ovvia, se siconsidera che le riforme elettorali sono state utilizzate alla streguadi surrogati di riforme costituzionali sulle quali le forze politichenon sono riuscite a trovare soluzioni condivise35. In tutte le legi-
33 Secondo S. MANGIAMELI, La forma, cit., pp. 40-41, tuttavia, la riduzione delnumero di partiti si sarebbe potuta ottenere già con i sistemi elettorali del 1993 attra-verso una scelta convenzionale dei partiti maggiori dei due schieramenti di non allearsicon i partiti minori; questa convenzione politica, infatti, avrebbe portato nel medio pe-riodo a far concentrare i voti degli elettori solo sugli schieramenti maggiori. Si v., inproposito, le osservazioni di A. LIJPHART, Patterns, cit., pp. 185-186, e L. PRIMICERIO,Forma, cit., pp. 77-78, – che richiamano M. DUVERGER, Political Parties: Their Organi-zation and Activity in the Modern State, 3ª ed., London, Methuen, 1964, pp. 217 ss. –sui fattori meccanici e psicologici che concorrono a ridurre il peso politico dei partitidi minori dimensioni. Si rinvia, inoltre, alle considerazioni di M. VOLPI, La natura, cit.,p. 174, sulla «attitudine “schizofrenica”» di Parlamento e mondo politico in merito aiprovvedimenti da assumere per ridurre il numero di partiti.
34 Appaiono ancora attuali, a tal riguardo, le affermazioni di M. OLIVETTI, Latransizione, cit., p. 622: «la fase più problematica della transizione italiana, rappresen-tata dalla vera e propria crisi di sistema (in senso espositiano) degli anni 1992-96, èstata superata, ma il sistema istituzionale non si è del tutto assestato su linee nuove, siaper la forma di Governo, sia per il rapporto Stato-autonomie». Nello stesso senso M.VOLPI, La natura, cit., pp. 172 ss., ma anche G. RIVOSECCHI, I poteri ispettivi e il con-trollo parlamentare: dal question time alle Commissioni di inchiesta, in E. GIANFRANCE-SCO, N. LUPO (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggio-ranza e opposizione, Roma, Luiss University Press, 2007, pp. 162-163.
35 Secondo T. GROPPI, Forma, cit., pp. 17-18, in effetti, «[e]mergono (…) tutti ilimiti dell’esperienza italiana degli ultimi 15 anni, che ha visto l’uso della legislazioneelettorale come strumento per razionalizzare la forma di governo. Se ne comprendono
206 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
slature successive al 1993, infatti, sono state ipotizzate importantiriforme della Parte II della Costituzione, che – eccezion fatta perla riforma del Titolo V – non si sono mai concretizzate, ancheperché il radicale scontro tra i due principali schieramenti parti-tici ha impedito ogni ipotesi di riforma condivisa36. Invero, se si
le ragioni pratiche, in quanto è assai più facile modificare la legge elettorale, a mag-gioranza semplice in Parlamento, o con referendum abrogativo, che modificare la Co-stituzione. Si tratta, però, di uno strumento non solo inadeguato, ma anche improprio:privilegiando le esigenze della governabilità su quelle della rappresentanza proprio nelmomento più importante di espressione della volontà popolare, le elezioni politiche, sirischia di accentuare la distanza tra elettori ed eletti e la sfiducia dei cittadini per la po-litica e le istituzioni, accrescendo l’apatia e la disaffezione al voto. Questo è un rischioche nessun sistema democratico può permettersi di correre, nemmeno in nome dellamitica “governabilità”».
36 In proposito ci si limita a ricordare: l’istituzione, nella XII legislatura, di uncomitato (c.d. Comitato Speroni) con il compito di studiare ed elaborare proposte diriforme istituzionali ed elettorali, nonché di revisione costituzionale, sul quale si rinviaa S. TROILO, Alla continua ricerca della governabilità: la forma di governo proposta dal«Comitato Speroni», in Quaderni costituzionali, 1996, n. 3, pp. 517 ss.; nella XIII legi-slatura, l’istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali(c.d. Commissione D’Alema, istituita con la l. cost. 1/1997), al fine di elaborare pro-getti di revisione della Parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma diStato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie (sulla quale si v. V.ATRIPALDI, R. BIFULCO (a cura di), La Commissione parlamentare per le riforme costitu-zionali della XIII legislatura, Torino, Giappichelli, 1998, e P. COSTANZO, G.F. FERRARI,G.G. FLORIDIA, R. ROMBOLI, S. SICARDI (a cura di), La Commissione bicamerale per leriforme costituzionali. I progetti, i lavori, i testi approvati, Padova, Cedam, 1998); nellaXIV legislatura, il tentativo di riforma della Parte II della Costituzione ricordato pocosopra; nella XVI legislatura, infine, si consideri il c.d. ABC costituzionale, ovvero ilprogetto di riforma costituzionale identificato con le iniziali dei segretari dei tre mag-giori partiti che hanno garantito il sostegno al Governo Monti: Alfano per il PDL, Ber-sani per il PD, Casini per l’UDC. Su tale progetto (“Testo unificato proposto dal rela-tore per i disegni di legge costituzionale n. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589,1590, 1761, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252”, A.S., XVI legislatura, I Commis-sione permanente), si v., per l’iter parlamentare, F. PARMIGIANI, Il rapido iter di appro-vazione delle proposte di revisione costituzionale al vaglio della Commissione Affari co-stituzionali del Senato, in www.rivistaic.it, 12 giugno 2012, pp. 1 ss., per un’analisi cri-tica del testo, M. OLIVETTI, Il vestito di Arlecchino, in www.federalismi.it, 2 maggio2012, pp. 1 ss., G. FERRARA, Editoriale, in www.costituzionalismo.it, 10 maggio 2012,pp. 1 ss., L. CARLASSARE, A proposito di riforme, in www.rivistaic.it, 22 maggio 2012,pp. 1 ss., e G. AZZARITI, A proposito della riforma costituzionale, ivi, 24 maggio 2012,pp. 1 ss.
207L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
osserva il costante ma fallimentare tentativo di condurre in portouna riforma ampia e incisiva della Costituzione da parte di en-trambi gli schieramenti politici, si ha la sensazione che si sia ormaipassati dalla “illusione” alla “sindrome” della grande riforma37.
Gli accadimenti della XVI legislatura, dunque, sembranomanifestare l’inutilità di attendere ulteriormente il (solo ipotetico)completamento della transizione alla democrazia maggioritaria38.Infatti, se il principale obiettivo delle riforme elettorali maggiori-tarie doveva essere quello di garantire l’efficacia dell’azione di go-verno39, tale obiettivo non appare affatto raggiunto. Al contrario,la grave crisi economico-finanziaria internazionale manifestatasidurante la XVI legislatura si è innestata sulle irrisolte inefficienzedel sistema politico e istituzionale, alimentando la sfiducia dell’o-pinione pubblica nei confronti della classe politica e offrendo lapercezione di un sistema la cui crisi richiama, per certi versi,quella che ha condotto alla riforma elettorale del 199340.
37 Si riprendono le espressioni di V. ATRIPALDI, L’illusione della «GrandeRiforma», in Diritto e cultura, 2002, n. 1/2, pp. 3 ss., e A. D’ATENA, La revisione dellaCostituzione tra maggioritario e sindrome della grande riforma, in Diritto e società,2011, n. 1, pp. 23 ss.
Sul margine di manovra per le possibili riforme costituzionali riguardanti laforma di governo italiana si v. M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia del di-ritto, Annali, vol. III, Milano, Giuffrè, 2010, part. pp. 588 ss.
38 Riprendendo le parole di G. DE VERGOTTINI, L’evoluzione del sistema politico-istituzionale, in www.federalismi.it, 4 maggio 2011, p. 16, si tratterebbe di una «transi-zione senza esito».
39 Paiono, dunque, da condividere le osservazioni di P. CARETTI, Principio mag-gioritario e democraticità del sistema costituzionale, in www.costituzionalismo.it, 21 gen-naio 2008, p. 4 non num., secondo il quale, «nonostante la forte accentuazione delprincipio di maggioranza, esso non ha portato affatto ai risultati sperati, né in terminidi maggiore efficienza-produttività, né in termini di un più corretto rapporto tra mag-gioranza e opposizione parlamentare».
40 Si pensi, ad es., al rilievo elettorale che sembrano destinati ad assumere unmovimento che proclama la sua distanza dai partiti politici (Movimento 5 stelle) e l’a-stensionismo o, ancora, alla presentazione di due richieste di referendum abrogativodella l. 270/2005, che, però, sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzio-nale, con la sent. 13/2012. Si tratta di fenomeni che ricordano quanto osservato primadella riforma elettorale del 1993: cfr. supra, parte III, cap. I, par. 3.2.
208 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
2.2. Le modifiche dei regolamenti parlamentari
In seguito alle riforme elettorali in senso maggioritario, sisono avute anche delle modificazioni dei regolamenti parlamen-tari. Alcune di queste innovazioni miravano semplicemente a co-dificare prassi già esistenti, oppure ad adeguare i regolamentiparlamentari ai vincoli derivanti dalla partecipazione dell’Italiaall’Unione europea. Altre modifiche, tuttavia, erano chiaramentevolte «ad adeguare l’ordinamento parlamentare ai principi por-tanti del sistema elettorale maggioritario»41. In questo senso, par-ticolarmente rilevanti sono le riforme dei regolamenti parlamen-tari attuate nella XIII legislatura, perché si è abbandonato ilprincipio dell’unanimità in favore di quello della maggioranza insede di programmazione dei lavori, superando il modello della“democrazia bloccata” e cercando di ispirarsi all’ideale della“democrazia decidente”42. Questa, in particolare, può essereconsiderata la chiave di lettura delle modifiche che hanno ri-guardato la programmazione dei lavori, il contingentamento deitempi, la previsione di una “corsia preferenziale” per l’iniziativalegislativa del Governo, la verifica del numero legale e le normerelative alle procedure finanziarie.
In questo contesto va inserito anche il superamento delleconvenzioni riguardanti l’elezione dei presidenti delle due Ca-mere. Dopo la riforma dei regolamenti parlamentari del 1971, in-fatti, si era seguita la prassi di attribuire la presidenza di unadelle due Assemblee – quella della Camera dei deputati – ad unesponente dell’opposizione. Dopo le riforme elettorali del 1993,questa prassi è stata superata, perché la presidenza di entrambele Camere è stata attribuita ad esponenti della maggioranza. Le
41 Così G. RIVOSECCHI, Regolamenti parlamentari e forma di governo nella XIIIlegislatura, Milano, Giuffrè, 2002, p. 169. Si v. anche G. ROLLA, Riforma dei regola-menti parlamentari ed evoluzione della forma di governo in Italia, in Rivista trimestraledi diritto pubblico, 2000, n. 3, part. pp. 600 ss.
42 A. MORRONE, Quale modello di Governo nella riforma del Regolamento dellaCamera dei deputati?, in Quaderni costituzionali, 1998, n. 3, pp. 485-486.
209L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
modificazioni dei regolamenti parlamentari volte a garantire lagovernabilità, in particolare quelle relative alla programmazionedei lavori, infatti, comportano una riduzione della posizione ar-bitrale del presidente: la posizione di quest’ultimo, infatti, po-trebbe non risultare più strumentale alla sola garanzia della dia-lettica parlamentare, bensì finalizzata anche alla tutela dell’attua-zione dell’indirizzo politico del Governo sul piano dell’attivitàlegislativo-parlamentare43. A fronte di tali cambiamenti, il presi-dente dell’Assemblea non può più essere scelto tra gli esponentidell’opposizione, ma deve essere eletto all’interno della maggio-ranza, come garante di una programmazione capace di raggiun-gere gli obiettivi propri del programma di governo, sebbenesenza sacrificare i diritti dell’opposizione44.
Con la riforma dei regolamenti parlamentari, tuttavia, non siè tentato solamente di adeguare l’organizzazione e il funziona-mento delle Camere alle novità intervenute nell’assetto istituzio-nale del Paese (quale, ad esempio, proprio la riforma del sistemaelettorale), ma si è anche cercato di anticipare alcuni cambia-menti in attesa della ripresa del dibattito sulle riforme costituzio-nali45. Le modifiche che riguardano la programmazione dei la-vori e il contingentamento dei tempi, infatti, sottintendono undiverso rapporto tra Governo e Parlamento, perché la gestionedei lavori parlamentari è rimessa prevalentemente al rapporto tra
43 Così A. MORRONE, Quale modello, cit., p. 462.44 Si v., al riguardo, S. SICARDI, Maggioranza, cit., pp. 125 ss., nonché S. CECCANTI,
Regolamenti parlamentari: un altro tassello di una «riforma strisciante», in Quaderni co-stituzionali, 1998, n. 1, p. 166, e A. CIANCIO, Riforma elettorale e ruolo garantistico delPresidente di Assemblea parlamentare: un modello in crisi?, in Diritto e società, 1996, n.3, pp. 405 ss. Per una ricostruzione del ruolo dei presidenti delle Camere nel senso con-siderato nel testo ben prima della riforma elettorale del 1993, si v. G. FERRARA, Il Presi-dente di Assemblea parlamentare, Milano, Giuffrè, 1965; cfr. anche M. IACOMETTI, I pre-sidenti di Assemblea parlamentare, Milano, Giuffrè, 2001, part. pp. 235 ss.
45 Come ricorda G. ROLLA, Riforma, cit., pp. 603-604, infatti, le modifiche deiregolamenti parlamentari cominciano nel 1997, contestualmente all’istituzione dellacommissione per le riforme costituzionali e, comunque, «in un contesto politico edistituzionale in continuo movimento».
210 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
Governo e maggioranza parlamentare che lo sostiene46. Tuttavia,ciò presuppone un assetto politico caratterizzato da un Governosorretto da una maggioranza coesa e un’opposizione responsabil-mente disposta a svolgere un ruolo propositivo di alternativa47.Ma un contesto con tali caratteristiche non ha certo rappresen-tato la costante delle legislature successive alla riforma elettoraledel 1993, nelle quali, invece, si è spesso assistito a maggioranzecaratterizzate da una carente coesione interna48 e da un clima dilimitata collaborazione tra i due schieramenti – soprattutto sultema delle riforme –, i quali, invece, puntano piuttosto alla dele-gittimazione reciproca.
La riforma dei regolamenti parlamentari spinge verso unamodifica della forma di governo in senso maggioritario, che pog-gia su un sistema politico sostanzialmente bipolare: le nuove di-sposizioni sul procedimento legislativo, infatti, sono congegnatecon riferimento ad un modello di democrazia dell’alternanza checontrapponga nella dialettica parlamentare le forze politiche dimaggioranza e di opposizione, costrette, se vogliono governare, acompattarsi e organizzarsi politicamente intorno a programmipreventivamente convenuti e condivisi tra tutte le forze politicheappartenenti a ciascuno schieramento49.
Ma non cambia solo il ruolo della maggioranza parlamen-tare che sostiene il Governo: cambiano anche il ruolo e le aspet-tative dell’opposizione. La riforma dei regolamenti parlamentari,infatti, comportando l’abbandono di un modello parlamentare ditipo consociativo, assegna all’opposizione una funzione diversa,perché la minoranza non può più pensare di determinare in-
46 Si v., in proposito, le osservazioni di C. DI ANDREA, Sulle ultime modificazionidel regolamento della Camera dei deputati, in Rassegna parlamentare, 1999, n. 1, p. 150.
47 Così F. SEMERARO, Prime riflessioni sull’attuazione della riforma del regola-mento della Camera dei deputati, in Rassegna parlamentare, 2001, n. 1, p. 218.
48 Con le conseguenze in tema di attività normativa che si riassumono infra,parte III, cap. II, par. 2.3.
49 Così A. MORRONE, Quale modello, cit., pp. 490-491. Sulle modificazioni rego-lamentari inerenti il procedimento legislativo si rinvia anche a U. ZAMPETTI, Il procedi-mento legislativo, in Rassegna parlamentare, 2001, n. 1, pp. 129 ss.
211L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
sieme alla maggioranza l’indirizzo politico generale, come acca-deva nel parlamento c.d. consociativo50. In un sistema maggiori-tario, all’opposizione vanno riconosciuti diritti differenti: il di-ritto di denunciare l’eventuale uso illegale del potere legislativoda parte della maggioranza; il diritto di esercitare un potere dicontrollo politico al fine di contestare le scelte della maggioranzae far emergere una linea differente da quella del Governo, per-mettendo alla minoranza di presentarsi come valida alternativaper guidare il Paese; il diritto di manifestare il proprio pensieropolitico51. Le riforme dei regolamenti parlamentari successive al1993, tuttavia, superando il modello consociativo e non introdu-cendo un vero e proprio statuto dell’opposizione parlamentare,hanno accentuato la tendenza maggioritaria ma, nel contempo,hanno ridotto i mezzi di cui dispone l’opposizione52, sollevandonumerosi dubbi anche sulla capacità delle procedure parlamen-tari di garantire la rigidità costituzionale in un sistema maggiori-tario (o proporzionale con effetti maggioritari)53.
50 Si v. le osservazioni di S. LABRIOLA, Note, cit., p. 217.51 Così M. PATRONO, Maggioritario, cit., pp. 68-69. Si v. anche C. CHIMENTI, L’op-
posizione parlamentare nella nostra democrazia maggioritaria, in Quaderni costituzio-nali, 2002, n. 4, pp. 741 ss.
52 In questo senso S. LABRIOLA, Note, cit., p. 230. Non a caso, dopo le riformeelettorali in senso maggioritario si è assistito all’accentuarsi del dibattito sul tema dellegaranzie dell’opposizione. Ad es., nel progetto di riforma costituzionale approvatonella XIV legislatura, si intendeva introdurre in Costituzione numerose disposizioni ri-ferite espressamente alle opposizioni, sebbene senza la previsione di un organico sta-tuto dell’opposizione parlamentare (cfr. A.S. 2544-D, artt. 9, 16 e 21). Tuttavia, già nelcorso dei lavori della Commissione bicamerale presieduta da Massimo D’Alema, eraemersa la necessità di configurare uno statuto dell’opposizione parlamentare attra-verso la riforma degli artt. 83, 88 e 105 Cost. (si v. N. LUPO, Statuto dell’opposizione,poteri di controllo e autonomia regolamentare delle Camere, in V. ATRIPALDI, R. BIFULCO
(a cura di), La Commissione, cit., pp. 348-353).53 Si v. i dubbi espressi al riguardo da G. RIVOSECCHI, Nota (a futura memoria)
sul procedimento di revisione costituzionale per un recupero della “soluzione Alfonso Te-sauro”, in www.forumcostituzionale.it, 4 dicembre 2005. Si rinvia, più in generale, aidubbi manifestati opportunamente da S. LABRIOLA, Per una storia, cit., p. 16 non num.,sulla capacità dei quorum previsti in Costituzione di rappresentare ancora adeguatistrumenti di garanzia nei Parlamenti maggioritari.
212 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
Tuttavia, molte sono le questioni rimaste irrisolte: la disci-plina dei gruppi parlamentari; le modalità del loro finanzia-mento; i tempi di intervento dei singoli parlamentari. La man-cata attuazione di modifiche regolamentari in tale senso con-sente, come si è già accennato, la permanenza in Parlamento diun gran numero di forze politiche. Infatti, anche se i nuovi si-stemi elettorali costringono le forze politiche a presentarsi unitealle elezioni, i regolamenti parlamentari consentono loro di ritro-vare una propria autonomia e specificità all’interno delle Assem-blee, potendo comunque costituire un autonomo gruppo parla-mentare, oppure una “componente politica” all’interno delgruppo misto, con conseguente attribuzione di risorse e strut-ture54. Tutto ciò induce tali forze politiche a evidenziare le loropeculiarità ideologiche al fine di distinguersi dalle altre forzedella coalizione, soprattutto da quelle ideologicamente affini,così da tentare di guadagnare voti e giustificare la propria auto-noma esistenza. In questo modo, si mina la coesione della coali-zione, perché i distinguo sollevati da tali forze politiche finisconocon il rendere meno efficace sia l’azione della maggioranza diGoverno sia la capacità di contrasto offerta dall’opposizione.
54 Secondo N. LUPO, I gruppi parlamentari nel parlamentarismo maggioritario, inDemocrazia e diritto, 2009, n. 3/4, p. 93, il mancato adeguamento alle leggi elettoralidel 1993 e del 2005 «della disciplina dei gruppi (e delle commissioni permanenti) fa sìche continuino a essere presenti, nel sistema parlamentare, una serie di non irrilevantiincentivi alla frammentazione». Si v., altresì, S. MERLINI, Natura e collocazione deigruppi parlamentari in Italia, in ID. (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parla-mentari, partiti: il contesto italiano, vol. II, Torino, Giappichelli, 2004, part. pp. 11 ss.,E. CANITANO, L’anomalia del gruppo misto, ivi, pp. 183 ss., S. CURRERI, Il ruolo deigruppi parlamentari tra fonti normative e prospettive politiche, ivi, part. pp. 257 ss., ID.,I gruppi parlamentari nella XV legislatura, in Quaderni costituzionali, 2006, n. 3, pp.548 ss., V. COZZOLI, I gruppi parlamentari nella transizione del sistema politico-istitu-zionale, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 78 ss., G. RIVOSECCHI, Regolamenti, cit., pp. 61 ss.,R. BIN, La disciplina dei gruppi parlamentari, in AA.VV., Annuario 2000. Il Parlamento,Atti del XV convegno annuale dell’AIC, Firenze, 12-14 ottobre 2000, Padova, Cedam,2001, part. pp. 92 ss., M.L. MAZZONI HONORATI, Considerazioni critiche sul rapporto traregolamenti parlamentari e forma di governo, ivi, pp. 351-352, nonché M. VOLPI, La na-tura, cit., p. 158, che definisce il gruppo misto un «monstrum tipicamente italiano».
213L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
Si può affermare, quindi, che sono rimasti irrisolti quegliaspetti dei regolamenti parlamentari ancora modellati su unarealtà politica e parlamentare basata su un sistema proporzionalee che la riforma elettorale del 1993 non è riuscita a scardinare55.Il tentativo di superare la logica consociativa, infatti, è stato at-tuato con reticenza e incertezza56 e proprio la persistenza nel pa-norama politico e istituzionale di spinte contrastanti e contrad-dittorie rende difficile ricondurre ad una coerente ispirazioneunitaria le modifiche ai regolamenti parlamentari57. Invero, oc-corre riconoscere che, di fronte all’incapacità di attuare una or-ganica e completa revisione costituzionale in grado di portare ilPaese verso una “seconda Repubblica”58, si è puntato ad attuare
55 Così G. RIVOSECCHI, Regolamenti, cit., p. 174, ma anche ID., I poteri, cit., pp.164 ss.
56 In questo senso M.L. MAZZONI HONORATI, Considerazioni, cit., part. p. 349,cui fa riferimento anche A. BURATTI, Governo, maggioranza e opposizione nel procedi-mento legislativo e nella programmazione dei lavori parlamentari, in Diritto e società,2002, n. 2, pp. 267-268. Secondo N. LUPO, I gruppi, cit., p. 99, la scelta di mantenereun impianto proporzionalistico dei regolamenti parlamentari non sarebbe casuale:«appare essere il frutto di una precisa opzione, nel senso di mantenere un’articolazioneelevata del quadro politico-parlamentare, accettando sì una logica di funzionamentodel sistema in senso bipolare, ma evitando che questo bipolarismo costringa effettiva-mente gli attori politici ad identificarsi integralmente (o almeno in larga prevalenza) al-l’interno di uno dei due poli». Secondo G. PASQUINO, La transizione a parole, Bologna,il Mulino, 2000, pp. 61 ss., la democrazia maggioritaria non riesce ad affermarsi in Ita-lia non perché non sia praticabile anche in culture politiche non anglosassoni ma soloperché ad essa si oppone una parte della classe politica, la quale teme di perdere i suoiprivilegi.
57 Così C. DI ANDREA, Sulle ultime, cit., p. 101.58 Come ricordava T. MARTINES, Diritto, cit., pp. 890-891, la seconda Repubblica
si dovrebbe distinguere dalla prima perché tende ad eliminarne i gravi difetti, dalla in-stabilità politica al consociativismo, dalla corruzione alla partitocrazia ed allo statali-smo, ed a stabilire nuove regole politiche e giuridiche per un efficiente governo delloStato. Secondo l’A., però, non si potrà parlare di seconda Repubblica «sino a quandonon si procederà ad incisive modifiche della Costituzione vigente, ancor più, ad ap-provare una nuova Costituzione»; al momento, quindi, non si può parlare di prima oseconda Repubblica: «siamo nella Repubblica voluta del popolo con il referendum co-stituzionale del 1946, il cui ordinamento è disciplinato dalla Costituzione del 1947».Occorre considerare, tuttavia, che «[t]he Italian transition from the First to the (so-called) Second Republic may well considered a similar exemple of change from partified
214 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
le riforme istituzionali attraverso il flessibile strumento dei rego-lamenti parlamentari, registrando i mutamenti della forma di go-verno già emersi nella prassi59. Ma, poiché le riforme regolamen-tari della XIII legislatura sono state insufficienti e la riforma co-stituzionale non si è mai concretizzata, il dibattito sulla necessitàdi riformare i regolamenti parlamentari è rimasto centrale intutte le legislature maggioritarie60, manifestando la scarsa reatti-
to presidentialized polity» (M. CALISE, Presidentialization, Italian Style, in T. POGUNTKE,P. WEBB (eds.), The Presidentialization of Politics, Oxford, Oxford University Press,2005, p. 97). Secondo M. OLIVETTI, Appunti, cit., pp. 107-108, la definizione di se-conda Repubblica, «non giustificata se intesa come evocante un mutamento di regimepolitico, è invece perfettamente calzante per il nuovo sistema dei partiti formatosi nel1994». Si v., infine, le perplessità di V. ONIDA, “Seconda Repubblica” o nuovo sistemapolitico, in Corriere giuridico, 1993, n. 2, pp. 121-122.
59 Secondo G. RIVOSECCHI, Regolamenti, cit., pp. 174-175, le prassi costituzionaliincidenti sulla forma di governo, non potendo trovare, al momento, una codificazionecostituzionale, «vengono giuridificate nei regolamenti delle Assemblee». Secondo l’A.,«in tale prospettiva, il regolamento parlamentare diventa, anche grazie alla flessibilitàdella “tecnica novellistica”, una sorta di “frontiera mobile” – come strumento più agilerispetto alla revisione costituzionale – in grado di includere più facilmente nella codi-ficazione scritta quelle tendenze che assumono una rilevanza di diritto costituzionale“vivente”». In relazione all’influenza delle modifiche ai regolamenti parlamentari sullaforma di governo si v. S. BARTOLE, Interpretazioni, cit., part., pp. 220 ss.; sulla capacitàdei regolamenti parlamentari di determinare mutamenti costituzionali anche in un si-stema a Costituzione rigida, peraltro, si v. già G. JELLINEK, Allgemeine, cit., p. 118.
60 Per quanto riguarda la discussione sulla riforma dei regolamenti parlamentarinella XVI legislatura ci si limita a rinviare a E. GIANFRANCESCO, N. LUPO (a cura di), In-terna corporis degli organi costituzionali, in www.osservatoriosullefonti.it, 2009, n. 1,pp. 1 ss., mentre, sulla proposta bipartisan di modifica del reg. Sen., presentata il 2febbraio 2012 dai senatori Quagliariello e Zanda, si v. G. SAVINI, Primissime osserva-zioni sulla proposta Quagliariello/Zanda di riforma organica del regolamento del Senato,in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 28 febbraio 2012, pp. 1 ss., N. LUPO, G.PERNICIARO, Riforma del regolamento del Senato: un approccio bipartisan, ma non an-cora sufficientemente organico, in www.osservatoriosullefonti.it, 2012, n. 1, pp. 1 ss., F.SOCCI, La proposta di riforma del regolamento interno in discussione al Senato, inwww.forumcostituzionale.it, 28 marzo 2012, pp. 1 ss., nonché D. PICCIONE, I Gruppiparlamentari alla prova delle (auto)riforme regolamentari, in www.rivistaic.it, 2012, n. 2,pp. 1 ss. Più in generale, per un’opinione che ritiene necessaria una riforma organicadei regolamenti parlamentari si v. E. GIANFRANCESCO, Ciò che è vivo e ciò che è mortonei regolamenti parlamentari del 1971, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scrittiin onore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, part. p. 889.
215L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
vità del Parlamento di fronte al mutato contesto politico61 e con-fermando, al tempo stesso, l’incompiutezza della transizionemaggioritaria.
2.3. Il rapporto tra Esecutivo e maggioranza parlamentare nell’at-tuazione del programma di governo
Le indicate modificazioni ai regolamenti parlamentari, inparticolare quelle inerenti la programmazione dei lavori, sottin-tendono un rapporto tra il Governo e la propria maggioranzaparlamentare che si potrebbe definire tipicamente maggioritario:l’organizzazione parlamentare predispone gli strumenti perun’attività legislativa efficace e la maggioranza lavora per concre-tizzare il programma di Governo sotto la guida dello stesso Ese-cutivo. Invero, se il sistema maggioritario consente – di fatto – alcorpo elettorale di votare per una maggioranza che afferma divoler realizzare un determinato programma elettorale, l’impor-tanza di quest’ultimo non può che aumentare. Infatti, da un lato,il programma dovrebbe contribuire ad attrarre il consenso elet-torale sugli obiettivi dichiarati dagli schieramenti elettorali; dal-l’altro, la sua mancata realizzazione da parte della maggioranzaparlamentare consente al corpo elettorale di valutarne l’attività,punendola alle elezioni successive. Il rilievo così assunto dal pro-gramma di governo consente di capire i motivi per cui ad essoviene dato ampio risalto in campagna elettorale ed anche perché
61 La scarsa capacità di reazione del Parlamento è evidente, ad es., nel mancatoadeguamento dei regolamenti parlamentari alle nuove procedure di finanza pubblicaintrodotte dalle leggi 196/2009 e 39/2011. Se si allarga l’angolo di visuale, peraltro,tale assenza di reattività può rappresentare un elemento preoccupante e finanche peri-coloso, perché, come osserva A. MANZELLA, Prefazione, in L. GIANNITI, N. LUPO, Corsodi diritto parlamentare, Bologna, il Mulino, 2008, p. XI, «[q]uel che si chiede ai Parla-menti è di essere reattivi ai mutamenti sociali (e tecnologici) in corso. L’autonomia par-lamentare è un capitale sprecato (o peggio: indifeso dalla critica di un antiparlamenta-rismo sempre endemico nelle nostre società ma che rischia di trovare giustificazioniscatenanti nella passività dei Parlamenti) se tale autonomia non viene utilizzata per la-vorare nel modo più accorto per incontrare la società, e non per fare “corpo sepa-rato”».
216 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
diviene essenziale prevedere strumenti che consentano al Go-verno in carica di rispettare gli impegni assunti con gli elettori62.
Le riforme delle disposizioni dei regolamenti parlamentarisulla programmazione sembrano derivare proprio da tale esi-genza. Nonostante tali riforme, il rapporto tra Esecutivo e Legi-slativo volto alla concretizzazione del programma di governonon si è conformato alla logica maggioritaria del Governo che di-rige l’attività normativa delle Camere; sembra, piuttosto, che intale rapporto si sia assistito ad una sorta di “fuga” del Governodal Parlamento63. Per realizzare il proprio programma, infatti,l’Esecutivo ha preferito agire al di fuori delle Camere, proce-dendo – ove possibile – attraverso l’utilizzo di regolamenti, op-pure ricorrendo con molta frequenza ai decreti legislativi, conconseguente riduzione della produzione legislativa del Parla-mento64. Quando, invece, l’Esecutivo deve o preferisce far ap-
62 Si v. in proposito A. NATALINI, Il Programma di governo tra indirizzo politico epropaganda elettorale, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, n. 7, pp. 708 ss., eID., Programma di governo e contratto con gli italiani Il Commento, ivi, 2003, n. 12, pp.1228 ss. Sul diverso ruolo dei programmi dei partiti prima della riforma elettorale del1993, si v. F. CUOCOLO, Programma di Governo, indirizzo politico, mozione motivata difiducia, in Diritto e società, 1982, pp. 629 ss.
63 In questo senso S. SICARDI, Maggioranza, cit., p. 144, ma anche, con specificoriferimento alla sessione di bilancio, M. RUBECHI, La sessione di bilancio in parlamento:governi in fuga, relazione al Convegno “La prassi degli organi costituzionali”, Bologna,14-15 giugno 2007, in www.forumcostituzionale.it, part. pp. 16 ss.
64 Secondo G. CAPANO, M. GIULIANI, Legiferare e governare fra prima e secondaRepubblica, in il Mulino, 2001, n. 5, pp. 943-944, infatti, il Governo, piuttosto che di-ventare più forte “in” Parlamento, è diventato più autonomo “dal” Parlamento; cfr.anche S. SICARDI, Maggioranza, cit., pp. 143-144, nonché U. DE SIERVO, Considerazionisull’ordinamento e l’organizzazione del Governo, in AA.VV., Annuario 2001, cit., pp.315-316, ID., Un travolgente processo di trasformazione del sistema delle fonti a livellonazionale, in ID. (a cura di), Osservatorio sulle fonti 1998, Torino, Giappichelli, 1999,pp. XIII ss., e T. GROPPI, La forma di governo italiana nella giurisprudenza costituzio-nale: la Corte a difesa del «monismo parlamentare»?, in Politica del diritto, 2000, n. 3,part. pp. 417 ss. Sull’ampio ricorso alla delegificazione si v. le considerazioni critichedi F. SORRENTINO, Intervento, in AA.VV., Annuario 2000, cit., pp. 360-361, e A.A. CER-VATI, Delegificazione, in Enciclopedia giuridica, vol. X, Roma, Treccani, 1997, pp. 1 ss.,nonché N. LUPO, Dalla legge al regolamento, Bologna, il Mulino, 2003, passim. Per laconsiderazione che l’ampio ricorso alla decretazione d’urgenza e a quella delegata sia
217L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
provare un provvedimento dalle Camere, il fenomeno cui fre-quentemente si assiste – ugualmente distorsivo del rapporto traGoverno e Parlamento – è quello del ricorso alla questione di fi-ducia65. Più nello specifico, il Governo ricorre in maniera quasisistematica alla decretazione d’urgenza e, in sede di conversionedel decreto legge, pone la questione di fiducia su un maxi-emen-damento sostitutivo del disegno di legge di conversione. Senzavoler considerare il Governo Monti, che è un Governo “tecnico”nato in un contesto di emergenza economica, si può osservareche il ricorso alla questione di fiducia è stato un tratto caratteri-stico della XV legislatura, nella quale il Governo Prodi II era so-stenuto da una maggioranza assai risicata al Senato, ma anchedella XIV e della XVI legislatura, nonostante i tre Governi dicentro-destra presieduti da Berlusconi in queste due legislaturepotessero contare su una maggioranza parlamentare piuttostoampia, almeno per buona parte della legislatura.
Il costante ricorso alla decretazione d’urgenza e alla que-stione di fiducia, dunque, caratterizza le legislature maggiorita-rie66, con effetti di notevole rilievo sul rapporto tra Governo eParlamento. Con il ricorso alla questione di fiducia il Governo
motivo di indebolimento anche dell’Esecutivo, si v. L. PALADIN, Atti legislativi delGoverno e rapporti fra i poteri, in Le Regioni, 1996, n. 1, pp. 7 ss.
65 Secondo G. PICCIRILLI, I paradossi della questione di fiducia ai tempi del mag-gioritario, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 811, la questione di fiducia rappresente-rebbe «la vera e propria concretizzazione del principio maggioritario nella dinamicaparlamentare». Al riguardo, appare utile un rinvio ai dati contenuti in V. DI PORTO, Inumeri delle leggi, in Il Filangieri, Quaderno 2008, part. pp. 190 ss., la cui analisi ar-riva sino alla XV legislatura, e in N. LUPO, Il ruolo normativo del Governo, in Il Filan-gieri, Quaderno 2010, pp. 81 ss., la cui analisi comprende anche parte della XVI legi-slatura.
Per una lettura di carattere più generale della “degenerazione” del ricorso alladecretazione d’urgenza si v. A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge, Padova, Cedam,1997, part. pp. 271 ss.
66 Il riferimento è alla c.d. fiducia tecnica, ossia quella posta più per motivi pro-cedurali che politici: cfr. V. LIPPOLIS, Le procedure parlamentari del rapporto fiduciario,in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto parlamen-tare, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 227-228.
218 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
tenta di contrastare la mancanza di coesione interna alla propriamaggioranza67 ma, così facendo, riduce i margini sia per l’oppo-sizione parlamentare sia per la propria maggioranza di incideresul contenuto del provvedimento da approvare68, sebbene nonsia affatto infrequente che le richieste di parlamentari di maggio-ranza e opposizione siano accolte nei maxi-emendamenti suiquali viene posta la questione di fiducia69. Inoltre, il ricorso allaquestione di fiducia contribuisce a ridurre l’importanza dellecommissioni parlamentari nell’attività di negoziazione legislativatra maggioranza e opposizione, dopo che la riforma maggiorita-ria ha già sensibilmente ridotto il ruolo delle commissioni nelprocesso legislativo70. Così facendo, nell’attuare il programma digoverno, l’Esecutivo non si limita a guidare il procedimento legi-slativo ma finisce con il ridurre gli ambiti di intervento del Par-lamento71 o col relegarlo in un ruolo di semplice ratifica delle de-cisioni assunte dallo stesso Esecutivo72. La funzione principale
67 Sul collegamento tra frequente ricorso alla questione di fiducia e scarsa coe-sione delle maggioranze parlamentari, si v. V. LIPPOLIS, La centralità del Governo nel si-stema politico. Le specificità del caso italiano, in Il Filangieri, Quaderno 2010, p. 26, eN. LUPO, Il ruolo, cit., pp. 119-120.
68 In senso analogo le osservazioni di R. PERNA, Tempi della decisione ed abusodella decretazione d’urgenza: il procedimento legislativo in una democrazia maggiorita-ria, in www.formumcostituzionale.it, 25 novembre 2008, p. 9, e G. SAVINI, Primissime,cit., p. 3, che parla di «totale svilimento del ruolo del Parlamento».
69 Cfr. F. BIONDI, S. LEONE, Il Governo “in” Parlamento: evoluzione storica e pro-blematiche attuali, in www.rivistaic.it, 14 marzo 2012, pp. 16-17.
70 Su questo punto si v. M. MIDIRI, Commissioni parlamentari e processo di deci-sione politica: la prassi recente, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, n. 4, pp.1035 ss.
71 Cfr., in proposito, G. CAPANO, M. GIULIANI, Legiferare, cit., part. pp. 944-945;si v. anche M. MAZZIOTTI DI CELSO, Relazione generale, in AA.VV., Annuario 2000, cit.,part. pp. 121 ss., e V. CERULLI IRELLI, Legislazione, ivi, part. pp. 159 ss.
72 Secondo M. VOLPI, La natura, cit., p. 159, il Governo «è diventato il “pa-drone” della produzione normativa». In senso analogo S. LABRIOLA, Per una storia, cit.,pp. 11-12 non num. Si v. anche A. D’ANDREA, La riconsiderazione della funzione parla-mentare quale strada obbligata per puntellare la traballante democrazia italiana, inwww.rivistaic.it, 7 dicembre 2010, pp. 1 ss., che parla di “declino” del Parlamento.Tuttavia, si v. anche le considerazioni di R. NANIA, Prime considerazioni sulla «funzionedi governo» come «funzione di indirizzo», in AA.VV., Annuario 2001, cit., pp. 305-306.
219L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
del Parlamento, di conseguenza, non appare più quella di legife-rare, bensì quella di sostenere il Governo73, considerato, altresì,che al rafforzamento dell’Esecutivo nei rapporti con il Parla-mento non corrisponde un adeguato potenziamento dei poteriispettivi delle Camere74.
Invero, il sistematico ricorso alla questione di fiducia sem-bra strettamente connesso alle riforme elettorali maggioritarie.Infatti, se le leggi elettorali costringono formazioni politiche dif-ferenti ad una artificiosa coalizione elettorale al fine di vincere leelezioni, l’utilizzo della questione di fiducia costringe le variegatecomponenti della maggioranza parlamentare così eletta a votare iprovvedimenti voluti dal Governo75, per evitare la crisi di go-verno e l’eventuale ritorno anticipato alle urne76.
2.4. Il procedimento di formazione del Governo
Occorre occuparsi, ora, degli effetti che le riforme elettoraliin senso maggioritario hanno prodotto direttamente sul Go-verno. Preliminarmente, è opportuno considerare che l’Esecu-tivo nel suo complesso ha visto gradualmente rafforzare il suoruolo, indipendentemente dalle riforme elettorali, a causa (quan-tomeno) di due fenomeni: il processo di integrazione comunita-ria e l’aumento dell’autonomia degli enti locali territoriali77. Nelmultilevel system che si è così sviluppato, infatti, un ruolo cen-trale è ricoperto dagli Esecutivi (di solito, anche quelli regionali),
73 Si v., in proposito, le osservazioni di C.J. FRIEDRICH, Constitutional Govern-ment and Democracy, Boston, Ginn and company, 1950, trad. it., Governo costituzio-nale e democrazia, Vicenza, Neri Pozza Editore, s.d., pp. 412 ss., che ricollega le dueindicate funzioni del Parlamento ai differenti sistemi elettorali utilizzati per eleggerlo.
74 In proposito si v. ampiamente G. RIVOSECCHI, I poteri, cit., pp. 155 ss.75 In questo senso le osservazioni di N. LUPO, I gruppi, cit., p. 101.76 L’apposizione della questione di fiducia si traduce così «nell’imposizione di
una sorta di ricatto: “prendere o lasciare”, con tutto quel che ne può conseguire»,come osserva A. D’ANDREA, La funzione parlamentare, in www.rivistaic.it, 12 giugno2012, p. 5.
77 In questo senso P. CIARLO, Governo forte versus Parlamento debole: ovvero delbilanciamento dei poteri, in AA.VV., Annuario 2001, cit., pp. 193 ss.
220 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
a scapito delle Assemblee rappresentative78, perché il Governo,in particolare, deve rappresentare la posizione italiana in ambitocomunitario, deve garantire il coordinamento tra i diversi livelli(interni e sovranazionale) di governo e deve contenere le spintecentrifughe79. Qui di seguito, tuttavia, si porrà l’attenzione suquelle modificazioni che hanno riguardato il Governo e che sono(prevalentemente) riconducibili alle riforme elettorali maggio-ritarie, a cominciare dal procedimento di formazione dell’Ese-cutivo.
Nell’iter di formazione dell’Esecutivo un ampio margine diintervento è rimesso a prassi, consuetudini e convenzioni costi-tuzionali, mentre la Costituzione si limita a disporre che «[i]lPresidente della Repubblica nomina il Presidente del Consigliodei ministri e, su proposta di questo, i ministri»80; che tutti imembri del Governo, prima di assumere le loro funzioni, de-vono prestare giuramento «nelle mani del Presidente della Re-pubblica»81; infine, che i rapporti tra Esecutivo e Legislativosono caratterizzati dal rapporto di fiducia82. Considerato il te-nore di tali disposizioni costituzionali, il procedimento di forma-zione del Governo non poteva che svilupparsi sulla scorta di re-gole convenzionali, che appare necessario ripercorrere sintetica-mente al fine di riscontrare eventuali modificazioni conseguentialle riforme elettorali maggioritarie.
78 Nello stesso senso A. RUGGERI, Il Governo, cit., p. 333.79 In questo senso le osservazioni di S. MANGIAMELI, Il Governo tra Unione euro-
pea e autonomie territoriali, in AA.VV., Annuario 2001, cit., pp. 213 ss., part. 218. Perquanto riguarda l’Unione europea, si pensi al rilievo delle relazioni intergovernative oalla centralità del Governo nella partecipazione dell’Italia al processo normativo co-munitario; per quanto attiene agli enti locali, invece, oltre alla partecipazione delle Re-gioni e delle Province autonome al processo normativo comunitario, si consideri che,in mancanza di una vera e propria Camera delle Regioni, un ruolo fondamentale neirapporti tra centro e periferia è ricoperto dal sistema delle Conferenze, che, come si ègià visto supra, parte I, cap. I, par. 5.2., rientrano nella nozione di Governo in sensoampio.
80 Così l’art. 92, co. 2, Cost.81 Così l’art. 93 Cost.82 Art. 94 Cost.
221L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
La prima fase del procedimento consiste nelle consultazionisvolte dal Presidente della Repubblica al fine di individuare ilsoggetto capace di formare un Governo che possa ottenere la fi-ducia da parte delle Camere. Dopo aver svolto tali consultazioni,il Presidente della Repubblica è in grado di individuare la perso-nalità alla quale affidare l’incarico; quest’ultima accetta l’incaricocon riserva e, solo dopo aver svolto a sua volta delle consulta-zioni, scioglie la riserva, accettando definitivamente l’incarico.Dopo l’accettazione da parte dell’incaricato, il Presidente dellaRepubblica adotta sia il decreto con il quale accetta le dimissionidel Governo uscente, sia i decreti di nomina dei membri delnuovo Governo. Questi ultimi, poi, devono prestare giuramentodinanzi al Presidente della Repubblica. Il Governo così formatodeve presentarsi, entro dieci giorni, alle Camere, per ottenere lafiducia83.
Tale procedimento, consolidatosi nel corso dell’esperienzarepubblicana, non è stato formalmente modificato dal passaggioad un sistema politico influenzato dalle riforme elettorali mag-gioritarie84. Anche dopo le elezioni maggioritarie, infatti, tale iterè stato rispettato, sebbene non siano mancati dei cambiamenti dicarattere sostanziale. Per quanto riguarda la prima elezione mag-
83 Sul procedimento di formazione del Governo si rinvia a L. ELIA, Appunti sullaformazione del Governo, in Giurisprudenza costituzionale, 1957, pp. 1170 ss., G. ZA-GREBELSKY, La formazione, cit., pp. 805 ss., A.A. ROMANO, La formazione del Governo,Padova, Cedam, 1977, e P. ARMAROLI, La doppia fiducia, in Quaderni costituzionali,1981, n. 3, pp. 580 ss.
84 Secondo L. CARLASSARE, Relazione generale, in AA.VV., Annuario 2001, cit., p.97, quello per l’individuazione del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe unpercorso «seguito sempre dai Presidenti [della Repubblica] che si sono succeduti e or-mai costituzionalmente obbligatorio». Secondo C. CHIOLA, Presidente, cit., pp. 107-108, invece, l’avvento del principio maggioritario avrebbe fatto saltare le regole con-venzionali formatesi durante la vigenza della proporzionale; nello stesso senso G.U.RESCIGNO, Ripensando, cit., part. pp. 509-510, ma anche G. DEMURO, Regole, cit., part.pp. 92 ss. Secondo M. AINIS, Sul valore della prassi nel diritto costituzionale, in Rivistatrimestrale di diritto pubblico, 2007, n. 2, pp. 333-334, infine, il maggioritario avrebbeprodotto uno scarto vistoso tra fatto e diritto in merito all’iter di formazione del Go-verno, generando una prassi incostituzionale.
222 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
gioritaria, occorre considerare il penetrante ruolo svolto dal Pre-sidente della Repubblica, il quale, dopo aver individuato nel lea-der della coalizione vincitrice dalle elezioni il soggetto cui confe-rire l’incarico di formare il nuovo Governo, gli indicava – attra-verso una lettera85 – le caratteristiche che avrebbero dovutopossedere coloro i quali sarebbero stati chiamati a ricoprire re-sponsabilità ministeriali, in particolare, nei dicasteri di maggiorerilievo86. Tale intervento – piuttosto invasivo, in verità87 – deveessere letto alla luce del momento nel quale il nuovo Governo sistava costituendo: non si trattava solo della prima legislaturamaggioritaria della storia repubblicana, ma anche della prima le-gislatura successiva alla deflagrazione dello scandalo provocatodalle inchieste giudiziarie che avevano contribuito a cambiare lafisionomia del sistema partitico italiano88. Nondimeno, si può os-
85 La lettera e la risposta del Presidente del Consiglio incaricato, Silvio Berlu-sconi, possono essere consultate in M. AINIS, T. MARTINES, Piccolo codice costituzionale,5ª ed., Milano, Led, 2005, pp. 311-312.
86 Su questa vicenda si rinvia a A. D’ANDREA, Art. 92, cit., p. 1784.87 Si v. le considerazioni di C. CHIOLA, Presidente, cit., pp. 108 ss.88 Sull’enlargement of functions del Presidente Scalfaro si rinvia a G. PITRUZ-
ZELLA, Forme, cit., pp. 114 ss., L. CARLASSARE, Presidente della Repubblica, crisi di go-verno e scioglimento delle Camere, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a cura di), Il Presidente,cit., pp. 150 ss., C. CHIMENTI, Addio prima Repubblica, Torino, Giappichelli, 1997, pp.365 ss., ma anche G. DEMURO, Regole, cit., pp. 65 ss. Come osserva M. OLIVETTI,Forme, cit., pp. 57-58, d’altro canto, è «naturale che il ruolo del Presidente della Re-pubblica diventa cruciale in periodi di crisi, intendendosi per tali sia le crisi di go-verno, che il Capo dello Stato, in un sistema parlamentare, ha il compito di risolvere,sia le crisi di sistema (…), nelle quali le trasformazioni del sistema politico, il crollodelle convenzioni costituzionali e l’indebolimento della carica precettiva della Costitu-zione determinano un vuoto che la natura monocratica della carica di capo dello Statoè la più idonea a colmare, almeno in parte: è quanto è accaduto in Italia durante lapresidenza Scalfaro, almeno negli anni dal 1992 al 1996»; in senso analogo R. CHERCHI,Il governo, cit., p. 289, che fa riferimento alla eccezionalità del momento politico. SulCapo dello Stato come “reggitore dello Stato nelle crisi di sistema” si rinvia a C. ESPO-SITO, Capo dello Stato, in ID., Capo, cit., pp. 35 ss., ma si v. anche C. SCHMITT, Der Hü-ter, cit., pp. 203 ss. È sicuramente utile rinviare anche a M. OLIVETTI, Ciampi al Quiri-nale: le prime elezioni presidenziali della democrazia maggioritaria, in Giurisprudenzacostituzionale, 1999, n. 5, pp. 3307 ss., per un’analisi del passaggio dalla presidenzaScalfaro a quella di Carlo Azeglio Ciampi, volta a valutare l’incidenza del sistema mag-gioritario sul ruolo del Presidente della Repubblica.
223L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
servare che, sin dalla prima elezione maggioritaria, il Capo delloStato ha individuato nel leader della coalizione vincitrice delleelezioni il soggetto deputato – quasi fisiologicamente – ad assu-mere la carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Tale ten-denza si è rafforzata nettamente nelle elezioni successive, perchéi due schieramenti hanno sempre preannunciato agli elettoriquello che sarebbe stato il loro candidato alla Presidenza delConsiglio. Con la riforma elettorale del 2005, poi, si è previstoformalmente che le coalizioni indichino il nome dell’unico capodella coalizione, il quale diventa il candidato di fatto alla Presi-denza del Consiglio, sebbene la legge confermi il rispetto delleprerogative attribuite dall’art. 92 Cost. al Capo dello Stato89.
Per comprendere appieno tale situazione occorre rifletteresul ruolo del Presidente della Repubblica nella formazione di unnuovo Governo. All’interno di tale procedimento, infatti, il Capodello Stato ha il delicato compito di individuare la personalità at-torno alla quale può coalizzarsi una maggioranza parlamentare eche, di conseguenza, sia in grado di formare un Governo che ot-tenga la fiducia del Parlamento. Il margine di manovra a disposi-zione del Presidente della Repubblica dipende dalla coesionedella coalizione che intende sostenere un dato Governo90: quan-do, all’esito delle elezioni, la coalizione vincente indica al Presi-dente della Repubblica la volontà di sostenere un Governo pre-sieduto dal leader indicato in campagna elettorale, infatti, il Capodello Stato è praticamente obbligato a decidere in tal senso91;quando, invece, la maggioranza che intende sostenere un nuovoGoverno manca di coesione, i poteri del Presidente della Repub-blica aumentano, perché quest’ultimo avrà un margine di mano-
89 Cfr. il d.p.r. 361/1957, art. 14-bis, co. 3 (introdotto dalla l. 270/2005, art. 1,co. 5), per la Camera, richiamato, per il Senato, dal d.lgs. 533/1993, art. 9, co. 3 (comesostituito dalla l. 270/2005, art. 4, co. 3).
90 In questo senso le osservazioni di P.A. CAPOTOSTI, Presidente della Repubblicae formazione del governo, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1980, n. 49-50, pp. 55-56.
91 In tal senso L. CARLASSARE, Relazione, cit., pp. 99-100.
224 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
vra maggiore nell’individuare il soggetto più adatto a diventarepremier. Nelle elezioni successive al 1993, la prima ipotesi si è ve-rificata – di solito – subito dopo le elezioni, la seconda, invece,nel caso di crisi di Governo in corso di legislatura, con conse-guente sfaldamento della coalizione che aveva vinto le elezioni.
Riassumendo, le riforme elettorali in senso maggioritario,seppure nel formale ossequio delle regole convenzionali inerentiil procedimento di formazione del Governo, hanno prodottodelle modificazioni concrete di tale iter92. Esso, infatti, risultanettamente più rapido, perché, da un lato, il Presidente della Re-pubblica, sulla scorta del risultato delle elezioni, può agevol-mente individuare nel leader della coalizione vincente il soggettoal quale affidare l’incarico93; dall’altro, anche quest’ultimo, puraccettando – di solito94 – l’incarico con riserva, non ha bisogno
92 In questo senso R. D’ALIMONTE, Italy, cit., p. 273, e R. CHERCHI, Il governo,cit., pp. 243 ss. Secondo M. CARDUCCI, Art. 94, cit., p. 1829, in tema di formazione delGoverno «le certezze procedimentali vacillano. Fondato sul paradigma della reciprocaautonomia di Parlamento e Governo, oggi il procedimento si trova sottoposto al vin-colo struttural-funzionale del patto elettorale di coalizione, personificato da un Leaderche concentra su di sé tutte le aspettative di fiducia. Si arriva a parlare di “fiducia tri-laterale” e ci si pone il dubbio della sua compatibilità costituzionale: dubbio già deco-struito, in realtà, dall’ermeneutica dei casi “Mancuso” e “Calabria”. Non ci sono più“eccedenze deontologiche” da ribadire e le “eccedenza semantiche” sedimentate dallastoria si dileguano al cospetto delle evidenze della investitura elettorale della coali-zione, come nell’art. 126 3° co. Ecco il punto. Si è invertito il paradigma di legittimitàdella fiducia: non più l’articolo con la sua retrospettiva maturata nelle aspettative delle“situazioni parlamentari” e “di coalizione”, ma l’oggetto immediato della volontà elet-torale maggioritaria; deliberazione indisponibile e inconfutabile che altera la soggetti-vità del rapporto fiduciario e influenza i criteri di cooperazione interorganica: in-somma il circuito operativo delle vecchie “situazioni” abdica alla forza espressiva dellainedita “situazione elettorale”».
93 Si consideri, ad es., che il Capo dello Stato non dovrebbe svolgere le consul-tazioni con le delegazioni di ogni singolo partito, bensì – di solito – solo con le dele-gazioni delle coalizioni. Si v., in proposito, A. REPOSO, Il procedimento di formazionedel governo e i suoi più recenti sviluppi costituzionali, in Diritto e società, 2003, n. 2, pp.194 ss., e E. GUARDUCCI, Natura e collocazione dei gruppi parlamentari in Italia, in S.MERLINI (a cura di), Rappresentanza, cit., pp. 226-227. Secondo G. DEMURO, Regole,cit., p. 64, il cambiamento è «talmente travolgente da trasformare la fase delle consul-tazioni in un mero passaggio rituale».
225L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
di lunghe consultazioni per cercare di coalizzare intorno a sé unamaggioranza di Governo dopo le elezioni, poiché tale maggio-ranza è costituita dalle stesse forze politiche che lo hanno soste-nuto alle elezioni95 e il programma di governo corrisponde aquello dichiarato in campagna elettorale.
Relativamente agli effetti delle riforme elettorali maggiorita-rie sul procedimento di formazione dell’Esecutivo, quindi, si po-trebbero fare le seguenti schematiche considerazioni: la fase diformazione del Governo rispetta gli stessi passaggi proceduraliconsolidatisi prima delle riforme elettorali, ma garantendo tempipiù rapidi; i cittadini riescono a determinare in maniera pratica-mente diretta l’elezione del premier, perché votando per una de-terminata coalizione sono anche consapevoli di sospingerne illeader alla guida del Governo; nel conferimento dell’incarico, ilPresidente della Repubblica, seppur nel formale rispetto dellesue prerogative, risulta quasi vincolato dal risultato elettorale96.Queste affermazioni, tuttavia, possono essere sostenute con unbuon grado di attendibilità solo con riferimento alla formazionedi un Governo successiva a nuove elezioni. Qualora la necessitàdi formare un nuovo Esecutivo derivi da una crisi durante la le-gislatura, invece, sembrano riassumere pienamente vigore le re-gole convenzionali sviluppatesi prima del 199397.
In primo luogo, diventa determinante il ruolo del Presidentedella Repubblica98. In particolare, quanto più grave è la crisi
94 … una eccezione è rappresentata dal Governo Berlusconi IV. Il 7 maggio2008, al termine delle consultazioni, il Presidente della Repubblica conferiva al leaderdel centro-destra l’incarico di formare il nuovo Governo; Berlusconi accettava l’inca-rico senza riserva e – contestualmente – presentava la lista dei ministri al Capo delloStato, il quale, il giorno stesso, adottava i decreti di accettazione delle dimissioni delprecedente Esecutivo e di nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri.
95 In questo senso le osservazioni di M. VOLPI, La natura, cit., pp. 161 e 166-167.96 S. GAMBINO, Riforme, cit., p. 16, parla, in proposito, di sostanziale condizio-
namento del Presidente della Repubblica; si v. anche O. CHESSA, La democrazia, cit., p.27, che parla di vincolo meramente fattuale e non giuridicamente rilevante.
97 G. DEMURO, Regole, cit., pp. 79-80.98 Ma si v. G. DEMURO, Regole, cit., pp. 72 ss.
226 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
(non solo politica) da affrontare, tanto più ampi appaiono i mar-gini di manovra del Capo dello Stato. Si tratta di una afferma-zione avvalorata dal fondamentale ruolo ricoperto dai PresidentiOscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano nella formazione diGoverni “tecnici” dopo le crisi di governo alle quali si è assistitonella prima e nell’ultima (sinora) delle legislature maggioritarie99.L’intervento del Presidente della Repubblica in tali circostanze èstato così penetrante e i Governi “tecnici” che ne sono derivatihanno manifestato un legame con la più alta carica dello Statotalmente stretto che, quando si sono concretizzate queste ipotesi,si è ragionato di tendenze al semipresidenzialismo della forma digoverno italiana100. Tuttavia, se si considerano i due casi in cui,nel corso delle legislature maggioritarie, il Capo dello Stato hafavorito la nascita di Governi “tecnici”, tale affermazione va pro-babilmente ridimensionata. Infatti, sia nella XII sia nella XVI le-gislatura, l’intervento del Presidente della Repubblica non è ser-vito a far fronte semplicemente alla crisi politica delle maggio-ranze parlamentari che avevano vinto le elezioni, bensì adaffrontare due momenti di grave crisi economico-istituzionaleche affliggevano il Paese. Così ricostruito, l’intervento presiden-ziale, piuttosto che richiamare quello di un Presidente della Re-pubblica in una forma di governo semipresidenziale, ricorda lafigura del Capo dello Stato che – nel governo parlamentare – fafronte alle situazioni di crisi, come si è visto poco sopra.
In secondo luogo, dopo una crisi di governo nel corso dellalegislatura, diventa (politicamente) possibile nominare al verticedell’Esecutivo un soggetto diverso da quello che aveva guidatoalle elezioni la coalizione vincente101.
Infine, è possibile che si formino alleanze parlamentari dif-
99 … il riferimento è, ovviamente, alla XII e alla XVI legislatura.100 Ipotesi avanzate sia nella XII sia nella XVI legislatura, come si è visto supra,
parte III, cap. II, parr. 2.1.1. e 2.1.5.101 È accaduto nella XII (Governi Berlusconi I e Dini), nella XIII (Governi
Prodi I, D’Alema I e II, Amato II) e nella XVI legislatura (Governi Berlusconi IV eMonti).
227L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
ferenti da quelle costituitesi per affrontare la competizione elet-torale102.
Il sistema maggioritario, dunque, sembra aver favorito chia-ramente l’affermazione di un ruolo preminente del leader dellacoalizione, ma questa preminenza riesce ad affermarsi soprat-tutto sul piano elettorale, mentre appare indebolita durante la le-gislatura dalla carenza di coesione all’interno della maggioranzadi governo103. D’altro canto, è inevitabile che il leader di una coa-lizione si muova in un contesto più problematico e meno strut-turato di quello di un leader di partito, «risultando moltiplicati isuoi elementi di debolezza»104, ancor più se questi non ha a suadisposizione strumenti giuridici che gli consentano di esercitarepressione sulla propria maggioranza, quale, ad esempio, la possi-bilità di determinare lo scioglimento delle Camere e il conse-guente ricorso anticipato alle urne105.
2.5.1. La modificazione del ruolo del Presidente del Consiglio deiministri: in seguito ai mutamenti elettorali e politici
Il candidato di fatto alla Presidenza del Consiglio, quindi,ha assunto un ruolo centrale nella fase elettorale, perché rappre-senta dinanzi al corpo elettorale l’intera coalizione che lo so-
102 Come si è visto, fenomeni del genere si sono verificati nella XII e nella XVIlegislatura.
103 In questo senso A. D’ANDREA, Art. 92, cit., p. 1787; si v. altresì E. CATELANI,Presidente, cit., pp. 4434-4435.
104 Così S. SICARDI, Maggioranza, cit., p. 120, nt. 16.105 Cfr., in questo senso, S. LABRIOLA, Per una storia, cit., p. 10 non num. Si v. an-
che R. CHERCHI, Il governo, cit., pp. 405 ss.È opportuno rinviare, inoltre, sia alla cronaca di M. OLIVETTI, Lo scioglimento
delle Camere del 2 febbraio 1992. Una «curiosità costituzionale» o un precedente imba-razzante?, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, pp. 599 ss., per l’episodio dello scio-glimento “governativo” delle Camere nel 1992, sia a G.G. FLORIDIA, L’eccezione e la re-gola: lo scioglimento del 1994, in Corriere giuridico, 1994, n. 3, part. p. 266, per la con-siderazione che l’art. 88 Cost. comprenda due tipi di scioglimento delle Camere:«quello strumentale alle esigenze del regime parlamentare e quello funzionale ai pro-blemi del sistema rappresentativo».
228 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
stiene106. La personalizzazione della campagna elettorale, tutta-via, si riflette inevitabilmente anche sul ruolo del Presidente delConsiglio in carica. Infatti, «l’assetto dei rapporti endogoverna-tivi [è] condizionato dalle modalità seguite per la formazione delGoverno, nonché nella refluenza delle vicende relative alla poli-tica generale del Governo sul circuito organizzatorio, che ne ri-sulta rinsaldato ovvero interrotto»107. Per quanto riguarda nellospecifico il premier, sebbene la nomina al vertice dell’Esecutivodel candidato indicato dalla coalizione in campagna elettoralenon sia giuridicamente vincolante, tra tale candidato e gli elettorisi stabilisce un legame che, almeno in parte, va oltre la media-zione dei partiti, tanto da risultare – di fatto – quasi impossibileper la maggioranza che vince le elezioni indicare un premier dif-ferente da quello sostenuto in campagna elettorale, salvo situa-zioni eccezionali, quali potrebbero essere, ad esempio, un so-pravvenuto impedimento del candidato, oppure, una crisi di go-verno nel corso della legislatura108. In quest’ultima ipotesi,peraltro, non è da escludere che la decisione di cambiare il ver-tice dell’Esecutivo esponga la maggioranza alla valutazione nega-tiva di tale scelta da parte degli elettori alle elezioni successive,come è accaduto già in occasione delle elezioni del 2001.
106 Sulla personalizzazione della campagna elettorale si v. M. CALISE, Presidentia-lization, cit., part. pp. 99 ss., nonché R. CHERCHI, Il governo, cit., part. pp. 200 ss. e 375ss. Appare interessante, inoltre, l’analisi svolta da M. BARISIONE, Interesse per la poli-tica, appartenenza di coalizione e giudizio sui leader: gli effetti della campagna elettorale,in G. PASQUINO (a cura di), Dall’Ulivo, cit., pp. 139 ss., con specifico riferimento alleelezioni del 2001.
107 Così G. PITRUZZELLA, Artt. 92-93, cit., pp. 105-106.108 Secondo M. OLIVETTI, Le dimissioni, cit., pp. 3001-3002, il sistema elettorale
del 1993 «ha (…) consentito agli elettori di indicare direttamente la maggioranza digoverno e lo stesso Presidente del Consiglio, privando così i partiti politici del poteredi contrattazione post-elettorale per la formazione delle coalizioni e dei Governi. Ilnuovo sistema elettorale non ha però sottratto ai partiti politici il potere di rescindere,in corso di legislatura, l’accordo stipulato prima delle elezioni politiche (né ha impo-sto, in siffatta ipotesi, la conseguenza automatica del ricorso alle urne). Per questa viai partiti recuperano quindi il ruolo di King-makers ad essi un tempo spettante in modopressoché esclusivo (…), ma ciò accade comunque solo in parte. In caso di crisi di go-verno, infatti, non si verifica una piena riespansione dell’originario potere di contrat-
229L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
Invero, con il susseguirsi delle legislature maggioritarie, incampagna elettorale si è gradualmente rafforzata la figura del lea-der della coalizione, che, agli occhi degli elettori, rappresental’intera coalizione, anche perché quest’ultima dà ampio risaltoalla personalità scelta per tale ruolo ed anche alle modalità attra-verso le quali si è giunti ad individuarla109. In questo modo, l’o-pinione pubblica identifica con il leader della coalizione dive-nuto Presidente del Consiglio anche il Governo e la maggioranza
tazione dei partiti politici, ma tale potere risulta in vario modo limitato. In primoluogo vi è una forte presunzione di legittimità a favore della coalizione uscente (…).Una volta che la coalizione uscente non sia per qualche ragione ricostituibile, le alter-native fisiologiche si riducono a due: le elezioni anticipate ed il governo tecnico o isti-tuzionale. La formazione del governo D’Alema ha contraddetto questo panorama – fa-cendo riemergere (…) le regole convenzionali della «Prima Repubblica» – ma ciò èstato giustificato nel nome di una (presunta) situazione eccezionale, caratterizzata, daun lato dall’asserita imperfezione del bipolarismo italiano e, dall’altro, dall’aspirazionedei contraenti del nuovo patto di governo di modificare nel breve periodo gli assetticomplessivi del sistema politico». E. CATELANI, Art. 95, cit., p. 1845, invece, osservache, quando, «in un sistema tendenzialmente maggioritario, i partiti della coalizione invia preventiva individuano il candidato a ricoprire la carica di Presidente, il pro-gramma di governo ed in parte anche la compagine governativa che formerà il nuovoesecutivo, l’esponente della maggioranza che viene eletto tende ad assumere, almenoall’inizio della legislatura, un ruolo di “Primo Ministro”». L’A., però, ritiene che lariforma elettorale del 2005 «potrebbe rimettere in discussione il ruolo differenziato delPresidente del Consiglio, potendo venir meno la legittimazione popolare». Si v., però,anche le osservazioni critiche di M. VOLPI, La natura, cit., p. 154.
109 Si pensi, in particolare, alle c.d. primarie svolte dal centro-sinistra nell’otto-bre del 2004 per l’investitura di Romano Prodi a leader della coalizione in vista delleelezioni del 2006 e alle conseguenze che questo procedimento di selezione ha avuto,dapprima sulla nomina di Prodi alla Presidenza del Consiglio dopo l’affermazioneelettorale del centro-sinistra, in seguito sulla incapacità della stessa coalizione di supe-rare la crisi di governo individuando un altro leader attorno al quale costruire unnuovo Esecutivo. Sulle primarie si v. G. PASQUINO, La transizione, cit., pp. 162 ss.Come visto in precedenza (parte III, cap. I, par. 3.5.), un analogo procedimento di se-lezione dei candidati ha ricevuto formale riconoscimento nella Regione Toscana per leelezioni regionali ad opera della l. reg. Toscana 70/2004, sulla quale si v. C. FUSARO, Lalegge regionale toscana sulle primarie, in Le Regioni, 2005, n. 3, pp. 441 ss., M. RUBE-CHI, Considerazioni a prima lettura sulla LR Toscana n. 70 del 2004 che disciplina l’isti-tuto delle elezioni primarie, in www.forumcostituzionale.it, 17 gennaio 2005, e G. TARLI
BARBIERI, Le riforme elettorali della regione Toscana (II), in Democrazia e diritto, 2005,n. 1, pp. 193 ss.
230 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
che lo sostiene. Una tendenza, questa, che certo si è rafforzataanche in virtù delle riforme che hanno modificato la forma di go-verno delle autonomie locali, nelle quali, oramai, il tratto caratte-ristico della rappresentanza politica è dato dall’elezione direttadel Sindaco, del Presidente della Giunta provinciale e del Presi-dente della Giunta regionale, con la conseguente applicazionedel principio aut simul stabunt aut simul cadent110. Di conse-guenza, anche a livello nazionale, nonostante nel susseguirsi dellelegislature maggioritarie le maggioranze parlamentari non ab-biano brillato per coesione, indebolendo il premier nel suo ruolodi guida della coalizione, il Presidente del Consiglio eletto in ma-niera quasi diretta dai cittadini, ha continuato a rafforzare il suoruolo di frontman del Governo dinanzi all’opinione pubblica,rendendo oltremodo difficoltosa la sua sostituzione nel corsodella legislatura111.
Il rafforzamento del leader della coalizione elettorale, succes-sivamente nominato Presidente del Consiglio, è certo evidente neiGoverni guidati da Silvio Berlusconi, quantomeno nella XIV enella XVI legislatura. Tali esperienze, tuttavia, sono caratterizzateanche da una personalità politica che – come leader di uno deidue schieramenti partitici capaci di aspirare alla guida del Paese –ha attraversato tutte le legislature maggioritarie, determinandoanche una personalizzazione della politica dai tratti peculiari112.Dunque, per valutare come hanno inciso sulla leadership deglischieramenti partitici le riforme elettorali in senso maggioritario èforse più indicativa la vicenda del Governo Prodi II.
Romano Prodi è stato scelto dalla coalizione di centro-sini-stra attraverso il procedimento delle c.d. primarie, ovvero, chie-dendo all’elettorato di riferimento dello schieramento di indicareprima delle elezioni quello che – di fatto – sarebbe stato il can-
110 Cfr., in proposito, M. CALISE, Presidentialization, cit., p. 99.111 Sulle difficoltà di sostituire il Presidente del Consiglio indicato dagli elettori
si v. R. CHERCHI, Il governo, cit., p. 379.112 Ci si limita a rinviare, a tal riguardo, a A. BARBERA, I costituzionalisti, nel trionfo
e nel declino del «berlusconismo», in Quaderni costituzionali, 2011, n. 4, pp. 929 ss.
231L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
didato alla Presidenza del Consiglio per la coalizione. Dopo lavittoria del centro-sinistra alle elezioni del 2006, infatti, RomanoProdi è stato nominato Presidente del Consiglio. Nondimeno, lasua leadership all’interno della coalizione si è incrinata subitodopo le elezioni: in primo luogo, per la esile maggioranza sullaquale il centro-sinistra poteva contare al Senato; in secondoluogo, a causa delle costanti frizioni fra le numerose forze politi-che che componevano la maggioranza; infine, per la espressa vo-lontà dello stesso centro-sinistra di individuare un nuovo leaderper le elezioni successive113. Questi elementi di instabilità hannocondotto il Governo – nel febbraio del 2007 – ad una crisi poli-tica114 che è stata superata proprio grazie al riconoscimento daparte della maggioranza del ruolo del Presidente del Consiglio(che si potrebbe definire) “demo-indicato”. Il ricompattamentodella coalizione, infatti, si è avuto intorno ad una lista di prioritàdel Governo115, all’interno delle quali si prevedeva il rafforza-mento del ruolo del premier. Innanzitutto, per assicurare pienaefficacia all’azione di governo, al Presidente del Consiglio venivariconosciuta l’autorità di esprimere in maniera unitaria la posi-zione del Governo stesso in caso di contrasto116. Così facendo, ilrafforzamento del ruolo del premier è evidente, perché gli vienericonosciuto il ruolo di decisore di ultima istanza in caso di con-trasto insorto all’interno del Governo. In secondo luogo, ilportavoce del Presidente del Consiglio assumeva il ruolo di por-tavoce dell’intero Esecutivo117, con la conseguente istituzionaliz-
113 L’individuazione di un nuovo leader della coalizione di maggioranza in vistadelle successive elezioni, infatti, può minare l’autorevolezza del Presidente del Consi-glio in carica: si v., a tal riguardo, C. DELL’ACQUA, Indicazione del premier e poteri delQuirinale, in Quaderni costituzionali, 2001, n. 1, pp. 133-134.
114 Sulla quale si rinvia a G. DORIA, S. TRIPODI, Cronaca di una strana crisi di go-verno, in www.federalismi.it, 27 febbraio 2007, pp. 1 ss.
115 Si tratta della lista dei c.d. 12 punti, che può essere consultata anche inwww.federalismi.it. Si rinvia, inoltre, a G. DORIA, S. TRIPODI, Cronaca, cit., part. p. 6.
116 Si tratta del punto n. 12 della lista indicata.117 Cfr. punto n. 11 della lista.
232 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
zazione di tale figura118. Anche questo passaggio dovrebbe ga-rantire il rafforzamento del Presidente del Consiglio secondodue prospettive differenti: all’interno dell’Esecutivo, perché isingoli ministri non dovrebbero manifestare all’esterno opinionidivergenti da quella espressa ufficialmente dal portavoce, ilquale, a sua volta, ha un rapporto privilegiato con il premier; neiconfronti dell’opinione pubblica, che dovrebbe vedere rappre-sentato l’intero Esecutivo dal solo portavoce e, di conseguenza,dallo stesso premier, sebbene in maniera mediata.
Il rafforzamento della visibilità e della responsabilità politicadel Presidente del Consiglio nei confronti dell’opinione pub-blica, peraltro, tende inevitabilmente ad incidere anche sui rap-porti tra lo stesso vertice dell’Esecutivo e la maggioranza che losostiene. Dal legame diretto – prevalentemente di carattere me-diatico119 – che si instaura tra premier e cittadini, infatti, derivache le valutazioni formatesi nell’opinione pubblica sul suo ope-rato si riflettono direttamente sull’intero Esecutivo e sulla coali-
118 Con la nomina attraverso un d.p.c.m. firmato dal Presidente del Consiglio il16 marzo 2007. Si v., ora, il d.p.c.m. 1 marzo 2011, art. 9.
119 Sul rapporto tra cambiamento della struttura dei media e rafforzamento dellafigura del premier si v. T. POGUNTKE, P. WEBB, The Presidentialization of Politics inDemocratic Societies: a Framework for Analysis, in ID. (eds.), The Presidentialization,cit., pp. 14 ss., secondo i quali «presidentialized chief executives (and party leaders) in-creasingly govern past their parties and, equally important, past the most important socialforces which support them. Skilful use of modern mass communication has become animportant resource for this strategy, and the recourse to a personalized mandate makesmodern leaders simultaneously both stronger and weaker. As long as they can ride thetiger of an increasingly fickle public opinion, they can ‘go it alone’; once public supportbegins to dwindle, however, they are left whit few allies» (p. 22). Non è possibile, inquesta sede, soffermarsi sull’influenza esercitata dai mezzi di comunicazione di massasulle scelte elettorali; ci si limita a rinviare a D. MCQUAIL, Media performance: mancommunications and the public interest, London, Sage, 1992, trad. it., I media in demo-crazia, Bologna, il Mulino, 1995, S. RODOTÀ, La sovranità nel tempo della tecnopolitica.Democrazia elettronica e democrazia rappresentativa, in Politica del diritto, 1993, n. 4,pp. 569 ss., e ID., Tecnopolitica, nuova edizione accresciuta, Roma-Bari, Laterza, 2004,nonché a G. PITRUZZELLA, Forme, cit., pp. 76-77, che ricostruisce sinteticamente il rap-porto tra televisione e politica, escludendo le «visioni “apocalittiche”» di tale rap-porto, e G. GUARINO, Riflessioni sui regimi democratici, in Politica del diritto, 1991, n.1, part. pp. 18-20.
233L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
zione di governo. Quest’ultima, di conseguenza, è praticamentecostretta a fare quadrato intorno al Presidente del Consiglio, an-che nel caso di dissidi interni alla stessa maggioranza, perché lecritiche all’operato del Presidente del Consiglio rischiano di tra-volgere l’intera coalizione, in quanto egli – dinanzi all’opinionepubblica – ne rappresenta la sintesi. Inoltre, la sostituzione du-rante la legislatura del premier “demo-indicato” con un altroscelto dalla stessa maggioranza, potrebbe apparire come l’am-missione di aver clamorosamente sbagliato la scelta del candi-dato alla Presidenza del Consiglio e, di riflesso, del fallimentodella politica del Governo e dell’intera maggioranza120. Ne derivache il Presidente del Consiglio risulti rafforzato anche nei con-fronti della maggioranza che sostiene il suo Governo, la qualedeve continuare a sostenere l’Esecutivo anche se l’indirizzo poli-tico determinato dal premier è parzialmente divergente da quelloauspicato dalle forze politiche di maggioranza121. Quando, in-
120 Dopotutto, come osserva S. MANGIAMELI, La forma, cit., pp. 159 ss., «i partitipolitici adottano i loro comportamenti e operano nelle istituzioni sulla base della con-vinzione che le scelte compiute nell’ambito della competizione imposta dal sistema èrilevante per (ed influenza) l’opinione pubblica. Da questo punto di vista, nessunamaggioranza (e nessuna opposizione) può essere indifferente a quello che pensa l’opi-nione pubblica e un Governo, nell’assumere le sue decisioni, finisce necessariamenteper tenerne conto. La condizione in cui si vengono a trovare le forze politiche, che agi-scono nella forma di governo parlamentare, diventa così alquanto singolare, dal mo-mento che ogni posizione assunta, essendo collegata allo studio preventivo delle possi-bili reazioni che possono tradursi in conseguenze elettorali, trasforma l’attività di go-verno e la condotta dell’opposizione in una continua campagna elettorale, nella qualeproporre continuamente le ragioni delle proprie posizioni e della differenziazione».L’A., però, ricorda opportunamente che l’opinione pubblica non rappresenta il corpoelettorale e, quindi, un comportamento politico adesivo alla volontà della prima po-trebbe anche non essere premiato alle elezioni. Sull’opinione pubblica si rinvia alle os-servazioni di C. SCHMITT, Verfassungslehre, cit., part. pp. 317 ss., nonché a J. HABER-MAS, Strukturwandel der Oeffentlichkeit, Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag,1962, trad. it., Storia e critica dell’opinione pubblica, Roma-Bari, Laterza, 1977.
121 Secondo P. WEBB, T. POGUNTKE, The Presidentialization of Contemporary De-mocratic Politics: Evidence, Causes, and Consequences, in T. POGUNTKE, P. WEBB (eds.),The Presidentialization, cit., p. 340, infatti, «the presidentialization of the executive facedoes not always coincide with increased legislative power. First and foremost, it impliesa reduction of the party’s political influence on executive leadership. Presidentialized
234 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
vece, la situazione politica sia tale da rendere inevitabile una crisidi governo, appare difficile che la maggioranza sia in grado di ri-compattarsi intorno ad una personalità diversa da quella soste-nuta in campagna elettorale, sicché l’esito di una crisi di governodetermina altresì la fine anticipata della legislatura, esattamentecome accaduto con il Governo Prodi II.
Le osservazioni sin qui svolte, appaiono confortare l’opi-nione che le riforme elettorali in senso maggioritario tendano arafforzare la posizione del leader di una coalizione non solo du-rante la campagna elettorale, ma anche nella sua veste di Presi-dente del Consiglio dei ministri. Tali osservazioni si fondano, evi-dentemente, sulla analisi di comportamenti e rapporti di carat-tere politico ed elettorale che sono certo caratterizzati da unnotevole grado di mutevolezza122; tuttavia, essi consentono di in-dividuare ugualmente un trend nel mutamento del ruolo del Pre-sidente del Consiglio, iniziato già prima della riforma elettoralemaggioritaria123, che può essere verificato anche sulla scorta del-l’evoluzione della normativa relativa al premier e al suo apparatoamministrativo.
2.5.2. La modificazione del ruolo del Presidente del Consiglio deiministri: in seguito alle riforme normative
Si è già osservato124 che la posizione dell’intero Esecutivo ri-sulta valorizzata dal sistema di multilevel governance che si è svi-
chief executive, whether presidents or prime ministers, tend to govern past their partiesrather than through them – even if this undermines their chances of realizing theirlegislative agenda».
122 Appare utile rinviare alle osservazioni di A. RUGGERI, Il Governo, cit., p. 318,sulla «evidente instabilità e confusione del quadro politico».
123 Per alcune “tendenze maggioritarie” anteriori alla riforma elettorale del1993, ma anche all’approvazione della l. 400/1988, si rinvia a G. PITRUZZELLA, Il Con-siglio, cit., pp. 643 ss.; sulla tendenza al rafforzamento del Presidente del Consiglio edel suo apparato amministrativo, sempre nel periodo indicato, si rinvia alle osserva-zioni di S. CASSESE, Esiste, cit., pp. 29 ss., e G. GUARINO, Il Governo, cit., pp. 407 ss. Siv. anche M. COTTA, Il Parlamento nel sistema politico italiano. Mutamenti istituzionalie cicli politici, in Quaderni costituzionali, 1991, n. 2, part. pp. 217 ss.
124 Supra, parte III, cap. II, par. 2.4.
235L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
luppato in conseguenza del processo di integrazione comunitariae della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali. Questiprocessi tendono ad accrescere ulteriormente il ruolo del Presi-dente del Consiglio, perché delicate funzioni di coordinamento ecooperazione tra i differenti livelli di governo sono esercitatedalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, con laconseguente assunzione da parte del premier di un ruolo centraleall’interno di tali processi.
Nel senso del rafforzamento della posizione del premier do-vrebbero spingere anche quelle riforme che hanno puntato a ga-rantire la separazione tra attività politica e attività amministrativadei ministeri125. Con l’attuazione di tale separazione, infatti, i mi-nistri dovrebbero occuparsi prevalentemente di determinare gliindirizzi politici di settore, caratterizzando in senso essenzial-mente politico la loro attività. Così facendo, assumono maggiorerilievo i compiti di indirizzo politico, promozione e coordina-mento dell’attività dei ministri attribuiti dalla Costituzione alPresidente del Consiglio e, di conseguenza, può rafforzarsi anchela sua posizione all’interno dell’Esecutivo e in particolare neiconfronti dei singoli ministri126.
Per quanto riguarda le riforme normative che hanno inte-ressato nello specifico l’ordinamento del Governo, un passaggiofondamentale è costituito dalla l. 400/1988127. Si è già osservatoche la legge in questione non ha assunto posizione sulla convi-venza dei principî monocratico e collegiale nell’organizzazionedel Governo. Nondimeno, definendo l’organizzazione e la strut-tura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri,tale legge ha riconosciuto un appropriato apparato amministra-tivo attraverso il quale consentire al Presidente del Consiglio diesercitare in maniera più incisiva i propri poteri. In questomodo, si è riusciti a perseguire un – seppur parziale – rafforza-
125 Di tale tendenza e dei suoi limiti si è già discusso supra, parte II, cap. II,par. 3.
126 Si v., in proposito, le osservazioni di L. ARCIDIACONO, Relazione, cit., p. 56.127 Sulla quale si rinvia supra, parte I, cap. I, par. 5.2.
236 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
mento del premier, senza una riforma costituzionale, bensì prov-vedendo – sebbene con grave ritardo – all’attuazione della Costi-tuzione del 1947128, almeno per quanto riguarda la riserva dilegge prevista dall’art. 95, co. 3, Cost. sull’ordinamento dellaPresidenza del Consiglio129.
La seconda tappa del percorso di modificazioni normativeattraverso la quale ripercorrere il progressivo potenziamento delPresidente del Consiglio dei ministri, è rappresentata dal già ci-tato d.lgs. 303/1999130. Anche in questo caso, come nel 1988, loscopo perseguito appare quello di rafforzare il ruolo del premier,in assenza di una apposita riforma costituzionale131. Il decreto le-gislativo del 1999, infatti, attraverso il riordino della Presidenzadel Consiglio dei ministri, punta a rendere più incisive le fun-zioni di impulso, indirizzo e coordinamento dell’attività dell’in-tero Esecutivo attribuite al Presidente del Consiglio132, garanten-dogli un ruolo centrale sia in relazione alla partecipazione dell’I-talia all’Unione europea133, sia nel sistema delle autonomie,
128 Secondo C. D’ORTA, La riforma, cit., p. 6, il potenziamento del ruolo del Pre-sidente del Consiglio, «anziché in una forma diretta ed esplicita che avrebbe probabil-mente sollevato resistenze, è apparso concretamente realizzabile per via indiretta, at-traverso il potenziamento dell’apparato servente del presidente».
129 Il che, peraltro, sembra indicare comunque un rafforzamento del principiomonocratico: cfr., in proposito, A. PAJNO, La presidenza, cit., part. p. 54.
130 Cfr. supra, parte I, cap. I, par. 5.3.131 Appare utile fare riferimento ancora a C. D’ORTA, La riforma, cit., p. 7, se-
condo il quale, infatti, l’intento della normativa del 1999, «più che riformare l’orga-nizzazione amministrativa in senso stretto della Presidenza, è quello di utilizzare lariforma della Presidenza come strumento di intervento sul sistema politico-costituzio-nale, per potenziare il ruolo del presidente del Consiglio».
132 Secondo C. D’ORTA, La riforma, cit., p. 8, infatti, il d.lgs. 303/1999 ha postole premesse per fare della Presidenza del Consiglio dei ministri «la vera “cabina di re-gia” della politica governativa». Secondo U. DE SIERVO, Considerazioni, cit., p. 314,però, sulla via del rafforzamento della Presidenza del Consiglio, con il d.lgs. 303/1999«si è andati addirittura oltre a quanto compatibile con il nostro generale assetto costi-tuzionale»; l’A., in particolare, faceva riferimento all’art. 9, co. 7, primo periodo, deld.lgs. 303/1999, che, in effetti, è stato dichiarato incostituzionale (cfr. Corte costitu-zionale, sent. 221/2002, part. punti 5 ss. cons. dir.).
133 Si v., in particolare, l’art. 3 del d.lgs. 303/1999.
237L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
configurandolo come organo deputato a garantire il coordina-mento tra i differenti livelli territoriali di governo134.
Un ulteriore rafforzamento della posizione del Presidentedel Consiglio e del suo apparato amministrativo è stato realizzatoattraverso una serie di disposizioni previste dal più volte citatod.l. 181/2006.
Vengono in questione, innanzitutto, quelle disposizioni chehanno sottratto competenze e risorse ai ministeri per attribuirleal premier e alla Presidenza del Consiglio dei ministri135. Conqueste disposizioni, infatti, non solo sono state attribuite al pre-mier una serie di funzioni che erano particolarmente rilevantinell’ambito delle competenze dei dicasteri cui spettavano in pre-cedenza136 ma sono state anche trasferite alla Presidenza delConsiglio tutte le risorse necessarie allo svolgimento di tali nuovefunzioni: personale, strutture e risorse economiche137. Questi tra-sferimenti rafforzano il ruolo del Presidente del Consiglio, siaperché gli attribuiscono funzioni di notevole rilievo, sia perchégli consentono di incidere su vari ambiti della politica del Go-verno, influendo e interagendo con le competenze specifiche dideterminati ministri. Le modificazioni previste dal decreto leggedel 2006, inoltre, rafforzano anche la Presidenza del Consiglio, laquale vede ulteriormente incrementate le sue risorse e le suecompetenze, trasformandosi sempre più da apparato serventedel premier in struttura centrale dell’amministrazione del Go-verno, cui sono attribuiti compiti diversificati e inerenti a molte-plici settori di intervento dell’intero Esecutivo.
134 Cfr. l’art. 4 del d.lgs. 303/1999 e le osservazioni di A. PAJNO, La presidenza,cit., part. p. 69.
135 Si consideri, in particolar modo, l’art. 1, co. 2, 19, 19-bis, 22 e 22-bis, del d.l.181/2006.
136 Si pensi, in particolare, alla rilevanza delle funzioni in materia di turismo, sot-tratte al ministero delle attività produttive (cfr. art. 1, co. 19-bis, del d.l. 181/2006).
137 Secondo il d.p.c.m. 1 marzo 2011, infatti, fanno parte del segretariato gene-rale della Presidenza del Consiglio tutte le strutture non affidate alla responsabilità diministri o poste alle dirette dipendenze di sottosegretari (art. 3, co. 1), comprese quelleche abbiano cessato di essere affidate a ministri o sottosegretari (art. 4, co. 1).
238 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
Un’altra disposizione del d.l. 181/2006 che necessita di es-sere esaminata è quella che riguarda le attribuzioni dei ministrisenza portafoglio. In proposito, la l. 400/1988 prevedeva: «Ogniqualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senzaportafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1,tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio deiministri che può delegarli ad altro ministro»138. Questa disposi-zione è stata modificata nel 2006: «Ogni qualvolta la legge o al-tra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti speci-fici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici odipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessisi intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidentedel Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a unSottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri»139. La disposizione, nel suo testo originario, era volta –evidentemente – a garantire che, nell’ipotesi in cui un Governonon avesse istituito determinati ministri senza portafoglio, i rela-tivi compiti fossero comunque svolti, grazie alla loro attribuzioneal Presidente del Consiglio e alla successiva delega ad altro mini-stro. La riforma del 2006, invece, sembra ispirata da una ratioben diversa: dal tenore della modificazione e dal suo confrontocon il testo previgente, infatti, si può ritenere che determinaticompiti siano ormai da considerarsi come compiti propri del pre-mier e della Presidenza del Consiglio dei ministri e che la no-mina di un ministro senza portafoglio possa solo temporanea-mente portare alla delega a questi di alcune di tali funzioni. Ap-pare evidente, dunque, il mutamento di prospettiva: nel testoprevigente, il Presidente del Consiglio sembrava supplire ad unamomentanea mancanza di un soggetto cui attribuire in manieraappropriata determinati compiti; nel testo novellato, il premier ela Presidenza del Consiglio appaiono i titolari di determinati
138 Art. 9, co. 2, della l. 400/1988, nel testo previgente.139 Art. 9, co. 2, della l. 400/1988, come modificato dall’art. 1, co. 22-ter, del d.l.
181/2006.
239L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
compiti, che, solo ove ritenuto (politicamente) necessario, pos-sono essere delegati ad un ministro senza portafoglio. Anche inquesto caso sembra emergere il rafforzamento del Presidente delConsiglio, in particolare nei confronti dei ministri senza portafo-glio: questi ultimi, infatti, anche qualora sia necessario istituirliper garantire determinati equilibri politici all’interno di un Go-verno sostenuto da una maggioranza composita, sono chiamati asvolgere compiti propri del premier, che solo momentaneamentevengono loro delegati, e che devono comunque esercitare avva-lendosi dell’apparato amministrativo della Presidenza del Consi-glio dei ministri140.
2.5.3. Il rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio fratendenze contrastanti
Nelle legislature maggioritarie si può dunque rilevare unatendenza al rafforzamento del principio monocratico all’internodel Governo, ma si tratta di una tendenza che ha trovato una no-tevole resistenza. Esemplare, in proposito, è la vicenda legata alnumero di ministeri141. Con il d.lgs. 300/1999, infatti, il numerodi dicasteri era stato ridotto a dodici. La riduzione della compa-gine ministeriale può rappresentare un ulteriore elemento dirafforzamento del premier, il quale, dovendo coordinare l’attivitàdi un numero contenuto di ministri, riesce a svolgere più effica-cemente il suo ruolo142. Il numero di dicasteri, però, è tornato ra-
140 Appare utile rinviare alle osservazioni di A. RUGGERI, Il Governo, cit., pp.336-337, il quale – prima, però, della riforma indicata nel testo – ipotizzava una confi-gurazione di alcuni ministri senza portafoglio alla stregua di «Ministri “coordinatori”,aventi competenze su “materie” trasversali». Sulla figura del ministro “coordinatore”membro di comitato interministeriale si rinvia, invece, a G. PITRUZZELLA, Il ministro,cit., pp. 194 ss.
141 Si rinvia anche a quanto già detto supra, parte I, cap. I, par. 5.3.142 In questo senso L. ARCIDIACONO, Relazione, cit., pp. 55-56, secondo il quale
la riduzione del numero di ministeri «dovrebbe aumentare l’efficacia dell’attività di di-rezione del Presidente [del Consiglio], non come potenziamento del principio mono-cratico all’interno del Governo, ma quale conseguenza del suo ruolo costituzionale diresponsabile dell’unità di azione dell’Esecutivo».
240 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
pidamente a salire: quattordici nella XIV legislatura e ben di-ciotto nella legislatura successiva, mentre nella XVI legislatura ilnumero è sceso a tredici con il Governo Berlusconi IV e a dodicicol Governo Monti. L’aumento del numero di ministeri, da unlato, è indicativo della frammentazione della maggioranza che so-stiene il Governo e, quindi, della sua scarsa coesione; dall’altro,incide sulla posizione del Presidente del Consiglio, che, anzichéassumere il ruolo di guida di un Governo agile e – per quantopossibile in un Esecutivo di coalizione – compatto, è nuova-mente costretto a svolgere il ruolo di mediatore tra le diverseanime politiche della coalizione rappresentate all’interno delConsiglio dei ministri143.
Un altro elemento che non pare favorire la coesione dell’E-secutivo né il rafforzamento del ruolo del Presidente del Consi-glio è l’affermarsi della figura dei vice ministri. Il formale ricono-scimento di tale organo non necessario del Governo144 e l’au-mento delle relative prerogative145, infatti, contribuiscono adaumentare il numero di partecipanti alle sedute del Consiglio deiministri – seppure, nel caso dei vice ministri, senza diritto divoto – e, di conseguenza, a rendere il collegio numericamentepiù ampio e meno coeso, soprattutto se si considera che i viceministri sono – di solito – espressione di una forza politica diffe-rente da quella del ministro di riferimento146.
Un ulteriore fattore di contrasto al rafforzamento del princi-pio monocratico all’interno dell’organizzazione del Governo è
143 Ciò vale, evidentemente, anche per l’aumento del numero di ministri senzaportafoglio e di sottosegretari, come osserva M. VOLPI, La natura, cit., pp. 163-164.
144 Cfr. la l. 400/1988, art. 10, co. 3 e 4, come modificato dalla l. 81/2001, art. 1,e dal d.l. 217/2001, art. 12, convertito, con modificazioni, dalla l. 317/2001.
145 Cfr. il già citato d.l. 181/2006, art. 1, co. 24-quater, 24-quinquies, 25-quater e25-quinquies.
146 Si considerino i sei vice ministri del Governo Berlusconi II all’inizio dellaXIV legislatura, i nove nominati dal Governo Berlusconi III, i dieci del Governo ProdiII all’inizio della XV legislatura e i sette complessivamente nominati dal Governo Ber-lusconi IV. Il Governo Monti, infine, ha nominato solo tre vice ministri, uno dei quali,quello per l’economia, è poi divenuto ministro dell’economia e delle finanze al postodel premier, che in precedenza deteneva l’interim di tale dicastero.
241L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
rappresentato dall’alto numero di partiti. Appare piuttosto evi-dente, infatti, che la frammentazione del sistema dei partiti e, diconseguenza, delle coalizioni, operi chiaramente in senso contra-rio al rafforzamento del premier147. Se una coalizione è compostada un numero elevato di partiti, infatti, essi – come si è già visto148
– per acquisire consenso elettorale avranno la necessità di eviden-ziare le loro peculiarità ideologiche, distinguendosi anche daglialtri partiti della coalizione, oltre che dai partiti dello schiera-mento contrapposto. Tale esigenza comporta che le forze politi-che di minori dimensioni dovranno rimarcare la differenza delleloro posizioni anche dal premier, che, di solito, è espressione diuno dei partiti maggiori della coalizione, indebolendo, così, sia lacoesione dell’intera coalizione sia il ruolo di guida della maggio-ranza e dell’Esecutivo rivestito dal Presidente del Consiglio149.
Sembra comunque possibile sostenere che anche nel nostroordinamento, al pari di quanto accade in altri ordinamenti de-mocratici contemporanei, si assiste ad un rafforzamento della fi-gura del vertice dell’Esecutivo150, nonostante questa tendenza
147 Secondo G. PASQUINO, Parlamento, cit., p. 11, infatti, «in Italia nessun go-verno del primo ministro riuscirà mai a configurarsi come “forte” semplicemente gra-zie a qualche meccanismo istituzionale, ad esempio, “immediata”, nel doppio signifi-cato dell’aggettivo, entrata in carica del capo del governo, attribuzione del potere dinomina e revoca dei ministri e di scioglimento del parlamento. Otterrebbe, invece,questa possibilità una volta che il sistema dei partiti, e, se si vuole, delle coalizioni, saràstato opportunamente strutturato cosicché il primo ministro riesca a godere di quelpotere politico che ha reso e rende “forti”, ovvero autorevoli, gli altri capi di governodelle democrazie parlamentari, e non solo». Si v. anche R. CHERCHI, Il governo, cit., pp.393-394 e 415 ss.
148 Supra, parte III, cap. I, par. 2.149 In proposito, però, L. ELIA, Forme di stato e forme di governo, in S. CASSESE
(diretto da), Dizionario, vol. III, cit., p. 2600, osservava correttamente che, «se i partitiinfluiscono sugli assetti di governo, a loro volta questi ultimi e le leggi elettorali pos-sono incidere anche profondamente sul contesto partitico».
150 Cfr., in proposito, le osservazioni di A. BARBERA, C. FUSARO, Il governo delledemocrazie, 2ª ed., Bologna, il Mulino, 2001, p. 83, L. ELIA, La presidenzializzazionedella politica, in Teoria politica, 2006, n. 1, pp. 5 ss., G. PASQUINO, Leadership e comu-nicazione politica, in AA.VV., Scritti in onore di Aldo Bozzi, Padova, Cedam, 1992, pp.467 ss., nonché T. POGUNTKE, P. WEBB (eds.), The Presidentialization of Politics, cit., in
242 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
non sia stata sostenuta da una apposita riforma costituzionale,bensì attraverso varie modificazioni normative sia elettorali siadell’ordinamento del Governo, seguendo percorsi tutt’altro chelineari151. La conseguenza più evidente di tale rafforzamento con-siste in un indubbio aumento del tasso di “democrazia di inve-stitura”, almeno del vertice dell’Esecutivo, ma senza aver conse-guito nel contempo un elevato grado di “democrazia di opera-zione”, perché la frammentazione partitica e, quindi, dellemaggioranze di governo, non riesce a garantire la piena realizza-zione dei punti salienti del programma di governo152.
2.6. Gli organi “non necessari” del Governo
Come si è già avuto modo di osservare, gli organi non ne-cessari del Governo nascono spesso in maniera informale, a
particolare ID., The Presidentialization of Politics in Democratic Societies, cit., pp. 1 ss.Per l’opinione che ritiene necessario un rafforzamento del leader dell’Esecutivo, si rin-via a S. FABBRINI, Il Principe democratico, Bari, Laterza, 1999, part. pp. 207-208.
151 Secondo P. CIARLO, Governo, cit., pp. 204-205, infatti, in Italia «il vero pro-blema non va ravvisato tanto nel consolidarsi del dominio degli esecutivi, peraltro co-mune a quasi tutti i paesi simili al nostro, ma nelle modalità secondo cui questa tra-sformazione sta avvenendo. Modalità che, essendo il frutto di un processo continuo ditrasformazione sicuramente hanno il pregio della gradualità e della flessibilità, ma al-tresì il limite di una certa indistinzione, spesso dell’occasionalità. In certa misura edinevitabilmente ciò è nelle cose, nel senso che le grandi trasformazioni innanzitutto ac-cadono, e solo in parte seguono una progettualità. Ma nel caso italiano si ha la sensa-zione che la trasformazione del sistema istituzionale stia avvenendo al di fuori di qual-siasi disegno strategico, senza cioè che sia individuabile una prospettiva di fondo, unatendenza consapevolmente orientata verso nuovi assetti istituzionali». Secondo F. MU-SELLA, L’evoluzione della forma di governo in Italia. Populismo presidenziale al lavoro?,in Democrazia e diritto, 2010, n. 3/4, p. 127, le modalità attraverso le quali si è raffor-zato il ruolo del premier, in assenza di modifiche formali della Costituzione, hannocondotto all’affermazione di una sorta di “populismo presidenziale”, fondato sul «col-legamento costante – elettorale e mediatico – fra leader ed elettorato».
152 Si riprende la distinzione tra la democrazia “di investitura” e quella “di ope-razione” delineata da L. ELIA, Governo, cit., p. 650. Secondo L. CARLASSARE, Relazione,cit., p. 96, in realtà, l’esaltazione della tendenza alla personalizzazione del potere ser-virebbe anche a «compensare e coprire la vaghezza dei programmi (una sorta di delegain bianco, la cui irrazionalità diviene superabile solo giustificandola con la ‘capacità’,le ‘qualità’ o i ‘carismi’ della persona designata)».
243L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
causa di specifiche esigenze del Governo o degli equilibri politicidella maggioranza che lo sostiene, ma possono anche ottenere unsuccessivo riconoscimento normativo. Il formale riconoscimentodi tali organi, tuttavia, non ne garantisce la sopravvivenza, per-ché la loro concreta istituzione dipende da situazioni politichecontingenti. Esemplare, in proposito, è la sorte del Consiglio diGabinetto153. Questo collegio ristretto di ministri, che era sortonella prassi, dopo essere stato espressamente riconosciuto dalla l.400/1988 è rapidamente scomparso dal panorama istituzionale.
Invero, per quanto attiene agli organi non necessari del Go-verno costituiti per esigenze politiche della coalizione di maggio-ranza, occorre considerare che tale esigenza è strettamente legataalle caratteristiche della coalizione. La presenza di più vice presi-denti del Consiglio, ad esempio, dipende dalla composizioneframmentata della maggioranza e dalla conseguente necessità diaffiancare al Presidente del Consiglio degli esponenti di spiccodei principali partiti che compongono la coalizione154. Invece,qualora la maggioranza di governo dovesse essere “monocolore”,l’esigenza di ricorrere ai vice premier probabilmente verrebbemeno155.
Altri organi, invece, nascono per garantire un maggiorecoordinamento dell’azione di governo, che non viene rimessa intoto al Consiglio dei ministri, sia per motivi di efficienza nel suofunzionamento, così da evitare un inutile surplus di lavoro pertale organo, sia perché l’assunzione di talune decisioni attienealla competenza di un numero limitato di ministri e sarebbe inu-tile e controproducente coinvolgere l’intera compagine ministe-riale in tali decisioni, soprattutto quando il numero di parteci-
153 Relativamente al quale si rinvia a quanto già osservato supra, parte II, cap. II,par. 2.2.
154 Nel Governo Prodi II, ad es., i due vice presidenti del Consiglio appartene-vano ai due maggiori partiti della coalizione di maggioranza: i DS e la Margherita. Si v.anche S. MANGIAMELI, La forma, cit., part. p. 65 e nt. 166, nonché supra, parte I, cap.I, par. 5.2.
155 … e un discorso sostanzialmente analogo potrebbe farsi per i vice ministri.
244 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
panti al Consiglio dei ministri è piuttosto elevato. Il ricorso a talicollegi ristretti appare quasi fisiologico nello Stato sociale con-temporaneo, se si considera che l’interesse dello Stato per vastiambiti della vita sociale rende inevitabile la formazione di appa-rati amministrativi complessi e, di conseguenza, anche di Esecu-tivi numericamente consistenti156. Ciò nonostante, il ricorso a taliorgani è apparso alquanto problematico nel nostro ordinamento,perché la loro costituzione è stata contrastata sia dalla dottrinacostituzionalistica, sia dalla politica. Dal primo punto di vista, ilricorso a un collegio ristretto di ministri è parso esautorare ilConsiglio dei ministri (almeno) di una parte delle funzioni attri-buitegli dalla Costituzione, sollevando numerosi dubbi sulla le-gittimità costituzionale di un organo siffatto. Dal punto di vistapolitico, invece, la previsione di un collegio formato dai ministriconsiderati più importanti crea attriti tra le forze politiche checompongono la coalizione di governo, perché tale organo, da unlato, rende palese il differente peso politico dei diversi ministri,dall’altro, comporta una discriminazione tra i partiti rappresen-tati nel collegio ristretto e quelli che ne sono esclusi. Tali dubbipossono – forse – contribuire a spiegare perché il ricorso ad unorgano come il Consiglio di Gabinetto sia stato particolarmentelimitato nell’esperienza italiana.
Tuttavia, alcuni collegi ristretti di ministri continuano a farparte della struttura del Governo italiano in maniera pratica-
156 Si v., in proposito, le osservazioni di E. BALBONI, La funzione di governo oggi,in AA.VV., Annuario 2001, cit., pp. 276-277, nonché F. ORFINO, I comitati, cit., p. 11.Appare utile rinviare anche a C. ROSSANO, Problemi di struttura dello Stato sociale con-temporaneo, Napoli, Jovene, 1978, part. pp. 14-15, il quale ricostruisce i fenomeni che«hanno portato all’esigenza di un ampliamento notevolissimo del campo di azionedella politica statale, non confrontabile con nessuna altra situazione storica. Lo Statooggi si trova costretto ad operare, con intensità sempre crescente, in settori per i qualiprima un suo intervento era considerato una vera e propria eccezione, essendo essinormalmente riservati esclusivamente all’autonomia degli operatori privati. (…) Sirende quindi necessario procedere non per singoli settori, mediante una specializza-zione di tipo tradizionale, ma con opera di coordinamento che abbracci tutti i settori».Si v., infine, l’agile ricostruzione di G. GUARINO, Stato sociale e sviluppo in Italia (1945-1992): notazioni e ipotesi, in Economia italiana, 2007, n. 1, pp. 129 ss.
245L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
mente ininterrotta sin dal periodo prerepubblicano: i comitatiinterministeriali, appunto. Il costante ricorso a tali organi è do-vuto – presumibilmente – alla loro flessibilità, poiché apparepossibile adeguarne la struttura e il funzionamento alle modifica-zioni della struttura del Governo. E proprio delle modificazioniche hanno riguardato i comitati interministeriali occorre ora oc-cuparsi.
2.7. Il caso specifico dei comitati interministeriali
Per quanto attiene alle modificazioni inerenti i comitati in-terministeriali, occorre in primo luogo richiamare succintamentel’evoluzione del sistema creato da tali organi non necessari delGoverno delineata in precedenza157.
Come si è già visto, prima della riforma attuata con la l.537/1993, il sistema dei comitati era costituito da un considere-vole numero di organi, presieduti da vari ministri, in maniera taleda attribuire (tendenzialmente) la presidenza di almeno un co-mitato a ciascun ministro, e con competenze prevalentemente inmaterie economiche e finanziarie. Questo sistema è stato gra-dualmente scardinato, tanto che i comitati oggi esistenti che pos-sono farsi rientrare nella struttura del Governo sono solamentesei: il CICR, il CIPE, il CIACE, il Comitato interministeriale per l’in-dirizzo e la guida strategica per le politiche di semplificazione edi qualità della regolazione, il CISR e il Comitato interministerialeper la revisione della spesa pubblica. Relativamente a questi co-mitati, occorre subito ribadire i dubbi espressi in merito alla so-pravvivenza del CICR158.
Tale comitato, infatti, appare oggi un vero e proprio “resi-duato” del passato, perché le sue funzioni e la sua composizionelo rendono scarsamente compatibile con il vigente sistema credi-tizio e bancario. Inoltre, mentre gli altri comitati appaiono costi-
157 Cfr. supra, parte II, cap. II, par. 3.158 Cfr. supra, parte II, cap. II, par. 4.1.
246 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
tuire un sistema di organi sufficientemente omogenei tra loro, ilCICR è profondamente diverso per composizione e funzioni,tanto da non sembrare riconducibile all’interno di tale sistema.Non sorprende affatto, quindi, che – come si è già visto – anchein Parlamento si sia ipotizzata la sua soppressione.
All’altro estremo si situa il comitato di più recente istitu-zione, quello destinato ad occuparsi della c.d. spending review.Anche in questo caso occorre sottolineare le peculiarità dell’or-gano, istituito da un Governo “tecnico”, il Governo presiedutoda Mario Monti, nato in seguito alla grave crisi economico-fi-nanziaria internazionale e sostenuto dalla maggior parte delleforze politiche presenti in Parlamento. Questo comitato è statoistituito in un momento particolare per due ordini di motivi: inprimo luogo, è un organo destinato ad occuparsi di spesa pub-blica in una peculiare fase di contingenza economica; in secondoluogo, è istituito da un Governo “tecnico” in un momento in cuiil sistema maggioritario prodotto dalle riforme elettorali del 1993e del 2005 appare sempre più in crisi e sembra farsi più concretala possibilità di una nuova riforma elettorale. Nonostante ciò, an-che il Comitato interministeriale per la revisione della spesa pub-blica pare mantenere buona parte dei caratteri propri dei comi-tati istituiti nel primo decennio degli anni duemila.
L’analisi che segue, dunque, prenderà in considerazione il si-stema di comitati composto da quegli organi istituiti o profonda-mente modificati nel corso delle legislature maggioritarie: i trecomitati interministeriali istituiti tra il 2005 e il 2007, nonché ilCIPE, alla luce delle più recenti modificazioni della sua disciplina.Nelle prossime pagine si cercherà di verificare – è bene antici-parlo sin d’ora – se l’assetto del sistema dei comitati intermini-steriali configuratosi durante le legislature maggioritarie abbiaseguito la tendenza al rafforzamento del Presidente del Consigliodei ministri all’interno del Governo, che, come si è visto, si è ac-centuata dopo la riforma elettorale maggioritaria.
Prendendo in considerazione, innanzitutto, la loro composi-zione, i comitati sono costituiti da un numero differente di mem-
247L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
bri stabili dell’organo che, tuttavia, può essere considerato gene-ralmente piuttosto contenuto, considerato che tutti i comitatihanno meno di dieci componenti fissi159. Tutti i comitati intermi-nisteriali, tuttavia, hanno una composizione parzialmente flessi-bile, perché – sebbene con modalità differenti – consentono lapartecipazione alle riunioni dell’organo anche di altri ministri,individuati volta per volta, sulla scorta delle materie oggettodella riunione160. Queste previsioni comportano certo un au-mento del numero di membri del comitato, ma – allo stessotempo – consentono all’organo di adeguare la propria composi-zione alle diverse necessità connesse agli argomenti da trattare.Tale flessibilità rende possibile manifestare – all’interno del co-mitato – le posizioni di tutti i ministri interessati ad un dato ar-gomento, con la conseguenza che la soluzione raggiunta dal co-mitato non dovrebbe essere rimessa in discussione in Consigliodei ministri, il quale – ove fosse necessario un voto dell’interoEsecutivo – potrebbe limitarsi a ratificare la decisione assunta inseno all’organo ristretto. Sempre in merito alla composizione, èutile ricordare che alle riunioni dei comitati possono partecipare
159 Si consideri, in particolare, che il CIACE è presieduto dal Presidente del Con-siglio dei ministri o dal ministro per le politiche comunitarie e che alle sue riunionipartecipano il ministro degli affari esteri, il ministro per gli affari regionali e gli altriministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematicheinseriti all’ordine del giorno (così la l. 11/2005, art. 2, co. 1); alle riunioni dell’organo,dunque, potrebbero partecipare solo tre membri. Analogamente, il Comitato per la re-visione della spesa pubblica è composto – salvo eventuali modificazioni con d.p.c.m. –di soli tre ministri, oltre al Presidente del Consiglio e al sottosegretario alla Presidenzadel Consiglio che assume le funzioni di segretario del comitato (cfr. il d.l. 52/2012, art.1, co. 1, come modificato dalla l. 94/2012).
160 Cfr. la l. 144/1999, art. 2, e la l. 48/1967, art. 16, co. 9, per il CIPE; la l.11/2005, art. 2, co. 1, per il CIACE; il d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 2, co. 4, per ilComitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica per le politiche di sem-plificazione e di qualità della regolazione; la l. 124/2007, art. 5, co. 5, per il CISR; comesi è visto, il Presidente del Consiglio può modificare la composizione del Comitato in-terministeriale per la revisione della spesa pubblica, dopo aver sentito le competenticommissioni parlamentari (cfr. il d.l. 52/2012, art. 1, co. 1, come modificato dalla l.94/2012).
248 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
– secondo le diverse modalità previste per ogni organo – anche irappresentanti delle autonomie locali161.
Per quanto riguarda la loro presidenza, tutti i comitati inter-ministeriali oggi esistenti (salvo il CICR) la attribuiscono al Presi-dente del Consiglio162, seppure prevedendo – in alcuni casi – lapossibilità di delegarla ad un ministro senza portafoglio163. Si ègià avuto modo di osservare, analizzando le caratteristiche deicomitati interministeriali, che la presidenza di uno di essirafforza il ruolo politico del ministro/presidente di comitato ri-spetto agli altri ministri164. Questa considerazione era stata allabase dell’aumento del numero di comitati e della richiesta diogni ministro di presiederne uno. Il superamento di un sistemapolitico che aveva favorito la configurazione di una struttura delGoverno “a multipolarità diseguale”, tuttavia, ha comportatoun’evoluzione anche a tale riguardo. Infatti, la formazione di unsistema politico bipolare e il graduale rafforzamento del ruolodel Presidente del Consiglio e del suo apparato amministrativo,
161 Tale presenza è prevista per il CIPE (l. 48/1967, art. 16, co. 9), per il CIACE (l.11/2005, art. 2, co. 2, per il comitato interministeriale, e co. 4 per il comitato tecnico)e per il Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica per le politichedi semplificazione e di qualità della regolazione (d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 2, co.4). Una previsione analoga non si riscontra nella normativa sul CISR, che, tuttavia, con-sente al Presidente del Consiglio di chiamare a partecipare alle sedute del comitato an-che delle “autorità civili” di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza inrelazione alle questioni da trattare (l. 124/2007, art. 5, co. 5). Un coinvolgimento delleautonomie locali non è previsto nel Comitato per la revisione della spesa pubblica: inmerito si v. quanto osservato supra, parte II, cap. II, par. 4.6.
162 Cfr. la l. 48/1967, art. 16, co. 2, per il CIPE; la l. 11/2005, art. 2, co. 1, per ilCIACE; il d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 2, co. 1, per il Comitato interministeriale perl’indirizzo e la guida strategica per le politiche di semplificazione e di qualità della re-golazione; la l. 124/2007, art. 5, co. 1, per il CISR; si v. anche, per il Comitato intermi-nisteriale per la revisione della spesa pubblica, il d.l. 52/2012, art. 1, co. 1.
163 In questo senso il CIACE (l. 11/2005, art. 2, co. 1), il Comitato interministe-riale per l’indirizzo e la guida strategica per le politiche di semplificazione e di qualitàdella regolazione (d.p.c.m. 12 settembre 2006, art. 2, co. 1), ma anche il CISR (l.124/007, art. 3, co. 1); per il CIPE, invece, si prevede la carica di vice presidente (l.48/1967, art. 16, co. 2).
164 Cfr. supra, parte II, cap. I, par. 8.
249L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
da un lato, hanno contribuito a ridurre il numero di comitati,dall’altro, hanno indotto ad attribuirne la presidenza al premier.Né, come si è già accennato, tale considerazione pare contrastatadalla possibile delega delle funzioni di presidente del comitatoad alcuni ministri senza portafoglio. Tale delega, infatti, avvienenei confronti di un ministro che – non essendo posto a capo diun dicastero – deve avvalersi delle strutture della Presidenza delConsiglio per esercitare funzioni che – in ogni caso – non sonoproprie, perché rientrano nella competenza – e nella disponibi-lità – del Presidente del Consiglio e del suo apparato ammini-strativo, come il d.l. 181/2006 pare chiaramente sottolineare165.Peraltro, tale preminenza del premier nel sistema dei comitatinon si manifesta solo nei comitati di recente istituzione, ma vienerafforzata anche in uno dei comitati più risalenti e più impor-tanti: il CIPE. Lo spostamento della segreteria tecnica del comi-tato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – sempre adopera del d.l. 181/2006 –, infatti, rende maggiormente evidentela tendenza a porre il Presidente del Consiglio e il suo apparatoamministrativo al centro del sistema dei comitati. L’attribuzionedella presidenza dei comitati interministeriali al premier, d’altrocanto, produce un effetto – per così dire – incrementale nel pro-cesso di rafforzamento della sua posizione. Infatti, se tale attri-buzione avviene perché si è gradualmente potenziato il ruolo delPresidente del Consiglio, essa contribuisce ulteriormente a talerafforzamento, ponendolo alla presidenza di collegi ristretti diministri che possono incidere in maniera determinante sull’indi-rizzo politico governativo in alcuni tra i principali settori di in-tervento dell’Esecutivo.
Quest’ultima affermazione rende necessario porre subitol’attenzione sull’ambito di intervento dell’attuale sistema dei co-mitati. Occorre osservare, infatti, che, da un lato, ai comitati in-terministeriali sono stati gradualmente sottratti i compiti ammi-
165 Appare sufficiente in questa sede rinviare a quanto già osservato supra, parteIII, cap. II, par. 2.5.2.
250 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
nistrativi, a tutto vantaggio di una loro connotazione preminen-temente politica166; dall’altro, appare completamente superatal’esperienza legata ad un sistema di comitati (prevalentemente)economici. I comitati istituiti o riformati nel corso delle legisla-ture maggioritarie, infatti, sembrano deputati a svolgere un’atti-vità di carattere essenzialmente politico, relativamente a macro-aree di competenza particolarmente rilevanti per l’attività dell’E-secutivo: politiche economiche (il CIPE); politiche comunitarie (ilCIACE); semplificazione e qualità della regolazione (Comitato in-terministeriale per l’indirizzo e la guida strategica per le politichedi semplificazione e di qualità della regolazione); sicurezza na-zionale (il CISR)167. Attraverso tale trasformazione, il sistema deicomitati sembra deputato a garantire la presenza di organi dicoordinamento delle politiche governative in settori essenzialidell’amministrazione pubblica: economia e sicurezza nazionale,che rappresentano gli ambiti di intervento classici di ogni Esecu-tivo; politiche comunitarie, che sono essenziali in uno Statomembro dell’Unione europea; politiche della semplificazione equalità della regolazione, che appaiono importanti in ogni Statocontemporaneo perché, a causa della grande mole di norme pro-dotte e della complessità degli apparati amministrativi, la sempli-ficazione e il miglioramento della qualità della regolazione «sonocertamente fattori decisivi per la competitività del Paese e per lareale fruibilità dei diritti da parte dei cittadini»168.
Anche sugli ambiti di intervento dei comitati interministe-riali occorre riflettere. Si è già osservato, infatti, che due processi
166 Secondo A. RAVALLI, I comitati interministeriali, cit., p. 33, «la fase attualemostra un ridimensionamento non solo numerico dei Comitati interministeriali deci-sori a competenze tecnico politiche, essendo oggi preferiti, da un lato, i Comitati in-terministeriali con funzioni di elaborazione, consulenza e controllo politico e, dall’al-tro, strutture deburocratizzate, agili, autonome, con compiti ad alto contenuto tecnico,guidate da atti di indirizzo politico».
167 È appena il caso di sottolineare che anche il Comitato interministeriale per larevisione della spesa pubblica, pur con le sue peculiarità, è deputato a svolgere un com-pito nodale per un Governo nato per far fronte ad una crisi economico-finanziaria.
168 Così C. MEOLI, A che punto, cit., pp. 2-3.
251L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
hanno condotto ad un chiaro rafforzamento della posizione delGoverno e del suo vertice: l’integrazione comunitaria e l’au-mento delle competenze delle autonomie locali. Tali processi siriflettono inevitabilmente anche sui comitati. Per quanto ri-guarda, in particolare, il secondo dei processi indicati, si è giàosservato che rappresentanti delle autonomie locali possono par-tecipare alle riunioni dei comitati interministeriali e che – in as-senza di un Senato delle Regioni – i rapporti tra centro e perife-ria si sono articolati prevalentemente per mezzo del sistema delleConferenze169. Ebbene, per le modalità attraverso le quali si sonosviluppati, entrambi i circuiti di dialogo tra Stato e Regioni sonoincentrati sul premier e sull’apparato amministrativo costituitodalla Presidenza del Consiglio dei ministri, i quali, assumendouna posizione fondamentale all’interno di tali attività, finisconocon il rafforzare anche i rispettivi ruoli170.
La centralità della posizione del premier e del suo apparatoamministrativo nei rapporti con le autonomie locali si riscontraevidentemente anche nella partecipazione delle Regioni al pro-cesso di integrazione comunitaria che, ancora una volta, si svi-luppa attraverso il sistema delle Conferenze e un comitato inter-ministeriale all’interno del quale gli enti locali possono avere unaloro rappresentanza: il CIACE. Questo comitato, peraltro, po-trebbe assumere una posizione del tutto preminente in relazionealle politiche comunitarie. Esso, infatti, pare potersi configurarecome una vera e propria “cabina di regia” all’interno della quale
169 Secondo A. RUGGERI, Il Governo, cit., part. p. 334, «quanto più si compli-cano (…) le relazioni tra più livelli istituzionali, sia interni ad un ordinamento dato che(ed a maggior ragione) interordinamentali, tanto più si fa palese il rischio che la “col-legialità” piena (a favore dell’intero Consiglio [dei ministri]) possa ulteriormente sce-mare, a vantaggio di sedi di collegialità “ristretta”, ovvero di singole figure istituzionali(Ministri e Presidente del Consiglio)».
170 Prima dell’evoluzione del sistema dei comitati (e della riforma del Titolo V),infatti, secondo S. BARTOLE, Assetto, cit., pp. 356-357, la presenza di esponenti delleRegioni nei comitati interministeriali rafforzava il ministro di settore, «cui spettava inconcreto (…) di negoziare con le regioni (con scarse possibilità di ulteriori variazioni)il coordinamento delle attività statali e regionali».
252 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
assumere di fatto l’indirizzo politico di settore171. Se il CIACE do-vesse assumere concretamente tale ruolo, le questioni di mag-giore rilievo in materia sarebbero definite dallo stesso comitatointerministeriale, all’interno del quale potrebbe svolgere unruolo determinante il Presidente del Consiglio. Per quanto ri-guarda le questioni di minore rilievo, invece, il CIACE potrebbelimitarsi a ratificare decisioni già assunte dal comitato tecnico, ilquale, a sua volta, opera all’interno di un apparato amministra-tivo che fa capo alla Presidenza del Consiglio. L’istituzione delCIACE e la sua organizzazione, dunque, sembrano volte a garan-tire al premier la possibilità di influire in maniera determinantesull’indirizzo politico del Governo in materia comunitaria, incre-mentando il suo ruolo anche in tale cruciale settore di interventodell’Esecutivo.
Tentando di riassumere i tratti essenziali dell’evoluzione delsistema dei comitati interministeriali, si può osservare, in primoluogo, che appare del tutto superata l’esperienza di un sistemacostituito essenzialmente da comitati economici. I comitati inter-ministeriali oggi esistenti, infatti, si occupano di differenti ambitidella politica nazionale, ognuno dei quali attribuito ad uno spe-cifico comitato.
Le conseguenze delle riforme elettorali in senso maggiorita-rio sul Governo, inoltre, hanno senz’altro contribuito alla ridu-zione del numero di comitati interministeriali e del numero deiloro componenti, considerato che le riforme elettorali hanno fa-vorito anche il superamento della “democrazia bloccata” che hacaratterizzato per lungo tempo il sistema politico italiano. Il mu-tamento politico indotto dalle riforme elettorali in senso maggio-ritario, infatti, ha portato anche a definire gli equilibri politici in-terni alla coalizione di governo attraverso organi non necessaridell’Esecutivo differenti dai comitati interministeriali: vice presi-denti del Consiglio; vice ministri; ministri senza portafoglio.
171 Si rinvia, in proposito, anche a quanto già osservato supra, parte II, cap. II,par. 4.3.
253L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
Il rafforzamento del Presidente del Consiglio, fenomenonettamente accentuato dalle riforme elettorali maggioritarie,inoltre, ha indotto ad attribuire al premier un ruolo centrale al-l’interno dei comitati interministeriali, dandogli la possibilità diesercitare al meglio le sue funzioni di indirizzo e coordinamentoin ampi settori della politica dell’Esecutivo, attraverso l’utilizzodi collegi ristretti del Governo, composti dai ministri interessatialle materie oggetto delle riunioni dei comitati. Il sistema di co-mitati così delineato, peraltro, potrebbe consentire al premier diincidere in maniera determinante sulle aree di competenza deicomitati172, perché la presenza al loro interno di tutti i ministriinteressati all’argomento oggetto della decisione permetterebbeai comitati interministeriali di determinare – di fatto – l’indirizzopolitico di settore, considerato che in Consiglio dei ministri nondovrebbero esserci ministri interessati a contestare la decisioneassunta dal comitato173.
Il ruolo centrale rivestito dal Presidente del Consiglio (an-che) all’interno dei comitati interministeriali, inoltre, deve in-durre ad una riflessione sulla responsabilità per gli atti assunti alloro interno. Si è già visto che in tema di responsabilità politicaper gli atti dei comitati sono state sostenute teorie differenti eche, stante l’articolato sistema di comitati sviluppatosi prima
172 Secondo E. CUCCODORO, Collegialità, cit., p. 829, «[i] “comitati interministe-riali”, nella loro originaria istituzione, dovevano esprimere un più efficace strumentodi supporto per il Presidente del Consiglio. Egli, nel presiederli, veniva ad assumereuna centrale ed aggiuntiva posizione all’interno del Gabinetto, in vista di favorire inci-sività e più organiche qualificazioni all’azione politica del Governo con altre maggioricapacità d’intervento in settori considerati decisivi per la macchina statale».
173 Secondo T.E. FROSINI, La forma di governo del premierato, in Il Filangieri,Quaderno 2006, p. 141, la valorizzazione dei comitati di ministri e del Consiglio diGabinetto, nell’ambito di una organizzazione della struttura di Governo meglio defi-nita, contribuirebbe ad avvicinare il sistema politico-istituzionale italiano al premieratobritannico: «[s]i emulerebbe così la figura del Cabinet britannico, quale organo ri-stretto responsabile dell’indirizzo politico all’interno dell’ordinamento governativo, al-l’interno del quale, cioè, vengono prese le principali decisioni governative, vengonocoordinate le politiche perseguite dai vai ministeri, viene fissato l’ordine dei lavori dellegislativo, vengono inoltre stabiliti i contenuti e i termini delle leggi finanziarie».
254 PARTE TERZA - CAPITOLO SECONDO
della riforma maggioritaria, sembrava opportuno consentire l’at-tribuzione di una responsabilità individuale ai singoli ministrimembri di comitato174. Alla luce dell’evoluzione appena rico-struita, è possibile svolgere una ulteriore riflessione su tale que-stione. Se attraverso l’attuale sistema di comitati il Presidente delConsiglio vede rafforzato il suo ruolo, potendo incrementare lesue capacità di coordinamento dell’attività dei ministri sino alpunto di essere in grado di determinare molteplici aspetti dellapolitica dell’Esecutivo, appare di conseguenza opportuno ade-guare anche la sua responsabilità. Potrebbe essere coerente conl’evoluzione dei rapporti endogovernativi e del ruolo dei comi-tati interministeriali, pertanto, attribuire in capo al premier la re-sponsabilità politica per gli atti assunti da tali organi collegiali,ferma restando, in ogni caso, la possibilità di far valere la re-sponsabilità politica del singolo ministro membro di comitato in-terministeriale per gli atti o comportamenti che siano riconduci-bili esclusivamente al ministro175.
174 Cfr. supra, parte II, cap. I, par. 7.175 La responsabilità politica del singolo ministro nei confronti del Parlamento
non può comunque mancare, considerato che nell’ordinamento italiano il Presidentedel Consiglio non ha il potere di revoca dei ministri. In dottrina, la questione è deci-samente controversa: tra gli Autori favorevoli al riconoscimento di tale potere al pre-mier si v. T. MARCHI, Il Governo, cit., pp. 139-140; G. RIZZA, Il Presidente, cit., pp. 237ss., M. OLIVETTI, La questione, cit., pp. 133 ss., S. SICARDI, Maggioranza, cit., p. 142, e,sembrerebbe, C. MORTATI, Istituzioni, tomo I, cit., p. 564, e A. PREDIERI, Presidente,cit., pp. 9-10, che, però, esclude la revoca di un ministro da parte del Presidente dellaRepubblica senza proposta del Presidente del Consiglio, «allorquando si verifichi unasituazione di urto fra Presidente della Repubblica e un singolo Ministro senza che visia un dissidio fra questi e il P.d.C.»; contra G. CUOMO, Unità, cit., pp. 50 ss., G. QUA-DRI, I comitati, cit., p. 348, nt. 30, L. PALADIN, Governo, cit., pp. 695-696, S. LABRIOLA,Revoca del ministro e rapporto di fiducia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1983,pp. 802 ss., P. ARMAROLI, Crisi di governo, in Enciclopedia giuridica, vol. X, Roma, Trec-cani, 1988, pp. 11-12, P.A. CAPOTOSTI, Governo, cit., p. 10, C. ROMANELLI GRIMALDI,Ministro, cit., pp. 5-6, e S. BARTOLE, Governo, cit., p. 656; si v., altresì, D. TRABUCCO, Ilrapporto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri: un difficile punto diequilibrio, in www.forumcostituzionale, pp. 1 ss. Si rinvia, infine, ai numerosi episodi di“dimissioni” di ministri su richiesta del Presidente del Consiglio verificatisi durante laXIV legislatura e riassunti da M. OLIVETTI, Appunti, cit., pp. 120-121, secondo il quale,anche se non si è avuta formalmente la revoca, ne ricorrono tutti gli estremi sostanziali.
255L’INCIDENZA DELLE RIFORME ELETTORALI IN SENSO MAGGIORITARIO
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Al termine dell’analisi sin qui svolta, è possibile riassumernei tratti essenziali al fine di trarne alcune valutazioni di caratteregenerale.
Come si è visto, la struttura del Governo è piuttosto elastica,così da consentire all’Esecutivo di adattarsi alle modificazioni so-ciali e politiche con le quali deve confrontarsi. Questa elasticitàsi manifesta sia attraverso la possibilità di configurare in manieradifferente i rapporti tra gli organi necessari del Governo, sia gra-zie alla facoltà di istituire organi “non necessari” dello stessoEsecutivo, ritenuti – volta per volta – indispensabili o utili per af-frontare al meglio le contingenze politico-sociali.
Numerosi sono i fattori che hanno influito sulla struttura delGoverno e sui rapporti fra i suoi organi: si pensi, in particolare,al processo di integrazione comunitaria e alla riforma del TitoloV della Parte II della Costituzione. Un altro elemento che haprodotto profonde modificazioni dell’Esecutivo – ma anche delsistema politico-partitico italiano, che su di esso influiscono – èrappresentato dalle riforme elettorali in senso maggioritario.Queste sono state determinate dal referendum abrogativo del1993, quando particolarmente acuta appariva la crisi del sistemapolitico-partitico italiano e molto severa era la critica dell’opi-nione pubblica nei suoi confronti. Tale situazione ha finito con ilcaricare di grandi attese la riforma elettorale maggioritaria, au-spicando il conseguimento – per mezzo di essa – di «effetti quasipalingenetici»1 sul sistema politico e istituzionale italiano. Tutta-
1 L’espressione è di V. ATRIPALDI, La transizione discontinua tra politiche costitu-zionali, politiche di risanamento e politiche per l’integrazione europea nella XII legisla-
via, appare ormai evidente che la riforma maggioritaria è riuscitasolo in parte a produrre gli effetti sperati2. Infatti, se, da un lato,essa ha indotto al superamento di un intero sistema politico epartitico e delle convenzioni sulle quali si reggeva, tanto da in-durre parte della dottrina a considerare la riforma maggioritariacome lo spartiacque tra le c.d. prima e seconda Repubblica, dal-l’altro, non si sono raggiunti quei risultati di efficacia nell’azionedi governo e di riduzione della frammentazione partitica chepure sarebbero tra gli effetti propri di un sistema maggioritario.Come si è avuto modo di osservare, infatti, la riforma elettoralein senso maggioritario è stata attuata con reticenza e in manieradel tutto parziale, conservando spazi “utili” per il mantenimentodi un sistema politico frammentato: si pensi, ad esempio, alle ca-ratteristiche delle stesse leggi elettorali “maggioritarie”, oppurealle insufficienti riforme dei regolamenti parlamentari3.
L’ambiguità con la quale si è proceduto all’adeguamento delsistema alle riforme elettorali maggioritarie ha prodotto conse-guenze – e, certo, non poteva essere diversamente – anche sulGoverno e sulla sua organizzazione.
Emblematica, in proposito, è la vicenda relativa al numerodei dicasteri. Come si è già visto4, infatti, nel 1999 si era provve-duto a ridurre sensibilmente il numero di ministeri. Una minoreframmentazione del sistema partitico, in effetti, avrebbe dovutocondurre alla costituzione di Governi sostenuti da maggioranzecoese, con la conseguente possibilità di formare Esecutivi con unnumero ridotto di ministri. Il mancato contenimento di tale
tura, in AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. I, Torino, Giappichelli, 2005,p. 146.
2 Si v. ancora V. ATRIPALDI, La transizione, cit., p. 149, secondo il quale «[q]uantoal complessivo adeguamento dell’ordinamento al principio maggioritario la riforma èassolutamente monca». In senso analogo, M. CALISE, Presidentialization, cit., p. 102:«The combination of the new electoral law, a strengthened executive, and a heavilymediatized political arena produced a majoritarian form of politics quite different fromthe one the reformers had envisaged».
3 Cfr. supra, parte III.4 Supra, parte I, cap. I, par. 5.3.
258 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
frammentazione e i Governi sostenuti da coalizione ampie o,comunque, poco coese che ne sono derivati hanno indotto le dif-ferenti maggioranze politiche succedutesi dopo il 1999 ad au-mentare nuovamente tale numero, oltre a nominare numerosisottosegretari, ministri senza portafoglio, vice ministri e vice pre-sidenti del Consiglio.
Nondimeno, alcuni effetti “maggioritari” si sono ugual-mente prodotti sull’Esecutivo e sulla sua organizzazione. In par-ticolare, occorre considerare il crescente ruolo assunto dal Presi-dente del Consiglio e dal suo apparato amministrativo. La perso-nalizzazione della politica non rappresenta certo un trattopeculiare del sistema politico italiano, essendo, al contrario, or-mai caratteristico (almeno) della maggior parte delle democrazieoccidentali. Nondimeno, tale tendenza è stata rafforzata in Italiadalle riforme elettorali maggioritarie, oltre che dalle riforme chehanno riguardato le Regioni e gli enti locali e l’elezione direttadei vertici dei relativi Esecutivi, modificando il rapporto tra lea-dership ed elettori. Invero, la centralità del ruolo del Presidentedel Consiglio si era già affermata a causa del processo di integra-zione comunitaria e del progressivo aumento del ruolo degli entilocali territoriali5, ma le riforme elettorali maggioritarie hannoprodotto effetti ulteriori, contribuendo a creare un legame di-retto tra leader di coalizione e corpo elettorale (ancor più dopola l. 270/2005), con il conseguente rafforzamento della compo-nente monocratica nei rapporti endogovernativi.
Esempio di tale graduale processo di rafforzamento e, più ingenerale, del complesso di fattori che hanno influito sull’organiz-zazione del Governo, possono essere considerati i comitati inter-ministeriali. Questi organi non necessari dell’Esecutivo, infatti,hanno manifestato un notevole grado di elasticità, dimostrandosiin grado di adeguarsi sia ai diversi compiti che il Governo puòessere chiamato a svolgere, sia al diverso atteggiarsi dei rapportiinfragovernativi.
5 Cfr. supra, parte III, cap. II, par. 2.5.2.
259OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
I comitati interministeriali, infatti, sono stati utilizzati già inun ordinamento ben differente da quello repubblicano per farfronte a contingenti esigenze economiche (come la crisi econo-mica del 1929) o politiche (si pensi alle politiche autarchiche delregime fascista), adeguandosi ad un Esecutivo e a rapporti endo-governativi caratterizzati dal ruolo di assoluta primazia del Capodel Governo6.
Dopo la nascita della Repubblica, i comitati interministerialisono stati istituiti soprattutto per occuparsi di materie economi-che, anche a causa del rilievo dell’intervento pubblico nell’eco-nomia del sistema italiano ad “economia mista”. Per quanto ri-guarda, invece, i rapporti tra gli organi del Governo, la fram-mentazione partitica e le coalizioni eterogenee che sostenevano iGoverni della c.d. prima Repubblica hanno influito anche sui co-mitati interministeriali. Poiché ogni ministro, piuttosto che comecomponente di un Esecutivo coeso, tendeva a rappresentare ilproprio partito all’interno del Governo, conservando ampi mar-gini di autonomia, era stato necessario creare un numero elevatodi tali comitati, al fine di consentire ad ogni ministro di presie-dere (o di far parte di) almeno uno di essi. In questo modo, i co-mitati interministeriali riflettevano chiaramente la politica di coa-lizione che si era gradualmente sviluppata, caratterizzata da unaelevata frammentazione dei centri decisionali e da una conside-revole autonomia dei singoli ministri.
Una significativa modificazione di tale tendenza nella costi-tuzione dei comitati interministeriali è conseguita al processo diintegrazione comunitaria e alle conseguenti aperture dell’ordina-mento italiano ai principî cardine del mercato comune7. Taleprocesso, infatti, ha sicuramente influito sulla possibilità di isti-tuire comitati interministeriali a carattere economico o finanzia-rio, che contrassegnavano l’intero sistema dei comitati. Nono-
6 Cfr. quanto già osservato supra, parte I, cap. I, par. 2.2.7 Come per l’Esecutivo nel suo complesso, d’altro canto: cfr. supra, parte III,
cap. II, par. 2.4.
260 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
stante ciò, la concreta soppressione della maggior parte dei co-mitati economici si è avuta – e non pare un caso – solo dopo lariforma elettorale del 19938. Infatti, se i fattori che in qualchemodo hanno influito sulle modificazioni del sistema dei comitatisono numerosi9, le riforme elettorali maggioritarie sembrano –quantomeno – aver dato fattivamente il via al complessivo pro-cesso di ridefinizione del sistema stesso. Né pare si possa sotto-valutare che dei sei comitati interministeriali attualmente esi-stenti, ben quattro siano stati creati dopo il 2005 e che, uno diquelli già esistenti, il CIPE, abbia subito nel 2006 delle modifica-zioni che lo rendono assimilabile ai comitati di più recente istitu-zione10.
Il sistema di comitati interministeriali sviluppatosi durante lelegislature maggioritarie, dunque, è costituito da organi con ca-ratteristiche alquanto omogenee; i tratti salienti del rinnovamentodi tale sistema si sono già visti11 ma è opportuno richiamarli bre-vemente. Il sistema dei comitati non è più caratterizzato in ma-niera quasi esclusiva dai comitati economici, ma attiene a settoridifferenti dell’attività di governo, raggruppati in macro-aree dellequali ogni comitato è destinato ad occuparsi. Ai comitati sonotendenzialmente sottratte le attribuzioni prettamente amministra-tive, così che essi si caratterizzano ora in senso più propriamentepolitico. Il numero dei componenti dei comitati risulta abba-stanza contenuto, ma la loro composizione elastica consente co-munque il coinvolgimento di tutti i ministri competenti o interes-sati all’argomento posto all’ordine del giorno di ogni riunione deisingoli comitati. All’interno di tali organi è frequentemente previ-sta la possibilità di una rappresentanza – sebbene attraverso mo-dalità differenti – delle autonomie locali. La presidenza dei comi-tati è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, seppurecon la possibilità – in alcuni casi – di delegarla a ministri senza
8 Con la già citata l. 537/1993: cfr., in particolare, supra, parte II, cap. II, par. 3.9 Sono stati riassunti supra, parte II, cap. II, par. 3.10 Cfr. supra, parte II, cap. II, par. 4.2.11 Supra, parte III, cap. II, par. 2.4.4.
261OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
portafoglio12. In virtù di tali modificazioni, l’attuale sistema di co-mitati interministeriali prevede un numero contenuto di organi dicoordinamento dell’attività politica dell’Esecutivo in settori diparticolare rilievo, all’interno dei quali un ruolo centrale è as-sunto del Presidente del Consiglio e dal suo apparato ammini-strativo. La costituzione di organi di coordinamento dell’attivitàdi governo, caratterizzati in senso prettamente politico, compostidai soli ministri interessati ad una data materia – nonché, in talunicasi, dai rappresentanti delle autonomie locali –, presieduti dalpremier e le cui strutture amministrative sono strettamente legatealla Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, potrebbe esal-tare la funzione di indirizzo e coordinamento dell’attività dei mi-nistri e dell’intero Esecutivo che la Costituzione attribuisce alPresidente del Consiglio. Quest’ultimo, in effetti, attraverso taliorgani potrebbe influire sulla determinazione dell’indirizzo poli-tico del Governo nelle materie di competenza dei comitati, con-frontandosi con i soli ministri interessati, senza la necessità di unanuova discussione in Consiglio dei ministri.
In pratica, i comitati interministeriali seguono la tendenzapiù generale che è possibile riscontrare nei rapporti infragover-nativi dopo le riforme elettorali in senso maggioritario: il raffor-zamento della posizione del Presidente del Consiglio. In questomodo, essi dimostrano la loro elasticità nell’adattarsi alle diffe-renti esigenze dell’Esecutivo e al diverso delinearsi dei rapportiendogovernativi. La loro capacità di riflettere le modificazioniche riguardano il Governo, tuttavia, comporta che essi racchiu-dano anche le ambiguità con le quali le riforme elettorali mag-gioritarie si sono manifestate all’interno dell’Esecutivo. Si pensi,ad esempio, al ruolo dei ministri senza portafoglio. Nelle legisla-ture maggioritarie si è fatto ampio ricorso a tale tipologia di mi-nistri, con l’attribuzione di funzioni che dovrebbero oramai es-sere considerate propriamente del Presidente del Consiglio13 e
12 Sulle caratteristiche dei singoli comitati vigenti si rinvia supra, parte II, cap. II.13 Si v. quanto già affermato supra, parte III, cap. II, par. 2.5.2.
262 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
che, di conseguenza, dovrebbero essere attribuite a questi esvolte, presumibilmente, da un sottosegretario alla Presidenzadel Consiglio. La frammentazione delle coalizioni che sosten-gono le diverse maggioranze parlamentari pro tempore, tuttavia,induce a prevedere tali figure – oltre ai vice ministri, ai vice pre-sidenti del Consiglio e a un numero elevato di sottosegretari –, alfine di garantire gli equilibri politici interni alla coalizione. Tuttociò non poteva che ripercuotersi anche sulle modificazioni atti-nenti ai comitati interministeriali. Non a caso, infatti, i comitatiistituiti nella XIV e nella XV legislatura – il CIACE, il Comitatointerministeriale per l’indirizzo e la guida strategica per le politi-che di semplificazione e di qualità della regolazione e il CISR –prevedono che la loro presidenza possa essere delegata dal Pre-sidente del Consiglio ad un ministro senza portafoglio, sebbeneappaia evidente che – ove fosse ritenuto necessario e ferma re-stando l’attribuzione della presidenza al premier – sarebbe piùopportuno delegare le relative funzioni – anche in questo caso –ad un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio14.
Se l’adeguamento al sistema maggioritario è stato attuatocon reticenza, senza contrastare la tendenza alla frammentazionepartitica, né la scarsa coesione delle maggioranze parlamentari,gli effetti di tale atteggiamento dovevano riflettersi inevitabil-mente anche sui comitati interministeriali. Le resistenze all’ade-guamento al principio maggioritario che emergono anche dallemodificazioni del sistema dei comitati, peraltro, confermano lacapacità di questi organi non necessari del Governo di costituireuno strumento – forse quello più efficace – di adeguamento allemodificazioni che riguardano l’Esecutivo, rappresentandone fe-delmente le tendenze evolutive. Ed è in questa flessibilità chedeve probabilmente ravvisarsi il motivo del loro costante utilizzoall’interno della struttura del Governo.
Ciò sembra confermato anche dal comitato interministerialedi più recente istituzione, quello per la revisione della spesa pub-
14 Cfr. supra, parte II, cap. II, parr. 4.3., 4.4. e 4.5.
263OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
blica. Questo comitato è stato istituito da un Governo “tecnico”in una fase particolarmente delicata per l’economia e per la te-nuta del sistema politico-istituzionale italiano, nella quale, comesi è già accennato, si registra una forte sfiducia dell’opinionepubblica nei confronti dei partiti e si dibatte dell’esigenza (quan-tomeno) di una nuova riforma elettorale. Pure in tale contesto, siè ritenuto utile istituire un comitato interministeriale. Ciò con-sente almeno due considerazioni. Innanzitutto, si conferma l’uti-lità di ricorrere a tali organi ristretti del Governo, indipendente-mente dalle circostanze politiche e dagli assetti partitici, conside-rato che essi si sono sviluppati già prima della nascita dellaRepubblica e hanno attraversato tutte le diverse fasi della storiarepubblicana. In secondo luogo, il comitato sulla c.d. spendingreview riflette la situazione nella quale è stato istituito e si trovaad operare. Il Governo Monti, infatti, è nato in un momento po-litico nel quale la mai compiuta transizione alla democrazia mag-gioritaria appare in crisi e si discute di nuove riforme elettorali ecostituzionali che dovrebbero aprire una nuova, ma del tutto in-certa, fase. Questa incertezza è manifestata anche dal Comitatointerministeriale per la revisione della spesa pubblica, che, se permolti versi è assimilabile ai comitati interministeriali istituiti du-rante le legislature maggioritarie15, per altri se ne discosta. Daquesto ultimo punto di vista, sono significative quelle disposi-zioni che richiedono un coinvolgimento delle commissioni parla-mentari in talune delle attività del comitato e, in particolare, nel-l’ipotesi in cui il premier volesse modificare la composizione del-l’organo. Tali disposizioni, infatti, non erano previste dal d.l.52/2012 e – non a caso – sono state introdotte dalla legge di con-versione. Si tratta di modificazioni che paiono rilevanti perchésintomatiche di un (seppur minimo) tentativo delle Camere diriequilibrare i rapporti con l’Esecutivo e con lo stesso Presidentedel Consiglio, considerato che, nel corso delle legislature mag-
15 Si pensi, in particolare, all’attribuzione della presidenza al premier e al ridottonumero di membri.
264 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
gioritarie, il Governo – per le ragioni che si sono viste16 – harafforzato il suo ruolo anche nei confronti del Parlamento.
Resta solo da osservare, in conclusione, che, a fronte di fu-turi sviluppi derivanti dalle (possibili) future riforme elettorali ocostituzionali, anche il sistema dei comitati interministeriali po-trebbe subire nuove modificazioni, consentendo di cogliere ap-pieno i mutamenti che investono l’intero Esecutivo. Non si puòescludere, peraltro, che un eventuale, ulteriore rafforzamento delruolo del Presidente del Consiglio possa produrre una evolu-zione dei rapporti endogovernativi differente, basata – come si èosservato nell’esperienza britannica17 – sul ricorso a strumentidecisionali caratterizzati dalla informalità, con la conseguenteperdita di rilievo del sistema dei comitati18.
16 Cfr. supra, parte III, cap. II, par. 2.3.17 Sul quale si rinvia supra, parte II, cap. I, par. 9.1.18 Le conclusioni qui raggiunte, dunque, non possono certo essere considerate
definitive o incontrovertibili ma, dopotutto, come osservava N. MATTEUCCI, Positivi-smo giuridico e costituzionalismo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,1963, p. 1049, «un pensiero senza contraddizioni e oscurità non suscita alcun vero in-teresse, privo com’è di ogni vitalità».
265OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
ELENCO DEI COMITATI INTERMINISTERIALI COMPOSTI DI MINISTRI
E OPERANTI NELL’ITALIA REPUBBLICANA*
* Il riferimento è ai comitati composti di ministri che hanno operato – anche perbreve periodo – nell’Italia repubblicana, pure se istituiti prima dell’approvazione dellaCostituzione. Considerata la frammentarietà della disciplina relativa a tali organi,l’elenco non può essere considerato esaustivo ma intende rendere con immediatezza lacomplessità e la continuità con cui si è manifestato il fenomeno dei comitati ristrettidel Governo nell’ordinamento italiano.
Denominazione dell’organo Acronimo Fonti istitutive
Comitato interministeriale per il cre-dito ed il risparmio CICR
r.d.l. 375/1936l. 141/1938
d.lgs.lgt. 226/1944d.lgs.c.p.s. 691/1947
Comitato interministeriale dei prezzi CIP d.lg.lgt. 347/1944
Comitato interministeriale per la rico-struzione CIR d.lgs.lgt. 432/1945
Comitato interministeriale per la pre-videnza agli statali – d.l. 388/1946
Comitato di ministri per il Mezzo-giorno CISMEZ
l. 646/1950l. 717/1965
d.p.r. 1523/1967
Comitato idrocarburi – l. 136/1953
Comitato permanente per le parteci-pazioni statali CIPPSS l. 1589/1956
Comitato di ministri per l’energia nu-cleare – l. 933/1960
Comitato di ministri per l’E.N.E.L. – l. 1643/1962
268 ELENCO DEI COMITATI INTERMINISTERIALI
Comitato per la cinematografia – l. 1213/1965
Comitato interministeriale per la pro-grammazione economica CIPE l. 48/1967
Comitato interministeriale per la pro-tezione civile CIPC l. 996/1970
Comitato per la gestione del fondoper il finanziamento delle agevolazionial commercio
– l. 517/1975
Comitato interministeriale per l’emi-grazione CIEM l. 64/1976
Comitato interministeriale per la tu-tela delle acque dall’inquinamento – l. 319/1976
Comitato interministeriale per la poli-tica economica estera CIPES l. 227/1977
Comitato interministeriale per il coor-dinamento della politica industriale CIPI l. 675/1977
Comitato interministeriale per le in-formazioni e la sicurezza CIIS l. 801/1977
Comitato interministeriale per la poli-tica agricola e alimentare CIPAA l. 984/1977
Comitato interministeriale per l’indi-rizzo, il coordinamento e il controllodegli interventi per la salvaguardia diVenezia
– l. 798/1984
Comitato interministeriale per la pro-grammazione economica nel trasporto CIPET l. 41/1986
Comitato interministeriale per la coo-perazione allo sviluppo CICS l. 49/1987
Comitato interministeriale gestionefondo interventi educazione e infor-mazione sanitaria
– l. 67/1988
Comitato interministeriale per la lottaall’AIDS – l. 135/1990
Comitato interministeriale per gliscambi di materiali di armamento perla difesa
CISD l. 185/1990
269ELENCO DEI COMITATI INTERMINISTERIALI
Comitato nazionale di coordinamentoper l’azione antidroga – d.p.r. 309/1990
Comitato dei Ministri per la Societàdell’informazione – d.p.c.m. 15-5-1997
Comitato di Ministri previsto dallanormativa di recepimento della diret-tiva 96/2/CE sulle comunicazioni mo-bili e personali
– d.p.c.m. 7-8-1997
Comitato dei Ministri previsto dall’art.6, co. 13, lett. c, d.p.r. 318/1997, re-cante «Regolamento per l’attuazione didirettive comunitarie nel settore delletelecomunicazioni» per l’aggiudica-zione di licenze individuali nei servizidi comunicazione mobili e personali
– d.p.c.m. 5-2-1999
Comitato dei Ministri previsto dall’art.6, co. 13, lett. c, d.p.r. 318/1997, re-cante «Regolamento per l’attuazionedi direttive comunitarie nel settoredelle telecomunicazioni» per l’aggiu-dicazione di licenze individuali perl’offerta al pubblico di servizi di co-municazione mobili di 3ª generazione
– d.p.c.m. 2-2-2000
Comitato interministeriale per la pre-venzione e la riduzione dell’inquina-mento elettromagnetico
– l. 36/2001
Comitato interministeriale per gli af-fari comunitari europei CIACE l. 11/2005
Comitato interministeriale per l’indi-rizzo e la guida strategica per le politi-che di semplificazione e di qualitàdella regolazione
–d.l. 4/2006l. 80/2006
d.p.c.m. 12-9-2006
Comitato interministeriale per la sicu-rezza della Repubblica CISR l. 124/2007
Comitato interministeriale per la revi-sione della spesa pubblica – d.l. 52/2012
l. 94/2012
BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
AINIS M., MARTINES T., Piccolo codice costituzionale, 5ª ed., Milano, Led,2005.
AINIS M., Sul valore della prassi nel diritto costituzionale, in Rivista trime-strale di diritto pubblico, 2007, n. 2.
ALDER J., Constitutional and Administrative Law, 3ª ed., Basingstoke andLondon, Macmillan Press Ltd, 1999.
AMATO G., BRUNO F., La forma di governo italiana. Dalle idee dei partitiall’Assemblea costituente, in Quaderni costituzionali, 1981.
AMATO G., I sistemi elettorali in Italia: le difficoltà del cambiamento, inQuaderni costituzionali, 1981, n. 3.
AMATO G., Il dilemma del principio maggioritario, in Quaderni costituzio-nali, 1994, n. 2.
AMATO G., Nuove tendenze nella formazione degli atti governativi di indi-rizzo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1970.
AMATO G., Un governo nella transizione. La mia esperienza di Presidentedel Consiglio, in Quaderni costituzionali, 1994, n. 3.
AMBROSI A., Art. 92, in BARTOLE S., BIN R. (a cura di), Commentario brevealla Costituzione Paladin-Crisafulli, 2ª ed., Padova, Cedam, 2008.
AMBROSINI G., Sistemi elettorali, Firenze, Sansoni, 1946.AMORTH A., Analisi costituzionale del Governo, in GLISENTI M., ELIA L. (a
cura di), Cronache sociali 1947-1951, Roma, Luciano Landi Editore,1961.
ANTONELLI V., I raccordi interistituzionali nella dialettica con l’Unione eu-ropea, in CARPANI G., GROPPI T., OLIVETTI M., SINISCALCHI A. (a curadi), Le Regioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la leggen. 11/2005, Bologna, il Mulino, 2007.
ARCIDIACONO L., Principio di gerarchia e principio collaborativo, in SPAGNA
MUSSO E. (diretto da), Costituzione e struttura del Governo. Lariforma dei ministeri, parte II, Padova, Cedam, 1988.
ARCIDIACONO L., Relazione generale, in AA.VV., Annuario 2001. Il Go-verno, Atti del XVI convegno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 no-vembre 2001, Padova, Cedam, 2002.
ARDANT P., Institutions politiques et droit constitutionnel, 18ª ed., Paris,L.G.D.J., 2006.
ARENA G., Le attribuzioni del Parlamento in materia di servizi per le infor-mazioni e la sicurezza in Italia e negli Stati uniti, in Rivista trimestraledi diritto pubblico, 1978.
ARENA G., Ministeri, in GUARINO G., Dizionario amministrativo, vol. II, 2ªed. riveduta e accresciuta, Milano, Giuffrè, 1983.
ARMAROLI P., Crisi di governo, in Enciclopedia giuridica, vol. X, Roma,Treccani, 1988.
ARMAROLI P., La doppia fiducia, in Quaderni costituzionali, 1981, n. 3.ARMAROLI P., Statuto dell’opposizione e democrazia maggioritaria, in Rasse-
gna parlamentare, 1995, n. 3.ATRIPALDI V., BIFULCO R. (a cura di), La Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali della XIII legislatura, Torino, Giappichelli, 1998.ATRIPALDI V., FICHERA C., Oltre la Commissione Bozzi, in ATRIPALDI V., FI-
CHERA C., Dalla grande riforma alla politica delle istituzioni, Padova,Cedam, 1986.
ATRIPALDI V., Il patto costituzionale in Assemblea costituente, in ATRIPALDI
V., FICHERA C., Dalla grande riforma alla politica delle istituzioni, Pa-dova, Cedam, 1986.
ATRIPALDI V., L’illusione della «Grande Riforma», in Diritto e cultura, 2002,n. 1/2.
ATRIPALDI V., L’organizzazione costituzionale dello Stato nel dibattito allaCostituente: il contributo di Renzo Laconi, in ATRIPALDI V., FICHERA
C., Dalla grande riforma alla politica delle istituzioni, Padova, Cedam,1986.
ATRIPALDI V., La transizione discontinua tra politiche costituzionali, politi-che di risanamento e politiche per l’integrazione europea nella XII le-gislatura, in AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. I, Torino,Giappichelli, 2005.
AZZARITI G., A proposito della riforma costituzionale, in www.rivistaic.it, 24maggio 2012.
BACHELET V., Comitati interministeriali, in Enciclopedia del diritto, vol.VII, Milano, Giuffrè, 1960.
BACHELET V., L’attività di coordinamento nell’amministrazione pubblica del-l’economia, Milano, Giuffrè, 1957, ora in ID., Scritti giuridici, vol. III,Milano, Giuffrè, 1981.
272 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
BAGEHOT W., The English Constitution [1867], London and Glasgow, TheFontana Library, 1963.
BAGNAI F., Il consiglio di gabinetto: problemi di compatibilità con la Costi-tuzione, analogie e differenze con i comitati di ministri ed i comitati in-terministeriali, in Diritto e società, 1991.
BALBONI E., La funzione di governo oggi, in AA.VV., Annuario 2001. Il Go-verno, Atti del XVI convegno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 no-vembre 2001, Padova, Cedam, 2002.
BALBONI E., Scalfaro e la transizione: ha fatto quel che doveva, in Quadernicostituzionali, 1999, n. 2.
BALLADORE PALLIERI G., Diritto costituzionale, 11ª ed., Milano, Giuffrè,1976.
BALLINI P.L., Le elezioni nella storia d’Italia dall’Unità al fascismo, Bolo-gna, il Mulino, 1988.
BARBERA A., CECCANTI S., La lenta conversione maggioritaria di CostantinoMortati, in Quaderni costituzionali, 1995, n. 1.
BARBERA A., Elezione diretta del Sindaco, Rimini, Maggioli, 1993.BARBERA A., FUSARO C., Il governo delle democrazie, 2ª ed., Bologna, il Mu-
lino, 2001.BARBERA A., FUSARO C., Maggioranza, principio di, 1. Diritto, in Enciclope-
dia delle scienze sociali, vol. V, Roma, Treccani, 1996.BARBERA A., I costituzionalisti, nel trionfo e nel declino del «berlusconi-
smo», in Quaderni costituzionali, 2011, n. 4.BARBERA A., La forma di governo in transizione, in Quaderni costituzionali,
1995, n. 2.BARBERA A., Quattro domande dopo il referendum elettorale, in Quaderni
costituzionali, 2000, n. 3.BARBERA A., Sussidiarietà e bipolarismo “mite”, Relazione al Convegno pro-
mosso dall’Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, Sala Zuc-cari - Senato della Repubblica, 29 marzo 2007, in www.forumcostitu-zionale.it.
BARGONE A., Governo, in Nuovo digesto italiano, vol. VI, Torino, Utet,1938.
BARILE P., Consiglio dei ministri, in Enciclopedia giuridica, vol. VIII, Roma,Treccani, 1991.
BARILE P., Corso di diritto costituzionale, 2ª ed., Padova, Cedam, 1964.BARISIONE M., Interesse per la politica, appartenenza di coalizione e giudizio
sui leader: gli effetti della campagna elettorale, in PASQUINO G. (a curadi), Dall’Ulivo al governo Berlusconi, Bologna, il Mulino, 2002.
273BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
BARNATO V., I referendum elettorali: analisi dei quesiti, in Rivista trime-strale di diritto pubblico, 1992, n. 3.
BARNETT H., Constitutional and Administrative Law, 3ª ed., London andSidney, Cavendish Publishing Limited, 2000.
BARONE A., Il Consiglio supremo di difesa, in Diritto e società, 1982.BARTOLE S., Assetto del Governo e relazioni intragovernative, in Quaderni
costituzionali, 1981, n. 2.BARTOLE S., Democrazia maggioritaria, in Enciclopedia del diritto, agg., vol.
V, Milano, Giuffrè, 2001.BARTOLE S., Governo italiano, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol.
VII, Torino, Utet, 1991.BARTOLE S., Il caso Mancuso alla Corte costituzionale, in Giurisprudenza co-
stituzionale, 1996.BARTOLE S., Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubbli-
cana, Bologna, il Mulino, 2004.BARTOLE S., La forma di governo in transizione, in Quaderni costituzionali,
1995, n. 2.BARTOLINI S., CHIARAMONTE A., D’ALIMONTE R., Maggioritario finalmente?
Il bilancio di tre prove, in BARTOLINI S., D’ALIMONTE R. (a cura di),Maggioritario finalmente?, Bologna, il Mulino, 2002.
BARTOLINI S., D’ALIMONTE R., Il maggioritario dei miracoli, in BARTOLINI S.,D’ALIMONTE R. (a cura di), Maggioritario per caso, Bologna, il Mu-lino, 1997.
BARTOLINI S., D’ALIMONTE R., Maggioritario ma non troppo, Bologna, ilMulino, 1995.
BASSANINI F. (a cura di), Costituzione: una riforma sbagliata, Firenze, Pas-sigli, 2005.
BATTINI F., La Presidenza del Consiglio dei ministri alla vigilia della riforma,in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1998, n. 1.
BATTINI F., La presidenza del Consiglio: il modello organizzativo, in PAJNO
A., TORCHIA L. (a cura di), La riforma del Governo, Bologna, il Mu-lino, 2000.
BATTINI S., Gli uffici di staff dei ministri: diversi ma uguali?, in Rivista tri-mestrale di diritto pubblico, 2006, n. 3.
BEDINI L., Disincentivi regolamentari alla mobilità parlamentare, in Qua-derni costituzionali, 2000, n. 2.
BELLANDI R., Il Consiglio supremo di difesa, Bologna, il Mulino, 2011.BENTHAM J., A Fragment on Government, a cura di BURNS J.H., HART
H.L.A., London, The Athlon Press, 1977, trad. it., Un frammento sulgoverno, a cura di MARCUCCI S., Milano, Giuffrè, 1990.
274 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
BERTI G., Relazione generale, in AA.VV., Annuario 2001. Il Governo, Attidel XVI convegno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 novembre 2001,Padova, Cedam, 2002.
BIFULCO R., Art. 5, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di),Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, Utet, 2006.
BIFULCO R., Le riflessioni della cultura giuspubblicistica sulle convenzionicostituzionali, in Diritto e società, 1992.
BIN R., Che cos’è la Costituzione?, in Quaderni costituzionali, 2007, n. 1.BIN R., La disciplina dei gruppi parlamentari, in AA.VV., Annuario 2000. Il
Parlamento, Atti del XV convegno annuale dell’AIC, Firenze, 12-14ottobre 2000, Padova, Cedam, 2001.
BIONDI F., LEONE S., Il Governo “in” Parlamento: evoluzione storica e pro-blematiche attuali, in www.rivistaic.it, 14 marzo 2012.
BISCARETTI DI RUFFÌA P., Consiglio dei ministri, in Novissimo digesto ita-liano, vol. IV, Torino, Utet, 1957.
BISCARETTI DI RUFFÌA P., Diritto costituzionale, 7ª ed., Napoli, Jovene, 1965.BISCARETTI DI RUFFÌA P., Governo, in Novissimo digesto italiano, vol. VII,
Torino, Utet, 1957.BISCARETTI DI RUFFÌA P., Le scelte costituzionali fondamentali dell’Italia e
della Germania nel 1947-49 considerate dopo un quarantennio di at-tuazione, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1990, n. 1.
BITETTI P., La nascita del NARS e la sua collocazione istituzionale, in Eco-nomia pubblica, 2002, n. 4.
BOBBIO N., Consuetudine a) Teoria generale, in Enciclopedia del diritto, vol.IX, Milano, Giuffrè, 1961.
BOBBIO N., La democrazia e il potere invisibile, in Rivista italiana di scienzapolitica, 1980, n. 2.
BOCCACCINI G., Più partiti in nome del bipartitismo, in Quaderni costitu-zionali, 2000, n. 3.
BÖCKENFÖRDE E.W., Democrazia e rappresentanza, in Quaderni costituzio-nali, 1985, n. 2.
BRAUSWETTER H.H., Kanzlerprinzip, Ressortprinzip und Kabinettsprinzip inder ersten Regierung Brandt, 1969-1972, Bonn, Eichholz Verlag, 1977.
BRUNO T., Gabinetto, in Digesto italiano, vol. XII, Torino, Utet, 1900-1904.
BUCCISANO J., Premesse per uno studio sul Presidente del Consiglio dei mi-nistri, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1972.
BURATTI A., Governo, maggioranza e opposizione nel procedimento legisla-tivo e nella programmazione dei lavori parlamentari, in Diritto e so-cietà, 2002, n. 2.
275BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
BURDEAU G., Le régime parlementaire, Paris, Editions internationales, 1932,trad. it., Il regime parlamentare, Milano, Edizioni di Comunità, 1950.
CALANDRA P., Il Governo della Repubblica, Bologna, il Mulino, 1986.CALANDRA P., Problemi e proposte sull’ordinamento della Presidenza del
Consiglio, in Quaderni costituzionali, 1982, n. 1.CALIFANO L., Stato, Regioni e diritto comunitario nella Legge n. 11/2005, in
Quaderni costituzionali, 2005, n. 4.CALISE M., Presidentialization, Italian Style, in POGUNTKE T., WEBB P.
(eds.), The Presidentialization of Politics, Oxford, Oxford UniversityPress, 2005.
CANITANO E., L’anomalia del gruppo misto, in MERLINI S. (a cura di), Rap-presentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto italiano,vol. II, Torino, Giappichelli, 2004.
CAPANO G., GIULIANI M., Legiferare e governare fra prima e seconda Re-pubblica, in il Mulino, 2001, n. 5.
CAPOGRASSI G., La nuova democrazia diretta, Roma, Pinnaro, 1922, ora inID., Opere, vol. I, Milano, Giuffrè, 1959.
CAPOTOSTI P.A., Governo, in Enciclopedia giuridica, vol. XV, Roma, Trec-cani, 1989.
CAPOTOSTI P.A., Presidente del Consiglio dei ministri, in Enciclopedia deldiritto, vol. XXXV, Milano, Giuffrè, 1986.
CAPOTOSTI P.A., Presidente della Repubblica e formazione del governo, inStudi parlamentari e di politica costituzionale, 1980, n. 49-50.
CAPURSO M., È possibile un “Governo del primo ministro” in Italia?, inStudi parlamentari e di politica costituzionale, 1980, n. 49-50.
CAPURSO M., Sistema parlamentare, principio di maggioranza e consensodelle minoranze negli ordinamenti democratici e l’esperienza italiana,in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1981.
CARANTA R., Intervento pubblico nell’economia, in Digesto delle disciplinepubblicistiche, agg., Torino, Utet, 2000.
CARAVALE G., Il Governo del premier nell’esperienza costituzionale del Re-gno unito, Milano, Giuffrè, 1997.
CARAVITA B., LUCIANI M., Oltre la «democrazia bloccata»: ipotesi sui mecca-nismi elettorali, in Democrazia e diritto, 1982, n. 6.
CARBONE L., Qualità della regolazione e competitività: ricette diverse maingredienti comuni, Seminario su «Tecniche di produzione normativae “better regulation”», Roma, 26 gennaio 2007, consultabile inwww.astrid.eu.
CARBONI G.G., Art. 83, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a curadi), Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet, 2006.
276 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
CARDUCCI M., Art. 94, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di),Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet, 2006.
CARDUCCI M., Corte costituzionale e diritto parlamentare vivente, in Giuri-sprudenza italiana, 1996.
CARDUCCI M., L’accordo di coalizione, Padova, Cedam, 1989.CARETTI P., DE SIERVO U., Istituzioni di diritto pubblico, 4ª ed., Torino,
Giappichelli, 1999.CARETTI P., Principio maggioritario e democraticità del sistema costituzio-
nale, in www.costituzionalismo.it, 21 gennaio 2008.CARLASSARE L., A proposito di riforme, in www.rivistaic.it, 22 maggio 2012.CARLASSARE L., Maggioritario, in www.costituzionalismo.it, 23 aprile 2008.CARLASSARE L., Presidente della Repubblica, crisi di governo e scioglimento
delle Camere, in LUCIANI M., VOLPI M. (a cura di), Il Presidente dellaRepubblica, Bologna, il Mulino, 1997.
CARLASSARE L., Relazione generale, in AA.VV., Annuario 2001. Il Governo,Atti del XVI convegno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 novembre2001, Padova, Cedam, 2002.
CARPANI G., GROPPI T., OLIVETTI M., SINISCALCHI A. (a cura di), Le Regioniitaliane nei processi normativi comunitari dopo la legge n. 11/2005,Bologna, il Mulino, 2007.
CARTABIA M., Governo, in CASSESE S. (diretto da), Dizionario di diritto pub-blico, vol. III, Milano, Giuffrè, 2006.
CARTABIA M., VIOLINI L., Le norme generali sulla partecipazione dell’Italiaal processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecu-zione degli obblighi comunitari. Commento alla legge 4 febbraio 2005,n. 11, in Le Regioni, 2005, n. 4.
CARUSI V., Art. 92, in CRISAFULLI V., PALADIN L., Commentario breve allaCostituzione, Padova, Cedam, 1990.
CARUSI V., Art. 94, in CRISAFULLI V., PALADIN L., Commentario breve allaCostituzione, Padova, Cedam, 1990.
CARUSI V., Art. 95, in CRISAFULLI V., PALADIN L., Commentario breve allaCostituzione, Padova, Cedam, 1990.
CASSESE S., Esiste un governo in Italia?, Roma, Officina edizioni, 1980.CASSESE S., Il controllo delle partecipazioni statali, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 1980.CASSESE S., La nuova costituzione economica, 3ª ed. riveduta e aggiornata,
Roma-Bari, 2004.CASSESE S., La riforma costituzionale in Italia, in Rivista trimestrale di di-
ritto pubblico, 1992, n. 4.
277BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
CASSESE S., PEREZ R., Istituzioni di diritto pubblico, Roma, La Nuova ItaliaScientifica, 1989.
CASSETTI L., Il Governo e la regolazione del mercato alla ricerca di nuoviequilibri, in www.federalismi.it, 11 luglio 2007.
CATELANI E., Art. 95, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di),Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet, 2006.
CATELANI E., La nomina del Governo Prodi e le anomalie della procedura,in www.forumcostituzionale.it.
CATELANI E., Presidente del Consiglio dei ministri, in CASSESE S. (direttoda), Dizionario di diritto pubblico, vol. V, Milano, Giuffrè, 2006.
CECCANTI S., I “nuovi” sistemi elettorali: regolarità, anomalie, utilizzazionipreviste e impreviste, in www.federalismi.it, 20 ottobre 2005.
CECCANTI S., La forma neoparlamentare di governo alla prova della dottrinae della prassi, in Quaderni costituzionali, 2002, n. 1.
CECCANTI S., La legge elettorale nel contesto delle trasformazioni del dirittoparlamentare e della Costituzione e il connubio tra stabilità e ineffi-cienza, in www.federalismi.it, 23 febbraio 2006.
CECCANTI S., Regolamenti parlamentari: un altro tassello di una «riformastrisciante», in Quaderni costituzionali, 1998, n. 1.
CECCANTI S., Riforme istituzionali: passato e futuro, in il Mulino, 1994,n. 5.
CECCANTI S., Una Bicamerale in chiaroscuro, in Quaderni costituzionali,1995.
CELOTTO A., L’«abuso» del decreto-legge, Padova, Cedam, 1997.CERRI A., Corso di Giustizia costituzionale, 5ª ed., Milano, Giuffrè, 2008.CERULLI IRELLI V., Legislazione delegata e delegificazione, in AA.VV., An-
nuario 2000. Il Parlamento, Atti del XV convegno annuale dell’AIC,Firenze, 12-14 ottobre 2000, Padova, Cedam, 2001.
CERVATI A.A., Delegificazione, in Enciclopedia giuridica, vol. X, Roma,Treccani, 1997.
CHAGNOLLAUD D., QUERMONNE J-L., Le gouvernement de la France sous laVe République, Paris, Fayard, 1996.
CHELI E., Consiglio dei ministri, in Enciclopedia forense, vol. II, Milano,Vallardi, 1958.
CHELI E., Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia, Bologna, il Mu-lino, 1978.
CHELI E., La riforma mancata, Bologna, il Mulino, 2000.CHELI E., Ministeri e ministri, in Enciclopedia forense, vol. IV, Milano, Val-
lardi, 1959.
278 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
CHELI E., Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale, in StudiEconomico-Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università diCagliari, Padova, Cedam, 1966.
CHERCHI R., Il governo di coalizione in ambiente maggioritario, Napoli, Jo-vene, 2006.
CHERCHI R., Le crisi di Governo tra Costituzione ed effettività, in www.co-stituzionalismo.it, 12 settembre 2011.
CHESSA O., La democrazia maggioritaria nell’interpretazione costituzionaledella forma di governo, in Diritto pubblico, 2004, n. 1.
CHIAPPETTI A., La ricerca della Costituzione perduta, Torino, Giappichelli,2001.
CHIARELLI G., Elasticità della Costituzione, in Rivista trimestrale di dirittopubblico, 1952.
CHIARI S., Gli interventi nel settore agricolo, in SORACE D. (a cura di), I Co-mitati interministeriali economici, Bologna, il Mulino, 1991.
CHIEPPA R., Non basta una qualsiasi modifica alla legge elettorale, in Iusti-tia, 2007, n. 2.
CHIMENTI C., Addio prima Repubblica, Torino, Giappichelli, 1997.CHIMENTI C., L’opposizione parlamentare nella nostra democrazia maggiori-
taria, in Quaderni costituzionali, 2002, n. 4.CHIMIENTI P., Capo del Governo, in Nuovo digesto italiano, vol. II, Torino,
Utet, 1937.CHIMIENTI P., Consiglio dei ministri, in Nuovo digesto italiano, vol. III, To-
rino, Utet, 1938.CHIOLA C., Presidente della Repubblica e formazione del Governo, in LU-
CIANI M., VOLPI M. (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bolo-gna, il Mulino, 1997.
CHIOLA C., Uno strappo alla Costituzione: la sfiducia al singolo ministro, inGiurisprudenza costituzionale, 1986.
CIANCIO A., Riforma elettorale e ruolo garantistico del Presidente di Assem-blea parlamentare: un modello in crisi?, in Diritto e società, 1996, n. 3.
CIARLO P., Art. 95, in BRANCA G. (a cura di), Commentario della Costitu-zione, continuato da PIZZORUSSO A., Bologna-Roma, Zanichelli-IlForo italiano, 1994.
CIARLO P., Governo forte versus Parlamento debole: ovvero del bilancia-mento dei poteri, in AA.VV., Annuario 2001. Il Governo, Atti delXVI convegno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 novembre 2001, Pa-dova, Cedam, 2002.
CIARLO P., La legge sulla presidenza del consiglio e l’evoluzione della formadi governo, in Il Foro italiano, 1989.
279BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
CIAURRO G.F., Ministro, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVI, Milano,Giuffrè, 1976.
CICCONETTI S.M., Il mutamento di fatto della forma di governo italiana, inAA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. II, Torino, Giappi-chelli, 2005.
CICCONETTI S.M., Sistemi elettorali e sistemi dei partiti, in Rivista trime-strale di diritto pubblico, 1996, n. 4.
CIMINO B., Gli uffici di diretta collaborazione nella Presidenza del Consigliodei ministri, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, n. 3.
CIRIELLO P., Ordinamento di governo e comitati interministeriali, Napoli,Jovene, 1981.
COCOZZA V., Costituzione II) Costituzione italiana, in Enciclopedia giuri-dica, vol. X, Roma, Treccani, 1988.
CODUTI D., Art. 58, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di),Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet, 2006.
CODUTI D., Comitati interministeriali e di ministri, in Digesto delle disci-pline pubblicistiche, agg., Torino, Utet, 2012.
CODUTI D., La partecipazione delle Regioni al processo normativo comuni-tario, con particolare riferimento alla c.d. fase discendente, in CARPANI
G., GROPPI T., OLIVETTI M., SINISCALCHI A. (a cura di), Le Regioniitaliane nei processi normativi comunitari dopo la legge n. 11/2005,Bologna, il Mulino, 2007.
COLAPIETRO C., Il Governo e la Pubblica Amministrazione, in MODUGNO F.(a cura di), Lineamenti di diritto pubblico, 2ª ed., Torino, Giappi-chelli, 2011.
COLARIZI S., Storia dei partiti nell’Italia repubblicana, Bari, Laterza, 1994.CORSO G., Individuo, decisione collettiva, principio maggioritario, in
AA.VV., Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, vol. I, Milano,Giuffrè, 1988.
COSTANZO P., FERRARI G.F., FLORIDIA G.G., ROMBOLI R., SICARDI S. (a curadi), La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. I pro-getti, i lavori, i testi approvati, Padova, Cedam, 1998.
COTTA M., Il Parlamento nel sistema politico italiano. Mutamenti istituzio-nali e cicli politici, in Quaderni costituzionali, 1991, n. 2.
COZZOLI V., I gruppi parlamentari nella transizione del sistema politico-isti-tuzionale, Milano, Giuffrè, 2002.
CRISAFULLI V., Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, 1, 6ª ed. aggiornataa cura di CRISAFULLI F., Padova, Cedam, 1993.
CRISAFULLI V., Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, 2, 5ª ed. riveduta eaggiornata, Padova, Cedam, 1984.
280 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
CRISAFULLI V., Stato Popolo Governo, Milano, Giuffrè, 1985.CROSA E., Gli organi costituzionali e il Presidente della Repubblica nella
Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1951.CUCCODORO E., Collegialità ministeriale, comitati e vertici, in Rivista trime-
strale di diritto pubblico, 1983.CUCCODORO E., I limiti della commissione per le riforme istituzionali, in
Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1992, n. 97-98.CUOCOLO F., Consiglio dei ministri, in Enciclopedia del diritto, vol. IX, Mi-
lano, Giuffrè, 1961.CUOCOLO F., Disomogeneità politica e tendenze nello sviluppo della forma
di governo italiana, in Quaderni costituzionali, 1981, n. 2.CUOCOLO F., Il Governo nel vigente ordinamento italiano, vol. I, Milano,
Giuffrè, 1959.CUOCOLO F., Istituzioni di diritto pubblico, 12ª ed., Milano, Giuffrè, 2003.CUOCOLO F., Programma di Governo, indirizzo politico, mozione motivata
di fiducia, in Diritto e società, 1982.CUOMO G., Unità e omogeneità nel governo parlamentare, Napoli, Jovene,
1957.CURRERI S., I gruppi parlamentari nella XV legislatura, in Quaderni costitu-
zionali, 2006, n. 3.CURRERI S., Il ruolo dei gruppi parlamentari tra fonti normative e prospet-
tive politiche, in MERLINI S., (a cura di), Rappresentanza politica,gruppi parlamentari, partiti: il contesto italiano, vol. II, Torino, Giap-pichelli, 2004.
D’ALIMONTE R., CHIARAMONTE A., Il nuovo sistema elettorale italiano: qualiopportunità?, in Rivista italiana di scienza politica, 1993, n. 3.
D’ALIMONTE R., Italy: A Case of Fragmented Bipolarism, in GALLAGHER M.,MITCHELL P. (eds.), The Politics of Electoral Systems, Oxford, OxfordUniversity Press, 2006.
D’ALIMONTE R., L’uninominale incompiuto, in il Mulino, 1994, n. 1.D’ANDREA A., Art. 92, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di),
Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet, 2006.D’ANDREA A., Considerazioni sull’evoluzione del bipolarismo nel sistema di
governo in Italia, in ID. (a cura di), Lo sviluppo bipolare della forma digoverno italiana, Milano, Giuffrè, 2003.
D’ANDREA A., La funzione parlamentare, in www.rivistaic.it, 12 giugno2012.
D’ANDREA A., La riconsiderazione della funzione parlamentare quale stradaobbligata per puntellare la traballante democrazia italiana, in www.ri-vistaic.it, 7 dicembre 2010.
281BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
D’ANDREA A., Osservazioni conclusive, in ID. (a cura di), Verso l’incerto bi-polarismo, Milano, Giuffrè, 1999.
D’ANDREA A., Partiti politici ed evoluzione della forma di governo nell’or-dinamento italiano, in www.forumcostituzionale.it, relazione del 5 no-vembre 2005.
D’ANIELLO E., Il Comitato interministeriale per la programmazione econo-mica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1973.
D’ANIELLO E., Modalità di determinazione degli indirizzi di politica indu-striale e sistema di governo delle agevolazioni finanziarie nella legge n.675 del 1977, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1978.
D’ATENA A., La revisione della Costituzione tra maggioritario e sindromedella grande riforma, in Diritto e società, 2011, n. 1.
D’AURIA G., La nuova geografia dei ministeri, in Giornale di diritto ammi-nistrativo, 2000, n. 1.
D’ORTA C., La riforma della presidenza del Consiglio, in Giornale di dirittoamministrativo, 2000, n. 1.
DAINTITH T., PAGE A., The Executive in the Constitution, Oxford, OxfordUniversity Press, 1999.
DE FIORES C., La Commissione bicamerale per le riforme istituzionali el’art. 138 Cost.: paradossi di una riforma, in Giurisprudenza costitu-zionale, 1993, n. 2.
DE FIORES C., Rappresentanza politica e sistemi elettorali in Italia, inwww.costituzionalismo.it, 16 ottobre 2007.
DE SIERVO U., Considerazioni sull’ordinamento e l’organizzazione del Go-verno, in AA.VV., Annuario 2001. Il Governo, Atti del XVI conve-gno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 novembre 2001, Padova, Ce-dam, 2002.
DE SIERVO U., Modelli stranieri ed influenze internazionali nel dibattito del-l’Assemblea costituente, in Quaderni costituzionali, 1981.
DE SIERVO U., Un travolgente processo di trasformazione del sistema dellefonti a livello nazionale, in ID. (a cura di), Osservatorio sulle fonti1998, Torino, Giappichelli, 1999.
DE SIMONE C., La Camera approva il disegno di legge Buttiglione, recante“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativodell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi co-munitari”, in www.rivistaic.it, 25 luglio 2003.
DE VERGOTTINI G., Art. 87, in BRANCA G. (a cura di), Commentario dellaCostituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1978.
DE VERGOTTINI G., L’evoluzione del sistema politico-istituzionale, inwww.federalismi.it, 4 maggio 2011.
282 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
DE VERGOTTINI G., Per una razionalizzazione della collegialità nel Governo,in Le Regioni, 1987, n. 3.
DE VINCENTI C., Non solo energia e telecomunicazioni: i problemi dellatransizione avviata nella regolazione delle altre utilities, in Economiapubblica, 2002, n. 4.
DEL VESCOVO P., Il Consiglio di Gabinetto. Un tentativo di rafforzamentodel Governo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1988.
DELION A.G., Les conseils et comité interministériels, in A.J.D.A., 1975.DELL’ACQUA C., Indicazione del premier e poteri del Quirinale, in Quaderni
costituzionali, 2001, n. 1.DEMURO G., Regole costituzionali non scritte tra diritto e altre scienze, To-
rino, Giappichelli, 2003.DI ANDREA C., Sulle ultime modificazioni del regolamento della Camera dei
deputati, in Rassegna parlamentare, 1999, n. 1.DI GASPARE G., Gli strumenti negoziali della governance esterna e della go-
vernance istituzionale, Estratti da Studio realizzato per il progettoGovernance del Formez (dicembre 2004), in www.amministrazio-neincammino.luiss.it.
DI GIOVINE A., PIZZETTI F., Nuove leggi elettorali e sistema politico, in Giu-risprudenza costituzionale, 1993.
DI PORTO V., I numeri delle leggi, in Il Filangieri, Quaderno 2008.DI VIRGILIO A., Legge elettorale correggere i difetti per chiudere un ciclo, in
il Mulino, 2007, n. 1.DI VIRGILIO A., Uniti si vince? Voto e politica delle alleanze, in il Mulino,
2001, n. 4.DICEY A.V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution
[1885], Indianapolis, Liberty Classics, 1982.DIMORA F., Art. 87, in BARTOLE S., BIN R. (a cura di), Commentario breve
alla Costituzione Paladin-Crisafulli, 2ª ed., Padova, Cedam, 2008.DOGLIANI M., Indirizzo politico, Napoli, Jovene, 1985.DOGLIANI M., Spunti metodologici per un’indagine sulle forme di governo,
in Giurisprudenza costituzionale, 1973.DONATI F., La responsabilità politica dei ministri nella forma di governo ita-
liana, Torino, Giappichelli, 1997.DORIA G., TRIPODI S., Cronaca di una strana crisi di governo, in www.fede-
ralismi.it, 27 febbraio 2007.DOSSETTI G., Costituzione e riforme, in Quaderni costituzionali, 1995, n. 2.DOSSETTI G., I valori della Costituzione italiana, in Archivio giuridico Fi-
lippo Serafini, 1995, n. 1.
283BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
DURANTI S., SAWICKI J., La nuova legge per l’elezione del Senato della Re-pubblica e della Camera dei deputati (legge 21 dicembre 2005, n. 270),in www.federalismi.it, 26 gennaio 2006.
DUVERGER M., Institutions politiques et droit constitutionnel I. Les grandssystèmes politiques, 1955, trad. it., I sistemi politici, Bari, Laterza,1978.
DUVERGER M., Political Parties: Their Organization and Activity in the Mo-dern State, 3ª ed., London, Methuen, 1964.
ELIA L., Appunti sulla formazione del Governo, in Giurisprudenza costitu-zionale, 1957.
ELIA L., Commissioni parlamentari, in Enciclopedia del diritto, vol. VII,Milano, Giuffrè, 1960.
ELIA L., Forme di stato e forme di governo, in CASSESE S. (diretto da), Di-zionario di diritto pubblico, vol. III, Milano, Giuffrè, 2006.
ELIA L., Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, vol. XIX, Milano,Giuffrè, 1970.
ELIA L., Il «direttorio» nel governo di coalizione, in Giurisprudenza costitu-zionale, 1971.
ELIA L., L’evoluzione della forma di governo, in AA.VV., Studi in onore diGianni Ferrara, vol. II, Torino, Giappichelli, 2005.
ELIA L., La Costituzione aggredita, Bologna, il Mulino, 2005.ELIA L., La presidenzializzazione della politica, in Teoria politica, 2006, n. 1.ELIA L., Primo ministro (diritto comparato), in Novissimo digesto italiano,
vol. XIII, Torino, Utet, 1957.ELIA L., Problemi costituzionali dell’amministrazione centrale, Milano,
Giuffrè, 1966, ora in ID., Studi di diritto costituzionale (1958-1966),Milano, Giuffrè, 2005.
ENDRICI G., ZUELLI F., Amministrazione pubblica dell’economia, in VAS-SALLI F., VISENTINI G. (a cura di), Legislazione economica, vol. II, Mi-lano, Giuffrè, 1979.
ESPOSITO C., Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Ce-dam, 1954.
ESPOSITO C., Consuetudine (dir. cost.), in Enciclopedia del diritto, vol. IX,Milano, Giuffrè, 1961.
ESPOSITO C., Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi inItalia, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954.
ESPOSITO C., Saggio sulla controfirma ministeriale, in ID., Capo dello Stato -Controfirma ministeriale, Milano, Giuffrè, 1962.
FABBRINI S., Il Principe democratico, Bari, Laterza, 1999.
284 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
FABBRINI S., VASSALLO S., Il governo, Bari, Laterza, 1999.FALCON G., Lineamenti di diritto pubblico, 8ª ed., Padova, Cedam, 2001.FENUCCI F., Il concorso del Comitato interministeriale per il credito e il ri-
sparmio alla determinazione dell’indirizzo economico, Napoli, Liguorieditore, 1984.
FENUCCI F., Il governo del credito, Milano, Giuffrè, 1996.FEROCI V., Dal Comitato centrale intersindacale, al Comitato corporativo
centrale, alla Commissione suprema per l’autarchia, in AA.VV., Scrittigiuridici in onore di Santi Romano, vol. III, Padova, Cedam, 1940.
FERRARA G., Editoriale, in www.costituzionalismo.it, 10 maggio 2012.FERRARA G., Il Presidente di Assemblea parlamentare, Milano, Giuffrè,
1965.FERRARA G., La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Mi-
lano, Feltrinelli, 2006.FICHERA C., La politica delle istituzioni in fase non costituente, in ATRIPALDI
V., FICHERA C., Dalla grande riforma alla politica delle istituzioni, Pa-dova, Cedam, 1986.
FISICHELLA D., Elezioni (sistemi elettorali), in Enciclopedia del diritto, vol.XIV, Milano, Giuffrè, 1965.
FISICHELLA D., Elezioni e democrazia, Bologna, il Mulino, 2003.FISICHELLA D., Recenti sviluppi del dibattito sulla riforma elettorale in Ita-
lia, in Quaderni costituzionali, 1981, n. 3.FLORIDIA G.G., L’eccezione e la regola: lo scioglimento del 1994, in Corriere
giuridico, 1994, n. 3.FOCACCIA G., Collegialità ristretta e razionalizzazione della struttura di go-
verno, in Diritto e società, 1987.FOCACCIA G., Consiglio di Gabinetto e organizzazione del Governo, in Di-
ritto e società, 1986.FOLLIERI E., Quadro positivo dell’organizzazione amministrativa statale, in
MAZZAROLLI L., PERICU G., ROMANO A., ROVERSI MONACO F.A., SCOCA
F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, Monduzzi, 2001.FRANCHINI M., Brevi note sulla figura della «Autorità delegata» nella legge
di riforma del sistema nazionale delle informazioni per la sicurezza(legge n. 124 del 2007), in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. I,Napoli, Jovene, 2010.
FRIEDRICH C.J., Constitutional Government and Democracy, Boston, Ginnand company, 1950, trad. it., Governo costituzionale e democrazia, Vi-cenza, Neri Pozza Editore, s.d.
FROSINI T.E., La forma di governo del premierato, in Il Filangieri, Qua-derno 2006.
285BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
FROSINI T.E., Sovranità popolare, principio maggioritario e riforme istituzio-nali, in Diritto e società, 1995, n. 4.
FROSINI T.E., Suggestioni anglosassoni sulla forma di governo della Repub-blica italiana, in Diritto e società, 2001, n. 1.
FROSINI T.E., Una nota sull’elettorato (passivo) degli italiani all’estero, inwww.forumcostituzionale.it.
FURLANI S., Elezioni, in Enciclopedia giuridica, vol. XII, Roma, Treccani,1989.
FUSARO C., Elezioni, in CASSESE S. (diretto da), Dizionario di diritto pub-blico, vol. III, Milano, Giuffrè, 2006.
FUSARO C., Forma di governo e principio maggioritario. La CommissioneBozzi e le strategie istituzionali dei partiti, in AA.VV., Scritti in onoredi Aldo Bozzi, Padova, Cedam, 1992.
FUSARO C., Il voto all’estero: quando i costituzionalisti […] non ci stanno,in Quaderni costituzionali, 2002, n. 2.
FUSARO C., La legge regionale toscana sulle primarie, in Le Regioni, 2005,n. 3.
FUSARO C., La questione dei voti della Valle d’Aosta nella legge proporzio-nale con premio in attesa di promulgazione, in www.forumcostituzio-nale.it, 19 dicembre 2005.
FUSARO C., Le regole della transizione, Bologna, il Mulino, 1995.FUSARO C., Media, sondaggi e spese elettorali: la nuova disciplina, in Rivista
italiana di scienza politica, 1994, n. 3.FUSARO C., Principio maggioritario e forma di governo, ed. provvisoria, Fi-
renze, Università degli Studi di Firenze, 1990.FUSARO C., RUBECHI M., Art. 56, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M.
(a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet,2006.
FUSARO C., RUBECHI M., Art. 57, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (acura di), Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet, 2006.
FUSARO C., Scalfaro e la transizione: non ha fatto quel che poteva, in Qua-derni costituzionali, 1999, n. 2.
GABRIELE F., Le nuove norme sull’elezione e sulle competenze degli organidei Comuni e delle Province, Bari, Cacucci, 1994.
GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi. L’attività, vol. II, Mi-lano, Giuffrè, 1975.
GALATERIA L., Gli organi collegiali amministrativi. La struttura, vol. I, Mi-lano, Giuffrè, 1975.
GALEOTTI S., Un governo scelto dal popolo: il Governo di legislatura, Mi-lano, Giuffrè, 1984.
286 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
GALGANO F., Principio di maggioranza, in Enciclopedia del diritto, vol.XXXV, Milano, Giuffrè, 1986.
GALLAGHER M., MITCHELL P., Introduction to Electoral Systems, in ID.(eds.), The Politics of Electoral Systems, Oxford, Oxford UniversityPress, 2006.
GAMBALE P., ‘Prima lettura’ del Parlamento per le modifiche alla “Legge LaPergola”: una nuova cornice normativa per definire la partecipazionedel “sistema Italia” nelle politiche UE?, in www.amministrazionein-cammino.luiss.it.
GAMBINO S., La «razionalizzazione» del potere esecutivo in Italia, in Qua-derni costituzionali, 1988, n. 3.
GAMBINO S., MOSCHELLA G., Regole elettorali, sistema politico e forma digoverno. Il caso italiano, in GAMBINO S. (a cura di), Forme di governoe sistemi elettorali, Padova, Cedam, 1995.
GAMBINO S., Riforme elettorali e modelli di democrazia, in www.federali-smi.it, 9 gennaio 2006.
GATTA E., Ministeri e ministri, in Nuovo digesto italiano, vol. VIII, Torino,Utet, 1939.
GATTA E., Presidenza del Consiglio dei ministri, in Novissimo digesto ita-liano, vol. XIII, Torino, Utet, 1957.
GENTILE M., Nasce il Ciace per concordare le strategie di Governo, in Guidaal diritto, 2005, n. 9.
GIANFRANCESCO E., Ciò che è vivo e ciò che è morto nei regolamenti parla-mentari del 1971, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti inonore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011.
GIANFRANCESCO E., LUPO N. (a cura di), Interna corporis degli organi costi-tuzionali, in www.osservatoriosullefonti.it, 2009, n. 1.
GIANNINI M.S., Diritto pubblico dell’economia, Bologna, il Mulino, 1977.GIANNINI M.S., Istituti di credito e servizi di interesse pubblico, in Moneta
e credito, 1949, ora in ID., Scritti, vol. III, Milano, Giuffrè, 2003.GIANNINI M.S., Rapporto sui principali problemi dell’Amministrazione
dello Stato, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1982.GIANNINI M.S., Sulla consuetudine, in Rivista internazionale di filosofia del
diritto, 1947, ora in ID., Scritti, vol. II, Milano, Giuffrè, 2002.GICQUEL J., Droit constitutionnel et institutions politiques, 14ª ed., Paris,
Montchrestien, 1995.GIOCOLI NACCI P., Articolazioni interne del Governo. Gli organi non neces-
sari, Torino, Giappichelli, 1995.
287BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
GIOCOLI NACCI P., Comitati di ministri e comitati interministeriali, in GIO-COLI NACCI P., LOIODICE A., Studi di diritto costituzionale, Bari, Ca-cucci, 1995.
GIROTTO D., Parlamento italiano e processo normativo europeo, Napoli, Jo-vene, 2009.
GIUSTI M., Fondamenti di diritto dell’economia, Padova, Cedam, 2005.GORLANI M., Le elezioni del 13 maggio 2001, in D’ANDREA A. (a cura di),
Lo sviluppo bipolare della forma di governo italiana, Milano, Giuffrè,2003.
GRASSO P.G., Rilevanza costituzionale del sistema elettorale nell’ordina-mento repubblicano, in Diritto e società, 1995, n. 4.
GROPPI T., Forma di governo e sistemi elettorali in Italia, in www.astrid.eu,25 gennaio 2007.
GROPPI T., La forma di governo italiana nella giurisprudenza costituzionale:la Corte a difesa del «monismo parlamentare»?, in Politica del diritto,2000, n. 3.
GROSSO E., Art. 48, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di),Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, Utet, 2006.
GROSSO E., Il voto all’estero: tra difficoltà applicative e dubbi di costituzio-nalità, in Quaderni costituzionali, 2002, n. 2.
GROTTANELLI DE’ SANTI G., Indirizzo politico, in Enciclopedia giuridica, vol.XVI, Roma, Treccani, 1989.
GUARDUCCI E., Natura e collocazione dei gruppi parlamentari in Italia, inMERLINI S. (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari,partiti: il contesto italiano, vol. II, Torino, Giappichelli, 2004.
GUARINO G., Due anni di esperienza costituzionale italiana, in Rassegna didiritto pubblico, 1946.
GUARINO G., Il Governo, in Potere, poteri emergenti e loro vicissitudini nel-l’esperienza giuridica italiana, Padova, Cedam, 1986, ora in ID., DallaCostituzione all’Unione europea, vol. V, Napoli, Jovene, 1994.
GUARINO G., Il Presidente della Repubblica italiana, in Rivista trimestraledi diritto pubblico, 1951.
GUARINO G., Il regime parlamentare, in Scritti dedicati ad Alessandro Ra-selli, vol. I, Milano, Giuffrè, 1971, ora in ID., Dalla Costituzione al-l’Unione europea, vol. III, Napoli, Jovene, 1994.
GUARINO G., L’ordinamento della Presidenza del Consiglio, in Rassegnaparlamentare, 1959, ora in ID., Dalla Costituzione all’Unione europea,vol. II, Napoli, Jovene, 1994.
288 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
GUARINO G., L’organizzazione del Governo e i Comitati interministeriali,resoconto ciclostilato a cura della segreteria del Centro di prepara-zione politico-amministrativa, Roma, 1954.
GUARINO G., Leggi recenti e sistema delle partecipazioni statali, in Rivistatrimestrale di diritto pubblico, 1968.
GUARINO G., Pubblico e privato nella economia. La sovranità tra Costitu-zione ed istituzioni comunitarie, in Quaderni costituzionali, 1992, n. 1.
GUARINO G., Questione morale, Costituzione, riforme, in Studi e docu-menti, 1988, n. 14, ora in ID., Dalla Costituzione all’Unione europea,vol. IV, Napoli, Jovene, 1994.
GUARINO G., Riflessioni sui regimi democratici, in Politica del diritto, 1991,n. 1.
GUARINO G., Stato sociale e sviluppo in Italia (1945-1992): notazioni e ipo-tesi, in Economia italiana, 2007, n. 1.
GUARINO G., Superdimensionamento della classe politica e disfunzioni delsistema, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1984, ora inID., Dalla Costituzione all’Unione europea, vol. IV, Napoli, Jovene,1994.
GUASTINI R., Teoria e dogmatica delle fonti, in CICU A., MESSINEO F. (di-retto da), Trattato di diritto civile e commerciale, continuato da MEN-GONI L., vol. I, tomo 1, Milano, Giuffrè, 1998.
GUICCIARDI E., Il Comitato interministeriale prezzi: un “fuori legge”, in Giu-risprudenza italiana, 1962.
GUIGLIA G., Il regolamento di attuazione del Consiglio supremo di difesa ei rapporti tra Presidente della Repubblica e Presidente del consiglio deiministri, in Quaderni costituzionali, 1991, n. 1.
HÄBERLE P., Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura,ed. italiana a cura di LUTHER J., Roma, Carocci, 2001.
HABERMAS J., Strukturwandel der Oeffentlichkeit, Neuwied, Hermann Lu-chterhand Verlag, 1962, trad. it., Storia e critica dell’opinione pub-blica, Roma-Bari, Laterza, 1977.
HAMON F., TROPER M., Droit constitutionnel, 29ª ed., Paris, L.G.D.J.,2005.
HAZELL R., YONG B., Inside Story: How Coalition Government Works. In-terim Report, in www.ucl.ac.uk, 3 giugno 2011.
HOLLIDAY I., Executives and Administrations, in DUNLEAVY P., GAMBLE A.,HEFFERNAN R., HOLLIDAY I., PEELE G. (eds.), Developments in BritishPolitics 6, Basingstoke and New York, Palgrave, 2002.
IACOMETTI M., I presidenti di Assemblea parlamentare, Milano, Giuffrè,2001.
289BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
ILARDI M., La crisi di potere del partito politico, in Democrazia e diritto,1979, n. 2.
JAMES S., British Cabinet Government, London and New York, Routledge,1994.
JELLINEK G., Allgemeine Staatslehre, 3ª ed., Berlin, O. Häring, 1914, trad.it., JELLINEK G., ORLANDO V.E., La dottrina generale del diritto delloStato, Milano, Giuffrè, 1949.
JELLINEK G., L’État moderne et son droit [1913], parte II, Paris, L.G.D.J.Diffuseur, 2005.
JEMOLO C., GIANNINI M.S. (a cura di), Lo Statuto albertino, Firenze, San-soni, 1946.
JENNINGS I., Cabinet Government, 2ª ed., Cambridge, Cambridge Univer-sity Press, 1951.
KATZ R.S., Why Are There So Many (or So Few) Electoral Reforms?, inGALLAGHER M., MITCHELL P. (eds.), The Politics of Electoral Systems,Oxford, Oxford University Press, 2006.
KEITH A.B., The British Cabinet System, 2ª ed. by N.H. GIBBS, London,Stevens & Sons Limited, 1952.
KELSEN H., Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen, Mohr, 1929,trad. it., Essenza e valore della democrazia, in ID., La democrazia, 5ªed., Bologna, il Mulino, 1984.
KIRCHHEIMER O., Weimar - und was dann? Analyse einer Verfassung, in Po-litik und Verfassung, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1964, trad.it., Analisi di una Costituzione. Weimar - E poi?, in ID., Costituzionesenza sovranità, Bari, De Donato, 1982.
La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Co-stituente, voll. IV, VII e VIII, a cura del Segretariato generale dellaCamera dei deputati, Roma, 1970-1971.
LABRIOLA S., Consiglio supremo di difesa, in Enciclopedia giuridica, vol.VIII, Roma, Treccani, 1988.
LABRIOLA S., Il comando supremo delle forze armate, in Studi parlamentarie di politica costituzionale, 1980, n. 49-50.
LABRIOLA S., Il Governo della Repubblica. Organi e poteri. Commento allalegge 23 agosto 1988, n. 400, Rimini, Maggioli, 1989.
LABRIOLA S., Il principio maggioritario e la Costituzione repubblicana: rilet-tura in termini di attualità, in Studi parlamentari e di politica costitu-zionale, 1995, n. 1.
LABRIOLA S., La forma di governo nella Costituzione repubblicana in Italia:temi per una revisione ed i principi di regime, in AA.VV., Scritti inonore di Aldo Bozzi, Padova, Cedam, 1992.
290 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
LABRIOLA S., Note sullo statuto costituzionale dell’opposizione, in Diritto esocietà, 2000, n. 2.
LABRIOLA S., Per una storia breve di un lungo decennio, in www.costituzio-nalismo.it, 11 ottobre 2004.
LABRIOLA S., Presidente della Repubblica, struttura del Governo, Consigliodi Gabinetto, in Diritto e società, 1985.
LABRIOLA S., Principio maggioritario e statuto dell’opposizione parlamen-tare, in Diritto e società, 1995, n. 3.
LABRIOLA S., Revoca del ministro e rapporto di fiducia, in Rivista trimestraledi diritto pubblico, 1983.
LANCHESTER F., Il nuovo attraverso il vecchio: la legge n. 81/1993 sull’ele-zione degli Enti locali, in Nomos, 1993, n. 2.
LANCHESTER F., L’innovazione istituzionale difficile: il dibattito sulla rappre-sentanza politica agli inizi della XI legislatura, in Rivista trimestrale didiritto pubblico, 1992, n. 4.
LANCHESTER F., Riforme elettorali e forma di governo: riflessioni sulle inno-vazioni istituzionali e i pericoli delle «democrazie a basso rendimento»,in LUCIANI M., VOLPI M. (a cura di), Riforme elettorali, Roma-Bari,Laterza, 1995
LASKI H.J., A Grammar of Politics, 6ª ed., London, George Allen & UnwinLtd, 1967.
LAVAGNA C., Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista tri-mestrale di diritto pubblico, 1952, n. 4.
LAVAGNA C., Istituzioni di diritto pubblico, 6ª ed., Torino, Utet, 1985.LEIBHOLZ G., Crisi della rappresentanza e sistemi elettorali (intervista a
cura di LANCHESTER F.), in Quaderni costituzionali, 1981, n. 3.LEIBHOLZ G., Parteienstaat und repräsentative Demokratie. Eine Betrach-
tung zu Art. 21 und 38 des Bonner Grundgesetzes, in RAUSCH H. (ed.),Zur Theorie und Geschichte der Repräsentativ-verfassung, Darmstadt,Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968, trad. it., Stato dei partiti edemocrazia rappresentativa. Considerazioni intorno all’articolo 21 e al-l’articolo 38 della Legge Fondamentale di Bonn, in LEIBHOLZ G., Larappresentazione nella democrazia, Milano, Giuffrè, 1989.
LEVI A., La Seconda Repubblica in movimento, in il Mulino, 1994, n. 3.LEWIS D.K., Convention. A Philosophical Study, Oxford, Blackwell, 1969.LIBERTINI M. (a cura di), Legge 12 agosto 1977, n. 675, in Le nuove leggi ci-
vili commentate, 1978.LIGNANI P.G., L’amministrazione centrale dello Stato, in SANTANIELLO G.
(diretto da), Trattato di diritto amministrativo, vol. VI, Padova, Ce-dam, 1990.
291BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
LIJPHART A., Patterns of Democracy. Government Forms and Performancein Thirty-Six Countries, New Haven, London, Yale University Press,1999, trad. it., Le democrazie contemporanee, Bologna, il Mulino,2001.
LIPPOLIS V., La centralità del Governo nel sistema politico. Le specificità delcaso italiano, in Il Filangieri, Quaderno 2010.
LIPPOLIS V., Le procedure parlamentari del rapporto fiduciario, in MARTINES
T., SILVESTRI G., DE CARO C., LIPPOLIS V., MORETTI R., Diritto parla-mentare, Milano, Giuffrè, 2005.
LONG G., Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, in Enciclopediagiuridica, vol. XXII, Roma, Treccani, 1990.
LUCIANI M., Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali, vol.III, Milano, Giuffrè, 2010.
LUCIANI M., Riforme elettorali e disegno costituzionale, in LUCIANI M.,VOLPI M. (a cura di), Riforme elettorali, Roma-Bari, Laterza, 1995.
LUPO N., Dalla legge al regolamento, Bologna, il Mulino, 2003.LUPO N., I gruppi parlamentari nel parlamentarismo maggioritario, in De-
mocrazia e diritto, 2009, n. 3/4.LUPO N., Il ruolo normativo del Governo, in Il Filangieri, Quaderno 2010.LUPO N., PERNICIARO G., Riforma del regolamento del Senato: un approccio
bipartisan, ma non ancora sufficientemente organico, in www.osserva-toriosullefonti.it, 2012, n. 1.
LUPO N., Statuto dell’opposizione, poteri di controllo e autonomia regola-mentare delle Camere, in ATRIPALDI V., BIFULCO R. (a cura di), LaCommissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII le-gislatura, Torino, Giappichelli, 1998.
MACCABIANI N., FRAU M., TIRA E., Dalla crisi del IV Governo Berlusconialla formazione del I Governo Monti, in www.rivistaic.it, 22 febbraio2012.
MACCABIANI N., Il ruolo del Presidente della Repubblica a fronte delle diffi-coltà interne alle maggioranze parlamentari di centro-sinistra e di cen-tro-destra durante la XV e la XVI legislatura, in www.rivistaic.it, 18gennaio 2011.
MACKINTOSH J.P., The British Cabinet, London, Stevens & Sons Limited,1962.
MALFATTI E., PANIZZA S., ROMBOLI R., Giustizia costituzionale, 3ª ed., To-rino, Giappichelli, 2011.
MANETTI M., Un passo avanti verso la riforma delle autorità indipendenti,in Rassegna parlamentare, 2007.
292 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
MANGIAMELI S., Il Governo tra Unione europea e autonomie territoriali, inAA.VV., Annuario 2001. Il Governo, Atti del XVI convegno annualedell’AIC, Palermo, 8-10 novembre 2001, Padova, Cedam, 2002.
MANGIAMELI S., La forma di governo parlamentare, Torino, Giappichelli,1998.
MANNINO A., Indirizzo politico e fiducia, Milano, Giuffrè, 1973.MANNINO A., L’abuso della mobilità parlamentare: ripensare il divieto del
mandato imperativo, in Quaderni costituzionali, 2001, n. 1.MANZELLA A., Il Capo di Stato in «Consiglio supremo di difesa», in Qua-
derni costituzionali, 1987, n. 2.MANZELLA A., Il parlamento, 3ª ed., Bologna, il Mulino, 2003.MANZELLA A., La forma di governo in transizione, in Quaderni costituzio-
nali, 1995, n. 2.MANZELLA A., Prefazione, in GIANNITI L., LUPO N., Corso di diritto parla-
mentare, Bologna, il Mulino, 2008.MARAVIGLIA M., Gran Consiglio del Fascismo, in Nuovo digesto italiano,
vol. VI, Torino, Utet, 1938.MARCHI T., Il Governo, in CALAMANDREI P., LEVI A. (a cura di), Commen-
tario sistematico alla Costituzione italiana, vol. II, Firenze, Barbera,1950.
MARI A., L’organizzazione e il funzionamento della pubblica amministra-zione: misure urgenti e questioni di lungo periodo, in Giornale di di-ritto amministrativo, 2006, n. 6.
MARONGIU A., Storia del diritto pubblico, Milano, Cisalpino-Giuridica,1973.
MARSHALL G., Constitutional Conventions, Oxford, Clarendon Press, 2001.MARTINES T., Diritto costituzionale, 8ª ed., Milano, Giuffrè, 1994.MARTINES T., Governo parlamentare e ordinamento democratico, Milano,
Giuffrè, 1967.MARTINES T., Indirizzo politico, in Enciclopedia del diritto, vol. XXI, Mi-
lano, Giuffrè, 1971.MARTINI C., La «nuova» riforma dei ministeri, in Quaderni costituzionali,
2006, n. 3.MASINI P., La mozione di sfiducia a singoli ministri, in Diritto e società,
1982.MASSARI O., La crisi di governo e il bipolarismo difettoso, in il Mulino,
2005.MASSARI O., PASQUINO G. (a cura di), Rappresentare e governare, Bologna,
il Mulino, 1994.
293BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
MASTROIANNI R., Il contributo delle Regioni italiane all’elaborazione del di-ritto dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2006, n. 2.
MATTEUCCI N., Positivismo giuridico e costituzionalismo, in Rivista trime-strale di diritto e procedura civile, 1963.
MATTIONI A., Comitati interministeriali, in Enciclopedia giuridica, vol. VI,Roma, Treccani, 1998.
MAYNTZ R., Executive Leadership in Germany: Dispersion of Power or“Kanzlerdemokratie”?, in ROSE R., SULEIMAN E.N. (eds.), Presidentsand Prime ministers, Washington D.C., American Enterprise Insti-tute, 1982.
MAZZIOTTI DI CELSO M., Relazione generale, in AA.VV., Annuario 2000. IlParlamento, Atti del XV convegno annuale dell’AIC, Firenze, 12-14ottobre 2000, Padova, Cedam, 2001.
MAZZIOTTI DI CELSO M., SALERNO G.M., Manuale di diritto costituzionale,3ª ed., Padova, Cedam, 2005.
MAZZIOTTI M., Il diritto al lavoro, Milano, Giuffrè, 1956.MAZZOLENI M., I sistemi partitici regionali in Italia dalla prima alla seconda
Repubblica, in Rivista italiana di scienza politica, 2002, n. 3.MAZZONI HONORATI M.L., Considerazioni critiche sul rapporto tra regola-
menti parlamentari e forma di governo, in AA.VV., Annuario 2000. IlParlamento, Atti del XV convegno annuale dell’AIC, Firenze, 12-14ottobre 2000, Padova, Cedam, 2001.
MAZZONI HONORATI M.L., Diritto parlamentare, Torino, Giappichelli, 2001.MCQUAIL D., Media performance: man communications and the public in-
terest, London, Sage, 1992, trad. it., I media in democrazia, Bologna,il Mulino, 1995.
MEOLI C., A che punto è la semplificazione?, in www.forumcostituzionale.it.MERLINI S., Il Governo, in AMATO G., BARBERA A. (a cura di), Manuale di
diritto pubblico, vol. II, 5ª ed., Bologna, il Mulino, 1997.MERLINI S., Natura e collocazione dei gruppi parlamentari in Italia, in ID. (a
cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il con-testo italiano, vol. II, Torino, Giappichelli, 2004.
MERLINI S., Presidente del Consiglio e collegialità di Governo, in Quadernicostituzionali, 1982, n. 1.
MERLINI S., Struttura del governo e intervento pubblico nell’economia, Fi-renze, La nuova Italia editrice, 1979.
MERUSI F., Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, il Mulino, 2000.MERUSI F., Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione, Mi-
lano, Giuffrè, 1977.
294 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
MEZZANOTTE C., NANIA R., Riforme e Costituzione, in Democrazia e diritto,1982, n. 6.
MIDIRI M., Commissioni parlamentari e processo di decisione politica: laprassi recente, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, n. 4.
MIELE G., Collegio amministrativo, in Novissimo digesto italiano, vol. III,Torino, Utet, 1959.
MIGLIO G., Una Costituzione per i prossimi trent’anni, Roma-Bari, Laterza,1990.
MIRKINE-GUEZTÉVITCH B., Les nouvelles tendences du droit constitutionnel,Paris, M. Giard, 1931.
MODUGNO F., Abrogazione, in Enciclopedia giuridica, vol. I, Roma, Trec-cani, 1988.
MODUGNO F., Costituzione I) Teoria generale, in Enciclopedia giuridica, vol.X, Roma, Treccani, 1988.
MODUGNO F., Fonti del diritto, in Enciclopedia giuridica, vol. XIV, Roma,Treccani, 1989.
MODUGNO F., Poteri (divisione dei), in Novissimo digesto italiano, vol.XIII, Torino, Utet, 1966.
MODUGNO F., Principi generali dell’ordinamento, in Enciclopedia giuridica,vol. XXIV, Roma, Treccani, 1991.
MODUGNO F., Validità (dir. cost.), in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Mi-lano, Giuffrè, 1993.
MONACO A., Concerto (Atti di), in Enciclopedia del diritto, vol. VIII, Mi-lano, Giuffrè, 1961.
MORETTI R., Il progetto di legge costituzionale sulla commissione parlamen-tare per le riforme istituzionali: appunti sul testo approvato dal Senato,in Foro italiano, 1992, n. 10.
MORRONE A., Quale modello di Governo nella riforma del Regolamentodella Camera dei deputati?, in Quaderni costituzionali, 1998, n. 3.
MORTATI C., Art. 1, in BRANCA G. (a cura di), Commentario della Costitu-zione, continuato da PIZZORUSSO A., Bologna-Roma, Zanichelli-IlForo italiano, 1975.
MORTATI C., Costituzione Dottrine generali e Costituzione della Repubblicaitaliana, in Enciclopedia diritto, vol. XI, Milano, Giuffrè, 1962.
MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, 10ª ed., Padova, Cedam,1991.
MORTATI C., Istituzioni di diritto pubblico, tomo II, 9ª ed., Padova, Cedam,1976.
MORTATI C., L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano[1931], Milano, Giuffrè, 2000.
295BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
MORTATI C., La costituzione in senso materiale [1940], Milano, Giuffrè,1998.
MORTATI C., Le forme di governo, Padova, Cedam, 1973.MOSCA C., GAMBACURTA S., SCANDONE G., VALENTINI M., I servizi di infor-
mazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano,Giuffrè, 2008.
MOSTACCI E., Un maggioritario in abito proporzionale: perplesse considera-zioni su alcuni aspetti essenziali del nuovo sistema elettorale, disegnatodalla legge n. 270 del 21 dicembre 2005, in Nomos, 2005, n. 3.
MOTZO G., Consiglio supremo di difesa, in Enciclopedia del diritto, vol. IX,Milano, Giuffrè, 1961.
MUNRO C.R., Studies in Constitutional Law, 2ª ed., London, Butterworths,2002.
MUSELLA F., L’evoluzione della forma di governo in Italia. Populismo presi-denziale al lavoro?, in Democrazia e diritto, 2010, n. 3/4.
NANIA R., Prime considerazioni sulla «funzione di governo» come «funzionedi indirizzo», in AA.VV., Annuario 2001. Il Governo, Atti del XVIconvegno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 novembre 2001, Padova,Cedam, 2002.
NATALINI A., Il Programma di governo tra indirizzo politico e propagandaelettorale, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, n. 7.
NATALINI A., Programma di governo e contratto con gli italiani Il Com-mento, in Giornale di diritto amministrativo, 2003, n. 12.
NEGRO G., Considerazioni in tema di composizione e funzionamento delCIPE, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1976.
NELKEN D., Il significato di Tangentopoli: la risposta giudiziaria alla corru-zione e i suoi limiti, in VIOLANTE L. (a cura di), Legge, diritto, giusti-zia, Storia d’Italia, Annali 14, Torino, Einaudi, 1998.
NICCOLAI S., Il conflitto di attribuzione e la politica, in Giurisprudenza co-stituzionale, 1996.
NICOTRA I., Il Governo Monti (Napolitano): l’Unione europea e i mercati fi-nanziari spingono l’Italia verso un semipresidenzialismo mite, inwww.federalismi.it, 14 dicembre 2011.
NOCILLA D., CIAURRO L., Rappresentanza politica, in Enciclopedia del di-ritto, vol. XXXVIII, Milano, Giuffrè, 1987.
OLIVETTI M., Appunti sulle trasformazioni della forma di governo italiana,in Il Filangieri, Quaderno 2006.
OLIVETTI M., Art. 1, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di),Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, Utet, 2006.
296 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
OLIVETTI M., Ciampi al Quirinale: le prime elezioni presidenziali della de-mocrazia maggioritaria, in Giurisprudenza costituzionale, 1999, n. 5.
OLIVETTI M., Forme di Stato e forme di governo, in S. MANGIAMELI (a curadi), Diritto costituzionale, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008.
OLIVETTI M., Governare con l’aiuto del presidente, in il Mulino, 2012, n. 2.OLIVETTI M., Il vestito di Arlecchino, in www.federalismi.it, 2 maggio 2012.OLIVETTI M., La Commissione Bicamerale sulle riforme costituzionali: pro-
fili storico-istituzionali e rilievi di ordine procedimentale, in Iustitia,1997, n. 2.
OLIVETTI M., La mozione di sfiducia a più ministri: un mostro a più teste?,in Diritto pubblico, 1999, n. 1.
OLIVETTI M., La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, Mi-lano, Giuffrè, 1996.
OLIVETTI M., La transizione continua, in Quaderni costituzionali, 2001,n. 3.
OLIVETTI M., Le dimissioni del Governo Prodi e la formazione del GovernoD’Alema. Cronaca di una crisi annunciata, in Giurisprudenza costitu-zionale, 1998, n. 5.
OLIVETTI M., Le dimissioni rientrate del Governo Prodi, in Giurisprudenzacostituzionale, 1997, n. 5.
OLIVETTI M., Le elezioni del 6 maggio 2010 nel Regno Unito: Westminsteradieu?, in Rassegna parlamentare, 2010, n. 3.
OLIVETTI M., Lo scioglimento delle Camere del 2 febbraio 1992. Una «cu-riosità costituzionale» o un precedente imbarazzante?, in Giurispru-denza costituzionale, 1993.
OLIVETTI M., Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni, Bologna, ilMulino, 2002.
ONIDA V., “Seconda Repubblica” o nuovo sistema politico, in Corriere giuri-dico, 1993, n. 2.
ONIDA V., Costituzione italiana, in CASSESE S. (diretto da), Dizionario di di-ritto pubblico, vol. II, Milano, Giuffrè, 2006.
ONIDA V., D’ANDREA A., GUIGLIA G., L’ordinamento costituzionale italiano,Torino, Utet, 1990.
ORESTANO R., Dietro la consuetudine, in Rivista trimestrale di diritto pub-blico, 1963, n. 3.
ORFINO F., I comitati interministeriali, in La Funzione Amministrativa,1965, n. 1.
ORLANDO V.E., Studi intorno alla forma di governo vigente in Italia secondola Costituzione del 1948, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,1951.
297BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
PACE A., L’apposizione del segreto di Stato nei principi costituzionali e nellalegge n. 124 del 2007, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, n. 5.
PAJNO A., La presidenza del Consiglio dei ministri dal vecchio al nuovo or-dinamento, in PAJNO A., TORCHIA L. (a cura di), La riforma del Go-verno, Bologna, il Mulino, 2000.
PALADIN L., Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri, in Le Re-gioni, 1996, n. 1.
PALADIN L., Diritto costituzionale, 3ª ed., Padova, Cedam, 1998.PALADIN L., Fascismo (dir. cost.), in Enciclopedia del diritto, vol. XVI, Mi-
lano, Giuffrè, 1967.PALADIN L., Governo italiano, in Enciclopedia del diritto, vol. XIX, Milano,
Giuffrè, 1970.PALADIN L., Lezioni di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1989.PALADIN L., Verso una nuova legge generale sul governo, in Le Regioni,
1987, n. 3.PALEOLOGO G.G., L’attività normativa del Governo nella legge sull’ordina-
mento della presidenza sul consiglio dei ministri, in Il Foro italiano,1989.
PALMA G., Economia pubblica e programmazione, Napoli, Editoriale scien-tifica, 1980.
PANEBIANCO A., Contorno istituzionale e buon governo, in il Mulino, 2012,n. 2.
PANEBIANCO A., Riforme contro i partiti? Un commento, in Rivista italianadi scienza politica, 1991, n. 3.
PAPPALARDO A., Il sistema partitico italiano fra bipolarismo e destruttura-zione, in PASQUINO G. (a cura di), Dall’Ulivo al governo Berlusconi,Bologna, il Mulino, 2002.
PAPPALARDO A., La nuova legge elettorale in Parlamento: chi, come e perché,in Rivista italiana di scienza politica, 1994, n. 2.
PARMIGIANI F., Il rapido iter di approvazione delle proposte di revisione co-stituzionale al vaglio della Commissione Affari costituzionali del Se-nato, in www.rivistaic.it, 12 giugno 2012.
PASQUINI M., Governo, in Enciclopedia forense, vol. III, Milano, Vallardi,1958.
PASQUINO G., I sistemi elettorali, in AMATO G., BARBERA A. (a cura di), Ma-nuale di diritto pubblico, vol. II, 5ª ed., Bologna, il Mulino, 1997.
PASQUINO G., La transizione a parole, Bologna, il Mulino, 2000.PASQUINO G., Leadership e comunicazione politica, in AA.VV., Scritti in
onore di Aldo Bozzi, Padova, Cedam, 1992.
298 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
PASQUINO G., Parlamento e Governo nell’Italia repubblicana, in Rivista ita-liana di scienza politica, 2007, n. 1.
PASQUINO G., Partiti, società civile e istituzioni, in ID. (a cura di), Il sistemapolitico italiano, Roma-Bari, Laterza, 1985.
PASQUINO G., Suggerimenti scettici agli ingegneri costituzionali, in il Mu-lino, 1979, n. 5.
PASSIGLI S., Riforme istituzionali e governo: un commento, in Rivista ita-liana di scienza politica, 1991, n. 3.
PATERNITI F., Nuove prospettive nella partecipazione “interna” delle Regionialla fase ascendente dei processi decisionali comunitari alla luce dellalegge n. 11/2005, in www.giustamm.it, 2005, n. 5.
PATRONI GRIFFI F., Le politiche della qualità della regolazione in Italia, rela-zione al Convegno OECD-Formez, Roma, 8 novembre 2007, inwww.astrid.eu.
PATRONO M., Maggioritario in erba, Padova, Cedam, 1995.PERNA, Tempi della decisione ed abuso della decretazione d’urgenza: il pro-
cedimento legislativo in una democrazia maggioritaria, in www.forum-costituzionale.it, 25 novembre 2008.
PETRILLO P.L., La nuova legge elettorale per la Camera ed il Senato, inwww.rivistaic.it, 1 febbraio 2006.
PETRILLO P.L., Nuovi statuti regionali e opposizione, in Quaderni costitu-zionali, 2005, n. 4.
PETRILLO P.L., Unione europea, Governo nazionale e Regioni nella c.d.«fase ascendente» tra azioni di filtro e tentativi di coordinamento, inCARPANI G., GROPPI T., OLIVETTI M., SINISCALCHI A. (a cura di), LeRegioni italiane nei processi normativi comunitari dopo la legge n.11/2005, Bologna, il Mulino, 2007.
PICCIONE D., Anatomia di una crisi di governo, in Rassegna parlamentare,2011, n. 4.
PICCIONE D., I Gruppi parlamentari alla prova delle (auto)riforme regola-mentari, in www.rivistaic.it, 2012, n. 2.
PICCIRILLI G., I paradossi della questione di fiducia ai tempi del maggiorita-rio, in Quaderni costituzionali, 2008.
PICOZZA E., Profili giuridici del Comitato interministeriale per la program-mazione economica (C.I.P.E.), con particolare riferimento all’attività,in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1976.
PIERGIGLI V., L’istituzione del segretariato generale nella legge di riformadella presidenza del Consiglio dei ministri, in Diritto e società, 1989.
PIRETTI M.S., La legge truffa, Bologna, il Mulino, 2003.
299BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
PITRUZZELLA G., Artt. 92-93, in BRANCA G. (a cura di), Commentario dellaCostituzione, continuato da PIZZORUSSO A., Bologna-Roma, Zani-chelli-Il Foro italiano, 1994.
PITRUZZELLA G., Forme di governo e trasformazioni della politica, Bari, La-terza, 1996.
PITRUZZELLA G., Il Consiglio di gabinetto nel Governo italiano, in Rivistatrimestrale di diritto pubblico, 1985.
PITRUZZELLA G., Il ministro in comitato interministeriale, in D’AURIA G.,BELLUCCI P. (a cura di), Politici e burocrati al governo dell’ammini-strazione, Bologna, il Mulino, 1995.
PIZZETTI F., Comitati interministeriali, in Novissimo digesto italiano, app.,vol. II, Torino, Utet, 1980.
PIZZORUSSO A., I nuovi sistemi elettorali per la Camera dei deputati e per ilSenato della Repubblica, in LUCIANI M., VOLPI M. (a cura di), Riformeelettorali, Roma-Bari, Laterza, 1995.
PIZZORUSSO A., Minoranze e maggioranze, Torino, Einaudi, 1993.POGUNTKE T., WEBB P., The Presidentialization of Politics in Democratic So-
cieties: a Framework for Analysis, in ID. (eds.), The Presidentializationof Politics, Oxford, Oxford University Press, 2005.
POTENZA G., L’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, inDiritto e società, 1980.
PREDIERI A., Presidente del Consiglio dei ministri, in Enciclopedia giuridica,vol. XXIV, Roma, Treccani, 1991.
PRETI L., Il Governo nella Costituzione italiana, Milano, Giuffrè, 1954.PRIMICERIO L., Forma di governo parlamentare e modelli di democrazia rap-
presentativa, Torino, Giappichelli, 2002.PRISCO S., «Il Governo di coalizione» rivisitato, in AA.VV., Studi in onore
di Gianni Ferrara, vol. III, Torino, Giappichelli, 2005.PUOTI M.E., L’attuazione degli strumenti di partecipazione alla fase ascen-
dente di formazione della normativa comunitaria previsti dalla legge 4febbraio 2005, n. 11: il comitato interministeriale per gli affari comu-nitari europei (CIACE), il comitato tecnico permanente e i tavoli dicoordinamento, in Diritto e società, 2006, n. 3.
QUADRI G., Diritto pubblico dell’economia, 2ª ed., Padova, Cedam, 1980.QUADRI G., Gabinetto economico (C.I.P.E.) e indirizzo politico economico,
Milano, Giuffrè, 1970.QUADRI G., I comitati di ministri [1965], Milano, Giuffrè, 1997.RACIOPPI F., BRUNELLI I., Commento allo Statuto del Regno, vol. III, To-
rino, Utet, 1909.
300 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
RAVALLI A., I comitati interministeriali, in JARICCI P. (a cura di), Studi di di-ritto pubblico dell’economia, Roma, Kappa, 2006.
RAVALLI A., I comitati interministeriali. La cabina di regia nazionale, inConsiglio di Stato, 1996, n. 4.
REPOSO A., Il procedimento di formazione del governo e i suoi più recentisviluppi costituzionali, in Diritto e società, 2003, n. 2.
RESCIGNO G.U., Consiglio di Gabinetto, in Enciclopedia del diritto, agg.,vol. II, Milano, Giuffrè, 1998.
RESCIGNO G.U., Corso di diritto pubblico, 7ª ed., Bologna, Zanichelli, 2001.RESCIGNO G.U., Democrazia e principio maggioritario, in Quaderni costitu-
zionali, 1994, n. 2.RESCIGNO G.U., Il ‘caso Mancuso’ ovvero della inesistenza dei casi di scuola,
ovvero ancora del dovere dei giuristi di rispondere ai quesiti giuridica-mente possibili, in Diritto pubblico, 1996
RESCIGNO G.U., La responsabilità politica del singolo ministro, in Studi par-lamentari e di politica costituzionale, 1980, n. 47-48.
RESCIGNO G.U., La responsabilità politica, Milano, Giuffrè, 1967.RESCIGNO G.U., Le convenzioni costituzionali, Padova, Cedam, 1972.RESCIGNO G.U., Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti, in
Diritto pubblico, 2002, n. 3.RESCIGNO G.U., Principio maggioritario, in Enciclopedia giuridica, vol.
XXIV, Roma, Treccani, 1998.RESCIGNO G.U., Ripensando le convenzioni costituzionali, in Politica del di-
ritto, 1997.RESCIGNO P., La lezione di Edoardo Ruffini sul principio di maggioranza, in
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1978.RISTUCCIA S., Amministrare e governare, Roma, Officina edizioni, 1980.RIVOSECCHI G., I poteri ispettivi e il controllo parlamentare: dal question
time alle Commissioni di inchiesta, in GIANFRANCESCO E., LUPO N. (acura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggio-ranza e opposizione, Roma, Luiss University Press, 2007.
RIVOSECCHI G., Il principio maggioritario tra statuti regionali e regolamenticonsiliari, ovvero della difficile transizione verso un modello di demo-crazia decidente, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2005, n. 2.
RIVOSECCHI G., Nota (a futura memoria) sul procedimento di revisione co-stituzionale per un recupero della “soluzione Alfonso Tesauro”, inwww.forumcostituzionale.it, 4 dicembre 2005.
RIVOSECCHI G., Organizzazione e funzionamento dei Consigli regionali:principio maggioritario, statuti regionali e regolamenti consiliari, in BI-
301BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
FULCO R. (a cura di), Gli statuti di seconda generazione, Torino, Giap-pichelli, 2006.
RIVOSECCHI G., Regolamenti parlamentari e forma di governo nella XIII le-gislatura, Milano, Giuffrè, 2002.
RIVOSECCHI G., Ritorno al diritto non scritto? A proposito di un contributoallo studio della consuetudine, in www.amministrazioneincammino.luiss.it.
RIZZA G., Commissario e alto commissario. Commissario straordinario, inID., Saggi di diritto pubblico, Bari, Cacucci, 1995.
RIZZA G., I comitati interministeriali: l’esperienza francese e quella italiana;le prospettive di riforma, in ID., Saggi di diritto pubblico, Bari, Ca-cucci, 1995.
RIZZA G., I rapporti fra gli organi del Governo ed il regolamento interno delConsiglio dei ministri, in Diritto e società, 1994.
RIZZA G., Il Presidente del Consiglio dei ministri, Napoli, Jovene, 1970.RODOTÀ S., Il tema: principio maggioritario e «nuovi interessi», in Politica
del diritto, 1981, n. 1.RODOTÀ S., La sovranità nel tempo della tecnopolitica. Democrazia elettro-
nica e democrazia rappresentativa, in Politica del diritto, 1993, n. 4.RODOTÀ S., Tecnopolitica, nuova edizione accresciuta, Roma-Bari, Laterza,
2004.RODRIQUEZ M., Segreto di Stato e servizi di sicurezza nella legge di riforma,
in Diritto e società, 1978.ROLLA G., Il Consiglio dei ministri tra modello costituzionale e prassi, in
Quaderni costituzionali, 1982, n. 2.ROLLA G., Riforma dei regolamenti parlamentari ed evoluzione della forma
di governo in Italia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2000,n. 3.
ROMANELLI GRIMALDI C., Ministro, in Enciclopedia giuridica, vol. XX,Roma, Treccani, 1990.
ROMANO A.A., La formazione del Governo, Padova, Cedam, 1977.ROMANO S., Nozione e natura degli organi costituzionali e dello Stato
[1898], in Scritti minori, vol. I, Milano, Giuffrè, 1950.RONZA R.W., Dalle appartenenze subculturali al mercato elettorale: il dibat-
tito sui paradigmi interpretativi del comportamento di voto in Italia,Sudafrica e Canada, in Rivista italiana di scienza politica, 2007, n. 2.
ROSA F., Il controllo parlamentare sul governo nel Regno Unito, Milano,Giuffrè, 2012.
ROSE R., SULEIMAN E.N. (eds.), Presidents and Prime ministers, Washing-ton D.C., American Enterprise Institute, 1982.
302 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
ROSELLI O., La riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri: proble-matiche inerenti alle fonti del diritto, in DE SIERVO U. (a cura di), Os-servatorio sulle fonti 1999, Torino, Giappichelli, 2000.
ROSSANO C., La consuetudine nel diritto costituzionale, Napoli, Jovene,1992.
ROSSANO C., Manuale di Diritto pubblico, 2ª ed., Napoli, Jovene, 2007.ROSSANO C., Partiti politici, in Enciclopedia giuridica, vol. XXII, Roma,
Treccani, 2002.ROSSANO C., Presidente della Repubblica I) Diritto costituzionale, in Enci-
clopedia giuridica, vol. XXIV, Roma, Treccani, 2002.ROSSANO C., Problemi di struttura dello Stato sociale contemporaneo, Na-
poli, Jovene, 1978.ROSSI L., Sottosegretari di Stato, in Nuovo digesto italiano, vol. XII, parte I,
Torino, Utet, 1940.ROTELLI E., La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Milano, Giuffrè,
1972.RUBECHI M., Considerazioni a prima lettura sulla LR Toscana n. 70 del 2004
che disciplina l’istituto delle elezioni primarie, in www.forumcostitu-zionale.it, 17 gennaio 2005.
RUBECHI M., La sessione di bilancio in parlamento: governi in fuga, rela-zione al Convegno “La prassi degli organi costituzionali”, Bologna,14-15 giugno 2007, in www.forumcostituzionale.it.
RUFFINI E., Il principio maggioritario. Profilo storico [1927], 3ª ed., Milano,Adelphi, 2002.
RUGGERI A., Art. 94 della Costituzione vivente: “Il Governo deve avere la fi-ducia dei mercati” (nota minima a commento della nascita del Go-verno Monti), in www.federalismi.it, 23 novembre 2011.
RUGGERI A., Il Consiglio dei ministri nella Costituzione italiana, Milano,Giuffrè, 1981.
RUGGERI A., Il Governo tra vecchie e nuove regole e regolarità (spunti pro-blematici), in AA.VV., Annuario 2001. Il Governo, Atti del XVI con-vegno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 novembre 2001, Padova, Ce-dam, 2002.
S.N., Duce, in Nuovo Digesto italiano, vol. V, Torino, Utet, 1938.SALERNO G.M., MALAISI B., Art. 87, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI
M. (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. II, Torino, Utet,2006.
SALVADORI M.L., Breve storia della lunga transizione, in il Mulino, 1998,n. 5.
303BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
SANDULLI A.M., Governo e amministrazione, in Rivista trimestrale di dirittopubblico, 1966.
SANDULLI A.M., Il problema della Presidenza del Consiglio dei ministri, inDiritto e società, 1980.
SANDULLI A.M., La costituente e la Costituzione italiana [1975], in ID.,Scritti giuridici, vol. II, Diritto costituzionale, Napoli, Jovene, 1990.
SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, vol. I, 14ª ed., Napoli,Jovene, 1984.
SANTANGELO SPOTO I., Ministero e ministri, in Digesto italiano, vol. XV,parte II, Torino, Utet, 1904-1911.
SARTORI G., Le riforme istituzionali tra buone e cattive, in Rivista italiana discienza politica, 1991, n. 3.
SARTORI G., Tecniche decisionali e sistema dei partiti, in Rivista italiana discienza politica, 1974, n. 1.
SAVINI G., Primissime osservazioni sulla proposta Quagliariello/Zanda diriforma organica del regolamento del Senato, in www.amministrazio-neincammino.luiss.it, 28 febbraio 2012.
SAVINO M., Solo per i tuoi occhi? La riforma del sistema italiano di intelli-gence, in Giornale di diritto amministrativo, 2008, n. 2.
SCHEPIS G., Elezioni (Storia dei sistemi elettorali in Italia), in Enciclopediadel diritto, vol. XIV, Milano, Giuffrè, 1965.
SCHINDLER D., Verfassungsrecht und soziale Struktur, Zürich, Schulthess,1932, trad. it., Diritto costituzionale e struttura sociale, a cura di BI-FULCO R., Padova, Cedam, 1999.
SCHMITT C., Der Hüter der Verfassung, Tübingen, Mohr, 1931, trad. it., Ilcustode della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1981.
SCHMITT C., Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 1928, trad. it.,Dottrina della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1984.
SCIOLA F., Lo Statuto dell’Opposizione parlamentare nell’ordinamento ita-liano, Firenze, Noccioli, 2001.
SCIOLA F., Note minime sulla forma di governo in Toscana tra statuto e leggeelettorale, in www.federalismi.it, 2 giugno 2005.
SCOCA F.G., Conferenza di servizi, in Enciclopedia giuridica, vol. VIII,Roma, Treccani, 1999.
SCUDIERO M., L’elezione diretta del sindaco tra riforme istituzionali e tra-sformazione del sistema politico, in Le Regioni, 1993, n. 3.
SEMERARO F., Prime riflessioni sull’attuazione della riforma del regolamentodella Camera dei deputati, in Rassegna parlamentare, 2001, n. 1.
SENESI A., TORRONI A., Gli snodi istituzionali: le competenze del CIPE e deiministeri in materia di regolazione, in Economia pubblica, 2002, n. 4.
304 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
SEPE F., La struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei mi-nistri, in Giornale di diritto amministrativo, 1999, n. 4.
SHUGART M.S., Comparative Electoral System Research: The Maturation ofa Field and New Challenges Ahead, in GALLAGHER M., MITCHELL P.(eds.), The Politics of Electoral Systems, Oxford, Oxford UniversityPress, 2006.
SICA V., Comitati governativi, gestioni autonome e personalità giuridica, inRassegna di diritto pubblico, 1956.
SICA V., Le associazioni nella Costituzione italiana, Napoli, Jovene, 1957.SICARDI S., Maggioranza e opposizione nella lunga ed accidentata transizione
italiana, in AA.VV., Annuario 2001. Il Governo, Atti del XVI conve-gno annuale dell’AIC, Palermo, 8-10 novembre 2001, Padova, Ce-dam, 2002.
SILVESTRI G., La nascita della Costituzione italiana ed i suoi valori fonda-mentali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, n. 3.
SILVESTRI G., Trasformazione del sistema elettorale e prospettive di riforma,in LUCIANI M., VOLPI M. (a cura di), Riforme elettorali, Roma-Bari,Laterza, 1995.
SMEND R., Verfassung und Verfassungsrecht, München-Leipzig, Duncker &Humblot, 1928, trad. it., Costituzione e diritto costituzionale, Milano,Giuffrè, 1988.
SOCCI F., La proposta di riforma del regolamento interno in discussione alSenato, in www.forumcostituzionale.it, 28 marzo 2012.
SORACE D. (a cura di), I Comitati interministeriali economici, Bologna, ilMulino, 1991.
SORACE D., Il governo dell’economia, in AMATO G., BARBERA A. (a cura di),Manuale di diritto pubblico, vol. III, 5ª ed., Bologna, il Mulino, 1997.
SORRENTINO F., Intervento, in AA.VV., Annuario 2000. Il Parlamento, Attidel XV convegno annuale dell’AIC, Firenze, 12-14 ottobre 2000, Pa-dova, Cedam, 2001.
SORRENTINO F., L’abrogazione nel quadro dell’unità dell’ordinamento giuri-dico, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1972, n. 1.
SORRENTINO F., Le fonti del diritto amministrativo, in SANTANIELLO G. (di-retto da), Trattato di diritto amministrativo, vol. XXXV, Padova, Ce-dam, 2004.
SPADARO A., Costituzione (dottrine generali), in CASSESE S. (diretto da), Di-zionario di diritto pubblico, vol. II, Milano, Giuffrè, 2006.
SPAGNA MUSSO E. (diretta da), Costituzione e struttura del Governo. L’or-ganizzazione del governo negli stati di democrazia parlamentare, Ri-cerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Padova, Cedam, 1982.
305BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
SPAGNA MUSSO E., Diritto costituzionale, 4ª ed., Padova, Cedam, 1992.SPAGNUOLO VIGORITA V., MARRAMA R., Prezzi (Disciplina pubblica dei), in
Novissimo digesto italiano, vol. V, Torino, Utet, 1957.SPREAFICO A., Il rendimento dei sistemi elettorali: il caso italiano, in Qua-
derni costituzionali, 1981, n. 3.SPROVIERI F., La riforma del CIPE, Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica. I decreti 21 giugno 2007 del Presidente delConsiglio dei Ministri, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2007, n.3/4.
STROPPIANA L., La riforma dei regolamenti parlamentari: un processo nonancora concluso?, in Quaderni costituzionali, 2000, n. 1.
TARLI BARBIERI G., Fonti del diritto e riforma dei ministeri, in DE SIERVO U.(a cura di), Osservatorio sulle fonti 1999, Torino, Giappichelli, 2000.
TARLI BARBIERI G., La forma di governo nel nuovo statuto della Regione To-scana: prime osservazioni, in Diritto pubblico, 2004, n. 2.
TARLI BARBIERI G., Le riforme elettorali della regione Toscana (II), in De-mocrazia e diritto, 2005, n. 1.
TESAURO A., Istituzioni di diritto pubblico, vol. I, seconda ristampa della 1ªed., Torino, Utet, 1962.
THOMAS G.P., Prime Minister and Cabinet today, Manchester and NewYork, Manchester University Press, 1998.
TORCHIA L., Il nuovo ordinamento dei ministeri: le disposizioni generali (ar-ticoli 1-7), in PAJNO A., TORCHIA L. (a cura di), La riforma del Go-verno, Bologna, il Mulino, 2000.
TORRE A., Il Cabinet system da Thatcher a Blair: leadership e Costituzione,in TORRE A., VOLPE L. (a cura di), La Costituzione Britannica, vol. I,Torino, Giappichelli, 2005.
TRABUCCO D., Il rapporto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed iMinistri: un difficile punto di equilibrio, in www.forumcostituzionale.
TREVES G., Comitato interministeriale, in Novissimo digesto italiano, vol.III, Torino, Utet, 1957.
TREVES G., Convenzioni costituzionali, in Enciclopedia del diritto, vol. X,Milano, Giuffrè, 1962.
TREVES G., Duttilità della Costituzione, in AA.VV., Studi per il ventesimoanniversario dell’Assemblea costituente, vol. IV, Firenze, Vallecchi,1969, ora in ID., Scritti giuridici, Milano, Giuffrè, 1982.
TREVES G., I comitati interministeriali, in AA.VV., Scritti giuridici in onoredella Cedam, vol. II, Padova, Cedam, 1953.
306 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
TRIPODI S., La fase indiretta della partecipazione delle Regioni alla forma-zione degli atti comunitari: alcune osservazioni sul ddl di riforma dellalegge «La Pergola», in www.federalismi.it, 8 gennaio 2004.
TRIPOLI G., Osservazioni sul principio maggioritario e sui suoi limiti, in Ri-vista internazionale di filosofia del diritto, 1983.
TROILO C., La ricerca della governabilità. La forma di governo nelle propo-ste della Commissione Bicamerale e del Comitato Speroni, Padova,Cedam, 1996.
TROILO S., Alla continua ricerca della governabilità: la forma di governoproposta dal «Comitato Speroni», in Quaderni costituzionali, 1996,n. 3.
TUFARELLI F., Art. 2, in BRENNA G., STABILE S., TROTTA A., DE VITA M., TU-FARELLI F., Commento alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, in CARPANI G.,GROPPI T., OLIVETTI M., SINISCALCHI A. (a cura di), Le Regioni ita-liane nei processi normativi comunitari dopo la legge n. 11/2005, Bo-logna, il Mulino, 2007.
TURPIN C., TOMKINS A., British Government and the Constitution, 6ª ed.,Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
TURPIN D., Droit constitutionnel, 1ª ed., Paris, Quadrige/Puf, 2003.VALASTRO A., La valutazione e i molteplici volti della partecipazione nell’or-
dinamento italiano. Quale ruolo per la consultazione in una gover-nance problematica?, in www.rivistaic.it, 14 settembre 2006.
VENTURA L., Il Governo a multipolarità diseguale, Milano, Giuffrè, 1988.VENTURA L., Ordinamento e organizzazione del Governo, in AA.VV., An-
nuario 2001. Il Governo, Atti del XVI convegno annuale dell’AIC,Palermo, 8-10 novembre 2001, Padova, Cedam, 2002.
VERZICHELLI L., Cambiare casacca, o della fluidità parlamentare, in il Mu-lino, 2000, n. 2.
VESPERINI G., I fondi di dotazione delle partecipazioni statali e l’approva-zione da parte del CIPE della loro ripartizione: un episodio di mano-missione del «sistema», in Giurisprudenza commerciale, 1985.
VESPERINI G., I governi del maggioritario, in ID. (a cura di), I governi delmaggioritario, Roma, Donzelli editore, 1998.
VESPERINI G., Il governo della semplificazione. Il commento, in Giornale didiritto amministrativo, 2007, n. 3.
VIGEVANI G.E., Il voto all’estero: interrogativi sulla «riserva indiana» per icandidati, in Quaderni costituzionali, 2002, n. 2.
VILLATA R., Collegi amministrativi, in Enciclopedia giuridica, vol. VI,Roma, Treccani, 1988.
307BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO
VILLONE M., Art. 94, in BRANCA G. (a cura di), Commentario della Costi-tuzione, continuato da PIZZORUSSO A., Bologna-Roma, Zanichelli-IlForo italiano, 1994.
VIRGA P., Diritto costituzionale, 8ª ed., Milano, Giuffrè, 1976.VIRGA P., La crisi e le dimissioni del Gabinetto, Milano, Giuffrè, 1948.VIVIANI SCHLEIN M.P., Irresponsabilità del Capo dello Stato e controfirma
ministeriale in Italia e in Francia, in Rivista trimestrale di diritto pub-blico, 1982.
VIVIANI SCHLEIN M.P., La Presidenza del Consiglio dei ministri: storia di unfallimento, in Giurisprudenza costituzionale, 1973.
VOLPI M., Ingegneria elettorale e crisi di rappresentatività, in Democrazia ediritto, 1982, n. 6.
VOLPI M., La natura della forma di governo dopo il 1994, in AA.VV., An-nuario 2001. Il Governo, Atti del XVI convegno annuale dell’AIC,Palermo, 8-10 novembre 2001, Padova, Cedam, 2002.
VOLPI M., Le forme di governo contemporanee tra modelli teorici ed espe-rienze reali, in Quaderni costituzionali, 1997, n. 2.
VON GIERKE O., Über die Geschichte des Majoritätsprinzips, in VINOGRA-DOFF P. (ed.), Essays in Legal History, London, Edinburgh, Glasgow,Oxford University Press, 1913, trad. it., Sulla storia del principio dimaggioranza, in Rivista delle società, 1961.
WEBB P., POGUNTKE T., The Presidentialization of Contemporary Democra-tic Politics: Evidence, Causes, and Consequences, in POGUNTKE T.,WEBB P. (eds.), The Presidentialization of Politics, Oxford, OxfordUniversity Press, 2005.
ZAGREBELSKY G., Convenzioni costituzionali, in Enciclopedia giuridica, vol.IX, Roma, Treccani, 1988.
ZAGREBELSKY G., Il diritto mite, nuova ed., Torino, Einaudi, 1992.ZAGREBELSKY G., La formazione del Governo nelle prime quattro legislature
repubblicane, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1968.ZAMPETTI U., Il procedimento legislativo, in Rassegna parlamentare, 2001,
n. 1.ZANON N., Il «patto Segni» e il diritto costituzionale della rappresentanza
politica, in Quaderni costituzionali, 1993, n. 1.ZANON N., Il transfughismo parlamentare: attenti a toccare quel che resta
del libero mandato, in Quaderni costituzionali, 2001, n. 1.
308 BIBLIOGRAFIA CITATA NEL TESTO