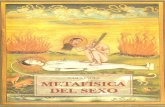Le fantasticherie di un passeggiatore solitario. Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le fantasticherie di un passeggiatore solitario. Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia
23�
Filippo Domenicali
Le fantasticherie di un passeggiatore solitarioGabriel Tarde tra metafisica e sociologia
Non fidarsi dei pensieri che non sono nati all’aria aperta e in movimento
Nietzsche
Appartengo a me stesso soltanto quando sono solo
Rousseau
�. Un inspiegabile oblio
Gabriel Tarde (�8�3-�90�) è un autore difficilmente classifi-cabile. Sociologo, criminologo e magistrato, ha al suo atti-
vo una cospicua produzione saggistica, costituita nel suo insieme da quindici volumi e un centinaio di articoli. La sua notorietà dev’essere fatta risalire al �890 ‒ anno che segna un vero e proprio spartiacque nella sua vita ‒ quando pubblica per i tipi della prestigiosa casa edi-trice Alcan di Parigi la sua opera maggiore, Le leggi dell’imitazione, autentica summa della sua riflessione filosofica e sociologica.
Diciamo “filosofica” perché pochi sanno che Gabriel Tarde è stato anche un grande metafisico. Ma, ancora oggi, non possiamo sottacere il fatto che si tratti di un autore largamente dimenticato. Raramente troviamo riferimenti alla sua opera negli attuali manuali di sociologia. In ambito criminologico, la sua fama ha resistito in misura maggiore, anche se continua ad essere considerato un autore marginale. Filoso-ficamente poi, nessuno ha più un’idea di quali concetti e di che tipo di intuizioni metodologiche siano scaturite dalla sua penna. Per questi ed altri motivi ci sembra sensato riproporre una sintesi delle sue vedu-te metafisiche, a maggior ragione nell’ambito di un progetto di ricerca espressamente rivolto ai “margini” della filosofia contemporanea.
In primo luogo, l’oblio. Jean Milet, autore di una delle più com-plete monografie sul pensiero e l’opera di Gabriel Tarde, si è espresso in questi termini:
23� Filippo Domenicali
La storia commette strane ingiustizie. Essa è stata particolarmente severa con Gabriel Tarde. Quest’uomo fu salutato dai contemporanei come uno dei più grandi pensatori della sua epoca. Gli sono stati at-tribuiti gli onori più invidiabili: è professore al Collège de France, con Henri Bergson; è membro dell’Institut; è presidente delle Società In-ternazionali di Sociologia e di Diritto. Lascia un’opera di più di quin-dici volumi, che attraverso numerose edizioni e traduzioni estende la sua fama fino alla Russia e all’America. Alla sua morte viene parago-nato ad Auguste Comte, a Taine, a Renan, come anche a Darwin e a Spencer; e Bergson, solitamente sobrio nei suoi omaggi, lo considera un maestro eminente. Ora, lo stesso uomo ha conosciuto, qualche anno dopo la sua morte, un inspiegabile oblio. (Milet �970, 9)�
Ora, “l’inspiegabile oblio” di cui ci parla Milet in realtà una ra-gione ce l’ha, e dev’essere ricercata nella violenta controversia che ha opposto il nostro Autore alla sociologia di Durkheim. È a questa po-lemica che dobbiamo guardare se vogliamo comprendere le reali mo-tivazioni che hanno indotto i sociologi a cancellare il nome di Tarde dalla storia della disciplina.
Senza entrare nel dettaglio di un dibattito che ha perduto oggi gran parte della sua attualità, saremmo tentati di leggere la vicenda in termini kuhniani, sostenendo che si è trattato di una “sostituzione di paradigma” che costituisce in qualche modo l’atto di nascita della sociologia contemporanea. Il casus belli è rinvenibile all’interno del volume metodologico pubblicato da Durkheim nel �89� (Les règles de la méthode sociologique), testo “fondatore” quant’altri mai, e, più in particolare, nella definizione stessa del “fatto sociale”. Ora, Durkheim ha sostenuto che il fatto sociale, in quanto sociale, è tale perché si impone coercitivamente agli individui, che sono perciò costretti a rico-noscerlo come una “cosa”. Le Règles dunque, a ben vedere, debbono essere interpretate come una vera e propria dichiarazione di guerra nei confronti del tardismo, che all’epoca si trovava all’apice del successo. Durkheim sostiene che
è un fatto sociale ogni modo di fare, più o meno fissato, capace di esercitare sull’individuo una costrizione esterna – oppure un modo di fare che è generale nell’estensione di una società data, pur avendo esistenza propria, indipendente dalle sua manifestazioni individuali (Durkheim 2008, 33)
� Quando non diversamente indicato, le traduzioni sono mie.
Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia 237
Qualche pagina prima, per non lasciare adito a dubbi, egli aveva precisato in una nota che:
Si vede come questa definizione del fatto sociale si allontani da quella che serve di base all’ingegnoso sistema di G. Tarde. In primo luogo dobbiamo dichiarare che le nostre ricerche non ci hanno per-messo di constatare da nessuna parte l’influenza preponderante che Tarde attribuisce all’imitazione nella genesi dei fatti collettivi; inoltre, dalla definizione precedente – che non è una teoria, ma un semplice riassunto dei dati immediati dell’osservazione – sembra effettivamen-te risultare che l’imitazione non solo non esprime sempre, ma non esprime mai ciò che c’è di essenziale e di caratteristico nel fatto socia-le. (Durkheim 2008, 3�)
Non è un caso se il capitolo a cui facciamo riferimento (Che cos’è un fatto sociale?) sia apparso originariamente proprio sulla “Revue phi-losophique”, di cui Tarde era assiduo collaboratore.
Come abbiamo anticipato, non ci proponiamo di indagare le mo-tivazioni più o meno recondite della controversia (secondo alcuni, l’invidia di Durkheim per il successo di Tarde), e per questo rimandia-mo alla letteratura critica2. Basti soltanto osservare che i fatti sociali, secondo Tarde, hanno la loro origine al di fuori del mondo sociale, nella mente delle persone. Non è possibile riconoscere la coercizione e l’imposizione dei fatti in questione se non si condividono in via pre-liminare tutta una serie di credenze e di desideri che ci permettono di percepirne l’oggettività. Per questo ed altri motivi, Tarde si contrap-pone all’“ontologia sociale” di Durkheim rivendicando la spontaneità delle relazioni sociali, il loro essere prodotte dal basso a partire dal confronto e dallo scontro tra le opinioni rivali, le visioni del mondo e i sistemi di valori che caratterizzano gli individui, gli unici agenti della storia, coloro che materialmente “fanno” la società a partire dai propri affetti. In breve, la sociologia di Tarde è molto più “psicologica” di quella di Durkheim, e ciò la rendeva, per lo spirito (positivista) dell’epoca, anche molto meno “scientifica”.
2 Si veda in particolare Besnard �99�.
238 Filippo Domenicali
2. Il canone-Deleuze
Sebbene, come abbiamo indicato, dal punto di vista sociologico l’opera di Tarde sia caduta in grave discredito, noi cercheremo
di dimostrare che da un altro punto di vista, filosofico questa volta, egli continua a manifestare una sorprendente attualità.
Al pari dell’oblio, anche la “rinascita” dell’interesse per la sua opera ha una data precisa, il �9�8. Qui comincia la storia contemporanea della sua ricezione, e lo fa con attraverso un testo fondamentale co-m’è Differenza e ripetizione di Gilles Deleuze. Si tratta di un lavoro, come sappiamo, assolutamente centrale nella produzione deleuziana, in quanto costituisce il primo tentativo di fare una filosofia in pro-prio, di “parlare a proprio nome”, seguendo una stagione in cui si era occupato principalmente di questioni storiografiche (segnatamente, nelle opere su Kant, Hume, Nietzsche e Bergson). Qui Deleuze si propone, programmaticamente, di definire una “nuova immagine del pensiero” fondata sulle due categorie di Differenza e Ripetizione. A questo punto il pensiero di Tarde assume un ruolo centrale. Egli viene presentato come un intercessore di primaria importanza per la genesi di queste categorie, venendo posto sullo stesso piano delle innovazioni concettuali proposte da Kierkegaard e da Nietzsche.
Tarde, Nietzsche e Kierkegaard sono per Deleuze gli autori che più di altri si sono opposti frontalmente alla grande impalcatura dialettica messa alla moda da Hegel e dai suoi discepoli. Essi hanno rivendicato per la filosofia un nuovo modo di pensare i concetti, rifiutando il platonismo e qualsiasi immagine presupposta dello sviluppo storico e sociale. Deleuze afferma che:
Tutta la filosofia di Tarde [...] è fondata sulle due categorie di differenza e di ripetizione: la differenza è a un tempo l’origine e la de-stinazione della ripetizione, in un movimento sempre più “possente e ingegnoso”, che tiene “sempre più conto dei gradi di libertà”. Questa ripetizione differenziale e differenziante, Tarde pretende di sostituirla in tutti i campi all’opposizione [...] la ripetizione fonda una dialettica ben diversa da quella di Hegel. (Deleuze �997, 39)
I riferimenti a Tarde non concernono soltanto Differenza e ripe-tizione, ma si trovano disseminati in molte opere di Deleuze, rico-prendo praticamente tutto l’arco della sua produzione. Si direbbe che egli abbia dettato una specie di “canone” tripartito per l’interpretazio-ne della filosofia di Tarde, che ha influito enormemente sulle letture
Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia 239
contemporanee di questo autore: «L’insieme della filosofia di Tarde si presenta come una dialettica della differenza e della ripetizione, che fonda su un’intera cosmogonia la possibilità di una microsociologia» (Deleuze �997, �0�). Come è evidente da questa sintetica citazione, l’interpretazione di Deleuze apre a tre direttrici di ricerca: �) la dialet-tica differenza/ripetizione; 2) la filosofia della natura (o cosmogonia); 3) la microsociologia. Tutto quello che è venuto dopo deriva da qui. Se si ha la pazienza di esaminare i più recenti contributi che hanno coinvolto, a vario titolo, il pensiero e l’opera di Gabriel Tarde, si potrà constatare agevolmente il fatto che tutti coloro che si sono occupati di lui hanno preso le mosse dal “canone” dettato da Deleuze3.
Eppure in questa sede vorremmo tentare di muoverci diversamen-te. Dopo aver precisato le ragioni di un oblio e quelle di una riscoperta possibile, vorremmo avvicinarci alla filosofia di Gabriel Tarde a partire dal suo stesso movimento, a partire dalla sua genesi concreta, abban-donando i vari “doppi” ereditati dalla tradizione. Tra la lettura discri-minante e contestataria di Durkheim e quella entusiastica di Deleuze, vorremmo cercare di riscoprire, nel mezzo, il “vero” Tarde. Per farlo dobbiamo ascoltare la voce dei contemporanei, di coloro che gli erano più vicini, dei suoi stessi figli, e immergerci nel contesto storico-cul-turale del suo tempo restituendolo, se possibile, emendato e corretto, al posto che gli spetta nella storia del pensiero.
Perciò bisogna che ricominciamo dalle sue passeggiate solitarie.
3. Un filosofo “en plein air”
Interrogato sull’origine delle sue riflessioni filosofiche e sociolo-giche, Gabriel Tarde rispondeva che il suo sistema filosofico ha
preso corpo «tra i venticinque e i trent’anni»�. È un dato di fatto rati-
3 Per rendersene conto, è sufficiente scorrere la biografia del pool di curatori delle Opere di Gabriel Tarde (apparse recentemente per i tipi della casa editrice parigina Les empêcheurs de penser en rond) per constatare che i principali protagonisti di questa im-presa editoriale sono tutti legati alla galassia deleuziana; si tratta di ricercatori che sono stati, a vario titolo, amici, collaboratori o discepoli di Deleuze. Oltre al filosofo Éric Alliez che ha coordinato i lavori, hanno partecipato in qualità di curatori Maurizio Laz-zarato, René Schérer, Jean-Clet Martin, Isaac Joseph, Jean-Philippe Antoine, François Zourabichvili, Bruno Karsenti e Bruno Latour. Si veda inoltre Montebello 2003.
� «Nel �8�9 egli fu nominato giudice supplente a Sarlat; qui esercita per quattro anni le sue funzioni. Nel raccoglimento forzato della vita provinciale, dove arrivavano soltanto gli echi dolorosi della guerra, egli già elaborava le più importanti delle sue idee generali, che doveva offrire al pubblico soltanto più tardi. Aveva �7 anni quando
2�0 Filippo Domenicali
ficato dai suoi interpreti più avveduti, come Lubek, che la pubblica-zione delle opere tardiane ha avuto luogo, generalmente, con un certo ritardo rispetto alla data della loro effettiva elaborazione. Così la sua opera principale, Le leggi dell’imitazione, è apparsa soltanto nel �890, sebbene la sua genesi debba essere fatta risalire già ai primi anni Ot-tanta�. Stessa cosa, come abbiamo cercato di dimostrare in altra sede�, per l’importante articolo Monadologia e sociologia, pubblicato soltanto nel �89�, ma la cui prima redazione risale al �879. Gran parte degli articoli filosofici di Tarde, di cui ci occuperemo più da vicino nelle pagine che seguono, provengono, come sottolineato sia da Espinas che dagli stessi figli di Tarde, da un lungo manoscritto intitolato La Répétition et l’évolution des phénomènes che era stato completato nel �87� e che l’anno seguente venne inviato al noto editore Germer-Baillière di Parigi, col quale tuttavia non si arrivò mai all’accordo de-finitivo per la pubblicazione7.
Per comprendere pienamente la genesi e lo sviluppo della meta-fisica tardiana bisogna dunque che cerchiamo di indagare il periodo immediatamente precedente alle sue prime pubblicazioni (il primo articolo su rivista appare nel �880), al fine di delineare i caratteri ge-nerali di quello che si presenta come un “periodo metafisico”8 molto caratterizzato. Diciamo subito che lo stesso Tarde si impegnò atti-vamente per nascondere le sue pubblicazioni giovanili, ritenendole inadatte al pubblico e alle tendenze culturali del suo tempo. Come sappiamo, l’ultimo quarto dell’Ottocento francese è dominato da quello che Ravaisson ha correttamente definito come un “positivismo spiritualistico” in cui arrivano a incontrarsi le tendenze scientistiche ereditate dal comtismo e lo spiritualismo di matrice biraniana9.
Il giovane Gabriel Tarde è un filosofo en plein air. Come testimo-niato dai suoi figli:
pubblicò le Leggi dell’imitazione (�890). Ma già prima dei 30 anni, come testimo-niano gli appunti dell’epoca, egli aveva elaborato alcune delle grandi linee della sua opera» (Tarde �909, �8).
� Cfr. Lubek �98�, 3�3-3��.� Cfr. Domenicali 20�3, 9-��.7 Cfr. Espinas �9�0, 32�-322. Dal manoscritto sulla Répétition vennero tratti
successivamente i seguenti articoli: Tarde �882, �89�, �90� e �9�0. Ma si tengano presenti anche Tarde �880 e 2000, risalenti allo stesso periodo.
8 Tarde �909, �8-23.9 Ravaisson �98�, 3�3.
Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia 2��
Durante le sue lunghe passeggiate, sia sulle colline che circondano Sarlat, sia sui massicci accidentati che circondano le rive della Dordo-gna, egli si arrestava spesso per annotare fin dal suo primo apparire, vivace e rapido, l’idea che gli sovveniva e che lo illuminava di colpo. In questo periodo il pensiero in lui non era mai più vivace e più fe-condo che quando camminava. (Tarde �909, �8)
Al pari di Nietzsche, che si vantava di ricordare il luogo e il mo-mento esatti in cui aveva ricevuto l’illuminazione dell’Eterno ritorno�0, anche per Tarde l’idea della Ripetizione universale è legata all’ecceità rappresentata da un momento della giornata e dalla contemplazione di un luogo ameno, che si ripercuote nell’intimo provocando uno stato d’animo di pace e di serenità, che non potremmo fare a meno di caratterizzare che come un vero e proprio “misticismo”:
Egli serbava ricordo, a distanza di molto tempo, del luogo preciso in cui gli era apparsa l’idea della ripetizione universale in tutta la sua pienezza armoniosa e nella sua maestosa grandezza, nei tre aspetti correlati dell’Ondulazione fisica, della Generazione e dell’Imitazione. Ciò accadde in un luogo elevato, molto vicino a La Roque, su di un aspro costone pietroso abitato da magri vimini, da cui si può ammi-rare la pianura, il fiume scintillante e rapido, e, all’orizzonte, l’enorme promontorio del Domme sotto la bruma... (Tarde �909, �8-�9)
Immerso nel pittoresco dei luoghi, lontano dal clamore della ci-viltà, “il troglodita di La Roque”�� si astrae dal commercio con gli uomini per abbandonarsi alla meditazione solitaria. È questo un pe-riodo poetico e mistico che influenzerà in profondità la riflessione del sociologo che qualche anno dopo si vorrà positivista, rimuovendo accuratamente, occultando tutte le tracce di ciò che era stato.
Il filosofo e il sociologo nascono dal mistico e dal poeta. Nel �878 Tarde pubblica una selezione di poesie intitolata Contes et Poèmes pres-so l’editore Calmann-Lévy, poesie che verranno bruscamente ritirate dal commercio (a sue spese) già nel �880 e oggi divenute pressoché in-trovabili. Possiamo farci un’idea dello stato d’animo del giovane Tarde da una di queste liriche, dedicata all’amata La Roque:
�0 Per Nietzsche, il pensiero dell’Eterno ritorno è stato, come si sa, un’autentica folgorazione presentatasi nell’agosto del �88� a Sils Maria, in Alta Engadina (cfr. Nietzsche �9��, frammento �� [���]. La prima formulazione “essoterica” della dot-trina dell’Eterno ritorno si trova nell’aforisma 3�� Il peso più grande).
�� Così Bouglé �90�, 3��.
2�2 Filippo Domenicali
Dans le plaisir, dans la langueur,Dans la souffrance je t’évoque,Je t’invoque au fond de mon cœur,O mon doux pays de La Roque!
La Roque, où j’ai tant égaréMa rêverie ou mon délire,Plus aimé que je ne puis dire Et plus pleuré!
La Roque, ô lieu suave et rude,Nid de corneilles populeux,Dont la rivière bleue éludeL’obstacle des grands rochers bleus!
Paradis de mon espéranceOù j’ai poursuivi l’apparenceDe félicités qui m’ont lui Et qui m’ont fui !
De mon cœur refuge et délices,Vert écrin de mes plus beaux jours,Cimetière de mes amoursOù je veux qu’on m’ensevelisse!
Vase de paix plein jusqu’aux bordsCorbeille de réminiscencesQui parle et console des morts Et des absences!
Amphithéâtre de coteaux,Gazonneuse et riante arèneOù ne luttent que des bateauxContre le flot qui les entraîne;
Golfe où les nacelles, le soir,Viennent s’abattre sur les grèves;Berceau joyeux, calme dortoir De mes longs rêves!
Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia 2�3
O solitude, où j’aimeraisEtre captif toute ma vie,Où mon âme brandit, ravieSes fers joyeux et pleins d’attraits,
Pareille aux barques de ton fleuveDont les chaînes ont un frissonHarmonieux, gai comme un son De cloche neuve!
Dans le plaisir, dans la longueur,Dans la souffrance, je t’évoque,Je t’invoque au fond de mon cœur,O mon doux pays de La Roque!�2
(Tarde �909, 2�8-220)
Come appare evidente, ci troviamo di fronte al topos romantico del passeggiatore solitario di rousseuviana memoria, a un mistico iso-lato che approfitta della quiete dei luoghi per abbandonarsi al dolce trasporto delle più soavi rêveries. Come ci ricorda la traduttrice di Bachelard:
�2 Sia nel piacere che nel languore, / E nella sofferenza ti evoco, / T’invoco al fondo del cuore, / O mio dolce paese, La Roque! // La Roque, dove ho così a lungo perduto / La mia rêverie o il mio delirio, / Amato più di quanto non possa dire / E pianto! // La Roque, o luogo soave e rude, / Popoloso nido di corvi, / Il cui celeste flutto elude, / L’ostacolo delle grandi rocce blu! // Paradiso della mia speranza / In cui ho ricercato l’apparenza / Di felicità che mi sono brillate / E sfuggite! // Del mio cuore rifugio e delizia, / Verde scrigno dei miei giorni più belli, / Cimitero dei miei amori / In cui voglio riposare in eterno! // Vaso di pace colmo fino ai bordi / Paniere di reminescenze / Che parla e consola dei morti / E delle assenze! // Anfiteatro di colli, / Ridente ed erbosa arena / In cui non lottano che battelli / Contro il flutto che li mena; // Golfo in cui le navicelle, la sera, / Vengono ad abbattersi sui greti; / Gioiosa culla, calmo dormitorio / Dei miei lunghi sogni quieti! // O solitudine, in cui vorrei / Essere prigioniero per tutta la vita, / In cui la mia anima brandisce, rapita, / I suoi ceppi gioiosi e pieni d’incanti, // Simile alle barche del tuo fiume / Le cui catene ema-nano un fremito / Armonioso, gaio come un suono / Di campana nuova! // Sia nel piacere che nella lentezza, / E nella sofferenza, ti evoco, / T’invoco al fondo del cuore, / O mio dolce paese, La Roque! (Ringrazio Jean Robaey per i preziosi suggerimenti sulla traduzione).
2�� Filippo Domenicali
La parola francese rêverie è difficilmente traducibile in italiano [...] La rêverie come stato dello spirito che si abbandona a ricordi e a immagini [...] è la situazione in cui l’io, dimentico della sua storia contingente, lascia errare il proprio spirito e gode in tal modo di una libertà simile a quella del sogno (rêve), in rapporto al quale la rêverie indica tuttavia un fenomeno della veglia. (Bachelard 2008, �)
Il giovane Gabriel Tarde è un dunque sognatore ad occhi aperti. Ma che cosa sogna? Ci si chiederà... La risposta è una sola: sogna
un cosmo. Vediamo quale.
�. Fantasticare un cosmo
La meditazione nel ritiro, lo studio della natura, la contem-plazione dell’universo spingono un solitario a lanciarsi senza
tregua verso l’autore delle cose, e a cercare con dolce inquietudine la fine di tutto ciò che vede e la causa di tutto ciò che sente. (Rousseau 20�2, �0)
Le celebri passeggiate di Rousseau, vero manifesto del cosiddetto “pre-romanticismo”, hanno rappresentato, e continuano a rappresen-tare ancor oggi, un topos letterario di sicura suggestione, che certa-mente deve avere influenzato anche il giovane Tarde. Esse rappresen-tano una sorta di rivolta anti-intellettualistica («L’esiguo numero di libri che ancora leggo...») che spinge il nostro Autore a gettare tutti i libri e a porsi, per così dire, a diretto contatto con la natura. Potrem-mo dire che, aristotelicamente, la filosofia continua a nascere dalla meraviglia�3.
Anche il metodo di lavoro di Tarde, basato su fogli volanti vergati nel bel mezzo delle sue passeggiate��, pare adattarsi perfettamente a
�3 «Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia» (Aristotele 2000, ��). Non intendiamo addentrarci nel coacervo di interpretazioni che si sono concentrate su questo luogo frequentatissimo del testo Aristotelico, e nemmeno intendiamo disputare sulla maggiore o minore correttezza della traduzione italiana con il termine “meraviglia”. Basti soltanto osservare che il verbo greco thaumazō utilizzato da Aristotele ha generalmente il significato di “mi meraviglio”, “mi stupisco”, “sono preso da ammirazione”.
�� Lo stesso dicasi del suo modo di leggere, o meglio di servirsi, delle sue letture: «Tarde in effetti non correggeva mai, o quasi mai. Egli utilizzava più o meno intatti gli appunti spesso molto ampi che gli venivano suggeriti dalle sue letture. Si inter-
Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia 2��
questa idea “peripatetica” e anticartesiana della filosofia in cammino, con la consapevolezza, propria a tutti i mistici, del fatto che «un pen-siero viene quando è “lui” a volerlo, e non quando “io” lo voglio; cosicché è una falsificazione dello stato dei fatti dire: il soggetto “io” è la condizione del predicato “penso”. Esso pensa» (Nietzsche �977, 2�). Il pensare è perciò sempre un’attività che concerne una relazione particolare con il “fuori”, e la mia coscienza (mia, in quanto soggetto che pensa) è soltanto una “piega” dell’esteriorità universale alla quale partecipo in quanto essere a vario titolo desiderante e credente.
Nessuno meglio di Gaston Bachelard ha saputo comprendere lo stato d’animo caratteristico del sognatore ad occhi aperti. La sua Poe-tica della rêverie costituisce una fenomenologia del sognatore che in questa sede non possiamo in alcun modo lasciare da parte.
Innanzitutto, Bachelard differenzia radicalmente il sognatore not-turno dal sognatore rêverie: «il sognatore notturno è un’ombra che ha perso il suo Io» (in quanto non c’è un cogito del sognatore, che nel sonno perde il proprio essere e si trova in balìa delle immagini che si susseguono sottraendosi al suo controllo), mentre «il sognatore di rêverie può formulare un cogito al centro del suo Io. In altre parole, la rêverie è un’attività onirica nella quale sussiste un bagliore di coscien-za» (Bachelard 2008, ���).
Ma, allo stesso tempo, una differenza ancora maggiore caratterizza la distanza che separa il sognatore di rêverie dal pensatore razionale, dal filosofo, poiché «Il cogito del sognatore è meno vivo del cogito del pensatore. Il cogito del sognatore è meno sicuro del cogito del filosofo. L’essere del sognatore è un essere diffuso» (Bachelard 2008, �73). Il sognatore di rêverie abbatte tutte le barriere che separano l’essere dal non-essere, il soggetto dall’oggetto. Egli abita una «regione interme-dia» tra il sogno profondo e la ragione più lucida, che è un mondo che egli esperisce immediatamente come un tutto vivente:
rompeva spesso mentre leggeva, e fissava il suo pensiero così come gli veniva; di solito era lo stadio definitivo. Egli contrassegnava il passaggio che l’aveva fatto riflettere con un piccolo segno a margine, elegante e discreto, simile al volo di una rondine. Ed era proprio questo, in effetti: il volo istantaneo di un’idea... Le sue letture non erano il più delle volte che dei pretesti per voli di questo tipo; egli cercava in esse meno la gioia di imparare che la speranza di scoprire, e un libro capace di farlo pensare, capace di aprire la porta alla voliera d’idee che lui era sempre, veniva considerato un bel libro. Sono proprio questi appunti senza modifiche che talvolta gli hanno fornito tutto un capitolo, e che spesso, semplicemente giustapposti, si conseguivano e si raccordavano in maniera del tutto naturale, a causa dell’unità del suo pensiero in cui le fonti più varie finivano per ritrovare alcune confluenze, sempre le stesse» (Tarde �909, 29).
2�� Filippo Domenicali
Attraverso la sua rêverie, vive in un mondo in sintonia con il suo essere, con il suo semi-essere. L’uomo della rêverie è sempre nello spazio di un volume. Abitando tutto il volume del proprio spazio, l’uomo della rêverie si radica nel suo mondo, in un interno privo di esterno. Non a caso si dice che il sognatore è immerso nella sua rêve-rie. Il mondo non gli si oppone più. L’Io non si oppone al mondo. Nella rêverie, il non-io non esiste (Bachelard 2008, �73).
Anche Gabriel Tarde si oppone al dualismo cartesiano, fatto di materia e spirito, per abbandonarsi ad un “monismo” spirituale che si richiama direttamente alla Monadologia di Leibniz, per il quale «c’è un mondo di creature – di esseri viventi e di animali, di entelechie e di anime – anche nella più piccola porzione di materia» che per questo può essere concepita come «un giardino pieno di piante, o come uno stagno pieno di pesci» (Leibniz 200�, 89). In Monadologia e sociolo-gia, lo scritto indubbiamente più eccentrico e visionario di Tarde, egli rivendica la necessità di completare le osservazioni scientifiche for-nendo ad esse una metafisica adeguata. E questa metafisica è in realtà un panpsichismo (o, nei suoi termini, uno psicomorfismo): «Nessuna intelligenza nella materia, oppure una materia che ne sia plasmata; non c’è via di mezzo». Ogni atomo, ogni monade dell’universo è una forza (non sostanza!) che desidera, sente, vuole e crede. «Credenza e desiderio costituiscono tutto l’essere delle monadi» (Tarde 20�2, �� e 80), perché c’è uno psichismo rudimentale perfino nella materia...
�. Differenza, Ripetizione (e ritorno)
Il cosmo immaginato da Tarde è governato da una sola legge uni-versale, quella di Differenza e Ripetizione. È sufficiente accen-
nare al titolo dei suoi due più importanti manoscritti giovanili ‒ La différence universelle (�870) e La Répétition et l’évolution des phénomè-nes (�87�) ‒ per comprendere l’importanza di queste categorie. In Monadologia e sociologia egli afferma ripetutamente che «La differenza è l’alfa e l’omega dell’universo» mentre «Tutte le somiglianze, tutte le ripetizioni fenomeniche» sono soltanto degli «intermediari inevitabili tra le diversità elementari». Si tratta – continua Tarde – di una «serie in cui l’identità e la differenza, l’indistinto e il caratterizzato, si utiliz-zano ripetutamente a vicenda» ma «è la differenza, il caratterizzato, [che] costituisce sia il termine iniziale, sia quello finale» (Tarde 200�3,
Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia 2�7
8�). La ripetizione è “per” la differenza. Il movimento che dalla diffe-renza porta alla ripetizione non ha altro fine se non quello di sublima-re in una differenza sempre più alta, facendo sbocciare le possibilità più elevate dello sforzo [effort] che caratterizza l’evoluzione universale. L’evoluzione presupposta da Tarde, a differenza di quella di Spencer, è discontinua e multilineare. E, a dire il vero, Tarde protesta spesso contro il termine evoluzione, preferendo utilizzare quello di “trasfor-mazione”, meno connotato in senso teleologico.
Il processo della Ripetizione universale, che dà il titolo al primo capitolo delle Leggi dell’imitazione, si manifesta in tre forme diverse, corrispondenti ai tre piani sovrapposti dell’evoluzione, e cioè la Ripe-tizione fisica (ondulazione), vivente (ereditarietà) e sociale (imitazio-ne). Ogni ripetizione scaturisce da una variazione infinitesimale che si produce in seguito all’incontro fortunato tra le due forze psichiche fondamentali, credenza e desiderio, assunte in una chiave assoluta-mente non-antropomorfica. Lo sforzo universale si biforca perciò in due correnti che possono aggregarsi o combattersi tra loro, e in questo modo danno forma ai fenomeni materiali. Ogni variazione è destinata ad attraversare il calvario della Ripetizione, una sorta di processo di selezione, che è anche una lotta per la vita e per la morte, che fa sì che soltanto la parte migliore possa perpetuarsi e continuare a ripe-tersi all’infinito. Maurizio Lazzarato ha acutamente osservato che per comprendere Tarde «bisogna comprendere il mondo come una realtà della stessa natura dei nostri desideri e delle nostre passioni» (Lazzara-to 20�3, ��8). Ciò che caratterizza le monadi infinitesimali è infatti la coppia concettuale “ambizione-avidità”. Ambizione (leggi: credenza) e avidità (leggi: desiderio) costituiscono tutto l’essere delle monadi, il loro psichismo rudimentale che, se anche non perviene alla coscien-za di sé, rimane pur sempre la sede di una volontà, oppure, detto in termini fisici, di una tendenza. Perché anche gli atomi hanno le loro preferenze nascoste, le loro affinità elettive. Ogni variazione prima di tutto vuole propagarsi in maniera geometrica e conquistare l’intero universo, così da foggiarlo a sua immagine e somiglianza. Volontà di dominare e volontà di non-essere-dominati sono gli elementi del-l’eterna lotta per la supremazia, una lotta che comincia già all’interno dell’atomo e dei suoi radicali.
Sant’Agostino diceva che «Il mondo è come un torchio che spre-me. Se tu sei morchia, vieni gettato via; se sei olio, vieni raccolto. Ma essere spremuti è inevitabile» (cit. da Löwith �998, 8). Tarde rispon-
2�8 Filippo Domenicali
derebbe, a tono, che l’universo è un grande alambicco�� in cui si su-blimano le differenze più elevate, le uniche degne di esistere. E questa regola vale sia per la materia che per la vita. Fino all’uomo.
Bibliografia
Aristotele (2000), Metafisica, trad. it. di G. Reale, Bompiani, Milano.
Bachelard, G. (2008), La poetica della rêverie, trad. it. di G. Sil-vestri Stevan riv. da B. Sambo, Dedalo, Bari [La poétique de la rêverie, Puf, Paris, �9�0].
Besnard, P. (1995), Durkheim critique de Tarde: des Règles au Sui-cide, in La sociologie et sa méthode. Les Règles de Durkheim un siècle après, L’Harmattan, Paris, pp. 22�-2�3.
Bouglé, C. (1905), Un sociologue individualiste: Gabriel Tarde, in “Revue de Paris”, �� mai �90�, pp. 29�-3��.
Deleuze, G. (1997), Differenza e ripetizione, trad. it. di G. Gu-glielmi riv. da G. Antonello e A.M. Morazzoni, Raffaello Cortina, Milano [Différence et répétition, Puf, Paris, �9�8].
Domenicali, F. (2013), La metafisica segreta di Gabriel Tarde, in G. Tarde, Monadologia e sociologia, ombre corte, Verona, pp. 7-3�.
Durkheim, É. (2008), Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, trad. it. di F. Airoldi Namer, Einaudi, Torino [Les règles de la méthode sociologique, Alcan, Paris, �89�].
Espinas, A. (1910), Notice sur la vie et les œuvres de M. Gabriel de Tarde, in “Séances et Travaux de l’Académie des Sciences Morales et Politiques”, juillet-décembre, pp. 309-�22.
Lazzarato, M. (2013), Gabriel Tarde. Un vitalismo politico, trad. it. di F. Domenicali, in G. Tarde, Monadologia e sociologia, cit., pp. ��7-��� [Gabriel Tarde: un vitalisme politique, in G. Tarde, Monadologie et sociolo-gie, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, �999, pp. �03-��0].
Leibniz, G.W. (2001), Monadologia, trad. it. di S. Cariati, Bom-piani, Milano [Lehrsätze über die Monadologie, Franckfurth und Lei-pzig, �720].
Löwith, K. (1998), Significato e fine della storia, trad. it. di F. Te-deschi Negri, Est, Milano [Meaning in History, University of Chicago Press, Chicago, �9�9].
�� L’immagine dell’alambicco (alambic) compare sia nel testo di Monadologia e sociologia che nelle ultime pagine delle Leggi dell’imitazione.
Gabriel Tarde tra metafisica e sociologia 2�9
Lubek, I. (1981), Histoire de psychologies sociales perdues: le cas de Gabriel Tarde, in “Revue française de Sociologie”, XXII, pp. 3��-39�.
Milet, J. (�970), Gabriel Tarde et la philosophie de l’histoire, Vrin, Paris.
Montebello, P. (2003), L’autre métaphysique. Essai sur la philo-sophie de la nature: Ravaisson, Nietzsche, Tarde et Bergson, Desclée de Brouwer, Paris.
Nietzsche, F. (�9��), La gaia scienza, Idilli di Messina e Fram-menti postumi 1881-1882, Adelphi, Milano.
Nietzsche, F. (�977), Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano [Jenseits von Gut und Böse, Naumann, Leipzig, �88�].
Ravaisson, F. (�98�), De l’habitude. La philosophie en France au XIXe siècle, Fayard, Paris [ed. orig., Imprimerie Imperiale, Paris, �8�8].
Rousseau, J.J. (20�2), Le passeggiate del sognatore solitario, trad. it. di B. Sebaste, Feltrinelli, Milano [Les rêveries du promeneur solitaire, Grasset & Comp., Paris, �782].
Tarde, G. (�880), La croyance et le désir, la possibilité de leur mesu-re, in “Revue philosophique”, t. X, pp. ��0-�80 e pp. 2��-283.
Tarde, G. (�882), Les traits communs de la nature et de l’histoire, in “Revue Philosophique”, t. XIV, pp. 270-29�.
Tarde, G. (1895), La variation universelle, in Id., Essais et mélanges sociologiques, Storck et Masson, Lyon-Paris, pp. 39�-�22.
Tarde, G. (�90�), L’action des faits futurs, in “Révue de métaphy-sique et de morale”, n. 2, pp. ��9-�37.
Tarde, G. (�909), Gabriel Tarde. Introduction et pages choisies par ses fils, Michaud, Paris.
Tarde, G. (�9�0), Les possibles. Fragment d’un ouvrage de jeunesse inédit, in “Archives d’Anthropologie Criminelle”, t. XXV, n.�93-�9�, pp. 8-�0.
Tarde, G. (2000), Maine de Biran et l’évolutionnisme en psycholo-gie, Les empêcheurs de penser en rond, Paris; ed. orig. Cassard Frères, Périgueux, �882.
Tarde, G. (20�2), Le leggi dell’imitazione, trad. it. di F. Domeni-cali, Rosenberg & Sellier, Torino [Les lois de l’imitation, Alcan, Paris, �890].
Tarde, G. (20�3), Monadologia e sociologia, cit. [Monadologie et sociologie, in Essais et mélanges sociologiques, cit., pp. 309-389].