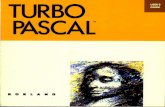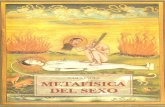La metafisica di Pascal e il sapere profondo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La metafisica di Pascal e il sapere profondo
DirettoreMaria Vita Romeo
RedazioneMassimo Vittorio (coordinatore), Floriana Ferro,Antonio G. Pesce, Elisabetta Todaro, Daniela Vasta
Segreteria di redazioneManuela Finocchiaro, Cinzia Grazia Messina
Comitato ScientificoPaolo Amodio (Università «Federico II», Napoli)Laura Berchielli (Université «Blaise Pascal», Clermont Fer-
rand)Domenico Bosco (Università di Chieti-Pescara)Calogero Caltagirone (Università LUMSA, Roma)Riccardo Caporali (Università di Bologna)Carlo Carena (Casa editrice Einaudi)Dominique Descotes (Université «Blaise Pascal», Clermont
Ferrand)Laurence Devillairs (Centre Sèvres et Institut catholique de
Paris)Gérard Ferreyrolles (Université Paris Sorbonne-Paris IV)Denis Kambouchner (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)Gordon Marino (St. Olaf College, Minnesota USA)Denis Moreau (Université de Nantes)Giuseppe Pezzino (Università di Catania)Philippe Sellier (Université Paris Sorbonne-Paris IV)Paolo Vincieri (Università di Bologna)
Direttore responsabileGiovanni Giammona
Direzione, redazione e amministrazioneDipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania.Piazza Dante, 32 - 95124 Catania.Tel. 095 7102343 - Fax 095 7102566Email: [email protected]
ISSN 1970-7401
© 2014 - Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università diCatania
Registrazione presso il Tribunale di Catania, n. 25/06, del 29settembre 2006
Semestrale del Laboratorio di Etica e Informazione Filosofica - Università di Catania
Impaginazione e stampa:, grafica editoriale
di Pietro Marletta,via Delle Gardenie 3, Belsito,95045 Misterbianco (CT),tel. 095 71 41 891,e-mail: [email protected]
Quadernileif
Quadernileif
Noterella redazionale 5
OmaggiO a PhiliPPe sellier
Paolo Amodio Pascal, Port-Royal (e Montaigne): que sais-ye? Note in due tempi a margine di un libro e di un colloquio con Philippe Sellier 7
Domenico Bosco Un Pascal «gaudioso». Omaggio a Philippe Sellier 17
Hélène Bouchilloux Dieu sensible au cœur, ou la libido des philosophes 41
Carlo Carena Sul Pensiero 168 di Pascal 55
Roberto Osculati Attualità di Pascal 61
Antonio Giovanni Pesce La metafisica di Pascal e il sapere del profondo 67
Giuseppe Pezzino Pascal: un compagno di viaggio nel deserto 83
Philippe Sellier Sept empreintes pascaliennes 97
sPigOlature
Antonio Giovanni Pesce Dio non esiste, dunque è reale 107
Sarah Eva Ravidà Fratello lupo e il Paradiso ritrovato 109
Semestrale del Laboratorio di Eticae Informazione Filosofica
Anno VIII n. 12, luglio-dicembre 2014
Università di Catania
Antonio Giovanni Pesce
La metafisica di Pascal e il sapere del profondo
Ogni uomo di questo orizzonte storico, di questa civiltà chechiamiamo Occidente; ogni generazione delle migliaia che si sono
date il cambio al trotto degli eventi, hanno avuto la loro telemachia: senzaun padre, i pretendenti fanno scempio del patrimonio. Uomini e genera-zioni intere, in questo cammino, hanno trovato il loro Ulisse poluvtropo~,«dal duttile ingegno», quell’ingegno che gli permette di affrontare «situa-zioni diverse». Nell’approcciarci alla civiltà, in questo nostro vivere la sto-ria, Pascal è stato l’Ulisse di migliaia di uomini, e non solo a lui coevi. Alui si è guardato, divenuto presto classico, come punto focale dell’orizzonteentro cui è inscritta la nostra civiltà: non si può cogliere tutto l’orizzonte,esso si dà in un punto, che può mutare, ma ogni punto ci comunica lagrandezza dell’orizzonte, lasciando che l’occhio spazi infinitamente. Laclassicità di un pensatore sta proprio in questo, cioè dire del tutto senza maiconcludere il discorso. Pascal ci ha detto il tutto, ma non ha potuto conclu-dere il discorso, perché egli rimane situato in un punto dell’orizzonte. Eccoperché non ha smesso di dire quel che ha da dire, parafrasando quanto di-ceva di un classico Italo Calvino in un suo famoso scritto.
Non ho interrogato Pascal per avere tutte le risposte che servono al no-stro tempo, e comunque non gli ho chiesto di quelle che servono a me, giàtroppe, bensì per vedere se, nel freddo di questo momento storico, appa-rentemente non più riscaldato dalla passione per il sapere profondo (e sta-bile, proprio perché non poggia sul friabile terriccio), egli ha ancora qual-cosa da dire.
Ricostruzione di senso
Leggendo la prefazione di Philippe Sellier all’edizione italiana del suoPascal e Port Royal, si ha modo di riflettere su quella vocazione che ha por-tato molti a dialogare con coloro che la storia annovera come classici, mache furono innanzi tutto uomini, donne, persone con un problema esisten-ziale da risolvere. Nella bella presunzione che genera un amore appenasbocciato, i giovani credono che essi soltanto sanno amare, che essi soltantosono mossi da una sincera passione che è vocazione, il richiamo di un de-stino da compiersi volontariamente, e non riescono ad immaginare untempo in cui i genitori, i maestri, coloro che li precedono nel camminodella vita, siano stati pervasi dalla medesima passione, unica bussola in unmondo che anche per loro era una selva e per i cui sentieri si inoltravanosenza sapere cosa ne sarebbe stato del loro viaggio. Come immaginare untempo in cui il maestro, che ora ti conferma nella tua vocazione, abbia do-vuto trovare la forza per confermarsi nella propria? che abbia dovuto tro-vare la propria strada, e che questa non era affatto tracciata, né tracciato eralo sviluppo del suo pensiero? Impariamo tardi ma impariamo definitiva-mente, che nessun filosofo è mai nato dall’astratto ed olimpico mondo delPensiero, ma da questo mondo, in momenti anche fortemente drammatici,tra le braccia di persone care alla cui perdita non ci si rassegna mai.
Fu così, nella drammaticità del vivere, che Philippe Sellier incontrò Pa-scal (e potremmo fare ancora centinaia di esempi). Incontro non pianifica-to, non nato da contingenze – che pure hanno il loro valore – accademicheo scientifiche. L’illustre accademico francese stava svolgendo la leva milita-re, in un’Europa che tentava di riprendersi dall’ultimo attacco di follia col-lettiva, i cui resti, soprattutto resti umani, erano ancora sparsi per le vie.Pascal, per lui, fu subito «infinitamente più di un oggetto di studio»1. Fuun dilemma, che doveva condurre necessariamente ad una scelta esisten-ziale: «disperare dell’uomo o, come negli esistenzialisti cristiani, aprire sullasperanza»2. Questo dilemma, che è innanzi tutto il suo dilemma, era anche
1 Ph. Sellier, Pascal e Port-Royal, introduzione, traduzione e note di Maria Vita Romeo, Bre-scia, Morcelliana, 2013, p. 31.
2 Ivi, p. 32.
Antonio Giovanni Pesce
quello del mondo filosofico dell’epoca: non è un caso che ad introdurreSellier ai temi cari a Pascal sia stata la ben nota opera di Mounier, Introdu-zione agli esistenzialismi del 147.
Il concreto dell’esistenza
Questo di Mounier è uno tra i documenti più importanti di una crisi.Di quale, però, è difficile dire. Forse, quell’evento che noi, alla spicciola,definiamo modernità, non è altro che una serie di scosse telluriche chestanno riconfigurando il nostro orizzonte culturale. Forse. Di sicuro c’èche, quando esce l’opera di Mounier, pochi confidavano ancora nelle ma-gnifiche sorti e progressive che il Novecento aveva illuso di poter donare.Sembrò, anzi, che un certo razionalismo avesse appiattito con una lucetroppo luminosa il chiaroscuro del reale, così come i carri armati le diver-sità del continente più combattuto e combattente del globo terrestre. Lastoria non aveva mantenuto ciò che aveva promesso, o che alcuni le aveva-no fatto promettere sotto la minaccia di metodi troppo angusti perché, nelcernere il grano dalla pula, non rimasse fuori oltre che l’errore la verità. Nelturbinio della catastrofe, risuonano le parole che Raissa Maritain scrive nelsuo esilio in America:
Quando le innominabili sofferenze avranno compiuto la nostra purificazione, al-lora soltanto potrà passare di nuovo, sulla nostra sventura e sulla nostra pazienza,il soffio della vita capace di rinnovare la faccia della terra3.
La guerra fa esplodere, comunque, una insoddisfazione latente. È dal-l’inizio di quel secolo martoriato che si va verso la concretezza, per citare iltitolo di una nota opera di Jean Walh4. A questa tendenza cercavano – variconosciuto – di dare risposta sia il positivismo che il neoidealismo, ma seil primo non poteva fare di più, al secondo mancò una terminologia ade-guata e un po’ di coraggio. Ancor prima dello scoppio del secondo conflit-
3 R. Maritain, I grandi amici, Milano, Vita e Pensiero, 172, p. 14.4 Cfr. J. Lacroix, Panorama della filosofia francese contemporanea, Roma, Città Nuova editrice,
171, p. 10.
La metafisica di Pascal e il sapere del profondo
to mondiale, ma soprattutto per tutti gli anni Quaranta, le dottrine dei pa-dri vengono chiamate a giudizio dalle aspirazione dei figli. Emblematica lasorte toccata al neoidealismo italiano, soprattutto a Giovanni Gentile. Nel143, sulla rivista «Primato»5 si discute di esistenzialismo, dopo che NicolaAbbagnano e Antonio Banfi avevano già dato fuori alcune delle loro operededicate al tema. In quell’occasione, Gentile tentò di dimostrare, soprat-tutto sull’incalzare dell’argomentazione di Armando Carlini, che egli nonaveva mai pensato ad altro spirito che a quello di colui che pensa attual-mente, del concreto soggetto pensante. Ma i tribunali, se sono amici dellaverità, non lo sono della verità tutta intera, e questo vale anche per i tribu-nali della cultura. In Italia il capro espiatorio servì ad attutire, almeno inun primo momento, l’evidenza di una contrapposizione, che in Francia fuevidentissima: quella tra esistenzialismo ateo ed esistenzialismo cristiano.Da qui, appunto, i due esistenzialismi di cui parla, già nel titolo, l’opera diMounier: Marcel, Sartre e altri.
Che cosa poté leggere la generazione di Sellier in quest’opera? Vi lesse,innanzi tutto, quel bouquet di temi esistenzialisti che, a detta di Mounier,anche Pascal offre. Anzi, accompagnando l’introduzione del suo scritto conuna dipintura, per l’esattezza un albero – la cui simbologia ricorre spessonella storia della filosofia, e qui è utilizzata come precisa citazione cartesia-na –, ai cui piedi poneva proprio Pascal, Mounier commenta così:
La storia del pensiero è segnata da una serie di risvegli esistenzialistici, che sonostati per il pensiero altrettante conversioni a se stesso, ritorni alla sua missione ori-ginale. È il richiamo di Socrate… È il messaggio stoico… È Pascal che si ergevasulla soglia della grande avventura cartesiana contro coloro che approfondisconotroppo le scienze e si preoccupano poco dell’uomo, della sua vita e della sua mor-
5 Per rileggere il dibattito cfr. AA. VV., L’esistenzialismo in Italia, a cura di Bruno Maiorca,Torino, Paravia, 13. Sul contributo di Gentile cfr. G. Invitto, La presenza di Giovanni Gentile neldibattito sull’esistenzialismo italiano, «Idee. Rivista di filosofia», 2-2, 15, pp. 175-4.
6 «Quanto a me son certo che parlare dell’atto pensante, o dell’uomo, o di colui che pensa ètutt’uno, posto che si sia capito che il soggetto pensante (che è appunto l’uomo) è atto e non so-stanza; e con certo del pari che costruire la dialettica dell’atto pensante è il meno che si possa fareper concepire in qualche modo questo atto e farne in qualche modo una filosofia», G. Gentile, L’e-sistenzialismo in Italia, «Primato», 15 marzo 143, ora in Id., Frammenti di filosofia, a cura di H. A.Cavallera, Firenze, Le Lettere, 14, pp. 11-24, da cui si cita p. 120.
70 Antonio Giovanni Pesce
te. Ma con Pascal siamo già nell’esistenzialismo moderno. Egli ha tracciato tuttele vie, ha affrontato quasi ogni tema7.
Quali sono queste vie? Mounier li affronta nel secondo capitolo, mo-strando la differenza d’approccio tra l’esistenzialismo cristiano e quelloateo. Per l’uno come per l’altro l’esistenza umana è contingente. Ma men-tre «per l’esistenzialismo cristiano, la mia contingenza ha la sua radice nellacontingenza originale dell’atto creatore gratuito, rinnovato poi dalla mise-ricordia gratuita dell’Incarnazione e della Redenzione», per quello ateo «lacontingenza dell’esistenza non prende più il carattere di mistero che pro-voca, ma di irrazionalità pura e d’assurda brutalità». Sia per l’uno che perl’altro, l’esistenza umana è uno slancio. Ma verso cosa? Verso un’abbon-danza d’essere o verso un nulla? È bene citare, adesso, un passo di Mounierche esprime bene alcuni concetti che, poi, converrà analizzare meglio:
Si tratta ora di sapere che cosa esprime questo slancio. Lo si voglia considerare co-me capacità di riflessione oppure come capacità di espansione, esso già di primoacchito appare come un arricchimento considerevole dell’essere umano in con-fronto all’essere immediato dell’esistenza e immobile, dunque come la rivelazionedi un più-essere in senso all’essere. È ciò che esprime l’antica prova ontologica, èl’intuizione che Cartesio ha ripreso nella sua prova di Dio mediante l’idea delperfetto che è in noi come una delle manifestazioni dell’esistenza del Perfetto. Èancora la chiave dell’apologetica pascaliana mediante l’analisi esistenziale dell’in-quietudine umana… In tutte queste prospettive, l’inquietudine, per quanto siadivorante, è recuperata con un’abbondanza d’essere10.
Quando, poi, Mounier arriva a trattare il tema dei limiti della ragione– tema che definisce «pascaliano per eccellenza»11 – il filosofo di Port-Royalè l’autore più citato. Qui, Mounier si rende conto, ammettendolo chiara-mente, che Pascal spinge il tema fino a trasformarlo in una sfida. È statanotata una certa analogia con l’esperienza kantiana12, ma anche che termini
17 E. Mounier, Introduction aux Existentialismes (147), trad. it. Gli esistenzialismi, a cura di A.Lamacchia, Bari, Ecumenica editrice, 11, p. .
18 Ivi, p. 3.19 Ivi, p. 3.10 Ivi, p. 4.11 Cfr. ivi, p. 41.12 Cfr. Ph. Sellier, Pascal e Port-Royal, cit., p. 347.
La metafisica di Pascal e il sapere del profondo 71
come filosofia e filosofi «non ricevano mai, in tutta l’opera pascaliana, chedelle accezioni peggiorative»13. Nel fr. 7 possiamo leggere
L’uomo non è che un soggetto pieno di errore naturale e ineliminabile senza lagrazia. Nulla gli mostra la verità. Tutto lo inganna. I due principî di verità, la ra-gione e i sensi, oltre a essere entrambi infidi, s’ingannano reciprocamente. I sensiingannano la ragione con false apparenze, e questa stessa frode fatta all’anima lasubiscono a loro volta da lei, che si prende la sua rivincita. Le passioni dell’animaintorbidano i sensi e vi producono impressioni false. È una gara di menzogne edi inganni14.
Il frammento è dedicato all’analisi dell’immaginazione, che però non èintensa da Pascal come un’operazione frivola, puerile o, tutt’al più, inno-cua, alla stregua del significato che, per molti versi, gli viene conferito nellalingua italiana. Immaginazione è qualcosa di più profondo. Non è un casoche, nello stesso frammento, Pascal faccia diversi esempi – il vuoto sottoun asse su cui si sta seduti, incute comunque paura, anche se è altamenteimprobabile che si cada; le toghe dei magistrati, «le sottane e la babbucce»dei medici, ecc. – che non possono essere rubricati tra le frivolezze dell’e-poca. C’è, insomma, una parte dell’uomo che la ragione – quel tipo di ra-gione che il secolo osannava – non riesce ad esaurire.
Ancor più interessante è che l’esaltazione della ragione trovi la sua figurastorica in un personaggio come Don Chisciotte, che Pascal amava. O chela simbologia della canna pensante riprenda quella utilizzata da Gesù Cristoper descrivere il più grande tra gli uomini nati da donna15: Giovanni il Bat-tista, il Precursore, colui che non battezzava in spirito e fuoco, ma con l’ac-qua, secondo la legge e non lo spirito. Pratica, però, che Gesù non disattese,perché non era venuto a negare la legge ma a portarla a compimento. Seandiamo più in profondità, capiamo che questa canna pensante grida neldeserto della vanità e dello svago, e che forse non potrà avere altra fine cheessere decapitata o bere la cicuta. Giovanni Battista venne ucciso per averdetto la verità, non già per essersi adeguato alla menzogna del mondo. Èimportante insistere su questa simbologia, perché ci mostra, innanzi tutto,
13 Ivi, p. 34.14 Edizione Sellier, a cura di C. Carena, Torino, Einaudi, 2004.15 Cfr. Ph. Sellier, Pascal e Port-Royal, cit., pp. 352-3.
72 Antonio Giovanni Pesce
che pensare è qualcosa di più che il semplice calcolare. Inoltre, che il pen-sare, pur non potendoci dare la verità tutta intera, non è vano esercizio, maha esso pure le sue buone ragioni, che Pascal non nega affatto. Infine, chese questo esercizio del pensare non è vano, non basta da solo: verrà il batte-simo del fuoco, portato da una verità che si rivelerà come Persona, al di làdi ogni dimostrazione intellettuale. Dunque, una simbologia chiara: la leg-ge/ragione non viene annientata in un vago misticismo, ma illuminata dal-lo spirito/fede. È questo il progetto dell’apologia pensata da Pascal. Ed è,mi sia consentita un’opinione forte, un progetto squisitamente metafisico.
Metafisica della persona
Aver accennato ad un Pascal metafisico può sembrare un azzardo, so-prattutto nelle intemperie culturali che viviamo: l’avversione alla metafisicanasce dalla paura di una reductio ad unum, di un annullamento di ogni di-versità, di una realtà che perda tutta la sua ampiezza di spettro per ridursiad un monocolore sbiadito. È sembrato che la metafisica potesse essere unatto di violenza necessitante contro ogni libertà, anche la più giusta. E poi,non fu Pascal a prendere le distanze dalla metafisica, seppur nel dialogocon quella cartesiana? Non è ancora Mounier, autore dal quale siamo par-titi, a scrivere in quella sua opera della distanza dalla metafisica1 e controil sistema17, questo terzo astratto che si interpone tra i due concreti, il filo-sofo e gli enti? E la metafisica viene intesa soltanto come sistema.
In quel 147, anno della pubblicazione dell’Introduzione agli esistenzia-lismi, il dibattito sull’esistenzialismo si fa intenso. L’«Archivio di filosofia»,diretto da Enrico Castelli, dedica un numero monografico all’esistenziali-smo cristiano. È anche l’anno in cui Heidegger risponde, con la sua Letterasull’umanismo (ripubblicata due anni dopo in versione definitiva) allo scrit-to sartriano dell’anno precedente, L’esistenzialismo è un umanismo. Esce an-che un piccolo ma denso libro di Jacques Maritain, dedicato alla moglieRaissa. Si tratta del Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente. Maritain si
16 Cfr. E. Mounier, Gli esistenzialismi, cit., p. 30.17 Cfr. ivi, p. 17. E più avanti: «Il sistema appartiene alla categoria del repertorio e dello stru-
mento. Colleziona o articola. Ma l’inesauribile non si conta e l’inafferrabile non si articola» (p. 24).
La metafisica di Pascal e il sapere del profondo 73
mostra subito riluttante ad accettare la moda dell’esistenzialismo. Conbrioso sarcasmo, fa notare come i suoi contemporanei confondano «le fa-coltà di invenzione dei filosofi con quelle degli artisti delle grandi case dimoda»1. Moda del momento è appunto l’esistenzialismo. Per Maritain, ilprimato dell’esistenza è ciò che distingue il tomismo autentico da alcunecorrenti scolastiche che lo hanno frainteso. Ma non si ferma qui. Va oltre.Ci invita a distinguere l’esistenzialismo da una sincera filosofia dell’esisten-za. Cosa distingue le due cose? Le distingue la ricerca di un senso dell’esse-re. Scrive Maritain:
Diciamo subito che vi sono due modi fondamentalmente diversi d’intendere iltermine esistenzialismo. In un caso si afferma il primato dell’esistenza, implican-do e salvando le essenze o nature, e come manifestando una suprema vittoria del -l’intelligenza e dell’intelligibilità: questo per me è l’esistenzialismo autentico.Nell’altro caso si afferma il primato dell’esistenza, distruggendo o sopprimendole essenze o nature, e come manifestando una suprema sconfitta dell’intelligenzae dell’intelligibilità: questo è l’esistenzialismo apocrifo; quello stesso di oggi e che“non significa assolutamente più nulla”. Lo credo bene! Poiché sopprimendo l’es-senza, o ciò che l’esse pone, si sopprime nello stesso tempo l’esistenza o l’esse, es-sendo queste due nozioni correlative e inseparabili: un siffatto esistenzialismo sidistrugge da sé1.
Quando Maritain parla dell’esistenzialismo di oggi e cita l’espressione«non significa assolutamente più nulla», si sta riferendo chiaramente a Sar-tre. Nel suo L’esistenzialismo è un umanismo, Sartre, rispondendo alla do-manda su cosa fosse l’esistenzialismo, aveva affermato che, ormai, il termi-ne aveva avuto una tale «risonanza e una tale estensione che non significapiù nulla»20. Ovviamente, sapeva cosa volesse indicare quel termine: unadottrina per cui
18 J. Maritain, Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente, Brescia, Morcelliana, 1, p. .19 Ivi, pp. 10-1. L’occasione non permette di approfondire la questione. Tuttavia, di questo pa-
rere è anche Armando Rigobello (cfr. la voce Esistenzialismo dell’Enciclopedia Filosofica, Bompiani,2011) e, seppur con sfumature diverse, attraverso un linguaggio meno vicino a quello metafisico pu-ramente detto, anche Luigi Pareyson nel suo scritto, apparso nel già citato numero monografico del-l’Archivio di filosofia, dal titolo Possibilità di un esistenzialismo cristiano (pp. 1-; cfr. soprattutto lepp. 3-5).
20 J.P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, Milano, Mursia, 14, p. 30.
74 Antonio Giovanni Pesce
l’uomo non è niente altro che quello che progetta di essere; egli non esiste chenella misura in cui si pone in atto; non è, dunque, niente altro che la somma deisuoi atti, niente altro che la sua vita21.
È lo stesso Sartre a segnalare la distinzione all’interno dell’esistenzia-lismo, tra una corrente cristiana (Jaspers e Marcel) ed una atea, nella quale,oltre che inserire se stesso, inserisce Heidegger. Ora, il progetto heidegge-riano era troppo ampio per essere ristretto così e a buon mercato. Nella suarisposta, il filosofo tedesco prima mette in chiaro che termini come existen-tia ed essentia sono concepiti da Sartre nei termini della metafisica, e il ro-vesciamento di una tesi metafisica è pur sempre una tesi metafisica. Egli,invece, non rovescia, forse neppure va oltre: egli parla di un mondo dimen-ticato e che ha da ritornare22. Per marcare ancor più le distanze, Heideggerchiarisce che l’espressione essere-nel-mondo non richiama a�atto una con-trapposizione tra «mondano» e «spirituale», bensì l’apertura primigenia del-l’uomo all’essere: ecco il suo e-sistere, situarsi in questa apertura23. Tuttavia,come dovremmo interpretare la dottrina secondo cui l’essere sarebbe il«darsi all’aperto unitamente all’aperto stesso»?24 L’essere, ci dice Heidegger,«è come destino del pensiero», ma questo destino è «in sé storico», e infattila sua storia «è già venuta al linguaggio nel dire dei pensatori»25. Ora, vipossono essere diversi di modi di interpretare il pensiero heideggeriano nelsuo complesso, e possiamo pure concederne altrettante a quella parte dellasua speculazione che va sotto il nome di Lehrer. Tuttavia, se non è parago-nabile a quello di Sartre, perché in filosofia i particolari sono più importan-ti di quanto non si sia disposti a credere, certo è ancor più di�cile avvici-narlo a quel tipo di esistenzialismo che vuole che l’essere sia fondato, e fon-dato alla maniera della tradizione metafisica.
Chiediamoci a questo punto: l’esistenzialismo di Sartre e, in parte,quello di Heidegger non sono forse paragonabili ai fiumi di Babilonia – la
21 Ivi, pp. 61-2.22 Cfr. M. Heidegger, Lettera sull’umanismo (1949), in Id., Segnavia, a cura di Franco Volpi,
Milano, Adelphi, 1987, pp. 267-315, da cui si citano le pp. 281-2.23 Cfr. ivi, pp. 301-2.24 Ivi, p. 287.25 Ivi, p. 313-4.
La metafisica di Pascal e il sapere del profondo 75
fluidità per la fluidità, l’essere frutto della prassi, l’esistenza fine a se stessafinché è, poi più nulla? Pascal aveva affrontato il tema sulla scorta di san -t’Agostino. Nel frammento 74 possiamo leggere: «I fiumi di Babiloniascorrono, e precipitano, e trascinano – O santa Sion, dove tutto è stabile edove nulla cade!». Fiumi che, come è stato notato, non hanno mai smessodi «scorrere» nell’immaginario dell’Occidente2. Ma questa riflessione pa-scaliana, che mette in risalto la contraddittorietà di un’esperienza di vitanon fondata, non è forse riflessione genuinamente metafisica?
Étienne Gilson invitava i metafisici a conoscere la storia della filosofiae a conoscerla bene27. Nella storia e solo nella storia possiamo renderci con-to che vi è metafisica e metafisica, e che con un solo termine si voglionodescrivere esperienze affatto diverse. Una metafisica che rimanga all’internodell’esperienza, che non ne mostri la contraddittorietà – i fiumi di Babilo-nia – è una metafisica dell’immanenza, mentre è della trascendenza quellache cerca spiegazioni in un ambito di realtà affatto diverso da quello chevuole fondare2. Non abbiamo motivo di mostrare come quella spinoziananon sia paragonabile a quella di Pascal, ma non vi è dubbio che, se ancheall’interno del secondo tipo di metafisiche, non facciamo le dovute distin-zioni, non sarebbe mai chiaro perché nel genio di Clermont-Ferrand c’è davedersi una spiccata attitudine metafisica.
Vi è una linea di pensiero che infine ha ceduto all’astrattismo, e che sireggeva su una visione univoca dell’essere. Secondo Suarez «bisogna direche il concetto formale proprio e adeguato dell’ente come tale, è uno»2.Ora, la metafisica che giunge a Kant è quella di derivazione suareziana, gra-zie a Christian Wolff. Non aveva tutti i torti a scrivere, nella prefazione allaseconda edizione della Critica della ragion pura:
Alla metafisica, conoscenza speculativa razionale, affatto isolata, che si eleva as-solutamente al di sopra degli insegnamenti dell’esperienza, e mediante sempli-
26 Cfr. Ph. Sellier, Pascal e Port-Royal, cit., p. 3.27 Cfr. É. Gilson, Realismo tomista e critica della conoscenza, introduzione di M. Borghesi, Ro-
ma, Studium, 2012, pp. 10-10.28 Cfr. E. Berti, Introduzione alla metafisica, Torino, Utet, 2004, pp. 1-.29 F. Suarez, Disputazioni Metafisiche, II.1., introduzione, traduzione e note di Costantino
Esposito, testo latino a fronte, Milano, Rusconi, 1, p. 321.
7 Antonio Giovanni Pesce
ci concetti… non è sinora toccata la fortuna di potersi avviare per la via sicuradella scienza30.
Tralasciando cosa intenda Kant per scienza, e tralasciando che, infine,egli sia ricaduto in un altro astrattismo, non c’è dubbio che il suo critici-smo cogliesse in parte l’obiettivo, perché attaccava una metafisica – «affattoisolata», «assolutamente al di sopra degli insegnamenti dell’esperienza» –chiusa tra le anguste pareti del logicismo. Contro questa metafisica avràsempre le sue ragioni da opporre il kantismo e ogni filosofia che aspiri aduna sana apertura alla realtà concreta. Dunque, se la metafisica fosse soloquesta – una ragione che coglie, logicamente, l’essere – allora Pascal è sicu-ramente il più fine e accanito degli antimetafisici.
Ma la metafisica non è solo questa. È quell’inclinazione naturale del-l’uomo, a cui anche Kant ha dovuto infine dare ragione. Perché è natu-rale? Perché è una capacità umana quella di sentire intimamente che i con-ti, infine, non tornano, e di cercarne una spiegazione; perché è dell’uomonella sua concreta vita, fatta di affetti aspirazioni e sentimenti, e non giàdi un mero soggetto epistemologico, capire che l’esistenza, infine, rischialo scacco; che l’esperienza, per quanto riccamente concepita, non potrà ba-stare a giustificarsi31. C’è un momento in cui le tenebre dell’insensatez-za sembrano calare la loro spessa coltre sul nostro vissuto. È il venerdì san-to che ogni uomo affronta prima o poi, quando pare che tutto sia perso edogni cosa sia stata una vana illusione. Davanti a questo, gli uomini han-no cercato un senso ad una realtà ricchissima, ciascuno nel tempo chegli era proprio e con sensibilità diverse. Lo hanno cercato partendo da-gli enti che affollano il mondo, e sapendo che la via si snodava tra dueestremi:
30 I. Kant, Critica della ragion pura, trad. it. di G. Gentile e G. Lombardo Radice e rivedutada V. Mathieu, Roma-Bari, Laterza, 1, p. 1.
31 «Il metodo della metafisica include sempre un momento trascendentale, in quanto è un ol-trepassamento radicale dell’esperienza. Però presuppone un momento di attenta e accurata letturae osservazione dei fenomeni, accompagnato a sua volta dal momento della riflessione. È la riflessio-ne che ci rivela che questo mondo non è tutto e che allo stesso tempo non può essere sorretto danulla. Il fenomeno va trasceso per essere compreso». B. Mondin, Ontologia Metafisica, vol. 3 del Ma-nuale di filosofia sistematica, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1, p. 133.
La metafisica di Pascal e il sapere del profondo 77
La notizia dell’esserci di una totalità dell’essere di là dall’esperienza storico-empi-rica, per un verso, e la natura indisponibile, per l’uomo, della totalità medesima,ossia l’impossibilità per l’uomo di metter le mani sull’Intero del senso32.
Se la metafisica è così intesa, non vi è dubbio che Pascal ne rappresentiuno sviluppo importante. Jean Mesnard ce lo indica chiaramente. Non eranelle sue intenzioni forse, ma la minuziosa ricostruzione che egli fa delloschema di Apologia concepito da Pascal33, conduce inequivocabilmente aquesto sbocco. In quella che, mutatis mutandis, può essere definita la Sum-ma contra Gentiles della modernità, Pascal non teme una disanima perfinocruda delle vicende esistenziali dell’uomo. Non c’è da dubitare che i con-temporanei vi si potessero rispecchiare perfettamente, e che tra quelle righese ne possano leggere i turbamenti. La capacità di Pascal di rinnovare il lin-guaggio della metafisica non dovrebbe essergli ascritta a colpa, ma dovreb-be apparire come motivo di vanto. La metafisica non è un arzigogolo lin-guistico, che deve creare un mondo artificiale per quelle che vengono defi-nite le «classi parlanti», per gli intellettuali sempre attenti alle mode di pen-siero. Non è sistema geometricamente eretto, museo dentro il quale espor-re brani di vita sottratti alla realtà. E la metafisica non è solo disciplina delpensiero, ma anche passione del pensare: tutto inizia così, perché innamo-rati della vita si vuole rispondere alle domande che essa pone.
Non troviamo nell’opera pascaliana la centralità di espressioni come«essere», «essenza», «esistenza», ecc., usati nel senso della metafisica tradi-zionale, ma proprio in ciò sta la portata della sua operazione: una riconqui-sta al pensiero di quel reale soggetto che è l’uomo. Una polemica che or-mai non ha più ragione di continuare, quella tra essere e pensiero, tra ilmondo e l’interiorità: noi non siamo senza l’essere, il nostro pensiero nonè pensabile senza un suo spazio riempito dalla presenza dell’essere, così co-me non tutto ciò che è, è cosciente di essere. Il realismo o l’idealismo sonodottrine di uomini, non di cose, e sapere se il mondo è e come è, è questio-ne di cui vale la vita dell’uomo, non quella delle cose – gli abissi siderali
32 C. Vigna, Il frammento e l’Intero. Indagini sul senso dell’essere e sulla stabilità del sapere, Mi-lano, Vita e Pensiero, 2000, p. XXV.
33 Cfr. J. Mesnard, Sui “Pensieri” di Pascal, a cura di Maria Vita Romeo, Brescia, Morcelliana,2011, p. 51.
7 Antonio Giovanni Pesce
non si curano non solo di noi, non si curano neppure di se stessi. Semmai,il pensiero è il palcoscenico su cui l’essere rappresenta se stesso. Siamo an-che noi, come una canna battuta dal vento – ma questa canna pensa!
Una metafisica dal volto umano, insomma34.
Metafisica della prudenza
La coerenza di fondo del pensiero pascaliano è in una visione antropo-logica dunque, la cui dimenticanza scatena la bestia che può celarsi in ogniuomo. Già e non ancora: non bestia e non angelo, non solo luce né soloombra, ma chiaroscuro. La teoria dei tre ordini non avrebbe potuto essereconcepita, se Pascal non avesse avuto un’ispirazione metafisica. Non è unadottrina politica, non è una teoria gnoseologica, non è neppure una pro-fessione soteriologica: si tratta dell’espressione di un metodo elementarenella conduzione dei tre aspetti fondamentali di ciò che, per millenni, ab-biamo pensato col concetto di uomo. Soprattutto, la teoria dei tre ordini èlo stupendo ritrovato del buon senso comune, merce rara sulla bilancia dellastoria – ancor più negli anni in cui venne formulata – eppure apparente-mente così diffusa sulla bancarella del vissuto individuale.
La politica, la più architettonica tra le discipline della praxis, non è unascienza e non è neppure una fede: ieri come oggi, queste parole premuni-scono da attacchi di isterismo collettivo, con élite convinte di poter dise-gnare la città del domani con la sicurezza di un dio, o folle pervase da quel-le passioni collettive che il Novecento ha compiutamente sperimentato(non è necessario scomodare il cristianesimo, l’islamismo, l’induismo,ecc.). La scienza non deve piegare, ma neppure piegarsi alla politica o allafede. E la fede, in ultima istanza, non abbisogna di prove scientifiche o delpotere politico per dire qualcosa al cuore dell’uomo.
Senza questa ispirazione metafisica, Pascal non avrebbe potuto essere lapietra d’inciampo – insieme a Vico – di ogni ricostruzione meramente ra-
34 Il richiamo non è solo al realismo dal volto umano di H. Putnam, ma anche a L. Stefanini,Metafisica della persona, Padova, Editoria Liviana, 150, pp. 3-25, e C. Vigna, Il frammento e l’Intero,cit., pp. XIII-XX. Potremmo ancora continuare citando G. Bontadini, V. La Via e G. Gentile.
La metafisica di Pascal e il sapere del profondo 7
zionalistica della modernità. Giambattista Vico non pensò mai che la storiapotesse ritornare identica a se stessa. Pensò di peggio, però. Pensò, comePascal, che si può essere bestioni per eccesso di pulsioni, ma anche per ec-cesso di ragioni – «le malnate sottigliezze degl’ingegni maliziosi»35. È la co-siddetta barbarie della riflessione, ben diversa da quella del senso, che
scuopriva una fierezza generosa, dalla quale altri poteva difendersi o campare oguardarsi; ma questa [la barbarie della riflessione], con una fierezza vile, dentro lelusinghe e gli abbracci, insidia alla vita e alla fortune de’ suoi confidenti ed amici3.
Soprattutto, Vico deludeva il giusnaturalismo e il contrattualismo, figlientrambi di questo razionalismo che pianifica società nella convinzione dipoter controllare tutti gli esiti delle azioni, e lasciava una inascoltata paginadi metodologia in filosofia della storia, quando, ancor con buon senso con-dito da un pizzico di sano realismo, scriveva che il mondo della storia è sìstato fatto dagli uomini, ma esso è «uscito da una mente speso diversa edalle volte tutta contraria e sempre superiore ad essi fini particolari ch’essiuomini si avevan proposti»37.
Prima di passare all’aspetto della fede, mi sia concessa una forzatura inchiave storica della teoria dei tre ordini. Questi tre ordini sono anche i pi-lastri su cui è fondata la nostra civiltà, e i tre aspetti sotto i quali si può de-scriverla abbastanza compiutamente. Siamo la civiltà che non si è limitataad accettare il potere e i suoi rituali, ma che li ha studiati, circoscritti, co-dificati. Siamo la civiltà in cui, da Solone in poi, è stato posto il problemadelle leggi e di come organizzare meglio la società umana. Siamo la civiltàin cui il sapere dimostrativo – quale che sia il tipo di dimostrazione – haassunto un valore eminente. Siamo la civiltà plasmata lungamente da unareligione che ha «dedivinizzato» il mondo, per usare un’espressione di EricVoegelin3, e che è basata su una follia e uno scandalo: l’idea che Dio hatanto amato il mondo da mandare il suo Figlio Unigenito a morire sulla
35 G. B. Vico, Scienza nuova secondo l’edizione del 1744, § 110. Il testo seguito è quello curatoda Fausto Nicolini per la Ricciardi, 153, in Opere, pp. 35-05, da cui si citano pp. -7.
36 Ivi.37 Ivi, § 110, p. .38 Cfr. E. Voegelin, La nuova scienza politica, Bologna, Borla, 1, pp. 134 e 143.
0 Antonio Giovanni Pesce
croce per i nostri peccati. Diritto, filosofia e cristianesimo sono il nostroorizzonte storico. Sono questi pilastri che Pascal vide tremare in un secoloche ha sperimentato la prima vera mattanza europea: la guerra dei trent’an-ni. Sono questi pilastri che la generazioni di Mounier vide traballare da-vanti all’altra «grande guerra di trent’anni» – quella iniziata a metà deglianni dieci del Novecento e conclusasi a metà degli anni Quaranta. Sonoquesti pilastri che, ancora una volta, vediamo traballare.
Infine, la fede. Qui, sappiamo di toccare il nerbo di ogni altra discus-sione che si possa fare su Pascal. Tutto è importante per capire il genio diClermont-Ferrand, e nulla è stato tralasciato in letteratura. Ma su questopunto noi incontriamo non un talento che egli fece fruttare – ne fece frut-tare tanti – ma l’intimità stessa della sua anima, la roccia della sua esisten-za. Sono partito dall’esistenzialismo per dimostrare che in Pascal c’è una fi-losofia dell’esistenza che è genuinamente metafisica, e metafisica della qua-lità migliore. Ho cercato di mostrare come la teoria dei tre ordini, lungi dalmettere in crisi questa lettura, la corrobori, a meno che per metafisica nonsi intenda la deduzione logica di alcuni principi, la creazione di un sistemamore geometrico. A questo punto, sembra che sia l’esperienza della fede asmentire questa lettura. Il Dio di carità, che ama tanto la creatura da nonvolerla perdere, e per non perderla si incarna nella persona del Figlio e siumilia fino alla morte e ad una morte di croce – questo Dio come può es-sere coniugato col Dio dei filosofi? Qui, ancora una volta, vi è una confu-sione di fondo. Si confonde l’Assoluto, come può essere pensato in meta-fisiche di stampo immanentistico, con quell’Assoluto che è vertice di queltipo di metafisica, a cui credo Pascal debba essere annoverato. Quest’ulti-ma metafisica non ci dice tutto su tutto: è più umile. Ci può dire molto,certo, ma solo all’interno del proprio ordine. La metafisica, quando è ret-tamente intesa, deve partire dall’esperienza e, dopo aver mostrato la con-traddittorietà di questa, sciogliere il nodo che l’avviluppa, cioè il fatto chenon è fondata e attende sempre una giustificazione più radicale. La meta-fisica ci mostra così l’Esse ipsum subsistens, l’essere sussistente per sé. Può,ancora, dimostrare che questo essere deve avere alcune caratteristiche, qualiper esempio la personalità. Può, insomma, dirci che esiste e alcune moda-lità strettamente connesse all’esistenza. Non può dirci, però, chi è questoDio, né farci conoscere il progetto che Egli ha per noi. Non ci può parlare
La metafisica di Pascal e il sapere del profondo 1
di quel Dio che, nei momenti di sconforto, anche chi non crede vorrebbeche esistesse. So che Gianni Vattimo non crede che lo scacco possa con-durre alla fede3, e so anche che molti vorrebbero una fede così pura, danon aver bisogno di alcun travaglio: una illuminazione repentina, senza al-cun conflitto d’interesse. Purtroppo, per molti la fede arriva quando la cor-tina delle illusioni che li separava da essa cede e cede di schianto. Per la psi-cologia lo sconforto ha lo stesso valore di una confutazione in metafisica.E a volte non è confutato un argomento, ma un’intera vita. La metafisicaci parla dell’esistenza di un Essere supremo, non dell’essenza di un Dio checi ama. La teoria dei tre ordini, in questo caso, mostra perfettamente ilproprio funzionamento.
Mi piace concludere con le parole di un profondo conoscitore di Pa-scal, qual è Philippe Sellier:
Pur avendo beneficiato di un ambiente familiare o sociale favorevole, arriva ilmomento in cui dobbiamo confermare, grazie ad un’esperienza personale di Dio,la visione del mondo che ci è stata proposta. Chiunque abbia vissuto un tale in-contro non lo dimentica tanto presto, e non si lascia trascinare dai venti dellamoda. Direttamente ammaestrato da Dio, il vero cristiano – pur restando sotto-messo alla Chiesa – gode di una sovrana libertà rispetto agli eventuali eccessi del-l’istituzione. Un siffatto credente non è roso dal dubbio. […] Una tale sicurezzanon esclude affatto le vertigini dinanzi alla dismisura sconcertante dell’universo,all’immensità del tempo dell’evoluzione, all’enigma del male. Ma le vertigini nonsono il dubbio40.
Non c’è altro da giungere. L’amore, sovrano nell’ordine della carità, èil dialogo incessante in cui le anime, pur restando ognuna se stessa, ciascu-na si fa l’altra. Dio si è fatto come noi per farci come lui. Qui, c’è solo daammettere di aver incontrato quella Persona o di non averla incontrata.Nient’altro.
39 Cfr. G. Vattimo, Credere di credere, Milano, Garzanti, 1, pp. 102-3.40 Ph. Sellier, Pascal e Port-Royal, cit., p. 34.
2 Antonio Giovanni Pesce