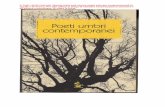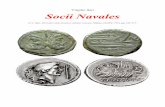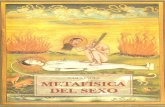Metafisica. Classici contemporanei
Transcript of Metafisica. Classici contemporanei
© 2008, Gius. Laterza & Figli
Prima edizione 2008
Achille C. Varzi
Editori Laterza
MetafisicaClassici contemporanei
Testi diArmstrong, Black, Carnap,Chisholm, Davidson, Ducasse,Dummett, Evans, Geach, Kripke,Lewis, Lowe, Mellor, Moore,Putnam, Quine, Russell, Ryle,Sellars, Sider, Stalnaker, Strawson, Wiggins, Williams
Introduzione
Da sempre uno dei settori principali della filosofia, la metafisica èoggi al centro di un rinnovato e accresciuto interesse. Soprattuttonell’ambito della cosiddetta filosofia analitica, ma non solo, gli ulti-mi anni hanno registrato un’impressionante progressione nel nu-mero di studi e ricerche dedicati ai temi classici di questo settore, edopo la «svolta linguistica» del primo Novecento e la «svolta co-gnitiva» degli ultimi decenni, il nuovo secolo sembra essere decol-lato all’insegna di un’enfatica e per certi aspetti inattesa «svolta me-tafisica».
Non si tratta, tuttavia, di una vera e propria svolta, se con ciò s’in-tende un cambiamento di rotta o una ridefinizione delle coordinate.È vero che la moderna filosofia analitica nacque in esplicita con-trapposizione alla metafisica che dominava la scena filosofica delvecchio continente: in un’Europa tutta assorta nell’impresa di ri-spondere a Kant attraverso macchinose riletture di Hegel, GeorgeEdward Moore non esitava ad accusare di miopia ogni metafisicache pretendesse di fornire «una comoda via d’uscita dalle difficoltàche ostacolano il cammino dell’indagine accurata» [1898, p. 186];Bertrand Russell scriveva che i problemi dei metafisici sono figli del-la «cattiva grammatica» [1918-19, p. 229]; e Rudolf Carnap giunsea proclamare che la metafisica consiste di «pseudoproposizioni» pri-ve di senso [1932, p. 505]. Più che un rifiuto della disciplina nel suoinsieme, tuttavia, queste dichiarazioni costituivano un attacco a uncerto modo di fare metafisica, improntato all’uso di parole opulenti(«l’assoluto», «l’idea») e costrutti oscuri («il nulla nulleggia») piut-tosto che alla trasparenza semantica e al rigore argomentativo. Ri-spetto ad altri campi di indagine filosofica, come la logica e la filo-sofia morale, la metafisica ereditata dall’Ottocento era molto distan-te dagli standard di accuratezza che si andavano imponendo ed era
Proprietà letteraria riservataGius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Finito di stampare nel gennaio 2008SEDIT - Bari (Italy)per conto della Gius. Laterza & Figli SpaISBN 978-88-420-8382-5
È vietata la riproduzione, ancheparziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.
Per la legge italiana la fotocopia èlecita solo per uso personale purché non danneggi l’autore. Quindi ogni
fotocopia che eviti l’acquisto di un libro è illecita e minaccia
la sopravvivenza di un modo di trasmettere la conoscenza.
Chi fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare,chi comunque favorisce questa pratica
commette un furto e opera ai danni della cultura.
duttivo e da una scheda di approfondimento bibliografico. Natural-mente è difficile dare un quadro completo. L’omissione principale ri-guarda il dibattito sul libero arbitrio, sul quale però è già disponibi-le in italiano un’ottima raccolta di testi curata da Mario De Caro[2002] (seguito dalla dettagliata monografia introduttiva dello stes-so De Caro [2004]). Un altro tema non trattato esplicitamente è la fi-losofia del tempo (per la quale si rimanda a Dorato [1997]), così co-me non sono affrontati i temi a cavallo tra metafisica e filosofia dellareligione (Hughes [2005]), filosofia della società (Di Lucia [2003]) ofilosofia della matematica (Piazza [2000], Lolli [2002]). Ci auguria-mo che entro questi limiti il volume possa comunque contribuire acolmare una lacuna che si è fatta profonda, e a stimolare anche in Ita-lia la ripresa di un confronto costruttivo in questo capitolo così im-portante della filosofia.
Ringraziamenti
Un doppio grazie ad Andrea Borghini, Luca Morena e Daniele Santoro,non solo per le traduzioni di cui si sono fatti carico, ma anche per le uti-li discussioni sull’impianto generale del volume. E grazie a Guido Boni-no, Massimiliano Carrara, Elena Casetta, Franca D’Agostini, StefanoGattei, Roberta Lanfredini, Roberto Miraglia, Marco Santambrogio eGiuliano Torrengo per il loro aiuto nella verifica di alcune citazioni e deidati relativi alle traduzioni italiane di alcuni titoli riportati in bibliografia.
naturale che divenisse il bersaglio di polemiche esemplari. (SecondoBryan Magee [1999, p. 74], Karl Popper affermò addirittura di averpreso Russell come modello di stile filosofico allo stesso modo in cuiSchopenhauer aveva adottato Hume: «non soltanto per chiarezza,ma per una questione di etica professionale».) Ciò non toglie che sulpiano dei contenuti non vi fu mai un completo divorzio di interessirispetto alla tradizione. E dopo una prima fase consacrata principal-mente alla critica e all’affinamento del metodo, si può dire che an-che i promotori più convinti della rivoluzione analitica non abbianomai trascurato di confrontarsi con quesiti che rientrano a pieno ti-tolo nel campo d’indagine di quella metafisica che il dibattito odier-no ripropone con crescente passione: il nesso tra esistenza e verità,le condizioni di identità e di persistenza delle cose che ci circonda-no (e di noi stessi), il senso della possibilità, la natura delle proprietà,il fondamento delle relazioni causa-effetto.
Il presente volume si propone di mettere a disposizione del let-tore italiano i testi più significativi e influenti di questa produzionefilosofica, tanto feconda quanto poco valorizzata in quei contesti cul-turali, come il nostro, dove la metafisica ha seguito percorsi diversie dove la filosofia di orientamento analitico ha per lungo tempo pri-vilegiato altre tematiche. In parte si tratta di rileggere proprio gli au-tori più classici, come gli stessi Moore, Russell e Carnap, ma ancheGilbert Ryle, Max Black, Willard Van Orman Quine, Peter Straw-son, Donald Davidson, Michael Dummett, Hilary Putnam, SaulKripke e Gareth Evans: autori che il lettore italiano conosce princi-palmente per il loro fondamentale apporto alla logica, alla filosofiadel linguaggio e alla filosofia della mente del ventesimo secolo, mache hanno altresì firmato pagine di enorme importanza per lo svi-luppo della nuova metafisica analitica. A questi testi si affiancanoperò anche quelli di altri filosofi che, pur occupando una posizionedi pari rilievo nella letteratura contemporanea, sono ancora relativa-mente poco noti in Italia, come Curt Ducasse, Donald Williams, Ro-derick Chisholm, Wilfrid Sellars, Peter Geach, David Wiggins, Da-vid Armstrong e David Lewis, nonché autori ancora più recenti etuttora in prima linea nel dibattito filosofico come Robert Stalnaker,David Mellor, Jonathan Lowe e Theodore Sider.
I testi, molti dei quali tradotti qui per la prima volta, sono orga-nizzati in sei sezioni, corrispondenti alle principali tematiche citatesopra: l’esistenza, l’identità, la persistenza, la modalità, le proprietà,la causalità. Ciascuna sezione è corredata da un breve saggio intro-
VI
duttivo e da una scheda di approfondimento bibliografico. Natural-mente è difficile dare un quadro completo. L’omissione principale ri-guarda il dibattito sul libero arbitrio, sul quale però è già disponibi-le in italiano un’ottima raccolta di testi curata da Mario De Caro[2002] (seguito dalla dettagliata monografia introduttiva dello stes-so De Caro [2004]). Un altro tema non trattato esplicitamente è la fi-losofia del tempo (per la quale si rimanda a Dorato [1997]), così co-me non sono affrontati i temi a cavallo tra metafisica e filosofia dellareligione (Hughes [2005]), filosofia della società (Di Lucia [2003]) ofilosofia della matematica (Piazza [2000], Lolli [2002]). Ci auguria-mo che entro questi limiti il volume possa comunque contribuire acolmare una lacuna che si è fatta profonda, e a stimolare anche in Ita-lia la ripresa di un confronto costruttivo in questo capitolo così im-portante della filosofia.
Ringraziamenti
Un doppio grazie ad Andrea Borghini, Luca Morena e Daniele Santoro,non solo per le traduzioni di cui si sono fatti carico, ma anche per le uti-li discussioni sull’impianto generale del volume. E grazie a Guido Boni-no, Massimiliano Carrara, Elena Casetta, Franca D’Agostini, StefanoGattei, Roberta Lanfredini, Roberto Miraglia, Marco Santambrogio eGiuliano Torrengo per il loro aiuto nella verifica di alcune citazioni e deidati relativi alle traduzioni italiane di alcuni titoli riportati in bibliografia.
naturale che divenisse il bersaglio di polemiche esemplari. (SecondoBryan Magee [1999, p. 74], Karl Popper affermò addirittura di averpreso Russell come modello di stile filosofico allo stesso modo in cuiSchopenhauer aveva adottato Hume: «non soltanto per chiarezza,ma per una questione di etica professionale».) Ciò non toglie che sulpiano dei contenuti non vi fu mai un completo divorzio di interessirispetto alla tradizione. E dopo una prima fase consacrata principal-mente alla critica e all’affinamento del metodo, si può dire che an-che i promotori più convinti della rivoluzione analitica non abbianomai trascurato di confrontarsi con quesiti che rientrano a pieno ti-tolo nel campo d’indagine di quella metafisica che il dibattito odier-no ripropone con crescente passione: il nesso tra esistenza e verità,le condizioni di identità e di persistenza delle cose che ci circonda-no (e di noi stessi), il senso della possibilità, la natura delle proprietà,il fondamento delle relazioni causa-effetto.
Il presente volume si propone di mettere a disposizione del let-tore italiano i testi più significativi e influenti di questa produzionefilosofica, tanto feconda quanto poco valorizzata in quei contesti cul-turali, come il nostro, dove la metafisica ha seguito percorsi diversie dove la filosofia di orientamento analitico ha per lungo tempo pri-vilegiato altre tematiche. In parte si tratta di rileggere proprio gli au-tori più classici, come gli stessi Moore, Russell e Carnap, ma ancheGilbert Ryle, Max Black, Willard Van Orman Quine, Peter Straw-son, Donald Davidson, Michael Dummett, Hilary Putnam, SaulKripke e Gareth Evans: autori che il lettore italiano conosce princi-palmente per il loro fondamentale apporto alla logica, alla filosofiadel linguaggio e alla filosofia della mente del ventesimo secolo, mache hanno altresì firmato pagine di enorme importanza per lo svi-luppo della nuova metafisica analitica. A questi testi si affiancanoperò anche quelli di altri filosofi che, pur occupando una posizionedi pari rilievo nella letteratura contemporanea, sono ancora relativa-mente poco noti in Italia, come Curt Ducasse, Donald Williams, Ro-derick Chisholm, Wilfrid Sellars, Peter Geach, David Wiggins, Da-vid Armstrong e David Lewis, nonché autori ancora più recenti etuttora in prima linea nel dibattito filosofico come Robert Stalnaker,David Mellor, Jonathan Lowe e Theodore Sider.
I testi, molti dei quali tradotti qui per la prima volta, sono orga-nizzati in sei sezioni, corrispondenti alle principali tematiche citatesopra: l’esistenza, l’identità, la persistenza, la modalità, le proprietà,la causalità. Ciascuna sezione è corredata da un breve saggio intro-
VI
Avvertenze
1. Nella traduzione di alcuni testi, così come nella ristampa dei sag-gi già disponibili in italiano, si sono effettuati lievi interventi di ca-rattere editoriale tesi a favorire l’omogeneità complessiva del volu-me. In particolare:
(i) Tutte le note sono riportate a piè pagina e numerate progres-sivamente (nell’ambito di ciascun saggio) anche quando l’originaleutilizza un sistema di numerazione diverso. Eventuali note del cura-tore o del traduttore, contrassegnate rispettivamente dalle dicitureN.d.C. e N.d.T. e racchiuse tra parentesi quadre, sono numerate se-guendo il medesimo ordine.
(ii) I riferimenti bibliografici, con l’eccezione dei classici della fi-losofia, sono stati uniformati e abbreviati secondo lo schema Auto-re [anno] (come già nell’Introduzione) e rinviano alla bibliografia cu-mulativa al termine del volume. Tali riferimenti sono sempre dati innota anche quando nell’originale si trovano incorporati nel testoprincipale. Ove un testo citato fosse disponibile in traduzione italia-na, eventuali indicazioni di pagina sono da intendersi riferite a que-st’ultima (nell’edizione indicata in bibliografia).
(iii) La numerazione dei paragrafi, delle formule, delle definizio-ni e di eventuali altri elementi è stata uniformata e, in certi casi, sem-plificata (per esempio dove nell’originale rinvia a elementi di testonon inclusi nella traduzione, come nel caso di sezioni o capitoli trat-ti da un libro).
(iv) La notazione logica, peraltro limitata a poche occasioni, è sta-ta uniformata come segue: per i connettivi di negazione, congiun-zione, disgiunzione, condizionale e bicondizionale si sono usati ri-spettivamente i simboli «~», «», «», «» e «»; per i quantifi-catori universale ed esistenziale si sono usati i simboli «» e «»; lapunteggiatura è stata sostituita da parentesi. Ogni altra simbologia èspiegata nel testo o in nota.
IX
evitare ambiguità col significato italiano di occorrere nel senso di ser-vire o bisognare, quando il soggetto è un’azione, un evento o un pro-cesso si è generalmente preferito tradurre con accadere e simili (unconto è dire che occorre un certo evento, altro conto dire che l’even-to accade, avviene, succede, ha luogo, si verifica).
(v) Sign design. Sellars (saggio 5.3) usa questo termine per rife-rirsi al particolare materiale linguistico – grafico o sonoro – nel qua-le una certa espressione si può concretizzare o «incarnare» nell’am-bito di una qualsiasi lingua storicamente data. Quest’uso dipendedalla particolare nozione di espressione con cui lavora Sellars e nontrova riscontro nella comune terminologia semiotica. Lo si è reso initaliano con tratto segnico. Il termine più specifico script design è sta-to tradotto con tratto grafico.
(vi) Truth-maker. Quest’espressione, tipica di Armstrong (saggio4.5), è entrata nell’uso corrente per riferirsi a ciò che «rende vera»una certa asserzione o una certa teoria: la si è tradotta con fattore diverità, soluzione che seppure con qualche difficoltà sembra ormaiessersi imposta anche in italiano (cfr. Caputo [2006]).
(vii) Instant e moment. Questi termini sono stati considerati si-nonimi e tradotti indifferentemente, a seconda del contesto, conistante o momento.
(viii) Thing e object. Anche questi termini sono stati generalmen-te trattati come sinonimi, salvo in quei contesti che richiedono unadistinzione esplicita tra cosa (in senso generico) e oggetto (nel sensopiù specifico di oggetto materiale).
(ix) Segnaliamo infine le seguenti corrispondenze: adhesion (rife-rito alle parti di un oggetto) connessione; fission (contrapposto afusion) scissione (contrapposto a fusione); instantiate e instance esemplificare ed esemplificazione, o esempio (di un universale da par-te di un particolare); preemption esclusione (di una causa poten-ziale); role/office common noun nome comune di ruolo/funzione;something/nothing over and above qualcosa/nulla in più di (o ri-spetto a); stage stadio o fase (temporale); statement (contrappostoa sentence) asserzione, asserto (contrapposto a enunciato, intesocome espressione linguistica con cui si può fare un’asserzione); sum-mative/collective/integrate individual individuo sommativo/collet-tivo/integrale; world-story mondo-storia.
XI
2. Buona parte dei testi tradotti fa uso di una terminologia chenella letteratura in lingua inglese è ormai entrata nell’uso corrente,ma che non trova ancora un chiaro riscontro in italiano. Riportiamoqui di seguito le espressioni principali la cui traduzione ha richiestoscelte o convenzioni non del tutto ovvie.
(i) Overlap. Letteralmente il termine significa sovrapporsi, o so-vrapposizione, che in inglese ammettono sia una lettura spaziale (dueentità in uno stesso luogo) sia una lettura mereologica (due entitàcon una o più parti in comune). In italiano la lettura spaziale tendea prendere il sopravvento, sicché in caso di ambiguità si è preferitorisolvere la lettura mereologica nella locuzione esplicita avere partiin comune.
(ii) Endure e perdure (e derivati). In inglese questi verbi sono ge-neralmente usati in modo sinonimo, con il significato di durare (neltempo). Tuttavia, a partire da Lewis (saggio 3.4) sono entrambi en-trati nel gergo filosofico con un significato ben preciso, indicandodue sensi diversi in cui si può dire che gli oggetti durano nel tempo:in quanto entità tridimensionali che continuano a esistere nella lorointerezza o in quanto entità quadridimensionali che consistono diparti temporali successive. Nella traduzione si è cercato di mantene-re la distinzione adottando rispettivamente i termini permanere eperdurare, da intendersi in senso egualmente tecnico (in ciò ci di-scostiamo da Runggaldier e Kanzian [1998], dove il primo termineè tradotto con il neologismo endurare, e ci atteniamo a Varzi[2001a]). Tuttavia, nei testi anteriori alla pubblicazione di Lewis, co-me quelli di Chisholm (3.1) e di Williams (5.2), endure è stato tra-dotto in modo più neutrale con durare.
(iii) Cause e bring about. Entrambi i verbi possono essere usati ininglese con il significato di causare. In certi contesti, tuttavia, spe-cialmente nei saggi 6.3-6.6, il secondo verbo è stato tradotto in mo-do più neutrale con provocare, determinare, far accadere (un evento)o compiere (un’azione), onde evitare distorsioni e petizioni di prin-cipio. Si è inoltre deciso di tradurre causation con causalità o con cau-sazione, a seconda che il termine sia usato con riferimento al con-cetto generale di causalità ovvero al nesso che lega una particolarecausa a un particolare effetto.
(iv) Occur. In contesti sintattici è pratica diffusa dire che un sim-bolo, una parola, ecc. occorre (o ha un certo numero di occorrenze)in una determinata espressione linguistica. Si è scelto però di nonestendere quest’uso del termine a tutti i contesti. In particolare, per
X
evitare ambiguità col significato italiano di occorrere nel senso di ser-vire o bisognare, quando il soggetto è un’azione, un evento o un pro-cesso si è generalmente preferito tradurre con accadere e simili (unconto è dire che occorre un certo evento, altro conto dire che l’even-to accade, avviene, succede, ha luogo, si verifica).
(v) Sign design. Sellars (saggio 5.3) usa questo termine per rife-rirsi al particolare materiale linguistico – grafico o sonoro – nel qua-le una certa espressione si può concretizzare o «incarnare» nell’am-bito di una qualsiasi lingua storicamente data. Quest’uso dipendedalla particolare nozione di espressione con cui lavora Sellars e nontrova riscontro nella comune terminologia semiotica. Lo si è reso initaliano con tratto segnico. Il termine più specifico script design è sta-to tradotto con tratto grafico.
(vi) Truth-maker. Quest’espressione, tipica di Armstrong (saggio4.5), è entrata nell’uso corrente per riferirsi a ciò che «rende vera»una certa asserzione o una certa teoria: la si è tradotta con fattore diverità, soluzione che seppure con qualche difficoltà sembra ormaiessersi imposta anche in italiano (cfr. Caputo [2006]).
(vii) Instant e moment. Questi termini sono stati considerati si-nonimi e tradotti indifferentemente, a seconda del contesto, conistante o momento.
(viii) Thing e object. Anche questi termini sono stati generalmen-te trattati come sinonimi, salvo in quei contesti che richiedono unadistinzione esplicita tra cosa (in senso generico) e oggetto (nel sensopiù specifico di oggetto materiale).
(ix) Segnaliamo infine le seguenti corrispondenze: adhesion (rife-rito alle parti di un oggetto) connessione; fission (contrapposto afusion) scissione (contrapposto a fusione); instantiate e instance esemplificare ed esemplificazione, o esempio (di un universale da par-te di un particolare); preemption esclusione (di una causa poten-ziale); role/office common noun nome comune di ruolo/funzione;something/nothing over and above qualcosa/nulla in più di (o ri-spetto a); stage stadio o fase (temporale); statement (contrappostoa sentence) asserzione, asserto (contrapposto a enunciato, intesocome espressione linguistica con cui si può fare un’asserzione); sum-mative/collective/integrate individual individuo sommativo/collet-tivo/integrale; world-story mondo-storia.
XI
2. Buona parte dei testi tradotti fa uso di una terminologia chenella letteratura in lingua inglese è ormai entrata nell’uso corrente,ma che non trova ancora un chiaro riscontro in italiano. Riportiamoqui di seguito le espressioni principali la cui traduzione ha richiestoscelte o convenzioni non del tutto ovvie.
(i) Overlap. Letteralmente il termine significa sovrapporsi, o so-vrapposizione, che in inglese ammettono sia una lettura spaziale (dueentità in uno stesso luogo) sia una lettura mereologica (due entitàcon una o più parti in comune). In italiano la lettura spaziale tendea prendere il sopravvento, sicché in caso di ambiguità si è preferitorisolvere la lettura mereologica nella locuzione esplicita avere partiin comune.
(ii) Endure e perdure (e derivati). In inglese questi verbi sono ge-neralmente usati in modo sinonimo, con il significato di durare (neltempo). Tuttavia, a partire da Lewis (saggio 3.4) sono entrambi en-trati nel gergo filosofico con un significato ben preciso, indicandodue sensi diversi in cui si può dire che gli oggetti durano nel tempo:in quanto entità tridimensionali che continuano a esistere nella lorointerezza o in quanto entità quadridimensionali che consistono diparti temporali successive. Nella traduzione si è cercato di mantene-re la distinzione adottando rispettivamente i termini permanere eperdurare, da intendersi in senso egualmente tecnico (in ciò ci di-scostiamo da Runggaldier e Kanzian [1998], dove il primo termineè tradotto con il neologismo endurare, e ci atteniamo a Varzi[2001a]). Tuttavia, nei testi anteriori alla pubblicazione di Lewis, co-me quelli di Chisholm (3.1) e di Williams (5.2), endure è stato tra-dotto in modo più neutrale con durare.
(iii) Cause e bring about. Entrambi i verbi possono essere usati ininglese con il significato di causare. In certi contesti, tuttavia, spe-cialmente nei saggi 6.3-6.6, il secondo verbo è stato tradotto in mo-do più neutrale con provocare, determinare, far accadere (un evento)o compiere (un’azione), onde evitare distorsioni e petizioni di prin-cipio. Si è inoltre deciso di tradurre causation con causalità o con cau-sazione, a seconda che il termine sia usato con riferimento al con-cetto generale di causalità ovvero al nesso che lega una particolarecausa a un particolare effetto.
(iv) Occur. In contesti sintattici è pratica diffusa dire che un sim-bolo, una parola, ecc. occorre (o ha un certo numero di occorrenze)in una determinata espressione linguistica. Si è scelto però di nonestendere quest’uso del termine a tutti i contesti. In particolare, per
X
Indice
Introduzione V
Avvertenze IX
Parte primaEsistenza
Nota introduttiva 5Ulteriori letture, p. 7
1.1. Esistere ed «esistere»George Edward Moore,L’esistenza è un predicato? 9
1.2. Esistenza e impegno ontologicoWillard Van Orman Quine, Su ciò che vi è 24
1.3. I modi dell’esistenzaGilbert Ryle, Esistenza ed errori categoriali 43
1.4. Questioni esistenziali interne ed esterneRudolf Carnap, Empirismo, semantica e ontologia 45
1.5. Esistenza e relatività concettualeHilary Putnam, Il realismo interno 65
Parte secondaIdentità
Nota introduttiva 71Ulteriori letture, p. 73
533
Varzi.qxp 28-11-2007 14:25 Pagina 533
2.1. Identità e uguaglianza qualitativaMax Black, L’identità degli indiscernibili 75
2.2. Identità e coincidenza spazio-temporaleDavid Wiggins, Sul trovarsi nello stesso luogo allo stesso tempo 88
2.3. Identità e composizione mereologicaE. Jonathan Lowe, Parti e interi 95
2.4. Il tutto nella somma delle partiDavid Lewis, La composizione come identità 107
2.5. L’identità relativaPeter Thomas Geach, Identità 113
2.6. Identità e indeterminatezzaGareth Evans, Ci possono essere oggetti vaghi? 124
Parte terzaPersistenza
Nota introduttiva 129Ulteriori letture, p. 131
3.1. Persistenza reale e persistenza fittiziaRoderick M. Chisholm, L’identità attraverso il tempo 134
3.2. La prospettiva tridimensionalistaPeter Frederick Strawson, La reidentificazione dei particolari 168
3.3. La prospettiva quadridimensionalistaWillard Van Orman Quine, Identità, ostensione e ipostasi 191
3.4. Il problema degli intrinseci temporaneiDavid Lewis, Contro la sovrapposizione 206
3.5. La prospettiva sequenzialistaTheodore Sider, Il mondo è uno stadio 210
534
Varzi.qxp 28-11-2007 14:25 Pagina 534
Parte quartaModalità
Nota introduttiva 243Ulteriori letture, p. 245
4.1. I guai della necessitàWillard Van Orman Quine, Tre gradi di coinvolgimento modale 247
4.2. La semantica dei mondi possibiliSaul A. Kripke, Identità, necessità, e designazione rigida 269
4.3. Il realismo modaleDavid Lewis, Mondi possibili 282
4.4. La prospettiva attualistaRobert Stalnaker, Mondi possibili 292
4.5. La concezione combinatoriaDavid Malet Armstrong, La natura della possibilità 304
Parte quintaProprietà
Nota introduttiva 329Ulteriori letture, p. 331
5.1. Le proprietà come entità universaliBertrand Russell, Il mondo degli universali 333
5.2. Le proprietà come entità particolariDonald Cary Williams, L’alfabeto dell’essere 340
5.3. Le proprietà come costrutti linguisticiWilfrid Sellars, Le entità astratte 357
5.4. Predicati, proprietà, e leggi di naturaDavid Malet Armstrong, Le proprietà 389
535
Varzi_cambio font.qxp:Varzi 30/01/18 17:03 Pagina 535
Parte sestaCausalità
Nota introduttiva 409Ulteriori letture, p. 411
6.1. La concezione regolaristaBertrand Russell, Leggi causali fisiche e psicologiche 414
6.2. La concezione singolaristaCurt John Ducasse, Sulla natura della relazione causale 418
6.3. La causazione come relazione tra eventiDonald Davidson, Relazioni causali 425
6.4. La causazione tra fattiDavid Hugh Mellor, Cause ed effetti fattuali 441
6.5. L’analisi controfattualeDavid Lewis, La causazione 461
6.6. La freccia del tempoMichael Dummett, Un effetto può precedere la sua causa? 476
Riferimenti bibliografici 493
Indice dei nomi 527
Varzi.qxp 3-12-2007 13:45 Pagina 536