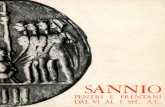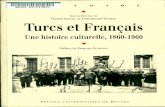Intellettuali tedeschi tra le due guerre (2010)
-
Upload
uni-konstanz -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Intellettuali tedeschi tra le due guerre (2010)
f-{zFll-rlt--FrFIFlFl-1
f-'.{lr{
|-{\J
FJ,anF d .
0l'\ a+-) r . \ /
. Ha
F = 'f . t P
P (t)
o R^1 \J.: l-(- a! ' | d .
^!! n')t t t )- Ä o
HJ. ).z-.^1 /h
\ y
a(+| r .
)\J
z
-
0q
L^l
E :.:
N a i
ä a -o : '2N ; J^ crq
g wv a
F. f r g$ t 6 F 4 ts * : t E oS * X B ä IR E ' : : S O }i E F ; Q Oi Ä Y .s o k I z: Y F * E . [ I ' K X; 5 ' ü S ' F * c A . \ ' I= ' o I F Ä - F6 H s ' s P dF t r r * i '
+ N $ T! E ä E E s S ' 6o € ö ! : * R - g : Fö & K ö ? Hß ä ' g ? Iä o S ? I o X6 ö S & E o: ;-. (Jr '+o F O ) K '
H Fd
A V- H
z
s l l Q R p Y * . t s F s F $ Q P s P FF $ ä $ ä $ ä Ä $ 5 $ + Ä & F S € $F s E ' $ q s P s " R [ $ 3 s ä E S g $S S ä S f ! s S t H
" = q $ a us : s $ E ' ' S s $ H $ i $ E H Ä S Ri $ f { 5 S . N g s r S = , X s
S s H S $ I I * . # s : g I tt $ : s F K - s ö R g P s '
s Ä $ $ $ s € = $ " E yP S S S 3 I * T , E$1$ E S $ E E$ $ E $ F E-$
$ � l ' s ' 2s s s s 'Y ö s = r *R t S " S '$ s ' S^ ' \ $' S. *,;
X@ { \9o0
H
s s ä g s 3 s F $ l E € s Y S g s E S f $ s 9 p s p F = 5 sE$ä stä 3ä $$ä i$E sä $? *[ Ääi E $$g $äB s q R * i$ $ + $ Ä [ $ ä S q ä F s t i E i s n u , ü ? F ; s . EE s E $ ü s $ * i s E t $ ä s s S " $ ; S [ t ä
- E - * €$ S - E € ' $ . $ F p s - * $ s
$ s 1 . $ F s s : 6F. ' -s S YS :E I s . H 2 IR S s S s = s q + $ i A { ' F* * S * s $ s Ä s ä E t R z$ S F . * 1 ä S F e 3 ss " S:' äa s: 7 trr =' 6: S N F s . a f t S
Es \ d - N N g
s F d5
$, N s $ä l 3.
N . F E S .$* $ ä q .
ä r + Nv s .\ä>r.
ü
F$fi E gH F$g $$ .$ä ssr $F+ $$F $F $$s Ess# e xq tsä $F sä $$ä ö$i i l€$ $3 $$* E$$= E $$ $sg Sä s8 $$ä r $u $E ä $ f [$F ss $ E s B * $ - ä ä $ ö s . = s - ; ; $ - $ s + Es s x $ " S S - 3 S " $ ' s s s R . ä S gi€ g $ s-* s $ sF $ r s $i-. 5$$$$$* w $ S s $S s $ t ss EEs 3 Ä $ I s s *
N G r 's s $ ss s $F \ s ' '
k x
ä RFsi
(J(
H
t9o0
P( o { o o e(J9 rrr qt( (o
N9
o0^9 t9(r( ()9( J ( {
N9@O
og Qg(t( Og{
OgA A A(Jr oc( t r { {
A A@ {o e {
(Jr
*J
FI
(A
(+
s e s E s q R v F 3$ä $ [ $E $$5 $s - F s " s ' d R - : F D I < r
s , 6 ' $ F $ g s \ r $ -' t X < s i s ' ä * $ € s .s i $ ä s ä s E s bi t S i s - 5 w
$ i $ s ES F $ $ s; s l 9 G
s Ä * s$ S N RS i s ss sS Ns v
t
\ai
(\t
s
gT|9oo
or(tr{FT
r-;
INTELLETTUALI TEDESCHI TRA LE DUE GUERRE
Gereon Wolters
Il periodo di cui qui mi occupo, comprende 21 anni oppure 30 se includiamo le guerre stesse. Di questi trenta anni circa, quattro fanno ancora parte del secondo Impero; la Repubblica di Weimar durò quattordici anni, mentre il Terzo Reich, vale a dire il presunto Reich “millenario” di Adolf Hitler ebbe una durata di dodici anni. In trent’anni, quindi, si svolsero tre cam-biamenti epocali del sistema politico: si passò dalla monarchia alla democrazia (1918-19), dalla democrazia alla dittatura na-zista (1933), seguita finalmente da un ritorno alla democrazia (dal 1945 in poi).
In periodi di gravi e repentine svolte politiche, le persone hanno, naturalmente, un gran bisogno d’orientamento. Ci si potrebbe aspettare che in tali situazioni scocchi l’ora degli in-tellettuali, almeno se si accetta la definizione di intellettuale che ho in mente, e che per la sua richiesta di razionalità e universalizzazione è normativa; la categoria di intellettuale do-vrebbe comprendere membri di quel non nettamente delimi-tabile gruppo di persone che 1) ha fatto propri orientamenti nel mondo politico, sociale e culturale sorretti dalla ragione, il più possibile liberi da pregiudizi e in tal modo considerati in linea di principio come fallibili, non legati primariamente ai loro propri interessi materiali; 2) che si servono nella critica e nelle proposte di soluzione dei problemi di procedimenti prevalentemente razionali e universalizzabili, cioè rispettosi dei legittimi interessi di tutti gli interessati, e che inoltre 3) sono
ultima.indd 353 26-10-2010 13:59:13
354 gereon wolters
presenti in pubblico con i loro orientamenti, senza tuttavia – di regola – esercitare in senso stretto la politica (partitica)1.
Intellettuali di questo tipo, però, e in numero sufficiente per cambiare il corso della storia, mancarono nella Repubbli-ca di Weimar. Nella dittatura nazista la maggior parte di essi dovettero invece o emigrare in terra straniera, o muoversi per emigrazione interna, oppure furono incarcerati o ammazzati. La mentalità e l’agire degli intellettuali tedeschi di quel pe-riodo furono segnati in misura massiccia dalla Prima guerra mondiale; la nostra percezione e valutazione di essi lo è stata a partire dalla seconda. Questo esprime la solita asimmetria tra le persone che devono agire in una situazione storica senza conoscere il futuro, cioè le conseguenze del loro agire, e lo sto-rico che si trova nella situazione comoda di sapere com’è finita la storia. Un’asimmetria insuperabile, che dovrebbe renderci cauti nei giudizi, soprattutto quelli morali. Nessuno di noi sa come si sarebbe comportato allora. Le mie supposizioni al ri-guardo non sono molto ottimistiche.
La mia tesi è che i parametri politici principali della Wel-tanschauung degli intellettuali tedeschi rimasero in sostanza inalterati nel passaggio dall’Impero alla Repubblica di Weimar. Neanche nel transito dalla Repubblica alla dittatura nazista tali parametri cambiarono, anche se furono radicalizzati in modo notevole, per non dire brutale. Solo la sconfitta totale della Germania nella Seconda guerra mondiale portò con sé un cambiamento profondo dei vecchi parametri. Il fallimento degli intellettuali della Repubblica di Weimar si può spiegare a partire da parametri di una mentalità antimodernistica, pro-fondamente radicata nella società, nella psicologia collettiva e nella cultura, risalenti a molto tempo prima, che si rispec-chiano nell’uso del termine “intellettuali” e a partire dalle con-seguenze dell’umiliazione della Germania nel trattato di pace di versailles.
Nella Repubblica di Weimar non poteva affermarsi l’acce-zione neutrale o positiva della parola “intellettuale”, perché persistevano nella stragrande maggioranza degli intellettuali,
1 Traduzione dal tedesco di G. Gregorio, rivista da F. Chiarotto. Per un utile resoconto storico, cfr. A. Asor-Rosa, “Intellettuali”, Enciclopedia, vol. 7, Einaudi, Torino 1979, pp. 801-27.
ultima.indd 354 26-10-2010 13:59:13
intellettuali tedeschi tra le due guerre 355
i vecchi parametri di mentalità. Si polarizzarono ai due estre-mi “destro” o “sinistro”, in certa misura fondamentalisti, dello spettro politico. Detto altrimenti e più concisamente: gli in-tellettuali della Repubblica di Weimar hanno fallito politica-mente, e ciò non solo rispetto alle implicazioni normative del termine. Nella Germania nazista rimase solo una parte degli intellettuali di destra, che si radicalizzò sempre di più. Il re-sto degli intellettuali di destra procedette verso l’“emigrazio-ne interna”, dove poteva già incontrare i colleghi di sinistra e i moderati. Solo la sconfitta totale della Germania nel 1945 portò a un cambiamento profondo della Weltanschauung degli intellettuali tedeschi.
1. Il Sonderweg 2 degli intellettuali tedeschi finisce a Versailles
La Repubblica di Weimar si costituì il 6 febbraio 1919. In quel momento non piovvero dal cielo nuovi intellettuali; essi erano già presenti da tempo. Le influenze decisive le avevano ricevute durante l’Impero e nel corso della Prima guerra mondiale. Cambiamenti fondamentali o rivoluzionari del sistema politico, sono solitamente accompagnati da un “ricambio” all’interno delle elite, tra cui anche gli intellet-tuali. È importante notare che la transizione quasi rivoluzio-naria dall’Impero alla Repubblica di Weimar condusse ad un ricambio assai scarso delle élite: le vecchie lasciarono solo l’amministrazione fallimentare alle nuove, alle quali (i so-cialdemocratici e gli altri partiti democratici) fu consentito soltanto di formare il governo e di nominare il presidente. Nell’amministrazione, nell’economia – all’interno della qua-le ovviamente assunse grande importanza il fatto che non fu capovolto il sistema capitalistico –, nelle università e in altri settori troviamo però, nel 1919, più o meno la stessa classe di-rigente. Per gli intellettuali vale lo stesso, anzi forse ancora di più. Agiscono in prima linea – con qualche eccezione – più
2 Il concetto di “via particolare” (Sonderweg), è stato introdotto dallo storico Hans-Ulrich Wehler, per designare le visioni culturali, sociali e politiche sostan-zialmente antimoderne, con le quali la Germania seguì una via diversa rispetto ai vicini Stati europei.
ultima.indd 355 26-10-2010 13:59:13
356 gereon wolters
o meno le stesse persone con la stessa mentalità di prima. Emblematico in questa prospettiva sembra che nel 1925, in un periodo di relativa stabilità economica e politica, Paul von Hindenburg, settantottenne ex-Generalfeldmarschall, capo del-lo stato maggiore nella Grande Guerra e sempre monarchi-co, fosse eletto presidente della Repubblica. Fu lo stesso Hin-denburg a nominare Adolf Hitler Reichskanzler il 30 gennaio 1933 e a firmare il cosiddetto Ermächtigungsgesetz, vale a dire la legge delega del 24 marzo 1933: certificato di morte della Repubblica di Weimar.
A costo di semplificazioni, si possono distinguere nel 1919 e nel periodo precedente i seguenti tre grandi gruppi di intel-lettuali: a) intellettuali di destra, come il giurista Carl Schmitt o lo scrittore Ernst Jünger, caratterizzati da un radicale anti-modernismo che rifiuta i valori illuministici di libertà e ugua-glianza; b) intellettuali di sinistra, come i giornalisti Carl von Ossietzky (premio Nobel per la pace nel 1936), o Kurt Tuchol-sky, che in linea di massima difendono la Repubblica, ma in real tà si sfiniscono in polemiche che contribuiscono al suo tramonto3 c) Un terzo gruppo di intellettuali sono i troppo po-chi difensori della Repubblica, tra i quali max Weber fino alla morte prematura nel 1920 e Thomas mann a partire dal 1922. Gli intellettuali di destra e in fondo anche gran parte di quelli della sinistra sono in egual misura antidemocratici, anche se per motivi del tutto diversi. In questa sede vorrei concentrarmi sugli intellettuali di destra, perché furono loro a seguire un’au-tentica via particolare (Sonderweg) tedesca, che diventò decisiva per il corso della storia e portò al disastro della seconda guerra mondiale. Il loro segnavia è, come detto, un antimodernismo radicale.
Fino all’incirca alla fine del XvIII secolo, il termine “cul-tura” (Kultur) era inteso in tedesco nel senso ciceroniano di cultura animi, quale affinamento personale nel senso della cura dello spirito e dell’anima, cioè della cura delle dimensioni in-dividuali, intellettuali, caratteriali ed emozionali della perso-
3 Cfr. W. Bialas, Intellektuellengeschichtliche Facetten der Weimarer Republik, in In-tellektualle in der Weimar Republic, a cura di W. Bialas - G. Iggers, Intellektuelle in der Weimarer Republik, Lang, Frankfurt 1996, pp. 13-30 (14). Su Tucholsky, cfr. S. Böhme Kuby, Intellettuali e Repubblica di Weimar: dalla ‘Kultur’ all’industria culturale, infra.
ultima.indd 356 26-10-2010 13:59:13
intellettuali tedeschi tra le due guerre 357
na. A poco a poco, venne affermandosi un uso più generale, secondo il quale “cultura” designava tutti i contributi civilizza-tori dell’uomo nella società. Questa estensione del concetto, non si trova in francese. “Culture” rimane anzitutto culture de l’esprit, mentre si iniziava a definire l’insieme dei contributi civilizzatori di una società come “civilisation”. Una volta che questi differenti usi terminologici di Kultur” e di “Zivilisation” si furono stabiliti, gli intellettuali tedeschi, come nota Ringer, iniziarono, «attraverso un’affascinante catena di associazioni, a scorgere in essi una contrapposizione»4.
Rinveniamo questa contrapposizione, ad esempio, nelle tira-te di Considerazioni di un impolitico di Thomas mann che – prov-viste di una lunga Prefazione – furono pubblicate per la prima volta nel 1918, dopo che già in precedenza ne erano apparsi alcuni stralci su rivista. La Prefazione è scritta nell’attesa della sconfitta. Nel contesto di una polemica di fondo contro “poli-tica”, “democrazia”, “filantropia” (= socialismo), “progresso”, ecc., mann si pone come uomo del XIX secolo. Cito così dif-fusamente da questo testo, perché Thomas mann apparten-ne certamente agli antidemocratici “civilizzati” (anche se lui stesso avrebbe respinto indignato questo termine). A sua lode va però detto già adesso che l’antidemocratico delle Conside-razioni di un impolitico subito dopo l’assassinio del ministro de-gli Esteri Walther Rathenau, nel giugno del 1922, si schierò risolutamente e apertamente dalla parte della Repubblica di Weimar, entrando perfino a far parte del Partito popolare libe-raldemocratico tedesco di Stresemann5, tra i cui fondatori, nel 1918, era stato anche max Weber.
mann così polemizza – con contenuti per nulla superiori a quelli di un qualunque “politico da caffè” –, sulla distinzione concettuale fondamentale tra cultura e civilizzazione:
4 F. Ringer, Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890-1933, dtv, münchen 1987, (ed. americana 1969, 1a ed. tedesca 1983), p. 84.5 Gustav Stresemann (1878-1929), in origine monarchico, fu in seguito tra i più risoluti combattenti per la Repubblica di Weimar. Operò dal 1923 fino alla morte in diversi governi come ministro degli Esteri. Fu tenuto in alta considerazione anche presso gli avversari della Germania; tra i suoi grandi contributi, i passi che condussero al Piano Dawes (1924), che mitigava gli oneri di riparazione del trat-tato di versailles, i trattati di Locarno (1925), che contribuirono a normalizzare i rapporti della Germania con gli ex-nemici, e infine nel 1926 l’ammissione della Germania all’interno della Lega delle Nazioni.
ultima.indd 357 26-10-2010 13:59:13
358 gereon wolters
La differenza fra spirito e politica implica quelle fra cultura e civi-lizzazione, fra anima e società, fra libertà e diritto di voto, fra arte e letteratura; ora la “germanicità” è cultura, anima, libertà, arte e non civilizzazione, società, diritto di voto, letteratura. La diffe-renza fra spirito e politica, per fare un altro esempio, è quella che passa fra il concetto di cosmopolitico e quello di internazionale. Il primo deriva dalla sfera della cultura ed è tedesco; l’altro nasce da quella della civilizzazione ed è qualcosa di completamente di-verso. […] L’esegesi storica ci dirà un giorno la parte e funzione che l’illuminismo internazionale, la loggia massonica mondiale – esclusi, naturalmente, gli ignari tedeschi – ha avuto nella prepara-zione spirituale e nel rea le scatenamento della guerra mondiale, la guerra cioè della “civilizzazione” contro la Germania6.
mann si scaglia quindi in una tirata contro «il tedesco asser-tore della “umana civilizzazione”»7, che rivela una forte affinità strutturale con la Dolchstoßlegende, vale a dire la “leggenda della pugnalata alle spalle”, che – sostenuta sopratutto da von Hin-denburg – compare suppergiù nello stesso periodo, secondo la quale l’esercito tedesco non avrebbe perso la guerra mondiale sul campo, ma sarebbe stato piuttosto pugnalato alle spalle dalla popolazione civile:
Non ho interessi né di vita né di morte per un’egemonia tedesca sul mercato, nutro anzi i miei bravi dubbi sulla vocazione della Germania per la grande politica e per un destino imperiale. […] Sono col cuore dalla parte della Germania non in quanto essa è concorrente dell’Inghilterra nella politica di potenza, ma in quanto è sua antagonista spirituale. Quanto al tedesco assertore della ‘umana civilizzazione’, quel che ben presto mi preoccupò, suscitando in me paura, odio e voglia di resistenza, non fu tanto la sua ostilità politica alla Germania, quanto piuttosto la non-ger-manicità del suo animo. […] L’invasione militare del paese ebbe esito infelice. Quello su cui l’assertore della civilizzazione con-tinuava a riporre le sue speranze […] era l’invasione spirituale, l’invasione politica dall’Occidente, la più forte di tutte e di gran
6 T. mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, postfazione di H. Helbling, Fischer, Frankfurt 1983, pp. 31sgg.; Considerazioni di un impolitico, Adelphi, milano 1997 (pp. 51-52).7 Ivi, pp. 33 sgg. (tr. it., pp. 53-54).
ultima.indd 358 26-10-2010 13:59:13
intellettuali tedeschi tra le due guerre 359
lunga la più travolgente che mai avesse segnato il destino della Germania. La conversione spirituale della Germania alla politica, alla demo-crazia […]: ecco quanto spera costui. La contrapposizione tra cultura e civilizzazione, che in Tho-
mas mann era ancora intesa come radicata nelle nature diver-se dei popoli, all’incirca nello stesso periodo (1919) viene sti-lizzata da Spengler nel suo Tramonto dell’Occidente in una legge dello svolgimento della storia mondiale.
Cultura e civilizzazione: sono come il corpo vivo di un’anima (eines Seelentums)8 e la sua mummia. In tali termini si distingue l’esistenza euro-occidentale di prima e dopo il diciannovesimo secolo, la vita in una pienezza e in una naturalezza, la cui forma è nata e si è sviluppata dall’interno, […] e quella più tarda vita senza radici delle nostre grandi città, le cui forme sono costruite dall’intelletto. Cultura e civilizzazione: sono come un organismo che nasce dalla passione e il meccanismo che risulta dall’irrigidi-mento di esso. […] L’uomo della cultura vive rivolto verso l’inter-no, l’uomo civilizzato vive rivolto verso l’esterno, nello spazio, tra corpi e ‘fatti’. Ciò che l’uno sente come destino, appare all’altro come una connessione di causa e effetto9
Nella teoria spengleriana dello svolgimento ciclico delle culture, la “civilizzazione” costituisce la forma decadente di ogni cultura finora comparsa all’interno della storia mondiale. Nella cultura “faustiana” euro-occidentale, in cui si troverebbe il suo presente, sarebbero riconoscibili degenerazioni analo-ghe ai fenomeni di decadimento propri ad esempio del tardo impero romano. In ciò l’Occidente, ovvero la Francia e l’In-ghilterra, ma anche gli Usa con il loro materialismo orientato interamente verso il denaro, sarebbero già stati ad uno stadio molto avanzato. La Germania teneva ancora alta la bandiera
8 Questo termine è uno strano neologismo, coniato probabilmente dallo stesso Spengler, che non è riuscito a imporsi nella lingua tedesca. Esso sembra designa-re l’anima, insieme con tutte le sue manifestazioni e prestazioni.9 O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltge-schichte, 2 voll., Beck, münchen 1919, p. 488; tr. it. di J. Evola, Il tramonto dell’Occi-dente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale, Guanda, Parma 1991; tr. it. parz. modificata, p. 528. Il vol. I (1919), fu un bestseller.
ultima.indd 359 26-10-2010 13:59:13
360 gereon wolters
della cultura, ma avrebbe dovuto presto ineluttabilmente soc-combere alle forze della “civilizzazione”.
Questo estremo antagonismo antimodernistico tra cultura/Germania e civilizzazione/Francia non era proprio, in forma più o meno attenuata, solo della concezione di Thomas mann o di Oswald Spengler, ma si estendeva dall’estrema destra fino al centro politico della Repubblica di Weimar. Esso si sedimentò quindi, con esplicito riferimento a Spengler, nel solido sapere enciclopedico, come ad esempio nell’enciclopedia tedesca più importante di quel periodo, il Großer Brockhaus (1928-1935):
Cultura […], in particolare la nobilitazione dell’uomo tramite la formazione e lo sviluppo delle sue forze morali, artistiche e spiri-tuali nonché il risultato dell’attività di uomini formatisi in modo siffatto. […] Specialmente nella dottrina tedesca della cultura si separa con ben precisi intenti valutativi la cultura dalla civilizza-zione. Secondo queste indagini la civilizzazione sta alla cultura come ciò che è esterno sta a ciò che è interno, ciò che è fatto sta a ciò che è divenuto, il meccanismo all’organismo, il mezzo allo scopo.10
Ciò non è detto soltanto così per dire. Quel primato in cer-ta misura morale che l’uomo di cultura tedesco possiede nei confronti dell’uomo occidentale della civilizzazione, viene af-fermato in molteplici ambiti, per esempio nella biologia. Leg-giamo così nel capitolo introduttivo (La rinascita della morfolo-gia dallo spirito della scienza tedesca) del manuale di morfologia comparata delle piante superiori del professore di botanica di Halle, Wilhelm Troll (1897-1978):
Chi voglia oggi rispondere alla domanda sull’essenza della scien-za tedesca, chi voglia anzi in assoluto comprendere seriamente tale domanda, può farlo solo se prende coscienza della contrap-posizione, si può ben dire della frattura insormontabile, che se-para la vita interiore dello spirito tedesco dall’i dea le scientifico positivistico dei popoli occidentali. […] Sebbene infatti la scienza come tale non conosca nazionalità, proprio là dove si tratta delle questioni supreme e ultime, dell’origine di tutto l’essere organico
10 Cit. in F. Ringer, Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890-1933 cit., p. 85.
ultima.indd 360 26-10-2010 13:59:13
intellettuali tedeschi tra le due guerre 361
e spirituale, il legame della ricerca con le nazionalità esercita il suo profondo influsso. […] Ciò che soprattutto contraddistingue il pensiero tedesco, non è tanto la sua scrupolosità quanto la sua profondità, il fatto che esso per usare un’immagine faustiana, risale alle “madri”. Non pago dell’esteriorità positivistica o del-la piattezza meccanica, esso aspira quindi a «scorgere la vivez-za della natura e la sua intima unità con l’essenza spirituale e divina»(Schelling).11
Si tratta qui soprattutto dell’“intuizione”quale peculiare metodo tedesco di considerazione della natura, contrapposto al formale e all’“astrazione”. È irrilevante che cose di questo genere siano state scritte solo nel 1937: certamente sono state pensate e dette molto prima e dimostrano, del resto, la con-tinuità della mentalità degli intellettuali di destra nella tran-sizione dalla Repubblica di Weimar al nazismo.12 Nel caso di Troll questa continuità sembra persino aver raggiunto senza danni anche la Repubblica Federale, perché il testo è rimasto inalterato nella ristampa – esplicitamente autorizzata dall’au-tore – nel 1967.
Qualcosa di analogo vale per la “Fisica tedesca” del Premio Nobel per la fisica (1905) Philipp Lenard (1862-1947), che a 75 anni, nel 1936, pubblicò una Fisica tedesca in quattro volu-mi, in cui metteva assieme le sue idee antioccidentali e, più ancora, antisemite dell’epoca di Weimar, con un progetto che respingeva sostanzialmente i moderni sviluppi della fisica.13 Il medesimo antimodernismo antisemita caratterizza la “mate-matica tedesca” di Ludwig Bieberbach (1886-1982), che nel 1913, appena ventisettenne, divenne ordinario a Basilea e pro-seguì poi la sua carriera a Francoforte e a Berlino.14 Rifletten-do sull’antagonismo di cultura e civilizzazione, di intuizione e astrazione, di profondità e superficie nella Repubblica di Wei-mar, non si può guardare unilateralmente solo alla Germania
11 W. Troll, Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen, I, Gebrüder Bornträger, Berlin 1937, p. 3 (2a ed. 1967). 12 Dopo la guerra la carriera di Troll a Halle (zona di occupazione russa) precipi-tò improvvisamente. Già nel 1946; lo ritroviamo a mainz, dove operò con succes-so per altri 20 anni come professore ordinario di botanica. 13 P. Lenard, Deutsche Physik in vier Bänden, J. F. Lehmanns, münchen 1936.14 Nel 1945, era del resto già conclusa.
ultima.indd 361 26-10-2010 13:59:13
362 gereon wolters
e ai Paesi occidentali di Troll. In modo perlomeno altrettanto frequente e ancora più forte gli ebrei sono oltraggiati con l’ac-cusa di essere prototipo di civilizzazione, astrazione e superfi-cialità senza radici.
Ed eccoci finalmente agli intellettuali. Né a Thomas mann, né a Oswald Spengler o a qualsivoglia altro intellettuale tedesco, sarebbe venuto in mente di autodefinirsi tale. Al contrario, gli in-tellettuali sono gli altri: ad esempio quei “senzapatria” che aspi-rano a un’intesa con la Francia e con il resto del mondo; quegli scrittori che non scribacchiano di romantici mondi immaginari, ma portano a espressione il sentimento del tempo proprio della modernità; “intellettuali” sono giornalisti di sinistra e liberali, che osservano il mondo moderno con curiosità e simpatia; sono persone appartenenti all’ambiente accademico, che si sentono più a proprio agio nelle grandi città che nei villaggi; e per molti, anche se a lungo non per tutti, lo sono gli ebrei. “Intellettuale” non appare quindi in Germania, a differenza che in Francia, una sorta di titolo nobiliare, ma un insulto: ulteriore divergen-za – non solo linguistica – , tra i due Paesi.
È facile immaginarsi l’effetto di umiliazione collettiva nell’animo tedesco causato dal trattato di versailles, anche se è impossibile ricostruire una catena causale in certa misura coe-rente degli stati d’animo, delle prese di posizione e degli avve-nimenti che hanno condotto al 24 marzo 1933. Nel corso degli anni, tuttavia, il “complesso versailles” si è andato chiaramente delineando come il fattore causale forse più importante per la fine della prima democrazia tedesca e per la presa del potere da parte del nazionalsocialismo. vorrei addirittura azzardare la tesi controfattuale, secondo cui senza versailles non ci sareb-be stato alcun dominio nazista in Germania e di conseguenza nemmeno la Seconda guerra mondiale e la Shoah.
Il 22 giugno 1919, il Parlamento tedesco, dopo un ultima-tum degli alleati unito a minacce di occupazione, decise – con 237 voti contro 138 – di accettare il cosiddetto “trattato di pa-ce” che era stato consegnato al governo tedesco due mesi pri-ma, il 7 maggio 1919, a versailles e che fu firmato nello stesso luogo il 28 giugno 1919. Quel trattato consisteva in un diktat di 434 articoli,15 nella elaborazione del quale, i tedeschi non
15 Può sembrare un’ironia della sorte il fatto che il trattato di versailles contenga
ultima.indd 362 26-10-2010 13:59:13
intellettuali tedeschi tra le due guerre 363
furono consultati e i loro desideri di modifiche furono total-mente ignorati: la forza trainante dalla parte francese fu il pri-mo ministro Georges Clemenceau. Non posso in questa sede occuparmi della vicenda della trasformazione del Trattato di versailles che, sostenuto con grande durezza dalla Francia, fu però mitigato dalla Gran Bretagna e dagli Usa. Quel che qui ci interessa sono gli effetti che questo trattato ebbe sulla visio-ne del mondo degli intellettuali tedeschi (nonché su quella dell’intero popolo tedesco). Per comprenderli, occorre pren-dere brevemente in considerazione l’immagine prevalente che di sé e della storia si formò la “generazione del 1914”. vorrei evidenziare due atteggiamenti e mentalità fondamentali:
Come abbiamo visto gli intellettuali tedeschi, in maggioran-za, si sentivano i portatori della vera “cultura” si consideravano superiori a quelli degli altri paesi occidentali, che presumeva-no legati meramente alla “civilizzazione” tecnico-scientifica.
Gli intellettuali tedeschi ritenevano che la prima guerra mondiale non fosse stata provocata dai tedeschi, e meno che mai esclusivamente dai tedeschi, ma che essa fosse stata invece imposta all’Impero tedesco dagli alleati, poiché costoro voleva-no spezzare il potere ai loro occhi crescente politico, economi-co, militare e culturale della Germania.16
Come agì su una mentalità fondata su parametri siffatti il diktat di versailles? La risposta appare ovvia: versailles fu avver-tito in Germania come una mostruosa umiliazione: la potenza in sé militarmente ed economicamente più forte del conti-nente, superiore da un punto di vista culturale e morale, viene derubata di una grossa parte del suo territorio e perde il con-trollo su parti importanti di quello rimastole. È castrata militar-mente e depredata economicamente, si sente moralmente dif-famata dalla “menzogna sulla colpa della guerra” e deve, oltre a tutto ciò, consegnare quelli che reputa degli eroi di guerra ai tribunali militari alleati. Ascoltiamo una voce fra tante: Oswald
agli artt. 1-26 lo statuto della Lega delle Nazioni, nel cui preambolo vengono invocate «relazioni tra i popoli fondate sulla giustizia e sull’onore», statuto che venne gravemente violato proprio dal trattato.16 La questione della responsabilità dello scatenamento della Prima guerra mon-diale continua a essere oggetto di discussione. Esiste comunque un ampio accor-do sul fatto che la Germania ebbe quantomeno una corresponsabilità piuttosto notevole se non ampiamente prevalente nello scoppio del conflitto.
ultima.indd 363 26-10-2010 13:59:13
364 gereon wolters
Spengler, il popolare autore nazionalista, anche se non nazio-nalsocialista, del Tramonto dell’Occidente, in un discorso tenuto allo Hochschulring Deutscher Art – un’associazione studente-sca nazionalista – a Würzburg il 26 febbraio 1924:
Abbiamo [dopo versailles] disimparato e dimenticato quel che ancora ieri eravamo come popolo in mezzo ai popoli del mondo. Siamo diventati non solo miserabili, ma anche senza onore. Il diritto dell’uomo, accordato a ogni popolo di nani, di difendersi con le armi in pugno, ci è stato tolto. Non apparteniamo più alla schiera delle nazioni indipendenti. Siamo diventati il mero ogget-to della volontà, dell’odio e dell’avidità predatoria altrui. mentre nel resto del mondo gli eserciti e le flotte vengono armati per nuove decisioni, noi paghiamo con denaro tedesco sul suolo tede-sco un esercito francese – questo è il nostro antimilitarismo17.
Le lagnanze di Spengler prorompono dall’anima della stra-grande maggioranza degli intellettuali tedeschi, anzi dell’inte-ra popolazione tedesca. E se egli avesse incluso nella sua espo-sizione ulteriori dimensioni dell’umiliazione di versailles, an-che ciò avrebbe trovato in Germania approvazione generale.
Ne ho trovato ultimamente una prova quasi commovente.18 Hubert Jedin, sacerdote cattolico di origine ebraica e celebre sto-rico della Chiesa, aveva perso la sua libera docenza all’Università di Breslavia subito dopo la presa del potere di Hitler. Si rifugiò nel Collegio Teutonico in vaticano per aspettare la fine del Reich. Quando, nel maggio 1940, le truppe tedesche in una campagna di poche settimane sconfissero la Francia, Jedin provò il senti-mento contraddittorio di orgoglio e preoccupazione: l’orgoglio del tedesco Jedin, perché le truppe naziste si erano vendicate della “umiliazione di versailles”, ma altresì la preoccupazione dell’ebreo, perché con la vittoria dei nazisti, il desiderato ritorno in patria appariva ancora più di là da venire
Una notazione: l’umiliazione nazionale collettiva mi sem-bra giacere anche nel presente, alla radice numerosi pericolosi conflitti. Si potrebbe ad esempio parlare della Serbia. Penso però soprattutto al conflitto dell’“Occidente” con il mondo
17 O. Spengler, Politische Pflichten der Deutschen Jugend, Beck, münchen 1924, p. 3.18 Cfr. H. Jedin, Lebensbericht, mit einem Dokumentenanhang, Grünewald verlag, mainz 1988 (3a ed.), pp. 110-11.
ultima.indd 364 26-10-2010 13:59:13
intellettuali tedeschi tra le due guerre 365
islamico in generale, e al conflitto israelo-palestinese in par-ticolare. ma non sembra che, soprattutto nell’ultimo caso, ai protagonisti sia venuto in mente di trarre possibili insegna-menti da “versailles”.
2. Il fallimento degli intellettuali di Weimar
Solo poche parole su questo argomento che viene trattato in un altro intervento19. Abbiamo visto che la grande maggio-ranza degli intellettuali tedeschi di destra erano sopravvissuti al grande cambiamento del sistema politico del 1918-’19 con grande facilità. Quelli di sinistra puntavano alla rivoluzione comunista o almeno ad un fronte popolare: per la difesa della Repubblica e della democrazia hanno fatto pochissimo, anzi la sinistra ha contribuito al fallimento20. Così si sono uniti con i veri becchini intellettuali della Repubblica, gli intellettuali del-la destra. Gli intellettuali moderati però, i soli difensori della Repubblica di Weimar, anche se spesso non in modo incondi-zionato, furono quasi immobilizzati dai due estremi. Tra loro, si trovano persone che erano diventate democratiche quasi loro malgrado. Un esempio fu Thomas mann che, a partire dal 1922, in seguito all’assassino del ministro degli esteri, Walther Rathenau, per mano di ufficiali della estrema destra, rivedette la sua posizione antidemocratica del 1918. Diventò ciò che si chiamava Vernunftrepublikaner, cioè un repubblicano di conve-nienza e non di sentimento. Lo storico Friedrich meinecke aveva formulato questa posizione già nel 1919: «volto verso il passato rimango nel mio cuore monarchico, volto verso il futuro divento per motivi razionali repubblicano». Ancora nel 1930, in una conferenza a favore dei socialdemocratici dopo le elezioni del 14 settembre in cui finirono secondi i nazisti e che portarono alla fine della coalizione dei partiti democratici, Thomas mann confessava di nutrire dubbi se la costituzione
19 Cfr. F. Trocini, I “mandarini” del Kaiser. Storici e Gelehrtenpolitik nella Germania a cavallo tra Otto e Novecento, infra.20 Si veda ad es. H.U. Wehler, Leopold Schwarzschild contra Carl v. Ossietzky, in Id., Preußen ist wieder chic….Politik und Polemik in zwanzig Essays, Suhrkamp, Frankfurt 1983.
ultima.indd 365 26-10-2010 13:59:13
366 gereon wolters
parlamentare stile europeo occidentale che fu adottata dalla Germania come per così dire storicamente a portata di mano, sia completamente adeguata alla sua essenza; dubbi, se questa costituzione forse fino a un certo grado deformi e danneggi la sua moralità politica (politische Sittlichkeit).21
Certo non parlava così un entusiasta repubblicano e mann, insieme a tantissimi altri difensori della Repubblica, non lo era. La Repubblica di Weimar per costoro era il male mino-re. mann lo dice francamente nel seguito del suo intervento, quando afferma «che i tentativi fino adesso fatti per superare il parlamentarismo democratico, intendo quello est-europeo e quello sud-europeo, cioè la dittatura di una classe e quella di un avventuriero cesareo generato democraticamente, sono ancora molto più alieni al sangue tedesco».
3. Gli intellettuali tedeschi nel nazismo
La Repubblica di Weimar cadde con la legge delega del 24 marzo del 1933. Tre giorni prima però nel “Giorno di Potsdam”, grande evento propagandistico messo in scena da Joseph Goebbels, ministro della Propaganda nel Governo Hit-ler, fu celebrato ciò che nelle intenzioni dei nazisti voleva esse-re un apparente ritorno al passato: l’incontro tra von Hinden-burg, il monarchico presidente della Repubblica, e Hitler. La foto della stretta di mano tra i due – Hitler con la testa china con deferenza verso l’eroe nazionale Hindenburg –, ebbe l’ef-fetto desiderato: tre giorni dopo, soltanto i socialdemocratici votarono contro la legge delega, che dava a Hitler poteri dit-tatoriali.22 I partiti conservatori insieme al Zentrum, il partito cattolico, sancirono in tal modo la fine della democrazia. Agli intellettuali di destra il “Giorno di Potsdam” doveva suggerire che nel nuovo sistema politico non era necessario un cam-biamento di mentalità. Esso indicava piuttosto un ritorno al
21 T. mann, Reden und Aufsätze, Bd. 3, Fischer, Frankfurt 1960, p. 876. 22 Si deve però tenere presente che allora 26 delegati socialdemocratici erano in carcere o erano fuggiti. L’intero gruppo parlamentare comunista di 86 membri era stato cancellato, i suoi membri arrestati, o uccisi, o avevano lasciato il Paese o si erano dati alla clandestinità.
ultima.indd 366 26-10-2010 13:59:13
intellettuali tedeschi tra le due guerre 367
sistema dei valori dell’Impero. Così von Hindenburg – tutt’al-tro che intellettuale – fu due volte l’emblema della continuità della mentalità di gran parte degli intellettuali; la sua elezione a presidente nel 1925 dimostrò che i valori dell’Impero erano ancora validi, e il “Giorno di Potsdam” servì a rassicurare gli stessi intellettuali che possibili riserve nei confronti del capo-ralmaggiore Hitler e delle sue orde non erano fondate, dopo che quest’ultimo aveva chinato con riverenza il suo capo da-vanti al generale feldmaresciallo. Naturalmente per gli intellet-tuali di destra e per i borghesi meno politicizzati il gesto di von Hindenburg contribuì molto al sentimento di continuità con l’Impero anche rispetto a questa svolta del sistema politico. Quanto al sistema economico, nessuno si aspettava veri cam-biamenti, nonostante la componente “socialismo” nella parola “nazionalsocialismo”
Se torniamo agli intellettuali, dobbiamo in primo luogo co-statare che con la presa di potere dei nazisti, il loro numero ca-lò notevolmente. Se la presenza pubblica, parte essenziale del-la mia proposta di definizione, fosse valida, tutti gli intellettuali di sinistra dovrebbero scomparire dalla scena. Lo stesso vale in parte per i moderati; persino tra gli intellettuali di destra, alcuni scomparvero, nel senso che non offrirono i loro servizi a quelli che erano giunti al potere. Tra loro Ernst Jünger, ai cui standard di nobiltà non piacque il caporalmaggiore con le sue orde rozze e violente: trattò con freddezza le avances dei nazisti e rifiutò tra l’altro l’offerta di un seggio nel Reichstag. Qualcosa di analogo accadde a Spengler, che durante la Re-pubblica di Weimar aveva sostenuto i nazisti e che Goebbels invitò a parlare nel “Giorno di Potsdam”: offerta che egli, stu-dioso privato, rifiutò, come aveva rifiutato quella del giugno 1933 di una cattedra di Storia della cultura e Storia universale presso l’Università di Lipsia. Qualche mese dopo il ministero della Propaganda di Goebbels ordinò di non menzionare più il suo nome alla radio.
Col tacere di quelli di sinistra, dei moderati e di alcuni di destra, la maggior parte degli intellettuali tedeschi era sparita dalla scena già nel 1933. Le facoltà di Giurisprudenza – per citare un esempio significativo, anche se non completamente rappresentativo – perse intorno al 40% del corpo docente: in quanto ebrei, o in quanto si erano professati democratici, so-cialisti o comunisti. Rimasero così visibili solo gli intellettuali
ultima.indd 367 26-10-2010 13:59:13
368 gereon wolters
di destra. In altre parole, risultava in Germania una situazione di enorme povertà culturale. viktor Klemperer, professore di Romanistica a Dresda, il quale nonostante le sue radici ebrai-che sopravvisse sotto il Terzo Reich grazie alla concatenazione di una serie di fortunate contingenze, annotava nel suo diario alla data del 14 ottobre 1934: «Il ministro della propaganda firma sempre “Dott. Göbbels”. È l’istruito nel governo, cioè lo pseudoistruito tra analfabeti. Curiosamente diffusa è l’i dea della sua potenza intellettuale; lo si definisce spesso la “mente” del governo. modestia di pretese!». 23 Proprio Goebbels, accennò al significato peggiorativo di “intellettuale”. In un discorso del 1942 afermò: «L’uomo ha il comprensibile bisogno di essere ritenuto “intelligente”; ma per questo non occorre affatto essere un “intellettuale”»24. Del resto il nazionalsocialismo fu un mo-vimento esplicitamente anti-intellettuale. In Mein Kampf Hitler polemizza spesso contro intellettuali e professori. Così durante il nazismo gli intellettuali non svolsero un ruolo veramente im-portante.
Gli intellettuali nazisti del resto potevano semplicemente mantenere i vecchi parametri della mentalità degli intellettuali di destra dei tempi dell’Impero e di Weimar (e spesso si tratta-va ovviamente delle medesime persone): supremazia culturale e militare tedesca, revisionismo quanto a “versailles”, autori-tarismo antidemocratico, annessionismo mirato su regioni di Paesi vicini25; e poi l’antisemitismo. ma tutti questi parametri furono radicalizzati dai nazisti. L’autoritarismo antidemocra-tico diventò autoritarismo dittatoriale; il vecchio annessioni-smo imperiale, diventò un programma dell’assoggettamento
23 v. Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten, Aufbau verlag, Berlin 1995, a cura di W. Nowojski (ed. it. Testimoniare fino all’ultimo, mondadori, milano 2000), vol. I, p. 157. I diari di Klemperer sono una straordinaria e insostituibile fonte per una comprensione della persecuzione antisemita da parte del nazionalsocia-lismo, all’interno della Germania. In annotazioni dettagliate e minuziose l’ebreo protestante Klemperer, perfettamente assimilato e sposato con una “ariana”, de-scrive le singole tappe attraverso le quali gli ebrei furono privati dei diritti, sino alla perdita del diritto alla vita.24 D. Bering, Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfwortes, Klett Cotta, Stuttgart 1978, p. 112. 25 Cfr. W. J. mommsen, Bürgerliche Kultur und politische Ordnung. Künstler, Schriftstel-ler und Intellektuelle in der deutschen Geschichte 1830-1933, Fischer, Frankfurt 2000, p. 221, dove si legge che nell’Accademia Prussiana delle Scienze solo Einstein «sosteneva una posizione anti-annessionista senza compromessi».
ultima.indd 368 26-10-2010 13:59:13
intellettuali tedeschi tra le due guerre 369
dell’Europa, mentre l’antisemitismo che non era stato molto diverso da quello in Francia e altrove, diventò un programma d’annichilazione degli ebrei. Si può dire che l’antisemitismo era il parametro centrale della mentalità di gran parte degli intellettuali nazisti. Esso diventò una vera e propria ossessio-ne. C’è pero una differenza importante tra autoritarismo e annessionismo da una parte e antisemitismo dall’altra; mentre l’autoritarismo dittatoriale e l’assoggettamento dell’Europa fa-cevano parte del discorso politico pubblico ed erano sotto gli occhi di tutti, l’annichilazione degli ebrei non fu proposta e ancora meno discussa pubblicamente. Fu progettata e svolta nel segreto e fuori della Germania.
Tra gli intellettuali nazisti ci sono due individui di spicco: il giurista e teoretico della politica Carl Schmitt e il filosofo martin Heidegger. mentre sappiamo poco e nulla sull’atteggia-mento politico di Heidegger prima del 1933, Schmitt si era già profilato nella Repubblica di Weimar come ultra-conservatore e sostenitore di un regime autoritario presidenziale, che prima della presa di potere di Hitler non era favorevole né alla ditta-tura comunista del proletariato, né alla dittatura di Hitler. Il 30 gennaio, giorno in cui Hitler fu nominato cancelliere, Schmitt annota nel suo diario: «è uno stato terribile»; e un giorno do-po – Schmitt era stato colpito di un raffreddore – scrive: «man mano sono di nuovo in forma, condizioni ridicole, ho letto i giornali, emozionato. Rabbia sullo stupido, ridicolo Hitler». Poco dopo però la rabbia era sbollita. Già dopo la legge dele-ga del 24 marzo si presentò come fedele nazista. Il 1° maggio 1933, aderì infine al partito nazista, nella stessa data in cui en-trò nel partito Heidegger. In seguito, Schmitt fu il principale e più intelligente ed eloquente teorico della distruzione nazista del diritto, della politica di annessione e dell’antisemitismo, anche se non della annichilazione degli ebrei. Non posso en-trare in questa sede nei dettagli della sua teoria politica. Ac-cenno solo ad alcuni concetti coniati di Schmitt:26 legittimità contro legalità, religione politica, romanticismo politico, Stato totale e guerra totale, il concetto del Grossraum e così via. Do-po il massacro, ordinato da Hitler, degli avversari interni del
26 Cfr. B. Rüthers, Carl Schmitt im Dritten Reich. Wissenschaft als Zeitgeist-Verstärkung?, Beck, münchen 1990 (2a ed.).
ultima.indd 369 26-10-2010 13:59:13
370 gereon wolters
regime, il cosiddetto Röhmputsch, del 30 giugno 1934, Schmitt trovava la seguente giustificazione: «Il Führer protegge il di-ritto dal più brutto abuso, se nell’attimo del pericolo in forza della sua carica da Führer come supremo giudice crea imme-diatamente il diritto». Per questo e tanti altri “servizi”, Schmitt fu ricompensato con una carriera folgorante, che era tuttavia in gran parte finita nel 1936, nel contesto di un intrigo ordito dalle SS. Schmitt mantenne però la sua cattedra a Berlino e rimase un servitore fedele del regime fino al 1945. In seguito non si distanziò mai dalle sue posizioni politiche, rimanendo anche antisemita.
Di martin Heidegger, invece, prima del 1933 troviamo so-lo cenni oscuri, che alludono alla necessità di un grande cam-biamento. Ancora oggi non si sa quale cambiamento avesse in mente. Nel 1933 però, dopo la presa di potere di Hitler, lo si trova dalla parte dei nazisti. Il 10 maggio diventò ret-tore dell’Università di Friburgo. La sua famigerata lezione d’inaugurazione lo etichetta come nazionalsocialista “doc”27. Procedette all’espulsione degli ebrei e degli avversari politici dal corpo docente dell’università; nel febbraio del 1934 però diede le sue dimissioni per ragioni non chiare. Ovviamente era dell’avviso che la sua visione del nazionalsocialismo, qua-lunque sia stata, non era rea lizzabile nel Terzo Reich. Si ritirò quasi completamente dalla politica, anche se nella sua Intro-duzione alla metafisica del 1935, parlò ancora «della verità inte-riore e la grandezza del movimento (nazista)».28 Esattamente come nel caso di Schmitt, anche nel caso di Heidegger non si è avuta alcuna ritrattazione. Riguardo alla Shoah, Heidegger nel 1949, disse a Brema – nell’occasione di una relazione –, qualcosa che però omise nella pubblicazione nel 1962 e che poi ritroviamo solo nel 1994, in un volume della postuma Gesamtausgabe:
L’agricoltura adesso è industria motorizzata dell’alimentazione, essenzialmente eguale alla fabbricazione di cadaveri nelle camere a gas e nei campi di sterminio, è eguale al blocco e al costringere
27 m. Heidegger, Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Das Rektorat 1933/34, Klostermann, Frankfurt 1983 (1a ed. 1933).28 Id., Einführung in die Metaphysik, max Niemeyer, Tübingen 1953, p. 152.
ultima.indd 370 26-10-2010 13:59:13
intellettuali tedeschi tra le due guerre 371
alla resa per fame di Paesi, è eguale alla fabbricazione di bombe all’idrogeno.29
Queste analogie hanno forse qualche aspetto interessante: se sono però la sola cosa che un pensatore come Heidegger sa di dire sulla Shoah, ciò dimostra una notevole mancanza di carattere e di rispetto morale.
vorrei chiudere con un’ipotesi sul fallimento degli intel-lettuali nel nazismo che è magari valida anche per altre svolte politiche: gli intellettuali tedeschi, come la stragrande maggio-ranza delle persone, si lasciavano guidare in questa situazione dall’opportunismo (con una buona dose di narcisismo), o dal-la paura. Gli intellettuali in quanto tali, però, a mio modo di vedere (si veda la mia definizione normativa all’inizio), sono molto meno giustificabili della gente comune.
29 Id., Bremer und Freiburger Vorträge, 1. Einblick in das was ist, Bremer Vorträge 1949. 2. Grundsätze des Denkens, Freiburger Vorträge 1957, Klostermann, Frankfurt 1994, p. 27.
ultima.indd 371 26-10-2010 13:59:13