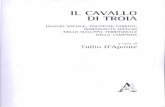Dimenticare Clausewitz? Conflitti asimmetrici e guerre di quarta generazione
Transcript of Dimenticare Clausewitz? Conflitti asimmetrici e guerre di quarta generazione
DIMENTICARE CLAUSEWITZ? CONFLITTI ASIMMETRCI E GUERRE DI QUARTA GENERAZIONE
1. Il Nomos d’Europa
«Da molti anni sono in corso nelle più diverse parti della terra lotte san-guinose, di fronte alle quali, nel consenso più o meno generale, si evita pru-dentemente di usare il concetto di guerra. Su questo è sin troppo facile faredell’ironia. In realtà, non emerge qui niente altro che la pura e semplice verità,ovvero che vecchi ordinamenti si stanno dissolvendo e al loro posto non nesono ancora subentrati di nuovi. Nella questione del concetto di guerra si rispec-chia il disordine dell’attuale situazione mondiale. Si manifesta ciò che è sem-pre stato vero, e cioè che la storia del diritto internazionale è una storia delconcetto di guerra. Il diritto internazionale altro non è che un “diritto di guerrae di pace” un jus belli ac pacis, e rimarrà tale finché sarà un diritto di popoliindipendenti, organizzati su base statuale, e questo significa: finché la guerrasarà una guerra fra Stati e non una guerra civile internazionale. [...] Per que-sto il concetto di guerra è oggi un problema la cui discussione obiettiva servea disperdere la nebbia delle attuali ingannevoli finzioni e a mostrare la realesituazione del diritto internazionale odierno» (1).
Così Carl Schmitt avviava, nel 1938, la sua riflessione sulla profonda crisidello jus publicum europaeum che il primo conflitto mondiale aveva innescato,ossia sul disfacimento di quel corpus di valori, convenzioni norme e consue-tudini che aveva regolato sino a quel momento l’essenza dei rapporti inter-nazionali europei e, di riflesso, del resto del mondo almeno a partire dalla con-clusione della guerra dei Trent’Anni. Per il filosofo tedesco il 2 aprile del 1917,data dell’ingresso degli USA nella grande guerra, non rappresentava soltanto
(1) CARL SCHMITT, Il concetto discriminatorio di guerra, Roma-Bari, Laterza, 2008 [1938],p. 3.
Emilio Gin506
il punto di svolta decisivo nell’equilibrio di quel conflitto che si trascinava dacirca tre anni, ma poteva considerarsi quale momento da cui poter concla-mare apertamente la crisi del diritto internazionale sin lì in vigore. L’interventoamericano contro la Germania accelerava infatti il carattere di contrapposi-zione ideologica tra i due schieramenti, già ravvisabile e prevedibile sin daiprimi momenti (2), e conduceva alla resurrezione, dopo svariati secoli di fati-cosa e precaria ibernazione cui gli sforzi del pensiero filosofico e giuridico euro-peo l’avevano costretto, del concetto di «guerra giusta».
Alla fatale decisione di spingere in guerra il proprio paese, sin lì sostan-zialmente isolazionista, Woodrow Wilson era giunto seguendo una rotta di cir-cumnavigazione completa della sua personale posizione iniziale nei confrontidella conflagrazione europea (3). Il combustibile necessario all’accensione dellamacchina bellica statunitense fu però reso disponibile solo attingendo alleriserve più profonde del patrimonio morale e culturale d’oltreoceano, a quel-l’insieme di valori che sin dalla loro costituzione fornivano il fondamento del-l’autorappresentazione e della dinamica identitaria degli Stati Uniti.
Almeno sino termine del XIX secolo l’America si era riconosciuta inmodo naturale nell’immagine di terra promessa – immune dagli egoismi e dal
(2) Si pensi, a esempio, ai temi ricorrenti negli slogan dell’interventismo democratico neipaesi dell’Intesa e all’evoluzione della propaganda dei vari governi nel dover gestire la crescentepressione che lo sforzo bellico esercitava nei rispettivi fronti interni. Sull’interventismo demo-cratico nel particolare contesto italiano cfr. R. DE FELICE, Mussolini il rivoluzionario, 1893-1920,Torino, Einaudi, 1995, p. 362 e ss.; sulla propaganda di guerra e la problematica relativa algoverno dello spirito pubblico nella Grande Guerra cfr. S. ROBSON, La prima guerra mondiale,Bologna, il Mulino, p. 63 e ss.
(3) Sulla personalità di Wilson e sul suo mutamento di giudizio circa la necessità dell’in-tervento, nonché sul suo impatto nella trasformazione della politica estera statunitense primae durante i cruciali mesi della guerra e delle trattative di pace cfr. E. H. BUEHRIG, Wilson’sNeutrality Re-Examined, in «World Politics», vol. 3, n. 1, (Oct. 1950), pp. 1-19; R. H. FERREL,Woodrow Wilson: Man and Statesman, in «The Review of Politics», vol. 18, n. 2, (Apr. 1956),pp. 131-145; H. A. TURNER, Woodrow Wilson and Public Opinion, in «The Public OpinionQuarterly», vol. 21, n. 4, (Winter 1957-1958), pp. 505-20; L. W. MARTIN, Necessity and Principle:Woodrow Wilson’s Views, in «The Review of Politics», vol. 22, n. 1, (Jan. 1960), pp. 96-114, ilquale cerca di stemperare molto l’immagine di un Wilson preconcettualmente contrario a un’e-ventuale pace di compromesso con gli Imperi Centrali; cfr. pure J. M. COOPER, Jr, The Vanityof Power: American Isolationism and the First World War, 1914-1917, Westport (Cn), Greenwood,1969; P. DEVLIN, Too Proud to Fight: Woodrow Wilson’s Neutrality, London, Oxford UniversityPress, 1974; J. A. THOMPSON, Woodrow Wilson and World War I: A Reappraisal, in «Journal ofAmerican Studies» vol. 19, n. 3 (1985), pp. 325-348; M. MACMILLAN, Parigi 1919. Sei mesi checambiarono il mondo, Milano, Mondadori, 2006, pp. 15-31 e H. KISSINGER, L’arte della diplo-mazia, Milano, Sperling & Kupfer, 2004, in part. pp. 23-33.
Dimenticare Clausewitz? 507
cinismo politico di stampo europeo – sulla quale edificare il faro di libertà edemocrazia cui gli altri popoli avrebbero dovuto volgersi per trarne ispirazionee speranza; e tale convinzione era andata costruendosi di pari passo, non acaso, all’obiettivo geopolitico di estromettere qualsiasi influenza esterna sul pro-prio continente. Tutto questo poi aveva avuto una diretta ricaduta nelle con-cezioni strategiche della classe politica e militare americane, nelle quali avevapredominato, nei confronti delle potenze europee, un atteggiamento meramentedifensivo unito al cosciente e costante impegno nell’estendere sin dove possi-bile le frontiere della repubblica a spese dei più deboli confinari continen-tali (4).
La costruzione della sfera d’indipendenza americana, esplicitatasi nellacosiddetta «dottrina Monroe», aveva però sino a quel momento giocato unruolo sussidiario e parallelo alla politica di equilibrio del vecchio continentefrutto del jus publicum europaeum nonostante, sotto l’energica e spregiudicatapresidenza di Theodore Roosevelt, la potenza statunitense avesse iniziato adaffacciarsi oltre i meri confini geografici dell’emisfero americano. L’interventismodi Wilson, pertanto, poté spingere il missionario a scendere giù dal faro dellalibertà e a riattraversare gli oceani, per assicurarsi di persona che i valori delnuovo continente potessero germogliare non solo con la forza dell’esempio,soltanto a patto di potergli fornire una spada forgiata nella fucina dei più genuini
(4) Per un’ampia ed esauriente analisi sulla corrispondenza tra politica estera e pensiero mili-tare americano e sulla sua evoluzione nel corso del tempo cfr. il classico lavoro di R. F. WEIGLEY,The American Way of War. A History of United States Military Strategy and Policy, Bloomington(In), Indiana University Press, 1977, e ID., American Strategy from Its Beginnings through theFirst World War, in Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, P. Paret(ed.), Princeton, Princeton University Press, 1986, pp. 408-43; ma cfr. anche la parziale revi-sione di giudizi in R. WEIGLEY - B. M. LINN, The American Way of War Revisited, in «TheJournal of Military History», vol. 66, n. 2 (Apr. 2002), pp. 501-33; cfr. pure H. A. KISSINGER,American Strategic Doctrine and Diplomacy, in The Theory and Practice of War, M. Howard (ed.),London, Cassel, 1965, pp. 273-292; J. SHY, The American Military Experience, in «Journal ofInterdisciplinary History», vol. I, (1971), p. 205-228, che correla la strategia di annientamentotipica dell’American Way of War alla natura ideologica della guerra d’indipendenza, tesi poi ripresain ID., A People Numerous and Armed: Reflexions on the Military Struggle for AmericanIndependence, New York, Oxford University Press, 1976, pp. 227-254; cfr. pure D. HIGGINBOTHAM,The Early American Way of War: Reconnaissance and Appraisal, in «The William and MaryQuarterly», vol. 44, n. 2, (Apr. 1987), pp. 230-273; sullo spartiacque costituito dalla GuerraCivile cfr. invece L. JANDA, Shutting the Gates of Mercy: The American Origins of Total War,1860-1880, in «The Journal of Military History», vol. 59, n.1 (Jan. 1995), pp. 7-26; per ciò cheattiene alla costruzione dell’egemonia statunitense nel continente Americano sino alla prima metàdel XIX secolo cfr. invece F. P. PRUCHA, The Sword of the Republic. The United States Armyon the Frontier, 1783-1846, New York, Macmillan, 1969.
Emilio Gin508
valori americani, con la cui lama recidere le radici più profonde dell’ordina-mento giuridico internazionale.
La guerra così scatenata non poteva che concludersi con la rimozione totaledegli ostacoli che, a giudizio americano, impedivano la crescita rigogliosa dellapianta democratica nel vecchio continente: il militarismo in genere e prussianoin particolare, la diplomazia segreta e, al di sopra di tutto, proprio la conce-zione dell’equilibrio tra le potenze, faticosamente perseguito, benché in modofallimentare, dal concerto d’Europa quale mezzo per ottenere la stabilità geo-politica. Ad esso andava sostituito un nuovo sistema di norme fondate sull’i-dea della sicurezza collettiva tra attori internazionali riconoscentisi nei mede-simi ideali liberaldemocratici e sottoposti all’autorità di un ente sovranazionale,la Società delle Nazioni, appositamente creato a tale scopo. Qualsiasi soggettoche si fosse posto volontariamente al di fuori di tale sfera di condivisione valo-riale poteva essere trattato senza molte remore quale hostis generis humani,nei confronti del quale nulle potevano essere le possibilità di compromesso edi accomodamento. Almeno in teoria, su queste premesse, non vi era piùposto per la guerra tra soggetti qualitativamente paritari, essendo quest’ultimaespunta idealmente – se non come espediente d’autodifesa – dalle possibilitàdi scelta politica da parte di nazioni democratiche rese culturalmente omoge-nee dal principio di autodeterminazione dei popoli, e dunque da considerarsialla stregua di un atto criminale.
In Italia, più o meno nello stesso periodo e da un universo ideologico certomolto differente da quello di Schmitt, giungeva a conclusioni molto simili ancheGramsci nella sue riflessioni sull’assetto internazionale postbellico (5). Per ilpensatore italiano, infatti, la Società delle Nazioni risaltava chiaramente sul pianointernazionale quale strumento di diffusione del potere capitalistico e di garantedello status quo internazionale a vantaggio delle potenze anglosassoni sotto ilmal cucito sipario dell’ideologia umanitaria e democratica. L’analisi gram-sciana, in completa sintonia con quella del filosofo tedesco, coglieva con niti-dezza quanto nella decadenza dello stato nazionale andasse individuata laragione prima della crisi del vecchio sistema internazionale che l’apparizione
(5) Cfr. ad esempio gli articoli pubblicati tra il 1918 e il 1919, La Lega delle Nazioni;Individualismo e Collettivismo; Un soviet locale; La Russia: potenza mondiale, in A. GRAMSCI,Scritti politici, a cura di P. Spriano, Roma, Editori Riuniti, 1967, alle pp. 97 e ss., 110 e ss.,183 e ss., e 347 rispettivamente; sulla scuola neogramsciana e la sua riflessione sulla decadenzadello stato nazionale cfr. W. I. ROBINSON, Beyond Nation-State Paradigms: Globalization, Sociologyand the Challenge of Transnational Studies, in «Sociological Forum», vol. 13, n. 4 (Dec. 1998),pp. 561-594, in part. p. 583 e ss.
Dimenticare Clausewitz? 509
della Società ginevrina aveva reso manifesta: l’edificio concettuale del jus publi-cum europaeum si trovava così incrinato proprio nel suo pilastro fondamentalecon tutte le conseguenze previste da Schmitt sull’inevitabile, e nefasta, torsioneimposta al concetto di guerra – e alla logica della contrapposizione amico/nemico– tanto al di fuori che all’interno dei diversi confini nazionali (6).
Quale che ne possa essere il giudizio sull’effettiva capacità della sapienzagiuspolitica europea nell’aver raggiunto una concreta limitazione degli effettibellici e della violenza nei conflitti intereuropei (7), non vi è alcun dubbio cheessa raggiunse perlomeno una notevole razionalizzazione della materia incampo concettuale perseguendo il convergente obiettivo del perfezionamentodella teoria della sovranità, anima e cemento dell’edificazione dello statomoderno sulle rovine disseminate dal bellum intestinum interreligioso. DaAlberico Gentili a Jean Bodin, da Machiavelli a Vattel – per citarne soloalcuni (8) – il pensiero filosofico moderno riconobbe nella guerra, la pace e laneutralità le prerogative atte a meglio definire i contorni di uno jus ad bellumdi pertinenza esclusiva del sovrano, puntuale corrispettivo della capacità di que-st’ultimo a eliminare l’indisciplina feudale e ad assicurare la tranquillità e lasicurezza interne. Presero così lentamente forma il moderno sistema diplomatico,nutritosi inizialmente delle consuetudini e dell’etichetta spagnole, gli esercitipermanenti dipendenti dal sovrano, con l’apparato fiscale necessario a soste-nerli, che già dall’età di Carlo VII in Francia iniziarono a prendere corpo conla creazione e il mantenimento delle prime unità reggimentali stabili per com-battere il disordine delle milizie mercenarie e private (9).
(6) C. SCHMITT, Il concetto discriminatorio di guerra, cit., p. 65 e ss.(7) Cfr. sul punto N. BOBBIO, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, il Mulino,
1997, p. 99 e ss., e L. BONANATE, La guerra, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 101 e ss.; diversa-mente, e in maniera più condivisibile sull’efficacia del jus publicum europaeum cfr. invece E.DI RIENZO, Il diritto delle armi. Guerra e politica nell’Europa moderna, Milano, Franco Angeli,2005.
(8) Cfr. M. GALIZIA, La teoria della sovranità dal Medioevo alla Rivoluzione francese, Milano,Giuffrè, 1951; F. H. HINSLEY, Sovereignty, London, Basic Books, 1966; La formazione degli statinazionali nell’Europa Occidentale, a cura di C. Tilly, Bologna, il Mulino, 1984; H. HELLER, Lasovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato, Milano, Giuffrè, 1987; A. TARANTINO,Sovranità, Milano, Giuffrè, 1990; N. MATTEUCCI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna,il Mulino, 1997; W. REINHARD, Il pensiero politico moderno, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 9-27; F. MANCUSO, Diritto, Stato, Sovranità: il pensiero politico giuridico di Emer de Vattel tra asso-lutismo e rivoluzione, Napoli, Esi, 2002, ed esaustivamente E. DI RIENZO, Il diritto delle armi,cit., pp. 106-148.
(9) Cfr. P. DEL NEGRO, Guerra ed eserciti da Machiavelli a Napoleone, Roma-Bari, Laterza,2001, pp. 3-40; e cfr. pure R. PUDDU, Eserciti e monarchie nazionali nei secoli XV-XVI, Firenze,
Emilio Gin510
Nella guerra così ritualizzata si scorge forse l’acquisizione più alta dellaciviltà europea raggiunta in materia, ossia la perfetta parità dei soggetti sovrani,non certo quale illusoria rappresentazione della realtà materiale e soltanto invia mediata come presupposto per il perseguimento dell’equilibrio tra lepotenze, ma quale fictio juris che sola poteva prevenire il deragliamento – giu-sta la vitale differenziazione tra militari e civili – della reciproca ostilità versola spirale senza fondo della guerra di sterminio, del bellum internecinum; ilmutuo riconoscimento della legittimità degli interessi altrui da porre sullostesso piano qualitativo dei propri come base per l’eventuale ricomposizionedelle controversie e il ritorno alla pace. Tutto questo, naturalmente, non potevaschermare utopicamente l’Europa dal flagello della guerra, anzi il sistema direlazioni così costituito non ignorava nemmeno l’ipotesi che quest’ultimapotesse essere condotta sino in fondo, sino alla resa totale dell’avversario ealla sua scomparsa dall’agone internazionale, aprendo la via alla debellatiodello sconfitto, ma resta a mio avviso importante sottolineare come, in talemodo, si sia tentato per quanto possibile di trasporre il concetto di annien-tamento dalla base al vertice dell’organizzazione politico-sociale: il justum bel-lum, di agostiniana e tomistica memoria, lasciava il posto alla guerra legittima,anche se condotta sino all’estinzione giuridica dello stato rivale, così come siassisteva alla trasposizione dell’immagine del nemico in quella, non certo menoletale ma almeno più rassicurante, dell’hostis, del legittimo avversario da scon-figgere in una competizione entro limiti e norme genericamente condivisi.
Su questa base risulta comprensibile lo sforzo di Schmitt nel porre l’in-dice sull’importanza della frattura qualitativa creatasi nell’equilibrio concettualedel jus in bello europeo con l’interventismo americano nella prima guerramondiale, sebbene l’analisi del filosofo di Plettenberg non fosse del tuttoimmune da un vizio di inconscia rivalsa nei confronti del paese che aveva resoinevitabile la sconfitta della Germania guglielmina (10), e nonostante il falli-mento ultimo del concerto delle potenze a impedire un conflitto generalizzatoin Europa cui la potenza delle armi forgiate dalla rivoluzione industriale avevaconferito spaventosa intensità.
Naturalmente, la carica polemica infusa nelle parole del politologo tede-sco non deve impedire di guardare ai processi storici nella loro più ampia durata.
La Nuova Italia, 1975, p. 1-38; G. PARKER, La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e ilsorgere dell’Occidente, Bologna, il Mulino, 2005.
(10) Sul punto D. ZOLO, La profezia della guerra globale, a prefazione di C. SCHMITT, Il con-cetto discriminatorio, cit., p. XXV.
Dimenticare Clausewitz? 511
Lo stesso Schmitt si rendeva ben conto che l’ingresso americano nella grandeguerra con le sue conseguenze rappresentava soltanto un passaggio, invero cru-ciale, nel mutamento qualitativo di lungo periodo delle relazioni internazio-nali. Il jus publicum europaeum, in altre parole, non può essere consideratoquale un dogma storiografico vincolante e inossidabile lungo tutto l’arco stessodella sua durata, ma quale tentativo faticoso e concreto di giungere a una siste-mazione dei rapporti bellici che, proprio perché vivo e fattivo in seno allacoscienza giuspolitica europea, poteva conoscere, e conobbe, le sue eccezionie regressioni.
In questa prospettiva non vi è dubbio che la maggiore rottura dell’assettoraggiunto dall’Europa moderna possa essere individuata a partire dall’insor-gere della Rivoluzione francese sulle cui conseguenze a livello ideologico e diestremizzazione della violenza bellica, di criminalizzazione dell’avversario erievocazione del sino allora esorcizzato fantasma della guerra giusta, ben si pos-sono trasporre le parole che Schmitt utilizzò nella riflessione sulla crisi in attoai suoi tempi (11).
Le idee rivoluzionarie infatti, ancor prima di essere esportate con la guerradai governi repubblicani, travalicavano le frontiere combinandosi con le con-traddizioni interne dei diversi stati monarchici mettendone in crisi la stabilitàinterna, facendo riemergere dalla polvere del tempo lo spettro della discordiacivile che da quel momento tornò a protendere la sua scheletrica mano a sup-porto della baionetta, più materiale ma ugualmente devastante, del soldato rego-lare. A molti anni di distanza, nel gennaio del 1823, nel mezzo di una nuovatempesta rivoluzionaria, facendo eco ai timori di Joseph de Maistre sulla dif-fusione delle idee liberali persino tra i ranghi dei tenaci fanti contadini dellasanta Russia (12), de Chateaubriand ricordava a un preoccupato Lord Canningquanto ormai dovessero ritenersi obsoleti i vecchi metodi di gestione dello spi-rito pubblico a fronte della rapidità e pervasività con cui parevano diffondersi,incuranti dello spazio e delle barriere interstatali, i principi «sovversivi» (13).
(11) Come è noto, infatti, lo stesso Schmitt sarebbe molti anni dopo tornato sulla questione,sebbene affrontando il discorso da una prospettiva diversa, proprio partendo dal periodo rivo-luzionario e napoleonico, cfr. C. SCHMITT, Teoria del partigiano, Milano, Adelphi, 2008 [1963].
(12) Cfr. J. DE MAISTRE, Napoleone, la Russia, l’Europa. Dispacci da Pietroburgo, 1811-1813,con introduzione di E. Galli Della Loggia, Roma, Donzelli, 1994, p. 151.
(13) Il passo della lettera è citato in G. BUTRÓN PRIDA, Nuestra Sagrada Causa. El modelogaditano en la revolución piamontesa de 1821, Cádiz, Fundación municipal de cultura, 2007, p. 28.
Emilio Gin512
A riprova di quanto profonde fossero le cicatrici inferte dalla rivoluzionealla natura dei rapporti intereuropei, gli stessi stati vincitori, come è noto, nonpoterono che tentare un mero restauro conservativo di ciò che ancora potevaessere recuperato in campo sociale e politico, e anzi recuperando molti degliaspetti istituzionali perfezionati da Bonaparte. Dal punto di vista internazio-nale è, del resto, significativo che al momento di ingaggiare la battaglia finalecontro l’«Orco Corso» fuggito dall’Elba il Congresso di Vienna si affrettassea dichiararlo nemico pubblico, da considerarsi alla stregua di un brigante efuorilegge, nei confronti del quale non potevano essere applicate le regole rite-nute normali nei confronti di un avversario regolare (14), anticipando in ciòl’atteggiamento di Wilson quando ebbe a dichiarare che gli Stati Uniti nonavevano alcuna ostilità preconcetta nei confronti del popolo della Germaniaimperiale quanto piuttosto dei suoi cattivi governanti, o anche dello stessoChurchill nel suo attacco personale a Mussolini tendente a scindere le colpedell’uomo dal resto del paese nel pieno della seconda guerra mondiale (15).
Al tramonto del pallido sole di Waterloo, comunque, la forza residua deljus publicum europaeum poteva ancora ispirare a saggezza le azioni dei mini-stri rappresentanti le potenze vincitrici, a differenza dei ben meno duraturirisultati ottenuti dai loro corrispettivi convenuti a Parigi, circa un secolo piùtardi, a sancire lo stravolgimento completo della carta politica della vecchiaEuropa sulle ceneri degli Imperi centrali. Non è però secondario notarequanto la stessa Europa restaurata ritenesse ormai necessario per la propriastabilità, sia pure non nell’accordo generale dei suoi attori principali a secondadei diversi momenti, dover ammettere l’eventualità dell’intervento negli affaridomestici di uno stato sovrano eventualmente preda di convulsioni rivolu-zionarie.
Al tempo stesso, nasceva il concerto Europeo, o meglio la prassi del sistemadei congressi, periodiche consultazioni di vertice tra le maggiori potenze suitemi riguardanti la sicurezza e la stabilità, che non solo sarebbe sopravvissutoben oltre il crollo dei trattati di Vienna, all’indomani delle unificazioni nazio-nali italiana e tedesca, ma si sarebbe ben presto esteso anche al di fuori deiconfini geografici dell’Europa, così come la risoluzione del conflitto russogiapponese nel 1905 avrebbe mostrato, sino poi a travasarsi – sebbene con-
(14) J. D. MARKHAM, Abdication, Exile and Return, in Napoleon. The Final Verdict, D. Chandler (ed.), London, Arms and Armour Press, 1996, pp. 143-159.
(15) W. S. CHURCHILL, The Second World War, vol. II, Their Finest Hour, Boston, MarinerBooks, 1986, p. 548.
Dimenticare Clausewitz? 513
taminato da premesse ideologiche differenti – nella costruzione della Societàdelle Nazioni prima e, dopo una ripresa effimera nel periodo postbellico, delleNazioni Unite poi: ulteriore lascito della civiltà europea al cospetto del mondo,proprio nel momento di intraprendere la via del declino quale attrice geopo-litica dominante.
2. Oggi in Spagna, domani ...?
L’otto dicembre del 1798 mentre le schiere di Championnet, disfatto ildebole esercito napoletano mal comandato dal generale austriaco Mack, pro-cedevano all’occupazione del Regno disseminando nelle varie «università» glialberi della rivoluzione appoggiandosi agli elementi locali favorevoli, FerdinandoIV di Napoli lanciava due drammatici appelli alle popolazioni delle Due Sicilieinvitandole ad armarsi e a insorgere per respingere l’invasore. In breve ilfuoco dell’insorgenza divampò per tutte le province divorando il Regno in unaguerra a morte contro lo straniero, ma ancora più feroce contro il nemicointerno, il «giacobino», che lo aveva accolto condividendone il portato ideo-logico. Lo stesso Vincenzo Cuoco ebbe a sottolineare che si trattava della primavolta, a sua memoria, che la monarchia napoletana utilizzava le radici stori-che e quasi etniche delle popolazioni meridionali per spingerle alla lotta e comeespediente della propria politica militare (16): sintomo di quanto, una volta presele armi contro la repubblica francese, il conflitto non potesse essere più fron-teggiato facendo uso unicamente degli strumenti tradizionali del confronto dina-stico e interstatale. Forse è difficile trovare, in questo senso, parole più chiaree penetranti sul mutamento del clima politico europeo di quelle che ebbe autilizzare in seguito Carlo Bianco di San Jorioz, nel discorso preliminare al suotrattato Della guerra nazionale d’insurrezione per bande, applicata all’Italia (17)
Non meno disonorevoli che inumane per avventura, ed empie, parec-chie massime nel presente trattato contenute, potranno a cert’uni parere; cometali eziandio crediamo, da considerarsi, sarebbero, se nelle guerre tra re e reben di rado nazionali, o tra nazione e nazione per particolari convenienze,
(16) V. CUOCO, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, Milano, BUR, 1999, p. 133.(17) Cfr. C. BIANCO DI SAN JORIOZ, Della guerra nazionale d’insurrezione per bande, appli-
cata all’Italia. Trattato dedicato ai buoni italiani da un amico del paese, Italia [Malta], s. n. t.,1830, citato in Democratici, premazziniani, mazziniani e dissidenti, a cura di F. Della Peruta,Torino, Einaudi, 1979, p. 51.
Emilio Gin514
la loro pratica si porponesse; imperciocché non mettendosi in quelle lalibertà o la politica esistenza di un popolo intero in forse, aver non deb-bono l’oppressione o lo sterminio di nessuna delle parti belligeranti periscopo; ma quando di una insurrezione nazionale si tratta, all’unione del paese,alla sua indipendenza e libertà diretta, per quei sacrosanti oggetti, i piùessenziali ed i più cari agli uomini dabbene, intrapresa, quando quegl’ina-lienabili diritti, dallo straniero e dai tiranni nazionali conculcati, si voglionofermamente colla forza riprendere; allora ben lungi di doversi con tali sozzedenominazioni qualificare, si debbono in conto di giuste non solo ma di santedag’insorti tenere. Deve la santità del motivo rendere di niun valore qua-lunque considerazione di onore, d’umanità e di religione che ad un fine cosìsublime, così sacrosanto si opponga.
La santità della causa, dunque, giustificava il venir meno di qualsiasiregola morale o convenzionale di solito operante nella guerra tra stati; qua-lunque ferocia sarebbe stata giustificabile quando fossero in gioco la libertà ol’indipendenza di tutto un popolo. Empietà e disumanità divenivano, sotto taleluce, concetti da considerarsi relativi. Da quegli anni in Europa conflitto civilee guerra regolare, campagne militari e insorgenza popolare, si sarebbero intrec-ciati molto più strettamente rispetto al passato marcando una caratteristicaaggiuntiva dell’epoca contemporanea rispetto all’ultima metà dell’Evo moderno.
A pochi anni dall’invasione francese del mezzogiorno italiano poc’anzi ricor-data, le contrade meridionali, a seguito della nuova discesa transalpina, sareb-bero divenute teatro di una rinnovata insorgenza, stavolta appoggiata benchéin modo effimero dagli inglesi (18), prefigurando i termini del problema attornoa cui si sarebbe snodato il dibattito successivo sulla guerra irregolare: il valoredell’appoggio di un esercito regolare, i sentimenti della popolazione, la naturae l’atteggiamento della potenza occupante e la formazione e composizione dellebande guerrigliere. Di lì a poco, il vittorioso levantamiento generale del popolo
(18) Cfr. A. VALENTE, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale, Torino, Einaudi, 1965, p. 129e ss., p. 147 e ss., 175 e ss., e 207 e ss.; J. RAMBAUD, Naples sous Joseph Bonaparte, Paris, Plon,1911, p. 164 e ss., G. FERRARI, L’insurrezione calabrese nel 1806 e l’assedio di Amantea, in«Memorie Storico-Militari», n. 1, 1911; F. BARRA, Il brigantaggio del decennio francese, Salerno,Plectica, 2003; per un approccio al fenomeno nel più ampio quadro strategico della lotta nelmediterraneo cfr. W. H. FLAYHART, Counterpoint to Trafalgar: The Anglo-Russian Invasion of Naples,1805-6, South Carolina, University of South Carolina Press, 1992; M. C. FRIDLEY, Prelude toSpain: The Calabrian Insurrection, 1806-7, in «Military Affairs», vol. 40, n. 2, (1976), pp. 84-7,che si fonda sulla documentazione conservata presso l’Archivio nazionale di Parigi, ed. M. FINLEY,The Most Monstrous of Wars: The Napoleonic Guerrilla War in Southern Italy, Columbia S.,University of South Carolina Press, 1994.
Dimenticare Clausewitz? 515
spagnolo contro Napoleone avrebbe poi fornito il modello ideale e vincentecui fare riferimento lungo tutto il corso dell’Ottocento.
L’atteggiamento dell’imperatore dei francesi è pertanto significativo pro-prio della difficoltà, non solo teorica e concettuale ma anche politica e per-sino propagandistica, a ricomporre in un’unica fisionomia entrambi i volti –regolare e irregolare – della guerra che gli eventi successivi alla sanguinosagiornata del dos de mayo avevano proiettato alla ribalta del panorama bellico.All’apogeo del suo potere, infatti, Napoleone avrebbe costantemente rifiutatodi concedere alla rivolta spagnola alcuna patente di legittimità continuando aritenere, e trattare, i suoi protagonisti alla stregua di banditi e grassatori.Soltanto alla fine, dalla solitaria roccia di Sant’Elena, egli avrebbe sia pure adenti stretti riconosciuto il ruolo dell’insorgenza nell’economia generale del con-flitto e nel novero delle cause della sua rovina; ma sempre evitando di scen-dere sul piano di una completa equiparazione del metodo della guerra irre-golare, con i suoi orrori e la sua apparente mancanza di regole, rispetto allaguerre en forme della quale sin quasi all’ultimo si era dimostrato insuperabilemaestro, anzi escludendo che quel metodo potesse essere degno dei civilipopoli d’Europa.
Se il figlio della rivoluzione tradiva nel suo giudizio tutta l’ambiguità gene-tica della sua peculiare posizione politica che lo portava a voler stabilizzaresecondo canoni «tradizionali» proprio l’assetto internazionale del vecchio con-tinente sconvolto dalle passioni politiche sorte dalle ceneri della Bastiglia, ilsuo maggiore interprete, il barone Jomini, ne avrebbe ben riassunto le parolecaricandone al contempo i toni (19). Ciononostante egli, che tra l’altro avevaavuto modo di constatare di persona la violenza e l’efficacia dell’insurrezionespagnola, nella sua impostazione geometrica della strategia, pur ritenendolaun’impresa difficile e disperata, non escluse l’eventualità per un esercito rego-lare, sufficientemente forte da occupare i maggiori punti sensibili di un paese,di poter efficacemente affrontare la minaccia costituita da un popolo inarmi (20). Oltretutto, per il teorico svizzero, l’idea stessa della guerriglia, conla sua caratteristica dispersione delle forze su un ampio territorio, contraddi-ceva il principio della concentrazione della massa decisiva nel punto deboledell’avversario che solo un’armata di militari sarebbe stata in grado di attuareper sferrare un colpo decisivo. Logico corollario di tale impostazione era, per
(19) A. H. JOMINI, Précis de l’art de la guerre, Paris, Anselin, 1838, I, p. 29 e ss.(20) Ivi, p. 32.
Emilio Gin516
Jomini, l’indispensabilità dell’appoggio di un corpo di spedizione regolare, comeproprio il caso spagnolo aveva dimostrato, per la buona riuscita di una insur-rezione (21).
Impostazione completamente diversa, invece, quella di Clausewitz il qualerecependo il mutamento anche qualitativo dei caratteri che la guerra avevaassunto nella svolta rivoluzionaria dedicò molta attenzione, nella sua sistema-zione teorica, agli aspetti relativi alla guerra di popolo e nazionale ritenendoanzi, nonostante le critiche di molta della produzione scientifica e della pub-blicistica odierne, che fosse ormai impossibile effettuare una netta separazionetra i due metodi di lotta nei conflitti del futuro (22).
A partire dall’esempio spagnolo, infatti, gli studi sulla guerra irregolarelungo il XIX secolo mutarono sensibilmente di valore. Termini quali partigianoe guerriglia potevano essere datati a un periodo anteriore alla rivoluzione fran-cese ma essi rientravano ancora, nel Settecento, nel più ristretto novero delleoperazioni condotte da truppe leggere o semi-regolari a margine delle cam-pagne gestite dagli eserciti permanenti, ossia in ciò che con varietà di lemmiveniva definita la «piccola guerra», «guerra alla spezzata», «guerra alla spic-ciolata» e termini simili a cui applicare concetti e principi consolidati già dallasapienza bellica romana (23). Operazioni e marce notturne, valore della sor-presa, trattamento umano dei prigionieri e della popolazione locale, disper-sione delle forze di fronte a numeri superiori, rifiuto di indulgere a tentazionidi difesa statica, concezione elastica del controllo del territorio e sfruttamentodelle sue asperità naturali, mobilità continua e natura offensiva delle proprieazioni erano infatti nozioni già largamente acquisite che ancora oggi figuranonel manuale di operazioni di ogni buon guerrigliero; ma dinanzi al deraglia-mento della violenza bellica successivo agli eventi rivoluzionari però, gli studiottocenteschi non potevano più non tenere conto della possibilità che a con-durre operazioni di tal genere potesse essere direttamente il popolo in armi:correttamente, in tal senso, Jomini aveva individuato nel dosaggio delle forzedell’occupante e nell’eventuale supporto regolare esterno agli insorgenti duedei fondamentali problemi della guerra insurrezionale, ma era naturale che per
(21) Ivi, p. 30.(22) Cfr. W. LAQUEUR, The Origins of the Guerrilla Doctrine, «Journal of Contemporary
History». vol. 10, n. 3 (Jul. 1975), pp. 350 e ss.; lavoro ripreso e ampliato in ID., Guerrilla: AHistorical and Critical Study, London, Weidenfeld and Nicolson, 1977.
(23) Cfr. W. LAQUEUR, The Origins of the Guerrilla Doctrine, cit., pp. 341-382, e F. BOTTI,Il pensiero militare e navale italiano dalla Rivoluzione francese alla Prima Guerra Mondiale, Roma,Ufficio Storico SME, I, 1995, p. 842 e ss.
Dimenticare Clausewitz? 517
coloro che si ponevano, all’opposto, il problema di dover innescare la scin-tilla della rivoluzione, e di doverla gestire, a tutto questo si aggiungesse ildilemma di come sfruttare l’armamentario teorico e pratico della guerriglia inassenza di un esercito regolare su cui contare.
Per limitarci, a grandi linee, al dibattito in ambito italiano vi è da rilevarela differenza nell’impostazione tra Mazzini e Carlo Bianco per il quale la for-mazione delle bande guerrigliere non solo avrebbe dovuto anticipare l’insur-rezione, di cui avrebbero costituito una sorta di innesco, ma con un usointenso e senza remore delle tecniche di guerriglia avrebbero potuto anche con-durre a logorare l’avversario senza dover ricorrere alla costituzione di un rego-lare esercito rivoluzionario. Il settario piemontese avrebbe col tempo mutatoin parte la sua visione giungendo a riconoscere, sulla spinta della teorizzazionemazziniana, l’importanza di dover porre mano alla forgiatura di un organismoben strutturato in grado di reggere il campo aperto contro gli agguerriti bat-taglioni imperiali e dinastici (24). Non credo sia il caso di tentare sempre labilie pericolose ipotesi di filiazioni teoriche, ma resta comunque suggestivo notarequanto il dibattito teorico italiano a metà Ottocento contenesse già, per certiaspetti, alcune delle problematiche della guerra partigiana divenute poi cele-bri nel secolo successivo; e forte è la tentazione di accostare almeno a livellodi termine di paragone Mazzini, nello specifico della sua teoria dello sviluppoprogressivo della rivoluzione dalla rivolta iniziale e alla costituzione delle bandesino alla nascita dell’esercito popolare – esulando dunque dal tema specificosul rapporto città/campagne –, a Mao e, per converso, intravvedere sulla teo-ria del foquismo del Che Guevara per lo meno aleggiante lo spirito del sanJorioz (25). Diversa e peculiare nel suo genere, invece, si poneva sul tema laposizione del napoletano Pisacane il cui retaggio di militare di carriera lo avrebbecondotto a molto svalutare le possibilità di riuscita della guerra per bande, el’utilità delle formazioni di volontari (che lo avrebbe portato, come è noto, auna serrata polemica con Garibaldi), e a teorizzare invece la formazione del-l’esercito regolare rivoluzionario immediatamente a ridosso della riuscita insur-rezione nelle città (26).
(24) F. DELLA PERUTA in Democratici, premazziniani, cit., p. 42.(25) Cfr. pure E. LIBERTI, Tecniche della guerra partigiana nel Risorgimento. Testi di autori
mazziniani, Firenze, Giunti Barbera, 1972; C. JEAN, Guerra di popolo e guerra per bande nell’Italiadel Risorgimento, in «Rivista Militare», n. 6, 1981; V. ILARI, Riflessioni critiche sulla teoria poli-tica della guerra di popolo, in «Memorie storico-militari», 1983.
(26) C. PISACANE, Saggi storici-politici-militari sull’Italia, a cura di A. Romano, Milano, Ed.Avanti, 1957; ID. La guerra combattuta in Italia negli anni 1848-1849, a cura di A. Romano,
Emilio Gin518
A ogni modo, le divergenze sul valore della guerriglia, e soprattutto sullaliceità in sede di elaborazione teorica del suo accoglimento anche quale strumentoutilizzabile a livello strategico e non più soltanto come mero espediente tattico,non marcavano però le linee di differenza solo nel campo rivoluzionario, ma siripresentarono nel pensiero militare europeo lungo tutto il corso del secolo.
Risultò abbastanza condivisa la sensazione che il metodo della guerrigliafosse applicabile solo in particolari contesti nazionali, fosse un espedienteesclusivamente difensivo quale eventuale supporto all’esercito regolare duranteuna invasione straniera e che, come evidenziato da Clausewitz stesso, avessecome prerequisito indispensabile una certa vastità e conformazione fisica delterritorio. La guerra del 1870, pur decisa dallo scontro delle armate regolari,col suo strascico di guerriglia, aggiunse altra acqua al mulino della discussione,ma anche in tal caso il risultato in sede critica fu abbastanza ambiguo dalmomento che, oltre a rafforzare la convinzione jominiana che tale espedientefosse da bandire dal consesso delle nazioni civili, la sconfitta francese sembròdimostrare che i costi morali, umani ed economici di un simile modo di con-durre le operazioni su vasta scala non potessero essere sostenuti troppo a lungoda una progredita società europea (27). In definitiva, il caso spagnolo accen-deva le speranze dei rivoluzionari di mezza Europa, ma ci si rendeva ancheconto degli ostacoli a gestire con successo un metodo che continuò a esserecomunque ritenuto appannaggio di popoli più primitivi. Risulta pertantoalquanto significativo che in Francia, anche all’indomani della conclusionedella prima guerra mondiale, gli insuccessi e le difficoltà dell’esercito sui campidi battaglia europei vennero da più d’uno ascritti proprio al carattere «colo-niale» di gran parte delle sue unità, impiegate costantemente nelle lunghe cam-pagne per la costruzione dell’impero francese e mai sperimentate in battaglieconvenzionali (28). La stessa guerra civile in Russia non ebbe un impatto deci-
Milano, Ed. Avanti, 1961; ID., Scritti vari, inediti e rari, a cura di A. Romano, Milano, Ed. Avanti,1964; per un commento critico più recente cfr. F. BOTTI, Il pensiero, cit., II, pp. 261-339.
(27) G. E. ROTHENBERG, Moltke, Schlieffen and the Doctrine of Strategic Envelopment, in Makersof Modern Strategy, cit., p. 305; cfr. sul punto anche M. HOWARD, The Franco-Prussian War. TheGerman Invasion of France, New York, Macmillan, 1961, p. 249 e ss.; cfr. pure P. BUCHANAN
HATLEY, The Rise of Guerrilla Forces During the Franco-Prussian War of 1870-1871, Galveston,Texas A & M University, 1988, e ID., Prolonging the Inevitable: The Franc-Tireur and the GermanArmy in the Franco-German War of 1870-1871, Manhattan (Ks), Kansas State University, 1997.
(28) Cfr. D. PORCH, Bugeaud, Gallieni, Lyautey: The Development of French Colonial Warfare,in Makers of Modern Strategy, cit., pp. 376-407, in part. pp. 402 e ss.; cfr. pure M. MICHEL,L’appel à l’Afrique, contributions et reactions a l’effort de guerre en AOF, 1914-1919, Paris,Publications de la Sorbonne, 1982.
Dimenticare Clausewitz? 519
sivo in materia vista la preponderanza rapidamente assunta in essa dalla com-ponente regolare degli opposti schieramenti. La vittoria comunista in Cina, ibagliori di Dien Bien Phu e le crepe sempre più minacciose nell’edificio colo-niale europeo prima, e le disavventure americane nelle «piccole guerre» poi,avrebbero drammaticamente riportato la guerriglia, o meglio il problema dellasua traslazione dall’ambito tattico a quello strategico, all’attenzione della comu-nità strategica occidentale.
3. Requiem per un sovrano
Prima di continuare il discorso sull’evoluzione della percezione della guerrairregolare nella seconda metà del Novecento e giungere alle più moderne teo-rizzazioni riguardanti il mutamento progressivo nell’odierna natura della guerrasino all’asserita obsolescenza della teoria clausewitziana in merito, è però a mioavviso necessario sottolineare preventivamente anche un altro aspetto della que-stione.
Come si è visto, tanto Schmitt quanto Gramsci concordemente indivi-duavano la causa della crisi dei loro tempi nell’indebolimento del pilastroprincipale che sorreggeva l’impianto dello jus publicum europaeum, ossia lo stato.Schiacciato, per Schmitt, dalle teorie sovranazionali e umanitaristiche di stampoanglosassone al cui peso il filosofo italiano aggiungeva la pervasività del capi-talismo, anche se per quest’ultimo tale indebolimento si inscriveva in modonaturale nel processo storico di lungo periodo che si sarebbe concluso con larivoluzione e l’estinzione dello stato stesso secondo i dettami dell’interpreta-zione leniniana di Marx ed Engels. D’altra parte, come anche Lenin non avevamancato di ricordare, lo stesso Engels, oltre ad accettare la visione della nascitadello stato moderno quale ultima istanza per garantire la pace interna (seb-bene con la forza e a vantaggio della classe dominante), ne aveva intravisto lacrisi a causa della potenza dei trusts e del capitalismo finanziario già dai primianni ’90 del XIX secolo (29). A ogni modo, sulla decadenza dello stato e sullasua progressiva perdita della posizione centrale cui i secoli della storia modernal’avevano innalzato, e soprattutto sulla sua progressiva incapacità di giocareun ruolo prioritario nella preparazione e conduzione della guerra già altri ave-vano avuto modo di esprimersi.
(29) Cfr. N. LENIN, Stato e Rivoluzione, in Opere Scelte, Roma, Editori Riuniti, s.d., vol. IV,pp. 236-9.
Emilio Gin520
Sviluppando alle estreme conseguenze le premesse tratte dalle elucubra-zioni che Norman Angell avrebbe rifuso nella sua Grande Illusione (30), R. M.Mac Iver, nel 1912, sottolineava gli immensi vantaggi dell’avvenuta integrazioneeconomica globale, della sempre più stretta interconnessione delle società edegli individui delle varie nazioni, del consolidarsi sempre più nitido dell’o-pinione pubblica generale, proclamando l’ormai impossibilità dell’insorgere diconflitti fra stati a seguito della loro virtuale irrilevanza rispetto alla possanzainsita in questa sorta di neonata società mondiale (31). Su un binario paralleloma in modo singolarmente speculare si muovevano anche le previsioni di chi,a fronte della forza raggiunta dalla socialdemocrazia tedesca e nei diversi paesiindustrializzati, riteneva invero remota la possibilità che lo stato borghesepotesse ancora avere la forza di trascinare i propri cittadini sui campi di bat-taglia senza rischiare di innescare un processo di scioperi generali che avreb-bero colpito al cuore qualsiasi tentativo di mobilitazione bellica (32). È appenail caso di sottolineare che al momento in cui Mac Iver vergava le sue paginedi speranza l’orologio della storia contava soltanto poco più di due anni alloscoppio della prima guerra mondiale.
A ogni modo, nel dibattito giuspolitico e politologico nell’immediatodopoguerra, sulla scorta delle teorie internazionalistiche e della costruzione dellaSocietà delle Nazioni, sarebbe tornata con forza la percezione della decadenzae della diminuita importanza degli stati nel contesto internazionale, o quantomeno l’esigenza di doverne limitare anche artificialmente la loro autonomia alfine di garantire la concreta applicazione del concetto di sicurezza collettivae di diplomazia aperta. Come Schmitt non avrebbe mancato di riportare nellasua critica, si assisteva allo sforzo congiunto, sebbene con impostazioni cul-turali diverse, di settori importanti della dottrina anglosassone e francese diriformulare le basi giuridiche del diritto internazionale (33). Lo stato, perdutala sua posizione centrale, doveva essere considerato solo una delle diverse forme
(30) N. ANGELL, The Great Illusion. A Study of the Relation of Military Power in Nationsto Their Economic and Social Advantage, New York-London, Putnam’s Sons, 1911.
(31) Cfr. R. M. MAC IVER, War and Civilization, in «International Journal of Ethics», vol.22, n. 2 (Jan. 1912), pp. 127-145.
(32) S. NEUMANN – M. VON HAGEN, Engels, Marx on Revolution, War, and the Army in Society,in Makers of Modern Strategy, cit., pp. 262-280; A. JANOS, Unconventional Warfare, cit., p. 641;M. E. NOLAN, The Inverted Mirror. Mythologizing the Enemy in France and Germany, 1898-1914, New York, Berghahn, 2005, p. 92 e ss.
(33) C. SCHMITT, Il concetto discriminatorio, cit., p. 15 e ss.
Dimenticare Clausewitz? 521
di aggregazione umana, mentre l’individuo assurgeva a unico soggetto di dirittila cui tutela doveva ora essere devoluta all’auspicato potere normativo dellaSocietà delle Nazioni e delle altre istituzioni sovranazionali alle cui direttiveil diritto positivo dei singoli paesi avrebbe dovuto gradualmente uniformarsi.In tale prospettiva non poteva essere escluso il diritto di ingerenza negli affariinterni a scopo umanitario e venivano poste serie ipoteche giuridiche anchesullo stesso concetto di neutralità (34) – altro cardine dell’esecrando jus ad bel-lum – in presenza di palesi violazioni della pace. La guerra, retaggio dell’an-tica anarchia dei vari stati, lungi dall’essere considerata l’ultima legittima ratioregum andava espunta dalla teoria del diritto internazionale e confinata oltreil recinto della legalità così come la stessa pratica pattizia degli stati, con lasigla del patto Briand-Kellogg, lasciava sperare.
La crisi in Estremo Oriente, la guerra d’Etiopia e l’aggressione aperta delGiappone nei confronti della Cina avrebbero però assestato un duro colpo atali speranze e alla capacità della Società delle Nazioni – falcidiata dalle defe-zioni mal compensate dall’interessato ingresso dell’Urss – a scoraggiare l’in-sorgere dei conflitti ribadendo, con forza e con la forza, la perdurante vita-lità non certo dello jus publicum europaeum ma almeno di quello che ne erastato il suo presupposto, ossia lo stato sovrano.
A pochi mesi dall’ingresso delle armate italiane sul suolo etiopico e di fronteal contraddittorio atteggiamento dei delegati abissino e italiano accreditati aGinevra entrambi giustificanti le azioni dei propri paesi in base al diritto inter-nazionale vigente, George Grafton Wilson rilevava tutte le aporie cui potevacondurre un’interpretazione rigida dello spirito del Covenant e la difficoltà afar combaciare la teoria della sicurezza collettiva con la realtà (35). Non solo,
(34) Sulla lunga durata di tali idee nel dibattito politico americano cfr. il saggio di D. LUBAN,The Romance of the Nation-State, in «Philosophy and Public Affairs», vol. 9, n. 4 (Summer1980), pp. 392-397 che rivendicando l’universalità dei diritti umani derivanti dall’Illuminismoriattualizza i termini di guerra giusta e intervento umanitario che sarebbero stati poi riportatiin auge, più recentemente, nella concezione neocon della politica estera statunitense; cfr. anche,ad esempio, il significativo discorso (disponibile su www.alleanzacattolica.org/comunicati/-acnews/acnews002_03.htm) tenuto il 20 febbraio 2003 dal politologo americano Michael Novakin presenza dell’ambasciatore USA in Italia proprio a ridosso dell’invasione dell’Iraq; per unasintesi della tradizione filosofica del concetto di guerra giusta e un’analisi della sua correlazionecon l’interventismo umanitario degli anni ’90 del XX secolo cfr. invece M. FIXDAL - D. SMITH,Humanitarian Intervention and Just War, in «Mershon International Studies Review», vol. 42,n. 2 (Nov. 1998), pp. 283-312.
(35) G. GRAFTON WILSON, When Does War Begin?, in «The American Journal of InternationalLaw», vol. 30, n. 1 (Jan. 1936), pp. 80-3.
Emilio Gin522
infatti, non poteva essere ignorato il comportamento degli stati non aderentialla Società ginevrina, quali ad esempio gli stessi Stati Uniti; ma in presenzadel fallimento delle sanzioni a intralciare seriamente lo sforzo bellico italiano,anche a causa dell’ambigua posizione di membri stessi della Società, sorgevail non indifferente problema giuridico di come qualificare questi ultimi nel casoavessero scelto di non sanzionare lo stato eventualmente riconosciuto qualeaggressore. Già nel 1932, a ridosso della crisi della Manciuria, Quincy Wright,riecheggiando i discorsi di Briand e Stimson, aveva notato l’insufficienza a ricor-rere alla definizione dello stato di guerra in senso legale, cioè dichiarato o invo-cato da almeno uno dei due belligeranti, per un corretto funzionamento deglistrumenti giuridici previsti dagli articoli della Società e del Patto Kellogg (36).La sicurezza collettiva, di fronte alla indisciplina degli stati, faceva ormai acquada tutte le parti.
Il cataclisma della seconda guerra mondiale condusse, come era prevedi-bile, al duplice sforzo di ricostruzione di un ente sovranazionale di controlloper la limitazione dei conflitti e di restaurazione del connesso principio giu-ridico dello justum bellum. Hans Kelsen, nel pieno della bufera, aggiunse lapropria autorevole voce a quanti (37), sull’onda della nascita del patto delleNazioni Unite, ritenevano ormai indispensabile una limitazione del poteredegli stati sovrani (38)
Whether or not international law can be considered as true law dependsupon whether it is possible to interpret international law in the sense of atheory of bellum justum, whether it is possible to assume that, according togeneral international law, war is in principle forbidden, being permitted onlyas a sanction, that is, as a reaction against a delict.
(36) Q. WRIGHT, When does War Exist?, in «The American Journal of International Law»,vol. 26, n. 2 (Apr. 1932), pp. 362-368. Sulla fallacia delle disquisizioni giuridiche e con unavisione molto più pragmatica della reale situazione internazionale cfr. il quasi contemporaneoarticolo di E. M. BORCHARD, “War” and “Peace”, «The American Journal of International Law»vol. 27, n. 1 (Jan. 1933), pp. 114-117; su una lunghezza d’onda simile, in un contento inter-nazionale ancora più deteriorato, cfr. le riflessioni di C. G. FENWICK, War Without Declaration,«The American Journal of International Law», vol. 31, n. 4 (Oct. 1937), pp. 694-696. Sui pro-blemi posti dallo status di neutralità cfr. invece ancora G. GRAFTON WILSON, War and Neutrality,«The American Journal of International Law», vol. 27, n. 4 (Oct. 1933), pp. 724-725.
(37) Cfr. ad esempio P. E. CORBETT, The Future of Nationalism and the Nation State, in«Annals of the American Academy of Political and Social Science», vol. 218 (Nov. 1941), pp.153-161.
(38) H. KELSEN, War and Peace in International Relations, Cambridge, Harvard UniversityPress, 1942, p. 52.
Dimenticare Clausewitz? 523
Sebbene già lo scoppio della guerra di Corea avrebbe diviso, ancora unavolta, studiosi e giuristi sull’effettività della messa al bando dell’impiego dellaforza quale mezzo legittimo di risoluzione delle controversie internazionali, con-trapponendo chi vedeva nell’intervento delle Nazioni Unite proprio la con-ferma dell’affidabilità del concetto di difesa collettiva a quanti realisticamentene rilevavano la debolezza nell’impedire il ciclico ritorno della guerra tradi-zionale (39), la percezione della diminuita capacità degli stati a gestire in modomeno efficace rispetto al passato il fenomeno guerra – dunque venendo menoa una delle prerogative fondamentali della sovranità – proveniva però non sol-tanto dal rinnovato vigore delle teorie sovranazionali, e dalle istituzioni mul-tilaterali, ma dal drastico salto qualitativo compiuto dalla tecnologia bellicadurante il recente conflitto mondiale.
A molti infatti, nonostante l’utilizzo teorico dell’arma atomica venisseaccettato solo gradualmente nel calcolo degli stati maggiori occidentali sull’ondamontante della guerra fredda (40), parve che il fungo mortale di Hiroshimaavesse risucchiato in sé tutti i parametri della strategia tradizionale rendendoobsolete le armi cosiddette convenzionali (41), isolate in un ruolo sempre piùincerto, lasciando balenare in modo illusorio e paradossale la speranza che lapotenza dell’«arma assoluta» avesse vaporizzato non solo le ultime vittime delsecondo conflitto mondiale ma la possibilità stessa della guerra.
Ma, in maniera forse più subdola, il potere nucleare sembrava aver offu-scato proprio la capacità degli stati sovrani a garantire la sicurezza dei propriconfini territoriali e l’incolumità dei propri cittadini dalle offese esterne,facendo precipitare il mondo a una situazione che allo storico britannicoMichael Howard pareva presentare molti punti di similitudine con l’epoca pre-moderna quando i principi e i feudatari non potevano impedire le incursionidei vicini malintenzionati sul proprio territorio (42). Già a fine anni Cinquanta
(39) Q. WRIGHT, The Outlawry of War and the Law of War, in «The America Journal ofInternational Law» vol. 47, n. 3 (Jul. 1953), pp. 365-376, in. part. pp. 368-369, sulla contro-versia cfr. pure in particolare M. MAURER, The Korean Conflict Was a War, in «Military Affairs»,vol. 24, n. 3 (Autumn 1960), pp. 137-145.
(40) L. FREEDMAN, The First Two Generations of Nuclear Strategists, in Makers of ModernStrategy, cit., pp. 735-778; ID., The Evolution of Nuclear Strategy, New York, St. Martin’s, 1981;cfr. pure i saggi raccolti in Nuclear Heuristics: Selected Writings of Albert and Alberta Wolshstetter,R. Zarate, H. Sokolski (eds.), Carlisle, Strategic Studies Institute, 2009.
(41) M. HOWARD, The Relevance of Traditional Strategy, in «Foreign Affairs», vol. 51, n. 2,(Jan. 1973), pp. 253-266.
(42) Ivi, pp. 253-254.
Emilio Gin524
per John Herz appariva chiaro, alla luce accecante della bomba atomica e delleteorie internazionalistiche, che il processo di deterritorializzazione del concettodi stato così inaugurato fosse ormai inarrestabile, pur senza ancora intravve-dere quale avrebbe potuto essere il futuro assetto della scena mondiale unavolta calato il sipario sui suoi tradizionali «attori» (43).
In sostanza, però, l’apparizione dell’arma atomica sembra avere avuto uneffetto paragonabile, pur nella diversità delle proporzioni, a quello ottenutodall’impiego dell’arma aerea nel primo conflitto mondiale e dalle teorie sulpotere dell’aeronautica nei primi anni del dopoguerra elaborate da GiulioDouhet in Italia, e in parallelo da William «Billy» Mitchell negli Stati Uniti (44).Anche all’epoca fu infatti ipotizzato che le potenzialità della nuova arma,soprattutto se impiegata per colpire in modo massiccio con gas tossici le cittànemiche, avrebbero sconvolto i dettami della pratica bellica consolidata, rele-gando a un ruolo sempre più marginale gli eserciti terrestri e le flotte e soprat-tutto erodendo un altro dei cardini della guerra tradizionale – e dello stato –ossia la classica distinzione tra militari e popolazione civile.
Internazionalismo e istituzioni sovranazionali, tecnologia bellica e dilemmanucleare, apparizione del concetto di superpotenza con le relative sfere diinfluenza e di alleanza nel secondo dopoguerra, in cui riconoscere l’avvenutamenomazione della sovranità dei più deboli partners o satelliti, non hanno peròcondotto facilmente, in sede di elaborazione teorica, all’unanime dichiarazionedi morte del vecchio stato nazionale quale protagonista di primo livello nelloscenario mondiale. Quest’ultimo anzi è stato, ancora a lungo, identificato dallascuola neorealista statunitense (45), pur nella diversità dei propri approcci
(43) Cfr. J. HERZ, Rise and Demise of the Territorial State, in «World Politics», vol. 9 (1957),pp. 473 e ss.; tesi poi successivamente ampliata e rielaborata in ID., International Politics in theAtomic Age, New York, Columbia University Press, 1959.
(44) Sulle origini del douhettismo cfr. A. GAT, A History of Military Thought. From theEnlightenment to the Cold War, New York, Oxford University Press, 2001, pp. 561-597, maanche P. VERGANO, Origins of Aviation in Italy, 1783-1918, Genoa, Intyprint, 1964; C. SERGÈ,Douhet in Italy: Profet, without Honor?, in «Aerospace Historian», (June 1979), pp. 69-80; ID.,Giulio Douhet: Strategist, Theorist, Prophet?, in «Journal of Strategic Studies», vol. 15, (1992),pp. 351-366 e D. MACISAAC, Voices from the Central Blue: The Air Power Theorists, in Makersof Modern Strategy, cit., pp. 624-647; su Mitchell, il quale avrebbe sottolineato con più chia-rezza anche i vantaggi dell’impiego tattico dell’arma aerea, cfr. invece I. D. LEVINE, Mitchell:Pioneer of Air Power, New York, Duell, Sloan and Pearce, 1943, e A. F. HURLEY, Billy Mitchell:Crusader for Air Power, New York, Watts, 1964.
(45) La letteratura in materia è semplicemente sterminata, e non è possible riassumerla indettaglio in questa sede, cfr. comunque almeno E. GULICK, Europe’s Classical Balance of Power,
Dimenticare Clausewitz? 525
metodologici e nella problematicità dei suoi risultati, come un ambiente natu-rale dominato dalla vita e dall’attività degli stati superiorem non recognoscen-tes. E nell’ambito specifico del rapporto tra soggetti internazionali ed eventibellici imponente è stato lo sforzo concomitante di interpretazione volto a inda-gare la frequenza e le cause dell’insorgenza dei conflitti tenendo conto dellevariabili più disparate quali, ad esempio, l’ascesa e il declino di particolari grandipotenze, la presenza di uno stato in posizione egemonica rispetto ad altri o,al contrario, una situazione di sostanziale equilibrio tra i diversi soggetti (46).
L’impetuoso sviluppo economico dell’occidente, la nascita del welfare stateassieme a quella di nuove strutture sovranazionali, quali la Comunità Europea,che si affiancavano alle istituzioni già esistenti per la coordinazione economicascaturite dagli accordi di Bretton Woods e l’attività sempre più sensibile delleorganizzazioni non statali a livello internazionale contribuirono però a rinfo-colare, sul finire degli anni Settanta, i dubbi sulla vitalità e sul destino deglistati nazionali (47). Questi elementi, nel giudizio di Wolfram Hanrieder, anda-vano infatti ad aggiungere la loro forza corrosiva al processo di deterritoria-lizzazione già prodotto dall’avvento della bomba atomica e della guerra fredda.Più in particolare, i costi di gestione del welfare e l’integrazione sempre piùstretta delle economie europee, americana e giapponese, «la Triade» del mondosviluppato, avevano condotto a una sorta di «domesticazione» dei problemiinternazionali, rovesciando la classica predominanza della politica estera su quellainterna, rendendone sempre più problematica la soluzione se non ricorrendo
Ithaca, Cornell University Press, 1955; K. N. WALTZ, Man, the State, and War: A TheoreticalAnalysis, New York, Columbia University Press, 1959; ID., Theory of International Politics, Reading,Addison-Wesley, 1979; H. J. MORGENTHAU – KENNETH W. THOMPSON, Politics Among Nations:the Struggle for Power and Peace, New York, Alfred Knopf, 1985 (6th Ed.); cfr. soprattutto anchei saggi contenuti nel volume Neorealism and Its Critics, a cura di R. O. Keohane, New York,Columbia University Press, 1986.
(46) E. HAAS, The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda?, in «WorldPolitics», vol. 5, (1953); J. A. VASQUEZ, Capability, Types of War, Peace, in «The WesternPolitical Quarterly», vol. 39, n. 2 (Jun. 1986), pp. 313-327; R. GILPIN, The Theory of HegemonicWar, in «Journal of Interdisciplinary History», vol. 18, n. 4 (Spring 1988), pp. 591-613 il qualeapplica la teoria al contesto particolare della Grecia classica e alla rivalità tra Sparta e Atene;P. JAMES, Structural Realism and the Causes of War, in «Mershon International Studies Review»,vol. 39, n. 2 (Oct. 1995), pp. 181-208 e la nutrita bibliografia riportata dall’autore nell’ap-pendice.
(47) Cfr. ad esempio C. E. BLACK, The Dynamics of Modernization, New York, Harper &Row, 1966; H. R. WAGNER, Dissolving the State: Three Recent Perspectives on InternationalRelations, in «International Organization», vol. 28 (1974), pp. 435-466; E. L. MORSE, Modernizationand the Transformation of International Relations, New York, Free Press, 1976.
Emilio Gin526
al piano – sulla scorta dell’esperienza dello shock petrolifero e della crisi deldollaro – della cooperazione collettiva (48). Sebbene il politologo californianonon si nascondesse affatto la forza persistente del nazionalismo e della forma-stato e si guardasse bene dal prevederne la scomparsa, e anzi ne prevedesseper il futuro addirittura un rafforzamento numerico alla luce delle recenti espe-rienze del processo di decolonizzazione, molti dei temi da lui toccati si sareb-bero poi ritrovati nel dibattito degli anni successivi a seguito degli inattesi esbalorditivi sviluppi seguiti al dissolvimento del sistema imperiale sovietico. Adar nuovo fiato nelle trombe di Gerico per assistere all’imminente crollo dellostato sarebbero, infatti, intervenuti gli odierni sostenitori e gli studiosi dellacosiddetta globalizzazione modulando la loro melodia su toni non però deltutto originali (49).
Ancora una volta il capitalismo, stavolta vittoriosamente diffusosi al di làdella vecchia cortina di ferro attraverso la breccia nel muro di Berlino, avrebberappresentato il ritornello su cui intonare il de profundis per il vecchio sovranoormai paralizzato nel suo braccio economico dall’onnipotenza delle imprese
(48) W. F. HANRIEDER, Dissolving International Politics: Reflexions on the Nation-State, in«The American Political Science Review», vol. 72, n. 4 (Dec. 1978), pp. 1276-1287.
(49) Anche in questo caso l’inchiostro versato sul tema travalica di molto i limiti di unasemplice nota, a ogni modo quali punti di riferimento basilari cfr. A. GIDDENS, The Consequencesof Modernity, Cambridge, Polity Press, 1990; R. ROBERTSON, Globalization: Social Theory andGlobal Culture, London, Sage, 1992; M. WATERS, Globalization, London, Routledge, 1995, L.SKLAIR, Sociology of the Global System, Baltimore, John Hopkins University Press, 1995, ID.,Social Movements and Global Capitalism, in «Sociology», vol. 25, (1995), pp. 495-512, K.OHMAE, The End of the Nation State, New York, The Free Press, 1995; nei quali il motoredella globalizzazione e l’anima della nascente società globale è vista nella diffusione planetariadel capitalismo; tali riflessioni si innestano sulla base di studi fiorenti in America ancor primadel crollo dell’Urss, cfr. M. MANDEL, Late Capitalism, London, Verso, 1975, F. JAMESON,Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, in «New Left Review», vol. 146,(1984), pp. 53-92 e H. HARVEY, The Condition of Postmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1989,per cui l’attuale processo di mondializzazione non sarebbe altro che l’effetto dell’avvento della«terza ondata» del capitalismo – e, per alcuni autori, dell’azione della classe capitalista globale– sulla spinta della tecnologia delle comunicazioni, dell’informatica, oltre che della dispersionedella produzione su scala planetaria; cfr. pure più recentemente M. T. BERGER, The Nation Stateand the Challenge of Global Capitalism, in «Third World Quarterly», vol. 22, n. 6 (Dec. 2001),pp. 889-907; L. SKLAIR, La clase capitalista transnacional y el discurso de la Globalización, in«Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales», XLV, n. 186 (2002), pp. 133-156; N.JACOBSON, Escape from Alienation: Challenges to the Nation State, in «Representations», vol. 84(Autumn 2003), pp. 44-51; diversamente F. MISZLIVETZ, The Unfinished Revolutions of 1989:The Decline of Nation State?, in «Social Research», vol. 58, n. 4 (Winter 1991); E. P. REIS, TheLasting Marriage between Nation and State despite Globalization, in «International PoliticalScience Review», vol. 25, n. 3 (Jul. 2004), pp. 251-257.
Dimenticare Clausewitz? 527
multinazionali e dei mercati finanziari, offeso nel suo braccio militare dalla dif-fusione sempre più perniciosa della violenza delle organizzazioni non statali,sconvolto nelle sue viscere dalla divaricazione dolorosa tra ricchi e diseredati,e infine alterato nella sua autocoscienza dall’urto delle imperfette identità deimigranti e della snazionalizzazione della società.
Se per i coniugi Toffler la fine della guerra fredda assieme alla rivoluzionenel campo dell’informazione condurrebbe dapprima a una nuova gerarchia tragli stati, in cui la potenza sarebbe da misurarsi in termini di monopolio egestione del flusso informativo a vari livelli, per poi giungere allo spostamentodei centri decisionali dai governi ad una sorta di alleanza tra le grandi areeurbane globalizzate e le multinazionali stravolgendo la dimensione classicadella politica (50), per altri si sarebbe giunti alle soglie di una fine della storiada intendersi quale mancanza di alternative alla diffusione globale del capita-lismo e del sistema liberaldemocratico occidentale (51). L’interdipendenza eco-nomica mondiale acquisterebbe però in tali analisi caratteristiche diverse dalpassato in quanto al fenomeno dell’investimento all’estero e alla moltiplica-zione delle multinazionali dei diversi paesi si starebbe affiancando la trasfor-mazione qualitativa delle imprese stesse sempre più svincolate dalla nazionedi origine e sempre più spinte a ricercare il proprio interesse ovunque e a dis-capito, se necessario, delle singole economie nazionali.
Eppure, come ho avuto modo di sottolineare, il dibattito sulla vitalità deglistati e sulla loro capacità di riproporsi quali attori non secondari nel pano-rama internazionale appare tutt’altro che concluso, e il tempo trascorso sinoa oggi non sembra aver tolto alle parole di Schmitt la loro problematicaattualità. Guerra, dunque, parola «fascinosa e terribile» ma di certo ingan-nevole e inafferrabile proprio quanto concreta e reale nella sua brutale atro-cità. La sua costante riapparizione in forma simmetrica o asimmetrica, civile,rivoluzionaria, regolare e irregolare, mostra sì bene le difficoltà a pervenirea una sua rigorosa concettualizzazione (52), ma dovrebbe spingere anche ariflettere su quanto troppo frettolose rischiano di essere le affermazioni oggi
(50) A. e H. TOFFLER, Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21(st)
Century, New York, Bantam Books, 1990; cfr. pure ID., War and Anti-War: Survival at the Dawnof the 21 (st) Century, Boston, Little, Brown, 1993, e i saggi del volume In Athena’s Camp: Preparingfor Conflict in the Information Age, J. Arquilla and D. Ronfeldt (eds.), Santa Monica, Rand,1997.
(51) F. FUKUYAMA, The End of History and the Last Man, New York, Free Press, 1992.(52) Cfr. ad esempio le riflessioni di L. BONANATE, La guerra, cit., p. 3 e ss.
Emilio Gin528
di moda nel dibattito politologico, filosofico e strategico contemporanei, sulmutamento, non tanto nei metodi di combattimento, ma nella natura stessadella guerra a seguito del progressivo smussamento della spada del vecchiostato sovrano.
4. Il soffio del Dragone
La bandiera rossa issata sul palazzo del Reichstag contornato dalle mace-rie di Berlino sventolava da circa un anno quando, il 5 marzo del 1946 la vocenervosa ma ferma di Winston Churchill tentava di sensibilizzare l’opinione pub-blica americana sul pericolo di una nuova e imminente divisione del vecchiocontinente in blocchi ideologicamente contrapposti. Di lì a poco gli eventi euro-pei e poi asiatici avrebbero esteso la cortina di ferro ben oltre i limiti geo-grafici indicati dal vecchio statista britannico dando alla contrapposizione trale potenze occidentali e l’Urss dimensioni presto globali.
Al di là delle controversie su quale tra i protagonisti vada a ricadere laresponsabilità dell’innesco della Guerra Fredda, sul problema di quanto siaverosimile la buona predisposizione di Stalin verso i vecchi alleati o adeguatele sue azioni alle reali esigenze di sicurezza sovietiche, sulla pretesa accondi-scendenza di Roosevelt cui avrebbe fatto riscontro dapprima un inascoltato –e più pragmatico – Churchill e poi un’ottusa rigidità di giudizi da parte diTruman (53), così come al di là del problema di poter considerare l’intero qua-rantacinquennio che va dal 1945 al 1991 come un soggetto storiografico uni-tario (54), non vi è dubbio che il clima creatosi all’indomani della rottura dellagrande alleanza contro l’Asse assieme allo shock delle prime esplosioni ato-miche agirono quali potenti catalizzatori per un ripensamento sulla natura stessadei conflitti e della contrapposizione tra gli stati.
Ruolo centrale in questo processo sarebbe poi stato svolto dalla repen-tina e inaspettata vittoria del partito comunista guidato da Mao Tse-tung con-
(53) Cfr. J. SMITH, La guerra fredda, 1945-1991, Bologna, il Mulino, 2000, p. 31 e ss.; sulruolo di Stalin in particolare cfr. pure V. MASTNY, Il dittatore insicuro. Stalin e la guerra fredda,Milano, Corbaccio, 1998.
(54) Sul punto recentemente cfr. B. BONGIOVANNI, Storia della guerra fredda, Roma-Bari,Laterza, 2001, che stempera di molto, quasi destrutturandolo, il carattere di unitarietà solita-mente invalso nella pubblicistica, nella saggistica e nell’immagine massmediatica del periodoconsiderato.
Dimenticare Clausewitz? 529
tro il governo nazionalista cinese, ma soprattutto dall’immagine che di quellalotta e di quel successo sarebbe filtrata nelle capitali e nei circoli strategicioccidentali. Alla paura della diffusione del comunismo e alla necessità di dareconcretezza a un containment ritenuto indilazionabile non tardò allora a som-marsi la percezione che la minaccia in oggetto si presentasse in modo moltodiverso dalle forme ritenute convenzionali, e apparisse per lo più come unasorta di «penetrazione informale» inevitabile presupposto di un processo insur-rezionale cui la teorizzazione maoista sembrava aver dato una solida e vincentebase dottrinale (55).
Il fatto che la guerra di Corea fosse combattuta secondo canoni tradizio-nali e anzi nella sua seconda fase addirittura rievocasse l’incubo minacciosodella guerra di trincea fu, infatti, molto oscurato dai presupposti dai quali sigiunse alla sua conclusione e che rendevano esplicita la riluttanza di entrambele superpotenze a impegnarsi in un confronto diretto in cui la recente proli-ferazione nucleare sovietica iniziava ad aggiungere ulteriori livelli di incertezzae rischio (56). Il modello rivoluzionario cinese fu pertanto giudicato semprepiù quale minaccia di prima grandezza, di livello pari a quello costituito dalleforze convenzionali comuniste, come le prime clamorose sconfitte francesi inIndocina sembrarono confermare oltre ogni ragionevole dubbio. Mentre lefiamme del conflitto finivano di brunire le medaglie di molti generali dell’Arméetra i meandri del Mekong, l’analisi occidentale sulla strategia di Mao avevagià evidenziato quelli che venivano ritenuti i suoi punti qualificanti e che siritroveranno nelle odierne teorie sui conflitti asimmetrici.
Se, in sostanza, il salto tecnologico europeo ottocentesco aveva abbattutotutti i limiti che ancora restavano per l’estensione globale del colonialismo, conla complicità degli indigeni troppo propensi a voler contrastare gli invasori incampo aperto, e se la via occidentale alla guerra si caratterizzava per la rapi-dità delle campagne, le regolarità degli eserciti e l’elevato grado di meccaniz-zazione, l’approccio cinese alla guerra, nella riflessione di Katzenbach e
(55) Sul punto cfr. W. W. ROSTOW, An American Policy in Asia, London, Chapman & Hall,1955.
(56) Sul conflitto coreano cfr. recentemente S. H. LEE, The Korean War, London-New York,Longman, 2001, ma anche A. CAMPANA, Corea. Una nazione divisa. Relazioni internazionali nelNord-Est asiatico 1945-1996, Roma, Eurispes, 1997 che affronta il tema dal punto di vista dellerelazioni internazionali sul lungo periodo; per la questione vista dall’osservatorio diplomaticoitaliano cfr. ID., Governo e diplomazia italiana di fronte alla crisi di Corea (1950-1953), in L’Italiae la politica di potenza in Europa (1950-1960), Milano, Marzorati, 1992, p. 91 e ss.
Emilio Gin530
Hanrahan (57), poteva ben dirsi rivoluzionario. Esso infatti appariva basato sututta una serie di sostituzioni, propaganda al posto di produzione industrialee del potere aereo, fattore umano al posto della macchina, spazio al posto dellameccanizzazione, che azzeravano qualsiasi superiorità tecnologica occidentalee che trasferivano il confronto dal mero piano materiale a quello politico epsicologico (58). Tale traslazione, inoltre, era resa possibile da una concezionedel rapporto tra il tempo e lo spazio completamente differente rispetto allatradizione occidentale e che era alla base di quella che Mao aveva definito laguerra prolungata (59): in un paese dai confini sterminati la cessione del terri-torio per guadagnare tempo era il primo presupposto per giungere al logora-mento del nemico, col contemporaneo utilizzo senza tregua della guerriglia nellesue retrovie, e creare le condizioni di forza da cui lanciare la controffensiva.Secondo entrambi gli storici americani la stessa guerra di Corea, risoltasi a lorogiudizio in una vittoria minore per il campo comunista, portava la firma diMao ed era evidente nell’insensibilità mostrata in campo comunista rispettoalle perdite quando si fosse trattato di guadagnare peso politico in sede ditrattativa diplomatica anche senza immediati acquisti territoriali.
Ma tra le caratteristiche del modo di condurre la guerra da parte maoi-sta l’elemento che colpì di più i commentatori euroatlantici fu senza dubbioil suo aspetto ritenuto non convenzionale (60). Nonostante l’Europa stessa
(57) Tali le loro conclusioni, cfr. E. KATZENBACH, Jr. – G. HANRAHAN, The RevolutionaryStrategy of Mao Tse-tung, in «Political Science Quarterly», vol. 70, n. 3 (sep. 1955), pp. 321-340; G. HANRAHAN, The Chinese Red Army and Guerrilla Warfare, in «Combat Forces Journal»(Feb. 1951); cfr. inoltre l’analisi dell’estensione del metodo maoista alla Malesia secondo l’in-terpretazione di G. HANRAHAN, The Communist Struggle in Malaya, New York, InternationalSecretariat, Institute of Pacific Relations, 1954, e alla guerra in Indocina compiuta KATZENBACH,Indo-China: A Military-Political Appreciation, in «World Politics», vol. 4, n. 2 (Jan. 1952), pp.186-222; e cfr. pure E. KATZENBACH, Time, Space and Will: The Politico-Military Strategy of MaoTse-tung in The Guerrilla and How to Fight Him, T. N. Greene (ed.), Preager, New York, 1962.
(58) E. KATZENBACH, G. HANRAHAN, The Revolutionary, cit., pp. 327-328.(59) MAO TSE-TOUNG, De la guerre prolongée, in Écrits militaires de Mao Tse-Toung, Pekin,
Éditions en langues étrangeres, 1968, pp. 211-304, le citazioni sono prese dall’edizione fran-cese, quella che ho a disposizione.
(60) Cfr. ad esempio F. F. FULLER, Mao Tse-Tung: Military Thinker, in «Military Affairs»,vol. 22, n. 3 (1958), pp. 139-145, in cui l’inafferrabilità della guerriglia faceva aggio su tutte lealtre caratteristiche della strategia maoista. Cfr. pure l’Introduzione di S. B. GRIFFITH alla rac-colta di scritti Mao Tse-Tung on Guerrilla Warfare, New York, Praeger, 1961, che tende a uni-versalizzare il pensiero strategico del dirigente comunista spogliandolo dei suoi riferimenti allarealtà storica di riferimento.
Dimenticare Clausewitz? 531
fosse reduce da un conflitto che aveva conosciuto anche l’impiego, sebbenenon prioritario, di numerose formazioni irregolari, la chiave del successo comu-nista in Cina andava individuata quasi esclusivamente nell’utilizzo innovativodi un mezzo di lotta antico quanto il mondo condensato nelle parole di Maoin seguito divenute ben presto famose: «Il nemico avanza, noi ci ritiriamo. Ilnemico si ferma noi lo molestiamo. Il nemico è esausto, noi lo attacchiamo.Il nemico si ritira noi inseguiamo» (61).
La percezione di una minaccia dalla fisionomia così definita, condita conla sensazione dell’obsolescenza del recursus ad arma tradizionale in un ambientestrategico dominato dall’ombra spettrale del fungo atomico, condusse al risul-tato di spingere la comunità strategica occidentale non solo a porsi il problemadi come affrontare e sconfiggere la guerriglia e individuare quali tecnichepotessero rivelarsi più adeguate alla bisogna, ma a suggerire al potere politicol’utilizzo deciso proprio dei metodi non convenzionali per sottrarre al comu-nismo internazionale, e ai movimenti anticoloniali, il vantaggio dell’iniziativae della sorpresa (62).
In Francia, come è noto, sulla spinta della sconfitta in Indocina e nel pienodella guerra di Algeria, tale deriva avrebbe condotto, in seno a importanti set-tori dell’Armée, alla formulazione del concetto di Guerre Révolutionnaire: sortadi summa dei precetti maoisti, dell’utilizzo della propaganda, della guerra psi-cologica a cui aggiungere l’abbattimento di qualsiasi scrupolo di natura moralebello durante. Dal momento che tale era la forma di guerra ormai dominante,in cui si esplicitava tra l’altro l’aggressione comunista globale contro il mondolibero, la salvezza di quest’ultimo, e della Francia in particolare cui spettavail destino di riprenderne la guida, dipendeva secondo i teorici della GuerreRévolutionnaire dalla volontà politica ad accettare di combattere il nemico conle sue stesse armi e sul suo medesimo livello. Naturalmente, una scelta delgenere non avrebbe potuto essere compiuta senza procedere alla completariforma delle istituzioni e della società francesi secondo coordinate fortementeilliberali, al prezzo di una pericolosa commistione del potere militare conquello politico così poco infrequente nella storia politica transalpina. Con talipremesse non fu dunque un caso se parecchi tra i sostenitori della Guerre
(61) MAO TSE-TOUNG, Problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire en Chine, in Écritsmilitaires, cit., p. 122.
(62) Cfr. ad esempio J. P. KUTGER, Irregular Warfare in Transition, in «Military Affairs»,vol. 24, n. 3 (Autumn 1960), pp. 113-123.
Emilio Gin532
Revolutionnaire finiranno per essere coinvolti nel fallito colpo di stato controDe Gaulle (63) e avrebbero tentato di impedire il ritiro francese dall’Algeriaproprio ricorrendo a metodi di lotta e tecniche non convenzionali dalla guer-riglia agli attacchi terroristici.
Nello stesso periodo negli USA, che si preparavano a raccogliere la pesanteeredità francese sebbene da punti di partenza ideologici differenti, l’idea del-l’impiego della guerra asimmetrica come panacea allo stallo nucleare aveva var-cato le soglie persino della Camera Ovale, contagiando non solo Kennedy maanche il Segretario alla Difesa Robert McNamara: guerra subliminale, guerri-glia e operazioni paramilitari avrebbero dovuto figurare da quel momento nelnovero delle legittime opzioni statunitensi e, come lo stesso presidente avevadichiarato al Congresso nel maggio del 1961, era da ritenersi necessaria un’a-deguata e conseguente ristrutturazione delle forze armate in cui assicurare mag-gior ruolo alle Forze Speciali e allo sviluppo delle tecniche di controinsor-genza (64).
A metà anni ’60, dunque, la guerriglia non era più percepita quale espe-diente tattico tipicamente difensivo ma pareva, assieme agli altri mezzi di«aggressione indiretta» quali lo sciopero o il colpo di stato (65), essere diven-tata valido strumento offensivo nel più generale concetto di guerra irregolareche aveva compiuto così la sua lunga transizione, dall’epoca napoleonica all’etànucleare, sino a diventare la forma principale – se non esclusiva – di lotta tra
(63) Sulla questione cfr. P. PARET, French Revolutionary Warfare from Indochina to Algeria,London & Dunmow, Pall Mall Press, 1964. La descrizione più lucida del concetto di guerrarivoluzionaria fu elaborata da Roger Trinquier, braccio destro del generale Massu, cfr. il suo R.TRINQUIER, Modern Warfare. A French View of Counterinsurgency, Fort Leavenworth, Kansas,Combat Studies Institute, 1985 [1961]. Per le interpretazioni retrospettive più recenti da unpunto di vista militare della guerra di Algeria cfr. A. LE GUEN, L’emploi des forces terrestresdans les missions de stabilisation en Algérie, Paris, Cdef, 2006; Q. PICHELIN, Vaincre une gué-rilla? Le cas français en Algérie, Paris, Cdef, 2006. Da un punto di vista complessivo classicoresta il lavoro di A. HORNE, A Savage War of Peace: Algeria, 1954-1962, New York, Viking Press,1978 [trad. it., Storia della guerra d’Algeria, 1954-1962, Milano, Rizzoli, 1980].
(64) Sul punto cfr. P. PARET - J. SHY, Guerrilla in the 1960’s, New York, Praeger, 1962; cfr.pure Modern Guerrilla Warfare: Fighting Communist Guerrilla Movements, 1941-1961, F. M.Osanka (ed.), New York, Free Press, 1962; D. GALULA, Counterinsurgency Warfare: Theory andPractice, New York, Praeger, 1964; J. J. MCCUEN, The Art of Counter-Revolutionary War: TheStrategy of Counterinsurgency, Harrisburg, Stackpole, 1966.
(65) Cfr. W. C. SODERLUND, An Analysis of the Guerrilla Insurgency and Coup d’État asTechniques of Indirect Aggression, in «International Studies Quarterly», vol. 14, n. 4 (Dec.1970), pp. 335-360.
Dimenticare Clausewitz? 533
le nazioni (66). Sul piano inclinato di un sempre più pesante impegno ameri-cano in Vietnam poteva pertanto esserci chi (67), dopo un’analisi in dettagliodella guerra di popolo maoista, poteva già profetizzare una vittoria del mondolibero in quel particolare scenario orientale a patto di saper bilanciare un approc-cio politico con un uso massiccio delle tecniche di controinsorgenza di cuiappariva possibile condensare gli elementi fondamentali anche alla luce dellerecenti esperienze britanniche in Malesia o richiamando alla memoria le lezionigià apprese, e subito dimenticate, dagli americani stessi nelle guerre indianee nelle Filippine (68).
Sebbene non mancasse la consapevolezza della farraginosità del concettodi guerra non convenzionale e del pericolo di creare confusione nell’utilizzopoco rigoroso di termini quali guerriglia, insurrezione, guerra irregolare esimili (69), anche dopo che le immagini cruente apparse sui teleschermi ave-vano moltiplicato a dismisura l’eco dell’offensiva del Tet scuotendo le coscienzeamericane, l’uso massiccio della controinsorgenza unito a una accorta politicadi riforme sembrava ancora una ricetta plausibile per contenere la minacciacomunista in Asia e scongiurare l’innesco di un pericoloso «effetto domino»e il diffondersi della micidiale strategia della penetrazione informale (70).
Di conseguenza, l’elicottero in fuga dal tetto dell’ambasciata americana diSaigon non portò via solamente le speranze di poter sottrarre il Vietnam all’ab-braccio del comunismo, ma anche le certezze di un apparato militare, sino a
(66) Cfr. J. P. KUTGER, Irregular Warfare in Transition, in «Military Affairs», vol. 24, n. 3,(Autumn 1960), pp. 113-123; J. E. CROSS, Conflict in the Shadows: The Nature and Politics ofGuerrilla Warfare, Garden City, Doubleday, 1963; R. TABER, The War of the Flea: A Study ofGuerrilla Warfare Theory and Practice, New York, Stuart, 1965.
(67) T. TSOU, M. H. HALPERIN, Mao Tse-Tung’s Revolutionary Strategy and Peking InternationalBehavior, in «The American Political Science Review», vol. 59, n. 1 (Mar. 1965), pp. 80-99.
(68) J. P. KUTGER, Irregular Warfare, cit., pp. 120-2; sul precedente bagaglio di esperienzenelle «piccole guerre» acquisito da parte americana cfr. R. SCHAFFER, The 1940 Small Wars Manualand the “Lesson of History”, in «Military Affairs», vol. 36, n. 2 (Apr. 1972), pp. 46-51; sull’e-sperienza britannica in Malesia cfr. invece J. E. DOUGHERTY, The Guerrilla War in Malaya, in«U. S. Naval Institute Proceedings», vol. 84, n. 9 (sept. 1958); ma più recentemente cfr. J. A.NAGL, Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam. Learning to Eat Soup With a Knife,Westport, Praeger, 2002.
(69) A. C. JANOS, Unconventional Warfare: Framework and Analysis, in «World Politics»,vol. 15, n. 4 (Jul. 1963), pp. 636-646, il quale definisce la guerra non convenzionale quella incui sia riconoscibile una enorme disparità tra i due avversari, e ne individua le due principaliforme della «guerra rivoluzionaria» e nella «insurrezione».
(70) W. C. SODERLUND, An Analysis of the Guerrilla, cit., pp. 344-353.
Emilio Gin534
quel momento invitto sui campi di battaglia convenzionali, che vedeva venirmeno tutte le certezze di poter maneggiare con destrezza l’arma della coun-terinsurgency. Tale insicurezza, vera e propria sindrome contratta nelle umidegiungle vietnamite, avrebbe spinto le forze armate a concentrarsi sulla piani-ficazione dell’ipotetica guerra da combattersi nelle pianure centroeuropee con-tro il Patto di Varsavia, mentre l’eco dello slogan «no more Vietnam» avrebbetormentato i sonni dei capi di stato maggiore e dei Segretari di Stato statuni-tensi ogniqualvolta si fosse riproposta la prospettiva di un intervento militareall’estero (71).
A mio modo di vedere però, buona parte della sconfitta americana (maanche francese), e ancor più della scottante delusione a essa seguita, al di làdi tutte le altre cause concomitanti, andrebbe individuata in una lettura dis-torta proprio di quella dottrina maoista che tanta polvere aveva sollevato negliocchi degli analisti militari a partire dagli anni Cinquanta. Il tradizionaleapproccio di matrice jominiana alla strategia e alla concezione della guerra tipi-camente americano col correlato impulso a ricercare principi strategici uni-versalmente validi per poi trarne da essi ricette operative cui uniformare lescelte sul campo, ha poi finito per imporre una certa rigidità alla soluzionedel problema vietnamita e allo stesso dibattito teorico.
All’inizio del confitto cino-giapponese, pur sottolineando il valore strate-gico assegnato alla guerriglia nell’economia della lotta in corso e rivendican-done il carattere di assoluta novità, per ampiezza e durata, nella storia delleguerre, proprio lo stesso Mao non aveva avuto difficoltà a riconoscerne il ruolomarginale rispetto alla guerra di movimento (72). Già all’epoca dell’iniziale lottacontro il Kuomintang prima dell’invasione nipponica del resto, il dirigentecomunista aveva avuto modo di sottolineare, da un lato, il carattere regolaredell’Armata Rossa cinese e giustificare quale una necessità dovuta alla situa-zione contingente il suo decadimento a una sparuta banda di partigiani al ter-mine dell’epica lunga marcia, dall’altro, aveva ricordato che la stessa guerradi guerriglia avrebbe dovuto ricoprire in seguito un ruolo certo insostituibile,ma limitato alle fasi della ritirata strategica in presenza di forze nemiche supe-riori e lo avrebbe fatto, per di più, richiamando alla memoria proprio i clas-sici del pensiero militare occidentale (73).
(71) Cfr. C. C. CRANE, Avoiding Vietnam: The US Army’s Response to Defeat in SoutheastAsia, Carlisle, Strategic Studies Institute, 2002.
(72) MAO TSE-TOUNG, De la guerre prolongée, in Écrits, cit., p. 279 e ss.(73) ID., Problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire, in Écrits, cit., p. 109 e ss.
Dimenticare Clausewitz? 535
Le operazioni contro i nazionalisti dovevano infatti per Mao seguire unandamento ciclico che dalla difensiva strategica, in cui le bande partigiane ele formazioni disperse dell’Armata Rossa alle spalle del nemico ne minavanolo slancio offensivo grazie alla possibilità per l’esercito maoista di poter di-sporre di sufficienti basi di appoggio su cui ritirarsi, passava alla fase dell’of-fensiva previo il concentramento delle forze comuniste contro le singole colonneavversarie per poterle annientare in successione in vere e proprie battaglie con-venzionali. A tale impostazione strategica, sulla cui accettazione in seno al par-tito comunista cinese Mao dovette lottare a lungo e che vedeva dunque il pas-saggio progressivo dalla difesa in profondità sino alla guerra regolare in campoaperto una volta acquisita la superiorità materiale contro l’avversario, si sarebbepoi uniformata anche mutatis mutandis la lotta del fronte unito cinese controil Giappone (74). Ai fini di questo discorso è però rilevante sottolineare quantoMao, tanto durante la guerra civile quanto nella guerra cino-giapponese, siastato sempre attento a legare gli elementi della propria impostazione strate-gica alle caratteristiche peculiari geografiche, economiche e sociopolitiche dellaCina del suo tempo. Il carattere di guerra civile rivoluzionaria prima e di resi-stenza allo straniero poi, assieme alla debolezza numerica degli avversari diturno – nazionalisti o giapponesi – rispetto alla vastità immensa del territorioavrebbe permesso infatti la creazione di aree franche in cui, previe la propa-ganda e l’infiltrazione politica, costituire le basi strategiche dell’Armata Rossa.Basi le quali, tra l’altro, proprio per le stesse caratteristiche necessarie alla lorocreazione, potevano essere considerate mobili dunque diminuendo – ma certonon annullando – la dipendenza dell’esercito comunista dall’occupazione delterritorio. Nell’analisi maoista apparivano perciò chiari sia il nesso fonda-mentale e imprescindibile tra la guerra partigiana e la lotta per la propria terra,quello che Carl Schmitt avrebbe definito il «carattere tellurico» del parti-giano (75), sia l’inscindibilità tra la strategia e i caratteri peculiari della guerrain Cina. Più volte lo stesso Mao ebbe a ripetere che la sua «guerra di popolo»,così concepita, sarebbe stata inapplicabile in un paese dalle dimensioni del
(74) Cfr. ID., Problèmes stratégiques de la guerre de partisans contre le Japon, e ID., De laguerre prolongée, entrambi in Écrits, cit., pp. 171-210 e 211-304. Sull’intreccio tra guerriglia eguerra di movimento nella strategia maoista nella fase finale della lotta contro i nazionalisti cfr.H. M. TANNER, Guerrilla, Mobile and Base Warfare in Communist Military Operations inManchuria, 1945-1947, in «The Journal of Military History», vol. 67, n. 4 (Oct. 2003), pp. 1177-1222.
(75) C. SCHMITT, Teoria del partigiano, cit., p. 26 e ss.
Emilio Gin536
Belgio (76), ed è significativo che, altrove, il leader della rivoluzione in Orienteaggiungesse che neanche un paese quale l’Abissinia avrebbe presentato mag-giori chances di successo per l’applicazione del suo metodo (77).
Eppure, come si è visto, il modello maoista di insurrezione e lotta ha gua-dagnato rapidamente piede nei circoli militari occidentali e non, assumendo valoreprescrittivo per indirizzare le scelte strategiche nei contesti più disparati. A que-sto risultato credo non sia stato irrilevante il carattere jominiano degli scrittidello stesso Mao che spesso accennano alle leggi immutabili della strategia, aipunti geometrici dell’azione, alla scelta delle linee di operazione interne oesterne, e presentano moltissimi – e invero interessanti – punti di contatto conl’opera del barone svizzero. Anzi, a voler vedere in superficie l’azione dell’ArmataRossa cinese descritta (e prescritta) da Mao sembra quasi di ripercorrere le scenedelle campagne di Wellington in Spagna, Kutuzov e Washington: tra i motivie le circostanze che impedirono lo spegnimento della scintilla rivoluzionaria inCina Mao, infatti, non esitò a dare prioritaria importanza al fatto che mai, nelcorso della guerra, l’avversario fosse riuscito a distruggere completamente ilnucleo centrale dell’armata regolare comunista (78).
A tutto questo andarono ad aggiungersi il peso da un lato della propa-ganda cinese, a partire dalla volgarizzazione delle tesi maoiste effettuate da LinPiao (79), dall’altra di quella castrista da Régis Debray a Che Guevara che (80),sebbene da impostazioni oltremodo differenti, contribuirono ad alimentare lacertezza da parte occidentale dell’esistenza di coordinate comuni nella strate-gia insurrezionale comunista all’origine di così ampi, ripetuti e diversificati,successi. Come si è visto, istruttivo in tal senso appare il fatto che nonostante
(76) MAO TSE-TOUNG, Problèmes stratégiques de la guerre de partisans, cit., p. 195.(77) ID., De la guerre prolongée, cit., p. 227.(78) ID., Problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire, cit., p. 109(79) LIN PIAO, Guerriglia e guerra di popolo, a cura di A. Bolaffi, Napoli, Avanzini e Torraca,
1968.(80) Cfr. E. «CHE» GUEVARA, Scritti, discorsi e diari di guerriglia, a cura di L. Gonsalez,
Torino, Einaudi, 1974, ma anche J. A. MORENO, Che Guevara on Guerrilla Warfare: Doctrine,Practice and Evaluation, in «Comparative Studies in Society and History», vol. 12, n. 2 (April1970), pp. 114-133 e E. FRIEDMAN, Neither Mao, Nor Che: The Practical Evolution of RevolutionaryTheory. A Comment on J. Moreno’s “Che Guevara on Guerrilla Doctrine”, in «Comparative Studiesin Society and History», vol. 12, n. 2 (April 1970), pp. 134-139, che, criticando le conclusionidi Moreno, sottolinea le differenze – e soprattutto i fraintendimenti – tra Régis Debray, CheGuevara e Mao. Cfr. anche R. DEBRAY, Revolution in the Revolution?, New York, Grove Press,1967.
Dimenticare Clausewitz? 537
la guerra d’Algeria avesse poco a che fare con la penetrazione globale comu-nista, fosse quest’ultima la causa originaria intravista dai teorici francesi dellaGuerre Révolutionnaire, e che contro di essa andassero trovate le adeguate con-tromisure.
La spinta a ricercare universali principi di controinsorgenza, magari daraffinare alla luce delle situazioni particolari, non può pertanto destare moltameraviglia vista la concomitante ricettività in tal senso della componente mili-tare statunitense, e anche il dibattito successivo alla guerra del Vietnam si èsnodato lungo i binari così tracciati. La critica per la ricerca delle cause del-l’insuccesso, infatti, ha condotto in America a un profondo ripensamento dellanatura della guerra, alla (ri)scoperta della natura politica dei conflitti e del-l’importanza del contesto economico, culturale e sociopolitico spingendo a inter-rogarsi sulla reale valenza e significato nei tempi moderni di concetti quali quellodi «vittoria» (81).
Già alle soglie dell’impegno americano nelle malsane foreste vietnamite viera stato chi aveva riflettuto sulla futilità a calcolare le probabilità di successoconfidando unicamente sulla superiorità bellica materiale (82), introducendo ilconcetto secondo il quale i conflitti asimmetrici si componessero di due livelli,quello militare e quello politico, o chi sottolineasse di rimando che nei parti-colari scenari post-coloniali il centro di gravità della lotta fosse costituito dallalegittimità dei governi in carica, del suo consolidamento o meno a seconda dieventi, dinamiche e logiche che solo in via mediata avevano a che fare con leoperazioni militari (83). Verso la fine del conflitto, mentre il Vietnam del Sudsi apprestava a soccombere all’invasione – stavolta squisitamente convenzio-nale – del Nord, alla riconosciuta natura bicipite, militare e politica, dei con-flitti asimmetrici si aggiunse la progressiva svalutazione del primo di questidue elementi, con la relativa sensazione dell’inutilità della superiorità mate-
(81) Il dibattito si è intrecciato con i temi relativi al concetto di conflitto limitato nel con-testo della guerra fredda e agli effetti dell’impiego delle armi atomiche, innestandosi poi nelleriflessioni attuali sui conflitti non convenzionali e asimmetrici, cfr. ad esempio R. G. O’ CONNOR,Victory in Modern War, in «Journal of Peace Research», vol. 6, n. 4, (1969), pp. 367-384; E.N. LUTTWAK, On the Meaning of Victory: Essays on Strategy, New York, Simon and Schuster,1986; C. S. GRAY, Defining and Achieving Decisive Victory, Carlisle, Strategic Studies Institute,2002; J. B. BARTHOLOMEES, Theory of Victory, in «Parameters» (Summer 2008), pp. 25-36.
(82) A. C. JANOS, Unconventional Warfare, cit., p. 636 e ss.(83) B. FALL, Street without Joy. Indochina at war 1946-1954, Harrisburg, Stackpole, 1961,
e ID., The Two Viet-Nams. A Political and military Analysis, New York, Praeger, 1963.
Emilio Gin538
riale, e la conclamata predominanza degli aspetti psicologici nelle guerre con-temporanee: non altrimenti apparivano spiegabili conseguenze di eventi qualiDien Bien Phu o, ancora di più, l’offensiva del Tet. Pure, la struttura asim-metrica del conflitto sembrava garantire al più debole, nonostante la suaimpossibilità a recare offesa al territorio nemico, l’occasione di combattere sullapropria terra una guerra totale a oltranza, con conseguente maggiore insensi-bilità alle perdite e alle sofferenze, che la diversità della percezione degli inte-ressi relativi in gioco precludeva invece alla potenza occupante. In tal modo,il vero fulcro della guerra asimmetrica veniva a essere riconosciuto nella volontàdell’avversario da abbattere con tutti i mezzi immaginabili, non solo mediantele vittorie riportate sui campi di battaglia convenzionali, valutando ogni even-tuale ricaduta delle proprie iniziative sul fronte interno del nemico (84).
L’impianto teorico del conflitto asimmetrico così costruito dal dibattitoretrospettivo statunitense individuava quindi diversi concetti quali la guerraprolungata, l’impiego della guerriglia come espediente da parte del debole dirifiutare battaglia cedendo lo spazio in cambio del tempo, l’uso del terrori-smo, l’importanza dei «santuari» per la sopravvivenza dei guerriglieri, e la pre-dominanza degli aspetti psicologici della lotta e si nutriva pertanto di alcunielementi delle dottrine maoista e cubana ma accogliendoli in forma assolutiz-zata, e svincolata dai loro contesti originari, ai quali le frustrazioni originatedalla sconfitta dettero una minacciosa apparenza di solidità.
Per altro verso, la critica posteriore alla guerra del Vietnam ha portatoallo scoperto lo scottante tema dell’equilibrio tra potere politico-civile e quellomilitare nella gestione dei conflitti, suscitando una polemica che si è estesasino ai giorni nostri tra chi ha ritenuto plausibile una soluzione quasi del tuttomilitare al problema della guerriglia, enfatizzando e sottolineando spesso a buonragione i caratteri convenzionali della guerra del Vietnam, nell’intento diaddossare la responsabilità della sconfitta all’inopportuna intromissione dellapolitica in una sfera di esclusiva pertinenza militare (85), e coloro i quali hannoinvece, come si è visto, tentato di mettere in discussione le fondamenta stessedi tale interpretazione.
(84) Cfr. A. MACK, Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflicts,in «World Politics», vol. 27, n. 2 (Jan., 1975), pp. 175-200. Cfr. pure G. H. QUESTER, The GuerrillaProblem in Retrospect, in «Military Affairs», vol. 39, n. 4 (Dec. 1975), pp. 192-6.
(85) H. G. SUMMERS Jr, On Strategy. A Critical Analysis of the Vietnam War, Novato,Presidio, 1982.
Dimenticare Clausewitz? 539
Risulta però interessante notare quanto la via intrapresa per far risaltaregli aspetti politici dei conflitti asimmetrici e della guerriglia abbia finito perfacilitare il contagio della stessa «sindrome del Vietnam» dal comparto mili-tare a quello intellettuale, favorendo l’inclinazione a trattare la guerra asim-metrica quale soggetto scientifico unitario. È significativo, infatti, quanto nellapiù recente riedizione – e rielaborazione – di uno dei testi classici maggior-mente apprezzati di storia della strategia in ambito anglosassone, ossia ilMakers of Modern Strategy: Military Thought from Machiavelli to Hitler origi-nariamente curato da Edward Mead Earle nel 1944 (86), un intero nuovo capi-tolo sia stato dedicato appunto alla Revolutionary War, termine ambiguo incui far confluire gran parte delle tematiche ritenute caratteristiche dei conflittinon convenzionali.
Da tale impostazione metodologica non è scaturita – e a ben vedere nonpoteva scaturire – la soluzione al rebus strategico posto da una insurrezioneo da una guerra di popolo, ma anzi se ne è rafforzata ancora di più l’imma-gine di ingestibilità non solo da un punto di vista militare. In uno dei piùrecenti tentativi di sistemazione teorica del conflitto asimmetrico (87), infatti,anche se si è riconosciuto che la scelta di adottare una strategia asimmetricanon è univocamente appannaggio del soggetto più debole in una guerra, sene è evidenziata parimenti l’estrema difficoltà a ricorrervi da parte del piùforte, a causa ad esempio del peso dell’opinione pubblica o per lavolontà/necessità a non trascinare troppo a lungo il conflitto per motivi dipolitica interna. Difficoltà che, è appena il caso di dirlo, appaiono ancora piùinsormontabili quando a dover gestire una insurrezione è un soggetto stataleretto da istituzioni liberaldemocratiche e parlamentari (88). A ben vedere, lavolontà ad affrontare la guerra asimmetrica come un tutto nella speranza, ana-lizzandone struttura e caratteristiche basilari, di carpirne il funzionamento elogiche interne somiglia, dunque, molto da vicino al medesimo atteggiamentoall’origine della ricerca sul campo di battaglia di innovative, e vincenti, tec-niche di controinsorgenza.
(86) Makers of Modern Strategy: Military Thought from Machiavelli to Hitler, a cura di EdwardMead Earle, Princeton, Princeton University Press, 1944; il capitolo inserito nella nuova edi-zione è ad opera di J. SHY e T. COLLIER alle pp. 815-862.
(87) Cfr. I. ARREGUÍN-TOFT, How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict, in«International Security», vol. 26, n. 1 (Summer 2001), pp. 93-128.
(88) Cfr. G. MEROM, How Democracies Lose Small Wars, New York, Cambridge UniversityPress, 2003, in part. p. 15 e ss.
Emilio Gin540
Impostato su questi binari il dibattito si è pertanto protratto fino a oggi,per poi sovrapporsi e innestarsi su quello sorto in merito alle implicazioni mili-tari della rivoluzione delle comunicazioni e della tecnologia digitale assieme aquello sulla globalizzazione e le trasformazioni che quest’ultima starebbe pro-ducendo nella natura stessa della guerra a seguito del disfacimento dellapotenza bellica degli stati.
5. Conflitti asimmetrici e «guerre di quarta generazione»
Le lunghe trincee, immani cicatrici sul volto di una Europa irriconosci-bile, erano ormai deserte ma le fiamme scatenate dal primo conflitto mondialestentavano a placarsi. Tra le ceneri secolari degli imperi crollati ma anche neglistessi paesi dove amaro era risultato il frutto della vittoria, lo scontro socialee politico divampava nutrendosi dell’abitudine alla violenza ormai infusa trale masse smobilitate. Dal cuore del continente alle sue propaggini periferiche,guerre civili e conflitti convenzionali continuarono infatti a intrecciarsi e a sus-seguirsi per diverso tempo anche dopo la resa ufficiale degli Imperi Centrali.
Ma il vento acido del gas non aveva però avvelenato soltanto gli inermifantaccini sorpresi ai loro posti e la passione politica di chi tra essi era soprav-vissuto, ma aveva avuto modo di diffondersi in modo più sottile finendo perinquinare anche il terreno dove coltivare il pensiero e gli studi strategici.
Nonostante i precedenti forniti dalla guerra civile americana, in partedalla guerra anglo-boera, e dal conflitto russo-giapponese, la tragica novità diun fronte pressoché immobile in cui consumare senza apparenti risultati interegenerazioni richiedeva infatti una risposta e, con una dinamica simile al sor-gere nel contesto internazionale della «questione della colpa» e della legitti-mità conseguente a imporre gravose condizioni agli sconfitti, sul banco degliaccusati figurarono ben presto non solo il militarismo prussiano ma anche coluiche pareva esserne stato il padre spirituale.
Nel 1925 in un libello polemico, intitolato significativamente Paris or theFuture of War (89), Basil Liddell Hart, prendendo atto del grado di disumanitàassunto dalla guerra moderna, individuò chiaramente nella sclerotizzazionedella dottrina militare contemporanea, imbevuta rigidamente della strategia
(89) B. H. LIDDELL HART, Paris or the Future of War, New York, Dutton & co., 1925 (trad.it. Paride, o il futuro della guerra, a cura di F. Mini, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2007).
Dimenticare Clausewitz? 541
napoleonica di distruzione completa del nemico, la causa dei recenti massacri.Secondo il capitano britannico infatti, data l’efficacia dei mezzi difensivi, l’i-deale dell’annientamento totale dell’esercito nemico non era più raggiungibile.Qualsiasi tentativo di ottenerlo sul campo di battaglia non avrebbe condottoad alcun risultato se non quello di far ripiombare l’Europa nell’incubo dellaguerra di posizione: soltanto l’abbandono deciso del modello napoleonico e dellasua ricerca sistematica della grande battaglia a favore di un approccio strate-gico che puntasse sulla penetrazione in profondità sfruttando nei punti debolidel fronte nemico i ritrovati della tecnologia dall’aereo al carro armato, alloscopo di raggiungere e paralizzare i centri nevralgici dello sforzo bellico avver-sario, poteva avere maggiori speranze di superare l’impasse della guerra di trin-cea e porre termine ai conflitti con costi umani ed economici più accettabili.
L’approccio indiretto, concetto su cui Liddell Hart sarebbe più volte ritor-nato facendone il suo cavallo di battaglia nell’agone degli studi strategici (90),ossia in parole povere il sistematico sfruttamento delle debolezze del nemicopiù che la ricerca dello scontro cocciuto contro il grosso delle sue forze armate,doveva allora costituire per gli anni a venire il viatico per evitare una nuovaSomme e giungere più celermente alla vittoria. Pure, con un pizzico di orgo-glio nazionale, Liddell Hart non aveva mancato di sottolineare che tra le causedell’ascesa della Gran Bretagna a grande potenza andava individuata propriola coerente adozione, lungo tutto l’arco della sua storia moderna, di una stra-tegia indiretta, favorita dalla posizione insulare e dal dominio incontrastato deimari, che le avevano consentito di combattere ricorrendo a coalizioni di alleanzae di colpire i punti deboli e periferici delle nazioni nemiche (91). In coerenzacon tale impostazione Liddell Hart, assieme a J. Fuller e altri riformatori mili-tari, si fece pertanto promotore di un’attiva campagna pubblicistica a favoredella meccanizzazione delle forze armate e dell’adozione di tecniche innovativecirca il loro impiego in modo molto simile a quanto effettuato in parallelo, seb-bene da presupposti strategici in parte diversi, da Heinz Guderian in Germaniao, in Francia, da un ancora poco conosciuto capitano Charles De Gaulle (92).
(90) B. H. LIDDELL HART, Strategy: The Indirect Approach, London, Faber & Faber Ltd.,1954.
(91) B. H. LIDDELL HART, The British Way in Warfare, London, Faber & Faber Ltd., 1932.(92) H. GUDERIAN, Achtung Panzer!: The Development of Armoured Forces, Their Tactics
and Operational Potential, London, Arms and Armour, 1995; CHARLES DE GAULLE, La Franceet son Armée, Paris, Plon, 1938; A. GAT, British Armour Theory and the Rise of the PanzerArm: Revising the Revisionist, New York, St. Martin’s Press, 2000.
Emilio Gin542
La ricerca di un corpus teorico che avrebbe permesso il ritorno alla guerradi movimento nel discorso di Liddell Hart, che avrebbe di lì a poco reiteratoil suo ingeneroso attacco alla figura di Napoleone (93), era però effettuata incongiunzione a una serrata e veemente critica all’opera di Clausewitz reo, agliocchi del capitano britannico, di aver codificato ed elevato a dogma l’idealedella guerra di annientamento caratteristica del modus belligerandi dell’impe-ratore dei francesi. Il generale prussiano quale stregone maligno che aveva garan-tito la sopravvivenza artificiale, per le contrade d’Europa, del fantasma delVampiro Corso ottenebrando le menti degli strateghi degli stati maggiori e daconsiderarsi, quindi, quale responsabile morale degli orrendi carnai dellarecente conflagrazione mondiale (94).
Se si riflette sul fatto che von Moltke stesso (95), all’indomani di Sadowae Sedan, si fosse esplicitamente dichiarato discepolo degli insegnamenti clau-sewitziani al cui valore egli ascriveva buona parte delle sue vittorie, e che daallora la figura di Clausewitz, a torto o a ragione, potesse essere identificatacon i successi dello stato maggiore tedesco, si comprende come simbolicamentela condanna – e l’acredine – nelle parole di Liddell Hart aderissero con natu-ralezza al più generale clima di ostilità nei confronti della Germania imperialea ridosso della fine della prima guerra mondiale.
Il giudizio lapidario dello storico inglese, sebbene innestatosi in una cor-rente di pensiero ostile all’opera di Clausewitz fiorente già in Francia verso lafine del XIX secolo e risalente sino alla polemica coeva tra il prussiano e Jominisull’interpretazione della strategia napoleonica (96), non è rimasto senza seguitoe ha avuto modo di essere ripreso e perfezionato sino a oggi sia dal discepolointellettuale di Liddell Hart, John Keegan, che più recentemente dagli storiciisraeliani Azar Gat e Martin Van Creveld.
Per Keegan, nella sua History of Warfare (97), la stessa celeberrima, e abu-sata, intuizione di Clausewitz secondo cui la guerra debba essere consideratala continuazione della politica con altri mezzi sarebbe da rigettare, in quanto
(93) B. H. LIDDELL HART, A Greater than Napoleon: Scipio Africanus, Edinburgh andLondon, Blackwood & sons Ltd., 1926.
(94) B. H. LIDDELL HART, The Ghost of Napoleon, London, Faber & Faber, 1933.(95) J. KEEGAN, A History of Warfare, Reading, Pimlico, 1994, p. 20.(96) Cfr. M. HOWARD, Jomini and the Classical Tradition in Military Thought, e P. PARET,
Clausewitz and the Nineteenth Century, entrambi in The Theory and Practice of War, cit., allepp. 5-20 e 23-41 rispettivamente.
(97) J. KEEGAN, A History, cit., p. 3 e ss.
Dimenticare Clausewitz? 543
inadatta a decifrare il fenomeno bellico nella sua multiforme complessità. Inparticolare, l’analisi clausewitziana presupponendo lo stato sovrano e la ragiondi stato, il calcolo razionale degli interessi in politica estera, gli eserciti rego-lari e le regole diplomatiche, o in altri termini presumendo quali assoluti i carat-teri della guerra concretatisi nell’Europa moderna, renderebbe impossibile lacomprensione di essa non solo in contesti culturali completamente diversi daquelli occidentali, in società senza stato in cui labile è la distinzione tra civilie militari in assenza di eserciti regolari, ma anche per il periodo medievale epremoderno della stessa storia d’Europa. La guerra, per Keegan, è piuttostocontinuazione della cultura più che della politica (98), e nella disamina dellesue cause andrebbero pertanto non ignorati fattori antropologici e psicologiciquali l’irrazionalità e l’egoismo nell’uomo, l’universo valoriale e la religione nellediverse società. Nella logica perversa di quella mostruosa aberrazione cultu-rale che fu la Grande Guerra poi, la «politica» clausewitzianamente intesa nonavrebbe avuto alcun ruolo e anzi, per riprendere la critica di Liddell Hart,secondo Keegan proprio il funesto avvertimento di Clausewitz per cui la palmadella vittoria andrebbe in ogni tempo al contendente che maggiormente sap-pia avvicinarsi all’ideale estremo della guerra assoluta, instillato nel codicegenetico dei generali dell’epoca, garantì il deragliamento della violenza oltreogni limite conosciuto (99). La più nota delle frasi del generale prussiano, dun-que, acquisterebbe il suo valore solo se posta rigidamente entro il suo conte-sto storico, essa infatti avrebbe rappresentato la sua naturale reazione allapoliticizzazione della guerra imposta dall’irrompere sui campi di battaglia dellearmate rivoluzionarie: la politica dello stato monarchico come corrispettivo,anzi inevitabile surrogato, di quella democratica posta a fondamento dellaconcezione clausewitziana della guerra (100).
In modo simile a quanto desunto da Liddell Hart e Keegan, pur con argo-menti diversi, Azar Gat ha ripreso la critica al pensiero di Clausewitz insistendosulla sua specificità quale prodotto significativo del più ampio clima culturaleromantico. In tal senso risulterebbe meglio leggibile il valore fondamentaleattribuito, nel quadro dell’opera del generale prussiano, alla superiorità dellabattaglia d’annientamento a fronte dell’ineffettività delle campagne tipiche della
(98) Sul punto cfr. le riflessioni di uno dei padri dell’antropologia contemporanea B.MALINOWSKI, An Anthropological Analysis of War, in «The American Journal of Sociology», vol.46, n. 4, (Jan. 1941), pp. 521-550.
(99) J. KEEGAN, A History, cit., p. 21.(100) Ivi, pp. 16-7.
Emilio Gin544
guerre en dentelles. Per questo, però, la profondità dei condizionamenti sto-rico-culturali nella genesi del Vom Kriege finirono per vanificare la pur espli-cita intenzione del suo autore di elaborare una riflessione sulla natura della guerrache potesse aspirare a resistere all’usura del tempo. Per Gat risulterebbe deltutto inutile tentare di vedere in Clausewitz altro che non l’aspetto brutale ediretto della strategia napoleonica, con la ricerca spasmodica della battaglia deci-siva e della distruzione completa dell’avversario, che in realtà era conseguenzadell’aver osservato i drammatici avvenimenti del periodo rivoluzionario e napo-leonico dal particolare punto d’osservazione prussiano. In questo, i critici suc-cessivi del pensiero clausewitziano, sino a Liddell Hart, a ragione ne avrebberocolto la parte più genuina e sostanziale. La revisione al testo effettuata daClausewitz stesso, iniziata nel 1827 e mai portata a termine per la sua prema-tura scomparsa, traeva forza intima dalla medesima esigenza di adattare il suopensiero alle mutate condizioni politiche dell’Europa della Restaurazione. Questasarebbe l’origine dell’introduzione del concetto della guerra quale continuazionedella politica statale e della tensione continua tra la guerra ideale (assoluta) equella reale (modificata dalla politica) che avrebbero reso famoso il primo deivolumi di cui si compone il Vom Kriege. La reclusione a Sant’Elena dell’arte-fice della guerra assoluta e il ritorno alla possibilità di conflitti limitati neimezzi e negli obiettivi, imposero al suo autore uno stravolgimento completodei presupposti teorici originari. Il risultato di questo tardivo ripensamentoavrebbe pertanto tolto irrimediabilmente qualsiasi unitarietà interiore all’operadi Clausewitz dal momento che, per Gat, insanabile risulterebbe la discrasiatra il suo pensiero originale (e genuino) e quello – incompleto e fuorviante –della fase della maturità: l’ambiguità quale elemento non trascurabile, se nonprioritario, delle ingiustificate fortune di un’opera non utilizzabile se non qualeparziale testimonianza di un’epoca e di una fase precisa dell’evoluzione del pen-siero strategico e non certo da accogliere quale guida alla comprensione dellapiù sanguinosa e antica delle attività umane.
A buon ragione Gian Enrico Rusconi, pur riconoscendo il fascino eser-citato sul pensatore prussiano dal modello di guerra ideale da lui stesso ela-borato, ha sottolineato quanto abbia pesato negativamente, soprattutto inambito anglosassone, il giudizio iniziale di Liddel Hart nell’individuare inClausewitz l’apostolo della guerra di stermino (101).
(101) G. E. RUSCONI, Clausewitz, il prussiano. La politica della guerra nell’equilibrio euro-peo, Torino, Einaudi, 1999, p. 359 e ss.
Dimenticare Clausewitz? 545
Come si è visto, però, il dibattito sulla natura della guerra innescatosiattorno ai concetti di guerriglia e conflitti irregolari lungo gli anni della con-trapposizione tra i blocchi del secondo dopoguerra si era svolto senza inve-stire il pensiero del generale prussiano e anzi, in qualche caso (102), propriole sue intuizioni relative alla politicità del fenomeno bellico erano servite a megliointrodurre la critica all’approccio troppo convenzionale ritenuto a fondamentodella strategia degli occidentali alle prese col processo di decolonizzazione.Proprio all’indomani del disengagement americano in Vietnam la figura e ilpensiero di Clausewitz si sono ritrovati al centro di un rinnovato interesse nelpiù ampio moto intellettuale volto a riesaminare criticamente la cause dellasconfitta, sebbene tale processo si sia, in modo contraddittorio, accompagnatoa un progressivo disinteresse tra i ranghi dell’US Army rispetto al problemadella controinsorgenza.
Gli spettacolari, e per certi versi inquietanti, eventi internazionali succes-sivi al crollo dell’Unione Sovietica, alla dissoluzione dello stato iugoslavo, e alritorno della guerra in Medio Oriente hanno però completamente ribaltato lasituazione portando di nuovo il generale prussiano e la sua opera sotto il fuocoincrociato della critica.
Il primo fronte di attacco in questo senso si è sviluppato in seno al piùampio dibattito fiorito attorno alla cosiddetta «rivoluzione militare» che da piùdi un decennio a questa parte si starebbe verificando grazie alla massiccia intro-duzione nei sistemi d’arma, e in quelli di comando e controllo, della tecno-logia informatica e digitale. Per Alvin e Heidi Toffler, non a caso al contempotra i maggiori teorici della globalizzazione, le trasformazioni occorse negli annirecenti nel mondo delle comunicazioni e le possibilità offerte a chi ne possaraggiungere il dominio avrebbero alterato in modo significativo i caratteridella guerra moderna e, ancor più, di quella futura. Sullo sfondo di una inter-pretazione evoluzionistica del fenomeno bellico, la rivoluzione dell’informazioneavrebbe reso obsoleto il modello invalso nell’era dell’industrializzazione, basatosugli eserciti di massa, sulla produzione industriale accentrata e sul sistema dicomando piramidale, plasmando una nuova gerarchia tra le potenze mon-diali (103). Per un nutrito numero di analisti militari, le armi di precisione a
(102) Cfr. A. MACK, Why Big Nations, cit., p. 181 e ss.(103) A. e H. TOFFLER, Powershift, cit., e ID., War and Anti-War, cit.; diversamente cfr. G.
S. SULLIVAN – J. M. DUBIK, War in the Information Age, Carlisle, Strategic Studies Institute,1994, che pur ammettendo l’importanza delle trasformazioni in ambito bellico a seguito del-
Emilio Gin546
distanza e il micidiale apparato di controllo moderno renderebbero superatele osservazioni di Clausewitz sulla guerra come regno incontrastato dell’in-certezza. La capacità del flusso informativo di fluire dal vertice del sistema dicomando alle unità inferiori e viceversa avrebbe il potere, in definitiva, di dira-dare con efficacia, se non di dissipare del tutto, la nebbia della guerra e garan-tire il completo dominio del campo di battaglia al contendente che sia in gradodi disporre della tecnologia adatta (104). Come conseguenza di tali specula-zioni anche un altro dei presunti pilastri della dottrina clausewitziana, ossia ladistruzione dell’esercito avversario come metodo per giungere alla vittoria,sarebbe entrato in crisi dal momento che – riecheggiando a distanza di tantianni le parole di Liddell Hart (o di Douhet) sull’approccio indiretto – oggi-giorno risulterebbe sufficiente colpire i centri nevralgici del nemico per dis-articolare qualsiasi resistenza. Le strabilianti prestazioni della coalizione gui-data dagli Usa durante la guerra del Golfo del 1991, e l’azione della Nato controla Serbia del 1999, hanno poi aiutato a conferire a tali previsioni il suggellodella conferma sul campo. Per altro verso, i recenti impieghi degli eserciti occi-dentali nelle diverse situazioni di crisi nel mondo hanno condotto a un ulte-riore ripensamento sulla trasformazione della guerra e dell’approccio a essaormai invalso su entrambe le sponde dell’Atlantico.
Il tema classico della riluttanza per le democrazie a ingaggiare batta-glia (105), condito con la consapevolezza che l’immediatezza e la maggiore cir-colazione delle informazioni avrebbero aumentato la sensibilità alle perdite diguerra nelle società aperte (106), assieme alle possibilità fornite dalla rivolu-
l’avvento dell’era dell’informazione concludono sottolineando la continua rilevanza del pensieroclausewitziano per lo studio della Guerra come fenomeno complessivo. Cfr. pure G. S. SULLIVAN
– A. M. COROALLES, The Army in the Information Age, Carlisle, Strategic Studies Institute, 1995.(104) Sul tema cfr. D. JABLONSKY, The Owl of Minerva Flies at Twilight: Docrtinal Change
and Continuity and the Revolution in Military Affairs, Carlisle, Strategic Studies Institute, 1994;M. J. MAZARR, The Revolution in Military Affairs: A Framework for Defense Planning, Carlisle,Strategic Studies Institute, 1994; E. H. TILFORD, The Revolution in Military Affairs: Prospectsand Cautions, Carlisle, Strategic Studies Institute, 1995.
(105) Cfr. ad esempio J. R. RUMMEL, War, Power, Peace, in Understanding Conflict and War,vol. IV, Beverly Hills 1979; tesi poi ribadite in ID., Libertarianism and International Violence,in «Journal of Conflict Resolution», vol. 27 (mar. 1983), pp. 27-71; diversamente cfr. E. WEEDE,Democracy and War Involvement, in «Journal of Conflict Resolution», vol. 28, n. 4 (Dec. 1984),pp. 649-664.
(106) Per Edward Luttwak, di contro, l’estrema suscettibilità alle perdite nelle democrazieoccidentali deriverebbe piuttosto dalla somma della crisi delle nascite e dell’allungamento dellavita media, con il conseguente diverso atteggiamento nei confronti dell’aspettativa di vita dei
Dimenticare Clausewitz? 547
zione tecnologica militare hanno fatto intravvedere la nascita di una nuovaAmerican Way of War, molto diversa da quella sinora dominante, le cui carat-teristiche si sarebbero presto estese al di qua dell’Atlantico dando luogo all’av-vio di quella che è stata definita l’età delle guerre post-moderne o meglio libe-rali (107). Utilizzo delle armi di precisione allo scopo di limitare i «dannicollaterali», standoff weapons e scarso impiego delle truppe di terra per scon-giurare il ritorno in patria di imbarazzanti feretri imbandierati, impegno limi-tato nel tempo e nello spazio con conseguente riduzione dei costi economici,ma soprattutto insistenza su motivazioni ideologiche che esaltino i fini uma-nitari e democratici a giustificazione dell’uso della forza: queste le coordinatedel nuovo modello di guerra espresso dalla società occidentale in cui risco-prire evidenti le sue radici nella tradizione dello justum bellum d’origine ago-stiniana (108). Per Edward Luttwak, infatti, per questa via saremmo alle sogliedi un ritorno a stili di guerra molto simili a quelli del XVIII secolo, una sortadi guerra post-eroica, dove sempre meno spazio vi sia per l’applicazione dellastrategia napoleonica codificata da Clausewitz (109).
figli da parte dei genitori, cfr. E. N. LUTTWAK, Blood and Computers: The Crisis of ClassicalMilitary Power in Advanced Postindustrialist Societies and the Scope of Technological Remedies,in War in a Changing World, a cura di Z. Maoz, A. Gat, Ann Arbor, University of MichiganPress, p. 49 e ss.
(107) C. MCINNES, A Different Kind of War?, in «Review of International Studies», vol. 29(2003), pp. 165-184 e M. FREEMAN, The Age of Liberal Wars, in «Review of InternationalStudies», vol. 31 (2005), pp. 93-107.
(108) Cfr. J. VON ELBE, The Evolution of the Concept of the Just War in International Law,in «The American Journal of International Law», vol. 33, n. 4 (Oct. 1939), p. 665-688.; J. T.JOHNSON, Ideology, Reason, and the Limitation of War: Religious and Secular Concepts, 1200-1740, Princeton, Princeton University Press, 1975 e ID., Just War Tradition and the Restraintof War: A Moral and Historical Inquiry, Princeton, Princeton University Press, 1981; cfr. pureil volume collettaneo Just War Theory, a cura di J. B. Elshtain, New York, Columbia UniversityPress, 1992; e anche D. SMITH, Just War, Clausewitz and Sarajevo, in «Journal of Peace Research»,vol. 31, n. 2 (May 1994), pp. 36-42, che affronta la questione al momento dell’intervento dellaNato in Bosnia.
(109) E. N. LUTTWAK, Toward a Post-Heroic Warfare, in «Foreign Affairs», vol. 74, n. 3 (May-June 1995), pp. 109-122; e ID., A Post-Heroic Military Policy: The New Season of Bellicosity, in«Foreign Affairs», vol. 75, n. 4 (Jul.-Aug. 1996), pp. 33-44, in cui, evidenziando la difficoltàper gli USA di proiettare potenza oltre i propri confini con l’impiego di truppe di terra, siauspica una revisione dell’apparato militare americano prodotto dalla guerra fredda in cambiodi uno strumento più flessibile incentrato sulla riduzione degli organici e sull’adozione dellearmi intelligenti a distanza.
Emilio Gin548
Contemporaneamente al dibattito sviluppatosi attorno al concetto di rivo-luzione militare, il pensatore prussiano è finito poi sotto l’indice della criticaa seguito del prepotente ritorno d’attualità del concetto di guerra non con-venzionale verificatosi dalla fine della guerra fredda sino agli eventi successiviagli attacchi terroristici dell’undici settembre del 2001. A differenza del pas-sato, però, stavolta il discorso si è arricchito traendo forza dalla fusione deglielementi classici della corrente di pensiero anticlausewitziana, che ne stigma-tizza la storicità e la scarsa attenzione agli elementi culturali del fenomeno guerraesemplificati nelle opere di Keegan e Gat, con quelli tipici dell’eterna pole-mica sulla decadenza dello stato nazione ridestata a nuovo vigore dalle recentiteorie sulla globalizzazione.
Già dal 1991 infatti, mentre le macerie del muro di Berlino attendevanoancora di essere rimosse del tutto, Martin Van Creveld anticipava, in unvolume da un pomposo e significativo sottotitolo (110), le sue conclusioni suldeclino dello stato moderno (111), leggendole nel particolare ambito della sto-ria dei conflitti. Per lo storico di Gerusalemme proprio lo studio dell’evolu-zione della guerra nei nostri tempi renderebbe più evidente il grado di dis-soluzione, dovuto alla forza della globalizzazione economica e del ritorno suvasta scala delle ataviche inimicizie etnico-religiose, delle istituzioni statali sem-pre meno individuabili quali centri d’imputazione prioritari nella gestione econduzione della violenza organizzata. Dalla disintegrazione del colosso sovie-tico e dagli altri esempi di failed states sorgerebbe sovrano, dalla polvere dellastoria, il «conflitto a bassa intensità» quale modello paradigmatico cui dovrannouniformarsi di necessità i futuri scenari di guerra: eserciti privati in connes-sione con le onnipotenti multinazionali e i potentati economici, postmodernecompagnie di ventura a guida carismatica, gruppi etnici o religiosi in cerca diautonomia, bande di criminali e terroristi transnazionali quali nuovi preten-denti al trono reso vacante dall’abdicazione del vecchio stato sovrano con lesue armate professionali in una sorta di rimedievalizzazione dello scenariomondiale globale (112).
(110) M. VAN CREVELD, The Transformation of War. The Most Radical Reinterpretation ofArmed Conflict since Clausewitz, New York, Free Press, 1991.
(111) M. VAN CREVELD, The Rise and Decline of the State, Cambridge, Cambridge UniversityPress, 1999.
(112) Cfr. sul punto anche P. CERNY, Neomedievalism, Civil War, and the New SecurityDilemma: Globalization as Durable Disorder, in «Civil Wars», vol. 1, n. 1, (Spring 1998), pp. 36-64; J. FRIEDERICHS, The Meaning of the New Medievalism, in «European Journal of International
Dimenticare Clausewitz? 549
In un tale contesto non vi sarebbe più alcuno spazio per i classici con-cetti strategici canonizzati nel Vom Kriege e che a malapena potrebbero esseregiudicati rappresentativi della forma assunta dalla guerra in Occidente nelperiodo ristretto dalla pace di Vestfalia al secondo conflitto mondiale. Ilmodello teorico «trinitario» della guerra clausewitziana, che suppone l’intera-zione reciproca tra il governo, le forze combattenti e il popolo, a cui far cor-rispondere rispettivamente le forze vive della razionalità, del caso e delle pas-sioni, nel contesto contemporaneo perderebbe allora qualsiasi forza esplicativaproprio perché presupporrebbe gli eserciti regolari permanenti e la distinzionetra civili e militari, il diritto di guerra e la ragion di stato, ossia in una parolalo scomparso jus publicum europaeum.
Da tale impostazione discenderebbe quindi, in modo simile a quanto acca-duto in parallelo nelle interpretazioni di Keegan e Gat, una forte limitazioneal senso da attribuirsi alla parola «politica» nel discorso clausewitziano da leg-gersi esclusivamente quale attributo della volontà del sovrano o del governo,in tal modo diminuendone ogni applicabilità a contesti di guerra religiosa ocivile o al di fuori del particolare scenario dell’Europa moderna (113). In modoquasi contraddittorio poi, ma che Van Creveld rovescia sulle ambiguità insa-nabili del messaggio contenuto nel Vom Kriege, lo storico israeliano ha per-fezionato la sua critica mettendo in luce la fallacità del concetto di guerra qualeatto di violenza portato agli estremi, sottolineando quanto invece sia possibilerinvenire lungo tutta la storia dell’umanità il costante sforzo da parte dei bel-ligeranti, a prescindere dal grado di animosità, a sottoporre il fenomeno guerraa convenzioni e regole anche non scritte, escludendo quindi dall’analisi tuttequelle parti dell’opera clausewitziana che pure indicavano nella politica ilfreno costante al deragliamento della violenza bellica (114).
Tutti questi temi hanno dunque oggi trovato, come ho avuto modo di anti-cipare, ampia risonanza nel contemporaneo risorgere del dibattito sulla deca-denza dello stato moderno andando a sostanziare e arricchire il discorso sullaglobalizzazione.
Relations», vol. 7, n. 4, (2001), pp. 475-502; J. RAPLEY, The New Middle Ages, in «Foreign Affairs»,vol. 85, n. 3, (May-June 2006), pp. 95 e ss.; P. WILLIAMS, From the New Middle Ages to a NewDark Age: The Decline of the State and U. S. Strategy, Carlisle, Strategic Studies Institute, 2008.
(113) M. VAN CREVELD, The Transformation of War, cit., p. 35 e 124 e ss.(114) M. VAN CREVELD, The Transformation of War, cit., 63 e ss., che riprende le tesi espo-
ste in ID., The Clausewitzian Universe and the Law of War, in «Journal of ContemporaryHistory», vol. 26, n. 3-4 (Sept. 1991), pp. 403-429.
Emilio Gin550
Il riaffiorare alla superficie delle radici dell’odio etnico e religioso a seguitodel clamoroso smottamento dello stato iugoslavo e i conflitti accesisi in altrezone del mondo, hanno spinto infatti Mary Kaldor, proprio richiamandosi alletrasformazioni indotte dalla globalizzazione, a una completa riformulazione delconcetto di guerra nell’epoca contemporanea (115). L’affievolimento, e in molticasi la scomparsa, dei poteri statali darebbe luogo all’inevitabile tendenza allaprivatizzazione della violenza organizzata evidente nel maggiore ruolo giocatosul campo dalle milizie paramilitari, spesso legate alla criminalità organizzata,e dai nuovi signori della guerra, dai contrabbandieri e dalle bande guerriglieresu base etnica. Più in particolare, la guerra oggi, lungi dall’essere il prodottodella competizione statale per il dominio sul territorio o per l’accaparramentodei mercati di sbocco, si innesterebbe sulla faglia di frizione tra le identità localiminacciate dal processo di omologazione prodotto dai modelli standardizzatiimposti e veicolati nelle reti transnazionali del capitalismo e dell’informazioneglobali. Il recursus ad arma quale rifiuto della «occidentalizzazione» andrebbe,pertanto, di pari passo col rigetto e l’obsolescenza del modello occidentale(moderno) di guerra e al suo graduale decadimento nello stesso occidente ormaiapparentemente pacificato al suo interno (116). Nelle «nuove guerre» con-temporanee, dunque, lo stesso rapporto tra la guerra e la pace risulterebbesconvolto nel suo nesso logico dal momento che le contraddizioni ingeneratedalla globalizzazione, travalicando i confini statali, minerebbero la classica
(115) M. KALDOR, Le nuove guerre. La violenza organizzata nell’era globale, Roma, Carocci,1999; tesi poi ribadite in EAD., Elaborating the ‘New War’ Thesis, in Rethinking the Nature ofWar, I. Duyvesteyn and J. Angstrom (eds.), New York, Frank Cass, 2005, pp. 210-224; ma cfr.pure M. DUFFIELD, Post-modern Conflict: Warlords, Post-Adjustment States and Private Protection,in «Civil Wars», vol. 1, n. 1, (Spring 1998), pp. 65-102; H. MUNKLER, The New Wars, Cambridge,Polity Press, 2005; R. SCHULTZ, A. DEW, Insurgents, Terrorists and Militias: The Warriors ofContemporary Combat, New York, Columbia University Press, 2006; Fragile States and insecurePeoples?: Violence, Insecurity, and Statehood in the Twenty-First Century, L. Andersen, B. Moller,F. Stepputatt (eds.), New York, Macmillan, 2007. Il concetto di conflitto post-moderno puòessere considerato equivalente a quello di «nuove guerre» utilizzato dalla Kaldor.
(116) Per una ripresa e una enfatizzazione delle tesi della Kaldor in Italia cfr. C. GALLI, Laguerra globale, Roma-Bari, Laterza, 2001; e A. D’ORSI, Guerre globali: capire i conflitti del ven-tunesimo secolo, Roma, Carocci, 2005, nei quali l’insorgere dei conflitti nel mondo contempo-raneo sarebbe comprensibile guardando al temporaneo malfunzionamento delle reti e dei nodicostituenti (e costituiti anche inconsapevolmente dalla politica mondiale degli USA) il capita-lismo globale proprio a causa dell’azione reagente da parte delle conculcate identità particolarie locali. Sulla teoria della società globale «reticolare» cfr. M. CASTELLS, The Rise of the NetworkSociety, Oxford, Blackwell, 1996, in part. pp. 376-428.
Dimenticare Clausewitz? 551
definizione di pace quale assenza di conflitto più o meno riconosciuto tra duesoggetti di diritto internazionale aprendo così la via alla predominanza, nelpanorama mondiale, delle guerre civili e insurrezionali. Ma anche queste ultimeavrebbero perduto buona parte delle caratteristiche che ne avevano in passatodelineato la fisionomia a seguito dell’avvenuto spostamento del fulcro della lottadalla legittimità di una entità statale, a cui i rivoltosi solitamente contrappo-nevano una legittimità diversa ma speculare e mirante alla costituzione di unostato ordinato su parametri sociali o ideologici differenti, alla lotta per il man-tenimento della propria identità etnica, tribale, culturale o religiosa minacciatadai processi di omologazione. Anche l’importanza di uno «stato sponsor» chefinanziasse, e all’occorrenza proteggesse entro i propri confini, gli insorgentiavrebbe perduto molta della sua primitiva importanza date le odierne possi-bilità di autofinanziamento mediante l’accesso ai mercati globali di armi e deicapitali, mediante il saccheggio e le vessazioni sulle popolazioni, il traffico inter-nazionale di stupefacenti o il contrabbando (117). In scenari come questi inol-tre la pace, lungi dall’essere clausewitzianamente il fine razionale di un governoo di un gabinetto di antico regime, smetterebbe di essere la naturale conclu-sione dello stato di guerra e anzi, nella situazione di fluidità determinata dallostate failure potrebbe benissimo non essere nel novero degli obiettivi deigruppi in lotta ai quali sarebbe sufficiente, spesso, affermare la propria soprav-vivenza tra le macerie fumanti della sovranità.
Sorta inizialmente quale reazione polemica alla ristrutturazione delle forzearmate statunitensi dopo l’avvio dell’attuale rivoluzione negli armamenti, anchela contemporanea ripresa dei concetti di guerriglia e conflitto asimmetrico siè nutrita degli stessi elementi che hanno sostanziato l’analisi della Kaldor e siinnestano direttamente nelle odierne previsioni sulla globalizzazione in atto.Il dibattito è iniziato già verso la fine degli anni Ottanta del secolo appenatrascorso ed è tuttora molto vivace soprattutto dopo l’interesse mediatico epolitico suscitato dagli attacchi terroristici della fine degli anni Novanta, del-l’undici settembre 2001, e dai conseguenti impegni Usa nell’area mediorien-tale. Anche su questo versante si è insistito sulla declinante abilità degli stati
(117) Sulle connessioni tra crimine e violenza organizzata nel prefigurato nuovo contestoglobale cfr. ancora P. WILLIAMS, Transnational Organized Crime and the State, in The Emergenceof Private Authority in Global Governance, a cura di R. B. Hall e T. J. Bierstke, Cambridge,Cambridge University Press, 2002, pp. 161-182, e gli altri saggi ivi contenuti oltre al volumeMenace to Society: Political-Criminal Collaboration Around the World, New Brunswick, Transaction,2003.
Emilio Gin552
ad arginare la violenza entro i propri confini e le inaspettate possibilità chela globalizzazione offrirebbe ai gruppi insorgenti di sfidare l’ordine costituitoriorganizzandosi su una struttura reticolare transnazionale, di cui al-Qaeda hafinito per rappresentare ben presto l’archetipo ideale, contro la quale a pocovarrebbero gli ultimi ritrovati tecnologici e un impianto dottrinario mirante aorientare le forze armate al classico scontro tra eserciti contrapposti entro campidi battaglia definiti. Il terrorismo internazionale e i gruppi insorgenti, a matricesoprattutto religiosa, mal si presterebbero a essere inquadrati nella classica con-cezione trinitaria della guerra del generale prussiano vista la sua supposta insi-stenza sulla ricerca e utilità della grande battaglia di annientamento tra armateregolari organizzate gerarchicamente. Anzi, in qualche caso, si è arrivati in modoparadossale a dichiararne l’inapplicabilità proprio perché, si ritiene, il conflittotra attori non statali o la minaccia del terrorismo odierno si sostanzierebberodi elementi non tanto militari quanto squisitamente culturali politici e massmediatici.
Le accuse al pensiero di Clausewitz sono state pertanto accolte e ripetuteanche da coloro che si sono riaccostati al problema della controinsorgenza,dopo la constatata difficoltà per le coalizioni guidate dagli Usa a pacificarel’Iraq e l’Afganistan e la proclamazione della guerra globale al terrorismo, esono state rifuse, in una rielaborazione delle acquisizioni sul tema sorte già apartire dagli anni Cinquanta, nel nuovo concetto di guerre di «quarta gene-razione».
Secondo i sostenitori di questa teoria (118), sulla base di un suppostocarattere darwiniano dell’essenza della guerra e del suo stretto legame con l’e-volversi della società, l’intera storia dei conflitti a partire dall’età moderna
(118) TH. X. HAMMES, The Evolution of War: The Fourth Generation, in «Marine CorpsGazette», vol. 78, No. 9 (Sept. 1994), p. 35 e ss.; W. S. LIND – K. LIGHTENGALE – J. SCHMITT
– J. SUTTON – G. I. WILSON, The Changing Face of War: Into the Fourth Generation, in «MarineCorps Gazette», November 2001, p. 22 e ss.; T. X. HAMMES, The Sling and the Stone. On Warin the 21 (st) Century, St. Paul, Zenith Press, 2004; ID., Fourth Generation Warfare: Our EnemiesPlay to Their Strengths, in «Armed Forces Journal» (Nov. 2004), pp. 40-44; Per una puntualecritica a tale teoria cfr. K. F. MCKENZIE, Elegant Irrilevance: Fourth Generation Warfare, in«Parameters», Autumn 1993, pp. 51-60; A. J. ECHEVARRIA, Deconstructing the Theory of FourthGeneration Warfare, in «Contemporary Security Policy», August 2005, pp. 11-20; ID., FourthGeneration War and Other Myths, Carlisle, Strategic Studies Institute, 2005. Gli spunti offertidalla riflessione sulle guerre di «quarta generazione» sono stati ripresi e riformulati nel con-cetto di «guerre ibride» da F. G. HOFFMAN, Conflict in the 21st Century: The Rise of HybridWars, Arlington, Potomac Institute for Policy Studies, 2007, che smussa molte delle critiche alpensiero clausewitziano.
Dimenticare Clausewitz? 553
potrebbe essere riassunta in periodi successivi i cui punti di svolta principalisarebbero costituiti dalla rivoluzione industriale e poi da quella dell’informa-zione. I mutamenti politici, sociali ed economici, dell’Europa degli stati-nazionevidero allora il proprio riflesso sul piano bellico in quella che è stata definital’età del mass manpower, il cui perfezionamento si sarebbe concretizzato nellastrategia napoleonica dell’impiego della massa nel punto decisivo sul campodi battaglia ben sintetizzata nelle opere intellettuali di autori quali Clausewitze Jomini. Il drastico salto nella qualità delle armi, ottenuto alle soglie del XXsecolo, avrebbe poi inaugurato l’era del mass firepower che rese obsolete leteorie dominanti nel periodo precedente, palesemente insufficienti alla luce dellecarneficine della prima guerra mondiale, e pose al tempo stesso il problemadel suo superamento effettuato solo col passaggio alla maneuver warfare pos-sibile grazie alla meccanizzazione degli eserciti e le relative teorie sul loro impiegoin combinazione con l’arma aerea. La attuale fourth generation warfare, fruttodelle recenti trasformazioni indotte dai mutamenti nell’economia mondiale enel campo dell’informazione, dunque presupporrebbe il declino dello stato qualeattore protagonista sul palcoscenico della guerra, accettando sul piano specu-lativo tutte le conseguenze già delineate dai teorici della globalizzazione, colrisultato di stravolgere dalle fondamenta la natura della guerra.
La strategia vincente nei tempi moderni passerebbe allora per l’utilizzo ditutti gli odierni network globali possibili, sociali, politici, economici, militarie mass mediatici per colpire direttamente al cuore la resistenza dell’avversa-rio, evidenziando ancora una volta l’effimerità – riecheggiando le tesi elabo-rate già durante e dopo le due guerre indocinesi – della superiorità bellicamateriale e dell’inutilità della ricerca della battaglia convenzionale come mezzopiù diretto per piegare la volontà del nemico e dell’illusorietà nel voler per-seguire il controllo del territorio in senso tradizionale. Al tempo stesso, la faci-lità odierna nel trasferimento dei dati, dei capitali, delle informazioni e degliindividui renderebbe estremamente pagante l’adozione, da parte dei bellige-ranti, di una poco vulnerabile struttura decentrata magari su scala planetaria,nei failed states, o anche nel cuore dei territori nemici, da cui pianificare ecoordinare gli attacchi, così come il ricorso alla finanza globalizzata e il col-legamento con le criminalità locali renderebbero possibile una certa autono-mia nel reperimento delle risorse.
Pertanto, alla luce di tutto questo non sembra affatto un caso che il padreintellettuale di tale ultimo stadio evolutivo nell’arte della guerra, che altro nonsarebbe che una forma perfezionata di guerriglia, sia stato individuato in MaoTse-tung e che al contempo sia stata riproposta una riattualizzazione del pen-siero di Sun Tsu, con la sua definizione della strategia quale arte dell’inganno
Emilio Gin554
e con la sua ipotesi ideale che fosse possibile giungere alla vittoria anche senzadover passare per la via del combattimento, quale fonte sicura cui attingereper un rinnovo degli studi strategici al posto degli ormai stantii insegnamenticlausewitziani. Col ritorno alla ribalta dell’approccio non convenzionale e dellaguerriglia si chiuderebbe così il cerchio di un lunghissimo periodo evolutivonella storia umana con una sorta di ritorno, a un livello più raffinato ma que-sta volta globale, alle origini primitive e premoderne della guerra quale attodi violenza organizzata.
6. Il fascino della «trinità»: dimenticare Clausewitz?
«Sono stati fatti molti confronti tra Clausewitz e Liddell Hart e l’ovviorisultato è che non sono uguali, ma non perché dicano cose diverse, o perchéle osservazioni di Liddell Hart sui carri, sul potere aereo, sulla guerra nucleare,sulla strategia indiretta non siano del livello delle osservazioni del grandePrussiano, ma perché dei due si ha una fruizione diversa. Mentre Clausewitzsi deve prendere o lasciare e si deve imparare, Liddell Hart si può prenderee lasciare, selezionare, accettare e discutere e, quindi, induce e produce pen-siero. Qualsiasi imbecille può spacciarsi per stratega se impara a memoriaClausewitz o se cita quattro delle sue innumerevoli leggi della guerra. Qualsiasiimbecille può diventare generale citando e seguendo alla lettera Clausewitz.Non importa se le conseguenze possono essere fatali. È già successo. SeguireClausewitz è sempre stato visto come un’assoluzione preventiva. Chiunque studie citi Liddell Hart deve invece essere disposto a fronteggiare l’immediata rea-zione della controparte. Deve integrare ciò che sa con ciò che pensa, perchéLiddell Hart non è mai conclusivo, anche quando sembra apodittico. LiddellHart è stato ed è maestro di persone normalmente intelligenti e coloro chepossono essere detti suoi “critici” devono dimostrare intelligenza superiore.La lista dei suoi estimatori è lunghissima ed è fatta di gente di ogni tipo: scrit-tori, filosofi, poeti, soldati, gente comune. Anche la lista dei suoi denigratoriè lunghissima, forse più dell’altra, perché l’imbecillità è una merce abbondante,ma la lista dei suoi veri «critici», quelli che lui stesso riconosceva come tali ècortissima e rappresenta una élite di pensatori che hanno reso ancora più pre-zioso il suo pensiero» (119).
(119) Così F. MINI nella Prefazione a B. LIDDELL HART, Paride, cit., pp. 71-2.
Dimenticare Clausewitz? 555
Come si vede, in queste parole di Fabio Mini nella prefazione alla recenteedizione italiana del Paride di Liddell Hart, è possibile misurare ancora oggila persistenza dei pregiudizi contro l’opera e il pensiero di Clausewitz inau-gurati dal capitano britannico al termine del primo conflitto mondiale. Al tempostesso però, al di là della stravagante idea per cui un utilizzo anche di singoliaspetti dell’opera di Liddell Hart possa risultare intellettualmente fecondomentre sterile finisca per risultare qualsiasi discussione su particolari temitratti dal Vom Kriege, tra le righe del giudizio del commentatore italiano siriproduce tutta la problematicità posta dal carattere ostico e dall’incompiu-tezza degli scritti di Clausewitz all’origine delle posteriori e spesso indebiteinterpretazioni.
Nella sua riflessione sul pensiero clausewitziano a metà anni Settanta delsecolo scorso lo stesso Raymond Aron non si nascondeva il pericolo intellet-tuale di un uso nozionistico, ossia slegato da un approccio complessivo, cuipoteva prestarsi il lavoro del generale prussiano (120).
Ad esempio, l’accenno all’importanza in guerra del fattore morale rispettoal mero dato quantitativo contenuto nel Vom Kriege giocò, sebbene mischiatoad altri fattori concomitanti, una parte non secondaria nella formazione delledottrine offensiviste degli stati maggiori alle soglie del primo conflitto mon-diale che sottovalutarono le possibilità offerte alla difesa dagli sviluppi dellatecnica, sorvolando sulle riflessioni che pure lo stesso Clausewitz aveva dedi-cato alla superiorità a livello teorico dell’atto difensivo (121).
Così, letture parziali o superficiali del suo pensiero sono servite molto spessoad alimentare il dibattito strategico su entrambe le sponde dell’Atlantico pro-prio nel senso stigmatizzato da Fabio Mini, come dimostra il caso della di-storsione che il concetto clausewitziano di guerra assoluta ha subito finendoper essere indebitamente confuso ed equiparato al molto diverso termine diguerra totale invalso tra i due conflitti mondiali (122).
(120) R. ARON, Penser la guerre, Clausewitz, II, L’âge planétaire, Paris, Gallimard, 1976, p.10.
(121) M. HOWARD, Men against Fire: The Doctrine of the Offensive in 1914, in Makers ofModern Strategy, cit., pp. 510-526; cfr. pure J. L. WALLACH, Misperceptions of Clausewitz’ OnWar by the German Military, e D. PORCH, Clausewitz and the French 1871-1914, entrambi inClausewitz and Modern Strategy, M. I. Handel (ed.), New York, Frank Cass, 2006 [1986], allepp. 212-239 e 287-302 rispettivamente.
(122) Anzi, vi è da sottolineare quanto il termine guerra totale sia stato utilizzato in Germaniadal generale Ludendorff proprio per ribaltare completamente il pensiero clausewitziano e giun-gere all’affermazione del primato assoluto del militare sul politico, o meglio della fusione di
Emilio Gin556
In modo simile si può procedere, come effettuato da Azar Gat, a una cer-nita tra i libri e i capitoli del Vom Kriege tentando di individuarne filologica-mente i più antichi, che l’autore non riuscì a rivedere prima della sua scom-parsa, allo scopo di isolare l’immagine genuina del pensatore prussiano qualeapostolo della guerra di annientamento mediante la battaglia decisiva (123). Perquesta direttrice si giunge a privare l’opera proprio della sua parte concet-tuale più feconda, costituita soprattutto dai libri I e VIII, ossia quelli in cuiClausewitz si interroga sul problema fondamentale della natura della guerracome fenomeno sociale e dei rapporti tra essa e la politica, e che risultanomeno ossidabili dall’usura del tempo. Pur volendo supporre che la discrasiatra i due Clausewitz, il predicatore della guerra assoluta e il sostenitore dellapolitica quale elemento moderatrice della violenza, siano inconciliabili, dav-vero risulta difficile comprendere per quale motivo il primo Clausewitz debbaessere ritenuto più «vero» del secondo. Al di là del fatto che tale modo diprocedere toglierebbe efficacia intellettuale a qualsiasi sistema di pensiero,contrapponendo in modo irrimediabile la fase giovanile agli scritti della matu-rità di ciascun autore, nel tener conto delle pur innegabili differenze nell’e-voluzione della riflessione clausewitziana a mio avviso non si può sottovalu-tare quanto, come rilevato autorevolmente, sia il metodo che le lineefondamentali di essa siano rinvenibili anche nelle sue prime opere (124).
Secondo Aron, più correttamente, proprio rileggere la parte dell’opera sca-turita dalla revisione del 1827 fornisce la chiave più valida per giungere a unacomprensione del messaggio del generale prussiano che sia valida anche nel-l’epoca contemporanea (125). Il metodo più diretto per capire la dinamica delfenomeno guerra per Clausewitz è infatti quello di paragonarlo alla lotta tradue individui; uno scontro tra due volontà tese, mediante il ricorso alla vio-lenza, al raggiungimento dei propri obiettivi contrapposti. Dall’urto delle duevolontà positive risulta naturale intravvedere il pericolo, insito in ogni situa-
entrambi gli aspetti nella persona del dittatore supremo della nazione in armi, cfr. E. LUDENDORFF,Der totale Krieg, München, Ludendorff-Verlag, 1936, cit. in J. EVOLA, La guerra totale, inEsplorazioni e Disamine, Parma, Edizioni all’insegna del Veltro, 1994, I, p. 69 e ss.
(123) Cfr. A. GAT, A History of Military Thought, cit., p. 170 e ss., 382 e ss.(124) P. PARET, Clausewitz and the State, Princeton, Princeton University Press, 1985, p. 78
e ss.(125) R. ARON, Penser la guerre, cit., II, p. 10 e ss.; C. JEAN nella Introduzione a C. VON
CLAUSEWITZ, Della guerra, cit., pp. XVII-LXIII; J. LUVAAS, Clausewitz, Fuller and Liddell Hart,in Clausewitz and Modern Strategy, cit., p. 197 e ss.
Dimenticare Clausewitz? 557
zione di conflitto, dello scivolamento progressivo verso livelli sempre più ele-vati di violenza sino a giungere alla «guerra assoluta», all’utilizzo senza frenidei mezzi di coercizione, che però per il generale prussiano resta da inten-dersi quale mero termine di paragone concettuale. Nella sua forma concreta,infatti, la guerra reale finisce sempre per differenziarsi dal suo modello asso-luto proprio perché essa, atto di forza organizzata, presuppone uno scopo, unamotivazione contingente discendente dallo stato delle relazioni reciproche deidue contendenti, un fine dunque «politico» che il gruppo in lotta si prefiggemediante il recursus ad arma.
La guerra dunque quale atto eminentemente politico volto al raggiungi-mento di un assetto delle relazioni tra i due soggetti contrapposti ritenuto nonottenibile senza l’utilizzo della violenza. Senza tale scopo razionale – raziona-lità da intendersi nel senso del rapporto tra un mezzo e un fine – sarebbepertanto fuorviante parlare di guerra e anzi una valutazione puramente mili-tare di una situazione strategica diverrebbe oltremodo pericolosa se non fossedi per sé un controsenso. Posta tale supremazia della politica sulla guerra biso-gna poi considerare che anche quest’ultima come atto compiutamente razio-nale rimane, nell’economia del discorso, un mero espediente di riferimento.Nella dinamica effettiva della guerra nella realtà concreta bisogna, infatti,tenere conto da un lato dell’elemento passionale, rappresentato concettualmentedal popolo nel suo insieme, dalla casualità e dall’attrito derivanti dall’impiegoe dall’urto delle forze combattenti, a cui aggiungere l’attività intelligente delvertice decisionale della nazione in lotta.
A questa trinità di elementi interagenti Clausewitz ne correla molteplicialtri, dall’incertezza sulle intenzioni e la forza del nemico, alla natura del ter-ritorio, all’impatto tra la volontà e il carattere del capo sulle forze morali emateriali che concorrono tutti non solo a fare del fenomeno bellico il regnodell’incertezza ma dare a ogni singola guerra la sua particolare individualitàstorica. Essa allora, se nella sua dinamica generale trova sempre dei freni allanaturale ascensione all’estremo, non è mai uguale a se stessa ma si presenta,come un «camaleonte», in forme e aspetti del tutto diversi nel corso dei secolia seconda della natura degli stati, dei capi, dei popoli, ovvero in una parola– contrariamente a quanto sostenuto sulla scarsa «sensibilità antropologica»di Clausewitz – a seconda del determinato contesto storico-culturale in cui essasi verifica (126)
(126) C. VON CLAUSEWITZ, Della guerra, Milano, Mondadori, 2000 [1942], Libro VIII, Cap.II, p. 794.
Emilio Gin558
Ogni epoca ha le sue proprie forme di guerra, le sue condizioni restrit-tive, i suoi pregiudizi. Ogni epoca dovrebbe dunque avere anche la sua teo-ria speciale della guerra, anche se si fosse stati disposti in tutti i tempi aconcretarla secondo criteri puramente razionali. Dobbiamo dunque giudicaregli avvenimenti di ciascun tempo in base alle loro caratteristiche; e solo chisappia riportarsi con la mente alle concezioni speciali d’ogni epoca, medianteun giusto colpo d’occhio anziché con un affannoso studio di tutti i parti-colari, sarà in grado di comprendere l’operato dei condottieri di ciascunaepoca e apprezzarli.
Inoltre, al di là delle condizioni squisitamente culturali e storiche, ogniconflitto presenta diversi gradi di intensità e forma propria a causa dell’inte-razione tra le due volontà politiche e la situazione contingente considerata nelsuo complesso. In altre parole, per la diversità degli interessi in gioco, o ancheper la sola percezione di essi, la disparità delle forze morali e fisiche in campo,la guerra può dunque variare dalla mera osservazione armata, o dalla scorri-banda in territorio nemico, alla guerra ideologica e di sterminio (127)
Dobbiamo dunque, per esporre la guerra quale è, cercare di costruirlanon già a mezzo di corollari desunti dalla sua definizione, ma lasciando unposto a tutti gli elementi estranei che in essa interferiscono, a tutti i pesi egli attriti, a tutte le inconseguenze, le incertezze, le esitazioni proprie dellospirito umano. Dovremo orientarci nel senso di vedere nella guerra e nelleforme che essa riveste un prodotto che porta l’impronta delle idee, dei sen-timenti e dei rapporti dominanti al momento della sua nascita. E anzi, sevogliamo essere del tutto nel vero, dobbiamo confessare che è stato così anchequando essa ha assunto, con Bonaparte, la sua forma assoluta.
Per altro verso appare del tutto naturale che Clausewitz, per descrivereil carattere trinitario del fenomeno guerra, ricorra alle categorie politiche e isti-tuzionali della sua epoca, giungendo a identificare la volontà politica al ver-tice del gruppo in lotta con l’intelligenza personificata dello stato, le forze com-battenti con gli eserciti professionali e i popoli con quelli dell’Europa d’inizioOttocento. E certamente quando egli passa a descrivere nei dettagli il com-battimento, la grande battaglia, o a soppesare la composizione ottimale deglieserciti nel rapporto tra fanti, cavalieri e bocche da fuoco, finisce per dive-
(127) Ivi, p. 776.
Dimenticare Clausewitz? 559
nire sempre più vincolato al suo periodo storico facendo perdere alle sue valu-tazioni ogni possibilità di resistere all’obsolescenza dei tempi. Pure, i suoistudi analitici delle operazioni storiche, come accadde nel caso della sua pole-mica indiretta con Wellington a proposito della campagna di Waterloo (128),possono prestarsi a critiche e contenere diverse inesattezze.
Ma destituire di ogni validità la sua analisi generale della guerra solo per-ché esposta mediante le categorie sociopolitiche dell’Europa moderna, insistendo– come Van Creveld (129) – sulla sua inapplicabilità al di fuori di codesto deter-minato ambito storico, a causa di un supposto, sempre imminente, e mai veri-ficato decadimento dello stato nelle sue funzioni belliche, credo sia alquantoingeneroso. Al di là del fatto che lo stesso Clausewitz, prima di esplicitare lacongruenza tra la volontà politica e l’«intelligenza personificata dello stato»,per definire il vertice razionale del gruppo in lotta utilizza in modo inter-cambiabile espressioni quali condottiero, nazione o stato (130), forse che Pericle,Cleone e Nicia non avessero da tenere in conto le passioni del demos ateniese,le caratteristiche dei propri opliti e della propria flotta nonostante l’inesistenzadello stato moderno e degli eserciti professionisti? O che Hassan Nasrallah,nonostante Hizballah sia tutto fuorché uno stato di antico regime, non debbatenere conto, nella sua lotta contro Israele, dell’impatto delle sue decisioni sullacomposizione della propria base di miliziani, sulla politica interna libanese, esul bacino teorico di reclutamento tra le masse musulmane oltre che delle rica-dute di efficacia sull’esercito israeliano e sugli equilibri politici tra Tel Aviv eTeheran? O ancora, che le riflessioni clausewitziane sulla supremazia della poli-tica sugli aspetti militari, sulla guerra quale regno dell’incertezza, sulla supe-riorità teorica della difesa, sul valore preminente degli aspetti psicologici inguerra, sull’economia delle forze, sulla tendenza naturale dell’attacco a esau-rirsi sino a un punto di equilibrio, condivisibili o meno, perdano per questoil loro carattere di atemporalità?
Ogni uomo è legato allo spirito dei suoi tempi e anche la sua operarisente dell’ambiente in cui è vissuto, Clausewitz non può essere un’eccezione.Molti di coloro i quali ne hanno proclamato l’inattualità, rifiutando di ana-lizzare il suo metodo e filtrare gli aspetti teorici da quelli più storici e con-tingenti, spesso ricorrono all’opera di Sun Tsu quale metro di paragone quanto
(128) Cfr. C. BASSFORD, Clausewitz in English. The Reception of Clausewitz in Britain andAmerica, 1815-1945, New York, Oxford University Press, p. 42 e ss.
(129) M. VAN CREVELD, The Transformation of War, cit., p. 33 e ss., e passim.(130) C. VON CLAUSEWITZ, Della guerra, cit., Libro I, pp. 19-38.
Emilio Gin560
a semplicità e inossidabilità dei concetti a fronte dell’usura del tempo (131),dimenticando quanto l’Arte della Guerra del pensatore cinese possa aver risen-tito del clima culturale, politico e istituzionale della Cina del V secolo avantiCristo. Una delle massime di Sun Tsu prescrive, ad esempio, l’inopportunitàdell’inseguimento a fronte di un nemico battuto che si stia ritirando e dilasciare sempre ad esso aperta una via di fuga (132): è facile immaginare qualesarebbe stata la reazione di un Napoleone, un Murat, di Patton o Rommelnell’udire tale affermazione.
L’aspetto che più colpisce dell’intera opera di Clausewitz, dunque, è il suocarattere antidogmatico, che la rende inadatta all’utilizzo quale vademecum infal-libile per qualsiasi situazione strategica particolare, dal momento che la suaragion d’essere originaria mirava a offrire al lettore una visione complessivadelle dinamiche generali del fenomeno guerra quale atto umano di violenzaorganizzata e quindi di fornire un metodo d’analisi propedeutico all’eventualestudio di problemi strategici contingenti. Lo stesso autore era consapevole delpericolo e, profeticamente, ma in modo altrettanto vano, non mancò di avver-tire il suo pubblico poco prima della sua morte (133).
Pertanto, proclamare l’obsolescenza dei precetti clausewitziani alla luce delmoderno carattere asimmetrico delle guerre contemporanee, oltre a sposareacriticamente le teorie sulla globalizzazione, significa snaturare la sostanza delsuo messaggio dal momento che l’asimmetria tra i belligeranti o anche i metodidi lotta meno convenzionali possono benissimo risultare congruenti entro i limiti
(131) Cfr. a titolo di esempio ancora LIDDELL HART, Paride, cit., p. 71; per un interessanteparallelo tra le opere dei due pensatori cfr. invece diversamente M. I. HANDEL, Masters of War.Classical Strategic Thought, London and New York, Routledge, 2005.
(132) SUN-TZU, L’arte della guerra, a cura di R. Fracasso, Roma, Newton Compton, 2006,p. 56.
(133) «Se una morte precoce dovesse interrompermi in questo lavoro, ciò che è fatto nonsi potrebbe considerare se non come una massa informe di pensieri, la quale, esposta a inter-minabili malintesi, darebbe occasione a molte critiche premature. Perché, in tale materia,ognuno crede degno d’esser detto e stampato tutto ciò che gli passa per il capo al momentoin cui prende la penna in mano; e lo ritiene indiscutibile come un assioma. Coloro che, comeme, si daranno invece la pena di meditare per lunghi anni su questo argomento, non trala-sciando di compararlo con la storia militare, si dimostreranno poi critici più circospetti. Tuttavia,nonostante la forma incompiuta del mio lavoro, penso che ogni lettore esente da pregiudizi edesideroso di giungere alla convinzione della verità, riconoscerà nei primi sei libri il frutto dimeditazioni e di uno studio assiduo della guerra, durato molti anni. E vi troverà forse alcuneidee fondamentali capaci di portare una rivoluzione nella teoria della guerra», C. VON CLAUSEWITZ,Della guerra, cit., p. 10; affermazioni contro l’approccio dogmatico alla guerra sono reiterateun po’ dovunque nel Vom Kriege.
Dimenticare Clausewitz? 561
della sua analisi generale. È naturale che Clausewitz, nel descrivere l’arte dellaguerra secondo Napoleone e nell’intento di dimostrare la distanza di quest’ultimarispetto a quella invalsa nell’età dei Lumi a seguito degli sconvolgimenti rivo-luzionari abbia insistito oltre misura sul valore della distruzione – mediantela grande battaglia – delle forze armate nemiche quale mezzo principale perottenere la sua sottomissione; ma è altrettanto vero che egli non disconosceaffatto che tale obiettivo possa essere raggiunto con tutti gli altri mezzi a dis-posizione, persino ricorrendo alla sovversione, soprattutto quando il rapportodelle forze materiali sia fortemente sbilanciato. Questo suo breve passo esem-plificativo potrebbe, a mio avviso, figurare a giusta ragione nelle più belle paginedegli Scritti Militari di Mao Tse Tung (134)
Ma possiamo altresì considerare un altro mezzo particolare per agiresulle probabilità del risultato senza atterrare la forza militare nemica: leimprese che hanno una ripercussione politica immediata. Se esistono impreseparticolarmente atte a rompere o paralizzare le alleanze del nostro avver-sario, per procurarne a noi delle nuove, per suscitare nel suo interno feno-meni politici a nostro favore, si vede chiaro come esse possono aumentaremolto le probabilità del successo e far raggiungere lo scopo seguendo uncammino molto più corto che non la distruzione delle forze. [...] [Inoltre]se l’intendimento negativo, e cioè la concentrazione di tutti i mezzi al finedi semplice resistenza, procura una superiorità nella lotta, e tale superioritàè così grande da compensare l’eventuale preponderanza di forze dell’avver-sario, lo scopo sarà semplicemente quello di prolungare la lotta, sì da por-tare gradatamente il dispendio di forza del nemico a un tale punto che ilsuo scopo politico non basti più a mantenere l’equilibrio e che egli debbarinunziare alla lotta. Chiaro risulta da ciò come questa via, lo spossamentodell’avversario, comprenda la maggioranza dei casi in cui il debole vuoleresistere al potente.
Allo stesso modo credo debbano considerarsi quanto meno impropri glistessi rilievi mossi al pensiero del generale prussiano dagli odierni teorici delleguerre di «quarta generazione», senza contare quanto fallace risulti, a un’in-dagine meno superficiale, la stessa base storica su cui tale teoria è statacostruita. Che le guerre anteriori al primo conflitto mondiale, e del periodo
(134) C. VON CLAUSEWITZ, Della guerra, cit., Libro I, p. 46 e 48-9; ed è da notare che ilcorsivo è dello stesso Clausewitz.
Emilio Gin562
napoleonico in particolare, siano state caratterizzate dall’impiego predomi-nante della massa umana rispetto al fuoco e alla manovra appare davvero pocosostenibile se non al prezzo di una fuorviante semplificazione. Se da un latoè innegabile che nel periodo rivoluzionario da parte francese il ricorso alla tat-tica d’urto, con la riscoperta della formazione in colonna, l’ordre profonde el’ordre mixte, fu all’origine di molti successi degli eserciti repubblicani (135),il ruolo fondamentale che la tattica del fuoco avrebbe continuato ad avere nelmedesimo tempo, se utilizzato sapientemente, pesando in modo capitale nellastessa sconfitta di Napoleone non può essere sottostimato (136). Mutatis mutan-dis, sostituendo i dardi alle pallottole, da Zama a Waterloo passando perCarre, Crécy e Agincourt non credo sia necessario aspettare i massacri dellaSomme per indicare nel «potere di fuoco» una componente fondamentalenell’arte della guerra. Così come per riconoscere l’importanza dei fattori psi-cologici e immateriali, della finanza e dell’opinione pubblica, delle compagnieprivate, a margine e spesso a monte della potenza e degli interessi degli statinella gestione e conduzione dei conflitti non ritengo si debba attendere l’av-vio dell’odierna fourth generation warfare: come parlare, per limitare gli esempi,dell’impero di Carlo V senza l’oro dei Fugger, di quello inglese senza laCompagnia delle Indie, o delle signorie italiane senza i capitani di ventura?E, posto che ci si accordi sul significato di asimmetria in guerra (137), ilRisorgimento italiano con la sua l’interazione tra gli stati, i gruppi privati diinteresse e gli attori non statali non sarebbe un conflitto asimmetrico in pienoOttocento, all’apogeo del vigore degli stati?
Eppure, le critiche all’inapplicabilità del pensiero del generale prussianoal contesto contemporaneo sono moneta corrente nelle teorizzazioni e nelle
(135) Cfr. D. CHANDLER, Le Campagne di Napoleone, Milano, Rizzoli, 1994, I, p. 210 e ss.,e p. 427 e ss.; e cfr. pure P. GRIFFITH, The Art of War of Revolutionary France, 1789-1802, London,Greenhill Books, 1998, p. 207 e ss.
(136) Cfr. J. WELLER, Wellington in the Peninsula, London, Vane, 1967, e ID., Wellingtonat Waterloo, London, Longmans, 1967.
(137) Sui limiti e sulla dubbia legittimità dell’utilizzo di termini quali «guerra a bassa inten-sità», «guerra asimmetrica» e simili cfr. la critica serrata di M. L. R. SMITH, Guerrillas in theMist: Reassessing Strategy and Low Intensity Warfare, in «Review of International Studies», vol.29, (2003), pp. 19-37, e ID., Strategy in an Age of ‘Low Intensity’ Warfare, in Rethinking theNature of War, cit., pp. 28-64. Cfr. ad esempio S. METZ – V. JOHNSON, Asymmetry and U.S.Military Strategy: Definitions, Background, and Strategic Concepts, Carlisle, Strategic StudiesInstitute, 2001, che forniscono una definizione di asimmetria talmente vasta da risultare quantomeno dispersiva.
Dimenticare Clausewitz? 563
riflessioni sul rinnovato problema dell’insorgenza dei nostri giorni, e le ragionidi tale scarsa sensibilità alla reale portata dell’insegnamento clausewitziano credosi possano ricercare su differenti piani esplicativi.
In primo luogo non è secondario sottolineare la forza di attrazione eser-citata dalle opere di Jomini nel ruolo di maggiore e indiscusso interprete dellastrategia napoleonica sino a essere stato identificato recentemente quale il verofondatore del moderno concetto di strategia (138). Napoleone, modello per eccel-lenza per le generazioni militari successive, fu infatti studiato e riappreso invia principale proprio tramite la mediazione costituita dagli insegnamenti delbarone svizzero, e la formazione della cultura strategica e militare, europea eamericana, risentì pertanto appieno del carattere normativo e dogmatico deisuoi scritti, alla ricerca delle leggi immutabili che dovevano aver reso possi-bili le strabilianti vittorie dell’imperatore francese. Per il barone svizzero lamanovra dalla posizione centrale e per linee interne, l’aggiramento sulle lineedi comunicazione del nemico, la concentrazione della massa sul punto deci-sivo, l’attenzione ai punti strategici e alle distanze geometriche tra essi, e innu-merevoli altre leggi della strategia, avevano permesso a Napoleone di innal-zarsi indiscusso sul trono del dio della guerra così come la loro violazione neavevano decretato il declino e la rovinosa caduta. La diversità dell’approccio,a fronte del più elastico e comprensivo metodo clausewitziano, non poteva per-tanto essere più radicale, nonostante Jomini stesso sulla spinta della critica dellostesso Clausewitz finisse per riconoscere la varietà storica dei conflitti a secondadei differenti contesti politici.
La separazione della strategia dalla politica, e dunque la convinzione chel’arte della guerra potesse obbedire a leggi proprie che fossero in grado dicondurre alla vittoria chi riuscisse a padroneggiarle, e che un determinato pro-blema strategico attendesse la sua soluzione anche in base a considerazioni esclu-sivamente militari, ebbe modo pertanto di filtrare a fondo nella comunità stra-tegica occidentale predisponendo il clima intellettuale adatto a leggere proprioClausewitz, una volta iniziata la diffusione delle sue opere, secondo canoni percosì dire «jominiani» favorendone un’interpretazione didascalica (139).
Come ho avuto modo di ricordare, il processo di decolonizzazione e, piùdi recente, gli sconvolgimenti seguiti al crollo dell’Urss e la fluidità politica
(138) J. SHY, Jomini, in Makers of Modern Strategy, cit., p. 144.(139) J. SHY, Jomini, in Makers of Modern Strategy, cit., p.161 e ss.; cfr. pure P. PARET,
Clausewitz and the Nineteenth Century, in The Theory and Practice of War, cit., pp. 21-41.
Emilio Gin564
mondiale successiva hanno poi rigenerato, e perpetuato, l’anelito jominiano atrovare ricette universali per risolvere i problemi strategici, che magari a un’a-nalisi più approfondita presentano caratteristiche simili soltanto a livello moltosuperficiale, nonostante gli scritti del vecchio pupillo di Ney siano ormaicaduti nel dimenticatoio.
A ben vedere, infatti, molte delle critiche oggi ascritte a Clausewitz sul-l’inutilità del suo pensiero a fronteggiare il contesto squisitamente politico deiconflitti di «quarta generazione», ignorando la natura analitica e non prescrittivadel suo pensiero, spesso si indirizzano proprio contro la mentalità tecnicisticadi taluni settori della comunità strategica occidentale che, però, non ha nulladi clausewitziano.
Ad esempio, la teoria della Fourth Generation Warfare ha trovato la suaorigine negli Stati Uniti quale strumento polemico per contrastare le derivatecnologica promossa dai sostenitori della cosiddetta «rivoluzione militare», daraggiungersi mediante l’informatizzazione dei sistemi d’arma e l’utilizzo dellatecnologia di precisione, soprattutto dopo che la strepitosa vittoria della coali-zione contro l’Iraq di Saddam Hussein nel 1991 aveva sembrato decretare lavalidità assoluta di tale tesi. Lo sforzo intellettuale volto a fornire supportoteorico per i concomitanti, ma spesso fallimentari, coinvolgimenti americanied europei in contesti «non convenzionali», dal Libano alla Somalia sinoall’Iraq, col riproporsi assillante del problema della controinsorgenza (140), hadunque mirato al recupero della dimensione umana e dei fattori morali entro
(140) S. METZ, The Future of Insurgency, Carlisle, Strategic Studies Institute, 1993; S. METZ
– J. KIEVIT, The Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War, Carlisle, Strategic StudiesInstitute, 1994; S. METZ – J. KIEVIT, Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theoryto Policy, Carlisle, Strategic Studies Institute, 1995, S. METZ, Armed Conflict in the 21(st)
Century: The Information Revolution and Post-Modern Warfare, Carlisle, Strategic StudiesInstitute, 2000; R. M. CASSIDY, Back to the Street Without Joy: Counterinsurgency Lessons fromVietnam and Other Small Wars, in «Parameters», Summer 2004, pp. 73-83; S. METZ – R. A.MILLEN, Insurgency and Counterinsurgency in the 21(st) Century: Reconceptualizing Threat andResponse, Carlisle, Strategic Studies Institute, 2004; D. KILCULLEN, Countering Global Insurgency,in «Journal of Strategic Studies», vol. 28, August 2005, pp. 597-617; Strategic Challenges forCounterisurgency and the Global War on Terrorism, W. Murray (ed.), Carlisle, Strategic StudiesInstitute, 2006; S. METZ, Rethinking Insurgency, Carlisle, Strategic Studies Institute, 2007; ID.,New Challenges and Old Concepts: Understanding 21(st) Century Insurgency, in «Parameters»Winter 2007-8, pp. 20-32; D. S. ROPER, Global Counterinsurgency: Strategic Clarity for the LongWar, in «Parameters», Autumn 2008, pp. 92-108; con attenzione al dibattito parallelo sulla glo-balizzazione cfr. invece P. B. RICH, Theories of Globalization and Sub-State Conflict, in Rethinkinghthe Nature of War, cit., pp. 191-209.
Dimenticare Clausewitz? 565
le mura del Pentagono e dei ministeri della difesa occidentali. In questo sensotale impulso ben potrebbe rientrare nell’orizzonte e nello spirito dell’analisidi Clausewitz se non ne avesse frainteso il messaggio sull’essenza della guerraa livello teorico, dimenticando che nelle sue riflessioni, tra le altre cose, il gene-rale prussiano non precludeva affatto l’evoluzione dei modi di fare la guerralungo i secoli, e tralasciando il suo invito a non farsi irretire dalla chimericaprospettiva di trovare delle ricette strategiche valide in assoluto.
In secondo luogo, a mio avviso, tanto la critica ai sostenitori della rivo-luzione militare quanto la rinnovata idiosincrasia intellettuale verso la malcompresa teoria clausewitziana affondano molte delle loro radici nel semprefriabile terreno di convergenza tra l’ambito della pianificazione diplomatica equella strategico-militare. Come è stato giustamente rilevato per gli StatiUniti (141), proprio la difettosa comunicazione tra i due aspetti della politicaestera, che trova la propria origine nella troppo rigida separazione tra l’am-bito civile e quello militare, può essere individuata quale causa delle cronichedifficoltà a gestire con efficacia i molteplici, e spesso imprevisti, impegni bel-lici da parte del pur possente strumento militare americano. In altre parole,la scarsa sensibilità al contesto, all’ambiente in cui i militari statunitensi si tro-vano di volta in volta a operare deriverebbe in ultima analisi proprio dallamancanza di una strategia clausewitzianamente intesa, un deficit strategicoderivato in parte dalle stesse incertezze dell’unica potenza di livello planeta-rio, col risultato di ingenerare nella comunità strategica d’oltremare l’istintiva(e molto jominiana) tendenza a elaborare sempre fuorvianti ricette universalia temi quali la controinsorgenza o le cosiddette operazioni di stabilizzazionee peace enforcing. La medesima questione, vista dalla nostra spondadell’Atlantico, non appare poi molto diversa in una Europa, con la parzialeeccezione della Gran Bretagna (142), in cui l’approccio «post-eroico» alla poli-tica estera molto spesso nasconde, dietro il proliferare di pericolosi ossimori
(141) Cfr. C. S. GRAY, Recognizing and Understanding Revolutionary Change in Warfare: TheSovereignty of Context, Carlisle, Strategic Studies Institute, 2006, in part. p. 10 e ss.; cfr. purela controversia del medesimo autore con Martin Shaw in ID., In praise of Strategy, in «Reviewof International Studies», vol. 29, n. 3 (2003), pp. 285-295 e J. R. CERAMI - J. W. BOGGS, TheInteragency and Counterinsurgency Warfare: Aligning and Integrating Military and Civilian Rolesin Stability, Security, Transition, and Reconstruction Operations, Carlisle, Strategic Studies Institute,2008.
(142) A. M. DORMAN, Transforming to Effects-Based Operations: Lessons from the UnitedKingdom Experience, Carlisle, Strategic Studies Institute, 2008.
Emilio Gin566
quali gli «interventi militari umanitari» e i «soldati di pace», proprio quellamancanza di osmosi intellettuale tra il ceto militare e quello politico-civile, edunque manifestando una difettosa visione strategica complessiva che lungi dal-l’identificarsi con l’ottuso militarismo, secondo Clausewitz, dovrebbe sempreinformare l’agire di una classe dirigente che voglia dirsi responsabile.
EMILIO GIN
Università degli Studi di Salerno
Since the meltdown of the Soviet Union and its imperial system in the finalturn of the XX Century many voices have been raised indicating an incomingchange in the nature of war. One branch of the debate was constituted by thereflections about the supposed «revolution in military affairs» promoted by themarvelous technological leap occurred in the intelligence systems, stand-offweapons, and in the command and control chain. On the other hand, the returnof civil strife and ethnic conflict on the European landscape, after the tragic fail-ure of the Yugoslavian state as well as in other areas of the world, have drawnnew attention on old concepts like «irregular warfare» or «insurgency» andspurred many authors, like Mary Kaldor and Martin Van Creveld, in declaringthe impending obsolescence of war in the traditional sense, and inducing othersin defining the new concept of «fourth generation warfare». In all the cases theseanalysis have been supported by a parallel devaluation of Carl von Clausewitz’sclassical thinking about the nature of war. In this article the author makes areview of the fortunes of concepts like «guerrilla warfare» from the Napoleonicage to the present, stressing the continuing relevance, even in our chaotic times,of Clausewitz’s analysis of war as a political enterprise.