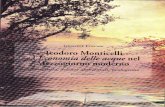Conflitti ambientali e territorio. Alcune evidenze dalla crisi dei rifiuti in Campania. (...
Transcript of Conflitti ambientali e territorio. Alcune evidenze dalla crisi dei rifiuti in Campania. (...
5
Indice 7 Presentazione
Oltre la logica parametrica dei divari Tullio D’Aponte
11 Per un approccio “geopolitico” al tema della marginalità terri-
toriale Tullio D’Aponte
71 Competitività territoriale e occasioni di sviluppo
Daniela La Foresta 87 Conflitti ambientali e territorio. Alcune evidenze dalla crisi dei
rifiuti in Campania Vittorio Amato
107 Dalla fabbrica a Gomorra. La trasformazione dell’area orienta-
le di Napoli Ernesto Mazzetti e Giovanna Russo
149 Utopie e realtà nei progetti per lo sviluppo dei Campi Flegrei
Anna Maria Frallicciardi, Marcello D’Anna, Miriam Di Fraia e Francesca Cerisano
171 La fascia costiera napoletana tra sviluppo e congestione:
l’impatto del turismo sull’ambiente Maria Laura Gasparini
Indice 6
205 Pompei un caso di turismo “incompiuto” Viviana D’Aponte
223 Le discariche dismesse della città stagionale del Parco Nazio-
nale del Cilento e Vallo di Diano. Fattori di degrado e priorità degli interventi per il recupero ambientale Mariagiovanna Riitano
251 Le discariche dismesse della città stagionale del Parco Nazio-
nale del Cilento e Vallo di Diano. Linee fondamentali della struttura geolitologica dei siti Massimiliano Bencardino
263 Armatura territoriale, traiettorie di sviluppo e marginalità in
Provincia di Salerno Teresa Amodio
285 Il sistema urbano di Benevento
Massimiliano Bencardino 297 Cupello: natura, uomo, ambiente. Un caso di sostenibilità am-
bientale nello sviluppo insediativo Gian Luigi Bocchetta e Rocco Guerriero
87
Conflitti ambientali e territorio. Alcune evidenze dalla crisi dei rifiuti in Campania
Vittorio Amato
1. Scelte politiche e territorio Non è nostra intenzione, in questa sede, analizzare le molteplici ed
intricate tappe dell’annosa vicenda dell’emergenza rifiuti in Campa-nia. Purtuttavia, è necessario ripercorrere almeno gli eventi salienti che, nell’ultimissima, fase hanno portato, per scelte strettamente lega-te all’uso del territorio, all’insorgere di conflitti ambientali.
Nel corso del 2007 si verificò, infatti, una nuova e più grave crisi nella gestione dei rifiuti, che indusse il Governo in carica1 ad interve-nire direttamente individuando nuovi siti da destinare a discarica ed orientando la soluzione del problema verso la regionalizzazione dello smaltimento dei rifiuti. Veniva autorizzata la costruzione di tre nuovi inceneritori superando, in tal modo, l’impostazione della gestione commissariale del Presidente della Regione che ruotava intorno alla travagliata costruzione del termovalorizzatore ad Acerra.
L’ordinanza per la costruzione degli inceneritori viene firmata il 31gennaio 2008. Per la gestione delle nuove criticità emerse il Presi-dente del Consiglio nomina nuovo commissario per l’emergenza rifiu-ti l’ex capo della Polizia di Stato, con l’obiettivo di risolvere la situa-zione entro quattro mesi. Riprendono così i trasferimenti di rifiuti ver-so la Germania tramite ferrovia, con un costo nettamente inferiore ri-spetto a quanto il commissariato per l’emergenza spendeva per smal-tirli in Campania. Inoltre, vengono individuate ulteriori nuove aree da adibire a discarica, tra cui la discarica chiusa nel quartiere di Napoli Pianura, e, successivamente, una cava dismessa nel quartiere di Chiaiano, al confine con il comune di Marano di Napoli, scelta che subito porta ad una violenta protesta della cittadinanza locale.
Prof. Straordinario di Geografia Economico Politica, Università di Napoli “Federico II”. 1 Ci si riferisce al Governo Prodi.
Vittorio Amato 88
Tabella 1 – Quadro degli impianti di gestione dei Rifiuti Urbani in Campania
Anno Imp. Compostaggio Inceneritori Discariche
2008 Teora (AV) 6000 T/anno 0
Savignano Irpino (AV) 700.000 m3 dal 06/08 S.A. Trimonte (BN)
750.000 m3 dal 06/2006 Serre (SA)
700.000 m3 chiusa 08/08
2009
Molinara (BN) 10.000 T/anno
S.Tammaro (CE) 30.000 T/anno
Teora (AV) 6.000 T/anno
Acerra (NA) 600.000 T/Anno
Chiaiano (NA) 700.000 m3 dal 02/09
Terzigno (NA) 650.000 m3 tempi n.d.
San Tammaro 150.000 m3 dal 01/09
Tempi non definiti
9 impianti con POR 2000/2006 per
223.000 T/anno Impianti di Avellino e Casalduni convertiti
Altri impianti con POR 2007/2013
Salerno 450.000 T/anno S.Maria la Fossa
Napoli Termovalorizz. Eco-
balle - non localizzato e non definito
Serre (SA) - Valle della masseria
Caserta - loc. Torrione Andretta (AV) loc. Pero
Spaccone
Il mandato del commissario viene nel frattempo prorogato alla sca-
denza dal Governo dimissionario e la situazione, ancora lontana dall’essere risolta, degenera con gravi ripercussioni sull’ordine pubblico.
Il 21 maggio 2008, quindi, il nuovo Governo appena insediato2 tie-ne il suo primo consiglio dei ministri proprio a Napoli, ed approva un decreto legge3 con cui, allo scopo di avviare definitivamente un ciclo integrato dei rifiuti, si stabilisce la costruzione di quattro, anziché tre nuovi inceneritori, si individuano dieci siti in cui realizzare altrettante nuove discariche - che vengono contestualmente dichiarate zone di in-teresse strategico nazionale di competenza militare - e si prevedono sanzioni fino al commissariamento per i Comuni che non dovessero portare a regime la raccolta differenziata.
2 Ci si riferisce al Governo Berlusconi. 3 Il n. 90 del 23 maggio2008, convertito in legge n. 123 del 14 luglio 2008.
Conflitti ambientali e territorio 89
Si prevede, inoltre, la cessazione dello stato di emergenza per il 31 dicembre 2009, nonché la nomina a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’emergenza rifiuti del capo della Protezione civile4. All’art. 9, tuttavia, il decreto in questione, in deroga a tutte le norme vigenti in materia, comprese quelle comunitarie, autorizza lo smaltimento nelle nuove discariche anche dei rifiuti pericolosi5, scelta che rende ancor più ferma l’opposizione alla loro realizzazione da par-te delle popolazioni locali. L’articolo 3, in deroga alle norme del codi-ce di procedura penale e dell’ordinamento giudiziario, prevede l’anomala attribuzione alla Procura della Repubblica presso il Tribu-nale di Napoli della competenza esclusiva ai fini dell’accertamento dei reati ambientali commessi su tutto il territorio della Campania.
Con un’ordinanza6, il Presidente del Consiglio dispone, poi, il commissariamento ad acta dei sette impianti per la produzione di cdr realizzati dalla FIBE, nel frattempo convertiti in impianti per la sem-plice tritovagliatura e l’imballaggio dei rifiuti, ed il 18 luglio l’emergenza dovuta alla mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani in Campania viene dichiarata chiusa. Ciò accade anche se, in mancanza dell’entrata in funzione di tutti i termovalorizzatori previsti nonché di una soddisfacente raccolta differenziata, un ciclo industriale dei rifiuti non può dirsi stabilmente avviato, mentre restano ancora da smaltire cinque milioni delle cosiddette “ecoballe” ancora in giacenza.
Nel tentativo di contenere l’indiscriminato accumulo di rifiuti non smaltibili ordinariamente, ed a conferma della difficoltà di uscire ef-fettivamente dallo stato di emergenza, il Governo approva un decreto-legge7, contenente una serie di norme, valevoli per i territori in stato di emergenza in relazione allo smaltimento dei rifiuti, tra le quali la pre-visione dello specifico reato di abbandono di rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti, punito con la reclusione fino a cinque anni. Dopo l’apertura della contestata discarica di Chiaiano, avvenuta alla metà di febbraio 2009, a fine marzo 2009, dopo l’ultimazione dei lavori, viene quindi avviata la fase di collaudo del termovalorizzatore di Acerra, da
4 Guido Bertolaso, già commissario nel 2006-2007. 5 Contraddistinti dai codici CER 19.01.11, 19.01.13, 19.02.05 e 19.12.11, fattore. 6 Del 16 luglio 2008. 7 Il n. 172 del 6 novembre 2008.
Vittorio Amato 90
concludersi entro dicembre con la consegna dell’impianto al gestore, la società A2A8.
2. Le cause dell’emergenza rifiuti Le cause alla base dell’emergenza rifiuti in Campania sono com-
plesse ma sostanzialmente riconducibili ad una commistione di errori tecnico-amministrativi uniti ad interessi politici, industriali e malavi-tosi. Di fatto, esse possono essere in parte individuate nei ritardi di pianificazione e di preparazione di discariche idonee, la cui progetta-zione e realizzazione inizia solamente a partire dal 2003; nell’inadeguato trattamento dei rifiuti urbani nei sette impianti di pro-duzione di combustibile derivato dai rifiuti (cdr), originariamente co-struiti e gestiti da società del Gruppo Impregilo; nei ritardi nella piani-ficazione e nella costruzione di inceneritori, dovuti anche a prescrizio-ni della magistratura sui progetti in essere e finalizzate ad una maggio-re tutela dell’ambiente e a contrastare la camorra; nei ritardi nella pia-nificazione e nella costruzione di impianti di compostaggio della fra-zione organica dei rifiuti proveniente da raccolta differenziata, ed, in-fine, nei bassi livelli medi della stessa, che nel 2007 nella Provincia di Napoli si fermava ad un irrilevante 8%.
Al di là delle cause tecniche ed amministrative, va però anche sot-tolineato come lo stato di emergenza abbia rappresentato, di per sé, una situazione economicamente vantaggiosa non solo per la criminali-tà organizzata campana9 ma anche per larghi settori dell’imprenditoria legale (dietro la quale si cela spesso comunque la camorra), che da un lato approfitta del sistema di smaltimento illegale per abbattere i costi, e dall’altro entra direttamente nella gestione della crisi. L’insieme di tali elementi ha determinato quindi il perpetuarsi di una situazione in cui, di fronte a forti interessi economici, più o meno criminali, si sono po-ste istituzioni politiche dimostratesi largamente incapaci di contrastarli.
8 A2A è la multiutility nata il primo gennaio 2008 dalla fusione tra AEM SpA Milano e ASM SpA Brescia con l’apporto di Amsa ed Ecodeco, le due società ambientali acquisite dal Gruppo.
9 Che, secondo alcune stime, con la gestione illecita dei rifiuti raccoglie profitti anche maggiori che con il traffico di droga o le estorsioni.
Conflitti ambientali e territorio 91
3. L’innesco dell’effetto NIMBY L’insieme delle cause sopra citate – che in particolar modo negli
anni Duemila hanno condotto ad una drammatica crisi nella gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania – ha an-che comportato, come si accennava in precedenza, la necessità di tro-vare soluzioni di breve e medio termine, come la riapertura o la realiz-zazione di nuove discariche, per superare l’emergenza in tempi rapidi. Ciò ha determinato forti proteste da parte della popolazione che vive nei dintorni dei siti di volta in volta individuati allo scopo, secondo l’ormai ben nota logica descritta come effetto NIMBY (Not In My Back Yard, “non nel mio giardino”). É necessario, tuttavia, sottolinea-re che i cittadini che si sono opposti alla riapertura delle discariche hanno motivato la propria posizione sostenendo che le scelte di piani-ficazione fatte in materia di stoccaggio dei rifiuti sono quasi sempre
Figura 1 – Discariche e termovalorizzatori in servizio ed in progetto
in Campania
Vittorio Amato 92
relative a cave dismesse, fuori norma ed inadeguate per motivi struttu-rali, geografici e, soprattutto, per ragioni sanitarie.Ciò mentre numero-se proposte di siti alternativi sono state ignorate, o, addirittura, in pre-senza di discariche già pronte, ma mai utilizzate.
A tal proposito, per meglio comprendere il paradosso, si consideri ad esempio che la cava dismessa di Chiaiano, individuata tra i nuovi siti da destinare a discarica fu acquistata dalla FIBE nel 2002 ad un prezzo superiore di otto volte quello di mercato. Spesso, poi, le cave dismesse scelte come siti dal commissariato sono già state sfruttate dalla criminalità organizzata, che, in spregio a qualsiasi norma, vi ha scaricato ingenti quantità di rifiuti industriali altamente tossici. Inoltre, vi sono casi in cui siti utilizzati come discarica distano da abitazioni civili solo poche decine di metri, a volte anche a causa dell’abusivismo edilizio10.
4. Il carattere dei conflitti ambientali Il poco incoraggiante scenario appena accennato per la Campania
dimostra, ancora una volta, che i conflitti ambientali nascono dall’interferenza di iniziative infrastrutturali ed industriali con quelle dei cittadini e con i loro interessi nel quadro di una conflittualità tra-sversale che è tipica delle società dei paesi industriali avanzati. Le cause di tali conflitti possono essere varie ma, in genere, sono ricon-ducibili a due categorie di problemi: la presenza fisica di infrastrutture o di impianti industriali e la destinazione dei rifiuti siano essi urbani o di lavorazione. Tra i valori in gioco se ne possono individuare di mol-to differenziati. Per citarne solo alcuni si può pensare alla vocazione naturale del territorio, alla salute, alla sicurezza, all’identità culturale, agli interessi economici, al paesaggio, alla qualità della vita; etc.
Molti di questi conflitti sono interpretabili in termini di competi-zione, in regime di scarsità, per beni a carattere monetario: le infra-strutture o le imprese, nella loro azione quotidiana, consumano i co-
10 La contiguità deriva dal fatto che le organizzazioni criminali in quelle cave hanno effet-
tuato prima lo sterro, poi il riempimento con rifiuti tossici ed infine la cementificazione con la costruzione di case più o meno abusive, ottenendo, quindi, un doppio ritorno economico.
Conflitti ambientali e territorio 93
siddetti “beni liberi” (aria, acqua, paesaggio, etc.) senza dar loro un particolare valore perché non di pertinenza delle loro contabilità. I cit-tadini, invece, attribuiscono a tali beni un valore ed un’influenza im-portanti sulle loro condizioni di vita.
Il risultato possono essere azioni di protesta ed opposizione che, talvolta, culminano con la richiesta -e l’ottenimento- della non localiz-zazione dell’infrastruttura o della cessazione delle attività dell’impresa.
In genere, la causa scatenante di questi contrasti non è tanto il livel-lo assoluto degli effetti contestati, quanto la loro variazione rispetto al-la situazione esistente. Ciò fa sì che, nella pratica, ogni caso sia un ca-so a sé, per cui paragoni e precedenti hanno scarso effetto sulla solu-zione del conflitto.
Altro elemento da considerare è la scarsa interscambiabilità dei va-lori in gioco, per cui le cosiddette “misure compensative”, cioè la compensazione di determinati effetti nocivi con vantaggi pecuniari o di altro genere, sovente non producono effetti.
5. Rischi tecnologici e conflitti in una prospettiva geografica In termini generali, il rischio tecnologico nasce con l’uso individua-
le e collettivo della tecnologia e presenta un insieme di problemi e ri-sposte che risultano molto diversi rispetto a quelli originati dai rischi naturali. Inoltre, i rischi tecnologici poiché sono spesso più pervasivi e meno individuabili di quelli naturali, pongono dei problemi di gestio-ne molto peculiari. Va aggiunto, poi, che al contrario dei rischi natura-li, quelli tecnologici sono complessivamente poco percepibili e ciò fa sì che la risposta del pubblico a tali rischi sia spesso ambigua tradu-cendosi in reazioni di sovrastima o di sottostima o, peggio ancora, di frequente indifferenza. Accade infatti che si faccia affidamento, in li-nea di massima, unicamente sulla comunità scientifica per la loro pre-venzione ed il loro governo. Su questo tema la geografia dovrebbe es-sere e sentirsi estremamente coinvolta perché è proprio la distribuzio-ne dei rischi tecnologici che permette di capire le interazioni tra tecno-logia e società, l’impatto della tecnologia sulla società e l’ambiente e l’adattamento a queste condizioni di rischio.
Vittorio Amato 94
I rischi tecnologici possono, in sintesi, esser definiti come la intera-zione tra tecnologia, società ed ambiente, sono costruiti all’interno della società e come tali sono connessi a più ampi contesti politici, e-conomici, sociali e storici e risultano inseparabili da questi. Si può di-re pertanto che non è possibile capire un rischio senza prendere in considerazione il contesto in cui esso si è prodotto.
Il rischio tecnologico, come campo di indagine scientifica, non è evidentemente di esclusiva competenza delle scienze sociali ma rien-tra certamente nell’ambito di ricerca della Geografia per gli aspetti della localizzazione e distribuzione, per i tipi di ambienti e persone che possono esservi esposte, per gli eventuali risultati di questa espo-sizione ed infine per i metodi idonei a ridurre gli impatti sull’uomo e sull’ambiente.
La prospettiva geografica è importante per comprendere la feno-menologia dei rischi tecnologici, la loro distribuzione, il loro impatto e le possibilità di loro riduzione. Certo è che risulta estremamente più facile indagare una forma di rischio puntuale e localizzata – come ad esempio una centrale elettrica che riversa le sue emissioni sui territori circostanti – piuttosto che indagare gli impatti cumulativi delle emis-sioni di gas serra sul fenomeno del mutamento climatico. Il livello di complessità (capire il processo ed il contesto che creano il rischio ini-ziale così come le risposte della società) aumenta spostandosi dalla scala locale (micro) alla scala globale (macro).
La geografia ci aiuta inoltre a capire la distribuzione degli impatti dei rischi tecnologici. Qual è il modello geografico dei rischi? É que-sta certamente una delle domande centrali di ogni ricerca sulla natura e sulle caratteristiche dei rischi tecnologici.
6. Percezione del rischio e comportamenti territorializzati Ricorrenti sondaggi di opinione hanno tentato di definire quale fos-
se la percezione del rischio da parte dei cittadini rispetto ad un insieme di problemi ambientali, nel tentativo di confrontare i risultati con quel-le che sono ritenute, in ordine di priorità, le emergenze prospettate in sede scientifica. Nel 1984, ad esempio, l’inquinamento ambientale era considerato ai primi posti nella scala delle emergenze dal 44% degli
Conflitti ambientali e territorio 95
intervistati, questa percentuale è salita al 62% nel 1989 (Dunlap, 1991). La maggioranza degli intervistati di un sondaggio sponsorizza-to dall’E.P.A. valutarono 17 dei 29 problemi ambientali presentati come molto seri (Miller e Keller, 1991). I problemi che emergevano come più preoccupanti in questo sondaggio erano i depositi di rifiuti tossici, l’inquinamento delle acque da parte dell’industria, l’esposizione dei lavoratori a sostanze tossiche, la riduzione dello stra-to d’ozono e la radioattività derivante da centrali nucleari. Sempre nel-lo stesso sondaggio questioni ambientali che viceversa ponevano bassi rischi includevano radiazioni da microonde e raggi X e l’inquinamento dell’aria degli ambienti di uffici ed abitazioni. Da que-sto studio emerge una mancata coincidenza – potremmo dire una vera e propria discrasia – tra le emergenze individuate dai cittadini e quelle definite in sede scientifica.
Ad esempio i depositi di rifiuti tossici, indicati dalla maggioranza degli intervistati al primo posto della lista dei problemi più seri (l’84% del campione), vengono, invece, collocati dal gruppo degli esperti ad un livello molto più basso; al contrario, riguardo l’inquinamento dell’aria in ambienti domestici e lavorativi esso è preso in seria consi-derazione dagli esperti mentre è sottovalutato o per nulla considerato dal pubblico.
É evidente l’esistenza di una spiccata divergenza di interpretazioni probabilmente riconducibile all’influenza che i mezzi di comunicazio-ne hanno sull’opinione pubblica. Essi, infatti, forniscono immagini più vivide e più durature della degradazione ambientale per cui il pubbli-co, quando viene richiesto di una valutazione, richiama alla mente queste immagini piuttosto che ricordare le stime scientifiche e i dati che le contraddicono. In relazione allo scenario campano la tabella n. 2, attraverso la frequenza delle parole utilizzate, mette in luce il ruolo svolto dai mezzi d’informazione nella veicolazione presso l’opinione pubblica dell’ “emergenza rifiuti”. Va, inoltre, considerato che i media tendono a fornire immagini e notizie di eventi dalla elevata spettacola-rità, e che, proprio in virtù di questa caratteristica, tendono a rimanere impressi nella memoria collettiva.
Si è giunti pertanto alla sensazione che si debbano fronteggiare molti più rischi ora che in passato, e che i rischi futuri saranno mag-giori degli attuali in una sorta di processo cumulativo di cui non si in-
Vittorio Amato 96
travede la fine né il punto di inversione. L’assioma che i rischi e la degradazione dell’ambiente aumentano all’aumentare del livello tec-nologico della società è un punto di vista molto diffuso ma bisogna chiedersi se tutto ciò è vero o se la preoccupazione dipende dal fatto che siamo sempre più consapevoli e informati.
Un termine frequentemente utilizzato quando si parla di rischio è quello di “percezione”. Percezione sta ad indicare il recepimento di stimoli ambientali da parte dei nostri cinque sensi. La cognizione, dall’altro lato è il processo che dà un significato agli stimoli che sono codificati e filtrati dalla nostra esperienza individuale, dal nostro si-stema di valori e credenze ed infine conservata come conoscenza e ri-cordi: il processo cognitivo procede senza che noi ce ne rendiamo conto.
Esistono più o meno sottili distinzioni nell’espressione “percezione del rischio”, ognuna basata su diverse prospettive disciplinari. Nel lin-guaggio geografico, ad esempio, la percezione del rischio dovrebbe essere un processo che lega il giudizio individuale del livello di ri-schio all’azione. Questa definizione dà forza ad un punto di vista che vede la percezione come qualcosa di più di un semplice processo co-gnitivo che forma la percezione. La percezione del rischio lega il giu-dizio all’azione, ed esamina quei fattori che influenzano la scelta di riaggiustamento dell’individuo in risposta al rischio. Questa distinzio-ne è importante perché, mentre gli psicologi pongono l’enfasi sul pro-cesso, i geografi dovrebbero farlo sulla risposta. In particolare l’interesse geografico negli studi sulla percezione del rischio è stato usato per spiegare il range delle scelte di aggiustamento per influenza-re dei cambiamenti nelle politiche più che per capire il processo cogni-tivo che sottostà alla percezione. I geografi, in sostanza, studiando la percezione del rischio cercano di capire perché e come la gente agisce in risposta a minacce ambientali e come essa forma la sua percezione dell’insieme delle azioni possibili da mettere in atto per una eventuale risposta. In tema di rischi naturali, ad esempio, la modellizzazione fat-ta da Alexander (1993) dimostra l’efficacia dell’analisi geografica.
In una rassegna della letteratura sul rischio tecnologico Covello (1983) evidenzia tre conclusioni principali relative alla tendenza, alla stima e alla credibilità del rischio. In primo luogo egli sostiene che li-miti dell’intelletto umano portano l’individuo a determinare delle scel-te, ad interpretare situazioni in base non a parametri oggettivi ma pu-
Conflitti ambientali e territorio 97
ramente istintuali: tali atteggiamenti, nel campo in questione, si tradu-cono in una visione semplificata del rischio. Ad esempio si tende a giudicare un evento più frequente quando sia possibile richiamare alla memoria delle immagini ad esso relative. L’evento di un disastro ae-reo, con tutta la sua cornice di operazioni di salvataggio, viene perce-pito come relativamente frequente mentre è noto che le vittime dei di-sastri aerei sono di molto inferiori rispetto a quelle degli incidenti au-tomobilistici, percepiti, invece, come meno rischiosi.
Inoltre, si assume che attività ed eventi simili, come ad esempio energia nucleare e guerra nucleare, possiedono le stesse caratteristiche e pertanto lo stesso livello di rischio. In ciascuno di questi casi la di-sponibilità di informazioni e la rappresentatività portano a stime del rischio falsate. Dal risultato finale osservato risulta che la pubblica o-pinione è scarsamente capace di valutare il rischio poiché tende a so-vrastimare costantemente la frequenza di eventi rari, e a sottostimare la frequenza di eventi relativamente comuni.
La seconda conclusione della ricerca sulla percezione del rischio è che la maggior parte degli individui è generalmente troppo sicura di se circa la stima di rischi che possano riguardarla, cosa che conduce co-munque ad errori di stima. Significa, in sostanza, che si tende a sotto-stimare quei rischi che sono familiari o sotto il proprio diretto control-lo come ad esempio la guida dell’automobile.
Infine, la letteratura psicologica ha messo in luce la differenza tra le stime degli esperti e quelle del pubblico. Gli esperti usano spesso sti-me basate sulla probabilità di accadimento moltiplicate per le conse-guenze e, proprio per questo motivo, le stime degli esperti sono correlate con i tassi annui di incidenti dell’attività o della tecnologia in questione.
É stato dimostrato che le influenze sociali condizionano pesante-mente le azioni spesso fornendo spiegazioni al comportamento in caso di rischio. La psicologia sociale, per esempio, ha contribuito a spiega-re i valori sociali, le norme, le regole sociali e la loro connessione con il giudizio individuale. Su una scala più ampia la ricerca sociologica ha posto l’attenzione sui meccanismi sociali che influenzano la perce-zione del rischio, contribuendo a spiegare come i gruppi e le comunità rispondono a tali emergenze e quale sia il ruolo dei valori sociali e delle istituzioni.
Vittorio Amato 98
Tabella 2 – Le prime 30 parole per ricorrenza negli articoli pubblicati dal 15/9/06 al 10/6/07 su Il Mattino, Il Corriere della Sera e Repubblica (1392 articoli)
Rank Parole Mattino Corriere Repubblica Totale 1 rifiuti 426 242 236 904 2 Napoli 200 172 179 551 3 discarica 228 115 163 506 4 emergenza 238 149 114 501 5 Campania 134 120 100 354 6 Bertolaso 136 107 105 348 7 sindaco 133 79 100 312 8 Bassolino 95 83 65 243 9 cittadino 102 77 59 238
10 commissario 89 70 52 211 11 regione 89 68 52 209 12 stato 84 55 49 188 13 tonnelata 90 37 57 184 14 governo 80 54 37 171 15 immondizia 68 47 53 168 16 problema 91 44 32 167 17 Iervolino 60 60 33 153 18 Napolitano 67 38 48 153 19 raccolta 63 52 36 151 20 crisi 70 30 42 142 21 ambiente 86 5 49 140 22 impianti 59 43 36 138 23 acerra 62 31 42 135 24 soluzione 70 24 38 132 25 Serre 61 31 27 119 26 straordinario 46 40 33 119 27 stoccaggio 52 25 37 114 28 protesta 52 29 30 111 29 responsabiltà 47 41 23 111 30 intervento 44 22 25 91
Fonte: elaborazione su Savarese (2009)
Conflitti ambientali e territorio 99
7. Rischio tecnologico e fenomeno NIMBY I fenomeni che gli acronimi LULU e NIMBY sottendono comin-
ciano ad essere largamente diffusi anche in Italia coinvolgendo i rap-porti società-territorio.
LULU sta per “Locally Unwanted Land Use” mentre NIMBY sta per “Not In My Back Yard” e spiega, come si è già accennato, la rea-zione delle comunità locali alla decisione di realizzare un LULU all’interno del proprio territorio.
Un LULU, così come le discariche ed i termovalorizzatori della Campania, può essere una qualsiasi infrastruttura, pubblica o privata, inevitabile corollario di una società tecnologicamente avanzata e o-rientata al benessere. Si tratta quindi di impianti che vanno dallo smal-timento di rifiuti tossici alla produzione di energia o prodotti chimici. Tutti questi impianti condividono un attributo comune: essi provocano un percepibile e sostanziale danno alle persone ed alle proprietà che si trovano ai contorni della loro localizzazione.
Sebbene gli impianti e le strutture che emettono sostanze tossiche o comunque dannose risalgano agli albori della rivoluzione industriale, il fenomeno NIMBY rappresenta qualcosa di realmente nuovo e re-cente e può esser visto come il culmine di alcuni trend di lungo perio-do. L’accelerazione dell’innovazione tecnologica ha provocato un mu-tamento nei modelli localizzativi delle infrastrutture sociali e delle imprese, anche rispetto alla ricerca di vantaggi che possono derivare dalla vicinanza a network di trasporto o a particolari luoghi di smalti-mento o mercati di consumo. I nuovi soggetti generano un mix sempre più complesso di esternalità e lo fanno in un momento in cui gli effetti cumulativi del degrado ambientale stanno generando una crescente domanda per risorse ambientali sempre più scarse in una popolazione che è sempre più informata ed aggiornata sui sottili effetti delle ester-nalità negative.
Come dimostra l’esperienza campana, il risultato di questi trend è uno scontro politicamente esplosivo tra imprese, governo e residenti. Ciò nonostante è indubbio che la società nel suo complesso, e di con-seguenza le comunità locali, ricevano un forte beneficio complessivo da questo tipo di impianti anche tenendo in conto i loro effetti collate-rali dannosi.
Vittorio Amato 100
Tuttavia accade che, nella pratica, la minaccia alla qualità ambien-tale così come avvertita dalle popolazioni direttamente interessate, possa essere completamente diversa da quella definita e stimata in se-de tecnica. Pertanto, in presenza di comportamenti di tipo NIMBY, la scelta localizzativa di un determinato impianto non viene influenzata da criteri tecnici di compatibilità ambientale bensì dai criteri soggetti-vi di chi subirà gli effetti dell’opera.
Come si è visto precedentemente la percezione della qualità, degli impatti e dei rischi ambientali può differire a seconda dei diversi sog-getti sociali. In particolare può variare in base a come tali aspetti sono trattati in sede tecnica.
É quindi necessario prendere atto della distanza che si crea tra le valutazioni dei tecnici e quelle dei soggetti interessati, e giudicare ac-cettabile una localizzazione solo qualora essa sia effettivamente tolle-rata dalle popolazioni interessate. In questa prospettiva il criterio op-portuno nasce dalla effettiva accettazione sociale dell’intervento in progetto.
Starr (1969) ponendosi la cruciale domanda how safe is safe e-nough?, ha formulato l’ipotesi che il rischio accettato dalle popolazio-ni sia proporzionale ai benefici ottenuti, ed ha anche proposto alcune elaborazioni secondo le quali, a parità di benefici, l’accettazione di ri-schi legati ad attività volontarie è di ordine di grandezza maggiore dell’accettazione di rischi non volontari. Secondo altri autori (Slovic et al. 1980), invece, i benefici attesi sembrano giocare un ruolo secon-dario mentre viene messo in luce come, nella considerazione del ri-schio a livello sociale, giochi un ruolo essenziale la possibilità che si verifichino catastrofi. Sarebbe questa la chiave che permette di spiega-re le gerarchie dei rischi così come sono percepiti dalla popolazione. Tra l’altro è proprio sul terreno delle catastrofi potenziali che si rag-giunge la maggior distanza tra pubblico coinvolto ed esperti, e su que-sto terreno si sviluppano conflitti irrisolvibili che portano a frustrazioni sociali e all’inefficacia delle azioni della pubblica amministrazione.
Le tecniche di valutazione del rischio e della pericolosità hanno in comune il fatto di essere sostanzialmente applicabili e verificabili in sede strettamente tecnica. Le popolazioni locali possono però non ave-re gli strumenti per entrare effettivamente nel merito degli aspetti squisitamente tecnici: è difficile ad esempio, per chi non sia uno spe-
Conflitti ambientali e territorio 101
cialista, comprendere a fondo le differenze di tecnologia o le motiva-zioni che hanno portato a scegliere determinati indicatori di qualità ambientale e non altri.
Le popolazioni interessate possono dimostrare una buona dose di diffidenza verso le soluzioni proposte; il problema si sposta allora dal campo strettamente tecnico a quello delle garanzie reali che i soggetti coinvolti (chi propone l’opera, l’amministrazione competente, il pub-blico coinvolto) possono fornirsi reciprocamente.
Sorgono tuttavia un insieme di interrogativi che risultano di non fa-cile soluzione. Come può cautelarsi il pubblico coinvolto dalla possi-bilità che l’evoluzione futura dell’ambiente, a intervento realizzato, sia diversa e peggiore rispetto a quella prevista dal proponente nello stu-dio di impatto? Come si cautela l’amministrazione, che emette il giu-dizio di compatibilità ambientale, nel caso in cui il proponente non sia più in grado di mantenere le promesse fatte? Come si cautela il propo-nente dalla possibilità che cambino le amministrazioni interessate e che sul problema in oggetto si possano in futuro avere atti differenti da quelli inizialmente stabiliti (ad esempio un blocco dei lavori di realiz-zazione prima del completamento dell’intervento, come nel caso del termovalorizzatore di Acerra)?
Si entra in un campo dove le azioni necessarie sono in buona parte differenti da quelle strettamente tecniche (quelle cioè legate alla stima dei possibili impatti sul territorio e sull’ambiente). Strumenti di questo tipo comprendono piuttosto convenzioni tra le parti, e un insieme di strumenti compensativi e cautelativi. Tale campo è stato finora affron-tato in modo poco sistematico, ma è certo, valutando il complesso e numeroso scenario di conflitti ambientali in essere, che la sua impor-tanza cresca in modo sensibile nei prossimi anni.
Si potrebbe ritenere, in base a tali considerazioni, che la soluzione del problema stia in una corretta informazione. Una volta che la popo-lazione coinvolta dovesse avere lo stesso livello di informazione dei tecnici che affrontano il caso, si potrebbe ipotizzare che le distanze in-dicate si riducano sensibilmente e la sindrome NIMBY venga ricon-dotta entro limiti ragionevoli.
L’esperienza degli ultimi anni, inclusa quella campana, mostra però che vi sono buone ragioni per essere pessimisti su tale ipotesi. É forse possibile dimostrare tecnicamente che le interferenze prodotte con
Vittorio Amato 102
l’ambiente, ad esempio dal termovalorizzatore di Acerra, sono trascu-rabili ma resta il fatto che la gente non vuole vicino casa sua il termo-valorizzatore in quanto tale, qualunque siano le tecnologie adottate.
Se vi sono casi in cui le comunità locali rifiutano opere che hanno una valenza territoriale più complessiva, possono verificarsi casi in cui la volontà delle comunità è favorevole alla realizzazione di opere di cui considerano i benefici economici immediati, ma non i costi am-bientali corrispondenti, o gli impatti socio-economici di lungo periodo, o comunque gli impatti provocati ad una scala territoriale maggiore.
La realizzazione di un’autostrada, ad esempio, può essere valutata localmente soprattutto come occasione immediata di lavoro per le ma-estranze locali e come via privilegiata di comunicazione futura con il resto del territorio, tale da favorire lo sviluppo economico del sito. In qualche caso tale atteggiamento può apparire realmente fondato, in al-tri casi i benefici attesi possono rivelarsi semplici illusioni mentre di sicuro rimane la certezza di devastazioni sul piano ambientale e di co-sti ingiustificati da parte della collettività. Non è infrequente il caso di forti spinte a livello locale su progetti di grandi opere (es. autostrade o dighe) dai sicuri effetti economici immediati (collegati ai lavori della fase di realizzazione) e dagli incerti benefici futuri.
L’accettazione sociale, che si esprime attraverso il fenomeno NIMBY, non è dunque sempre una garanzia di compatibilità ambien-tale e la decisione che una determinata opera o impianto rientri nel campo dei LULU non necessariamente aderisce alla realtà. Nel consi-derare la localizzazione di un impianto o, più in generale, la realizza-zione di un intervento, l’accoglimento acritico dell’accettazione socia-le quale sintomo di compatibilità ambientale può condurre a situazioni fortemente negative, tenuto anche conto delle strumentalizzazioni a cui il criterio si espone. Può capitare che i livelli di governo locali non necessariamente rappresentino in modo realistico la volontà generale della popolazione sui singoli problemi. Ciò può avvenire sia perchè non si riesce a convogliare in un unico atteggiamento le differenti opi-nioni espresse su una stessa questione dai vari strati sociali della popo-lazione, sia, sotto un aspetto più prettamente politico, a causa delle possibili forti incidenze delle dinamiche elettorali.
Il problema in oggetto coinvolge i temi della rappresentanza politi-ca e non va certamente affrontato in questa sede. Ci si limita pertanto
Conflitti ambientali e territorio 103
a ricordare che le valutazioni riguardo la qualità dell’ambiente e la compatibilità ambientale degli interventi sul territorio comportano i-nevitabilmente il problema del permanere di visioni diverse da parte di differenti soggetti sociali.
La componente tecnica e scientifica costituisce solo una tra le parti in causa; le sue proposte devono essere confrontate con quelle di altre componenti della società: l’amministrazione, le associazioni interessa-te, i rappresentanti del mondo economico, etc. Ciò che occorre è un serio processo di negoziazione tra le parti interessate che smussi le vi-sioni particolaristiche dei singoli soggetti anche attraverso una contrat-tazione sulla distribuzione dei costi e dei benefici attesi (non solo in termini economici).
Anche subordinare l’accettazione degli interventi semplicemente al fatto che vi siano processi di negoziazione presenta comunque alcuni rischi. Si tratta infatti di una logica del braccio di ferro in cui inevita-bilmente vince chi ha più forza. Il rischio può essere che chi rappre-senta gli interessi dell’ambiente (in linea di massima con forze limita-te) riesca a vincere su un numero modesto di casi di grande impatto psicologico, non avendo, però, poi, la forza per intervenire in modo diffuso sul complesso degli altri interventi sul territorio con grave ri-schio di erosione diffusa dei margini di qualità ambientale.
É essenziale a questo riguardo che il complesso dei soggetti inte-ressati alla qualità dell’ambiente si dia un obiettivo da raggiungere a breve termine: individuare regole del gioco per la definizione della compatibilità degli interventi che siano semplici e accettate in linea di principio da tutte le varie parti in causa. L’obiettivo reale dovrebbe es-sere quello di rendere effettivamente operativi processi di negoziazio-ne non come eccezione limitata a pochi casi emergenti, ma come pras-si comune che affronti la qualità e la compatibilità del complesso degli interventi che si producono su un dato territorio.
8. Alcune conclusioni Le cause della fallimentare esperienza campana in merito al feno-
meno NIMBY vanno ricercate, probabilmente, nell’ovvia constatazio-ne che l’area nella quale si manifestano i benefici dello smaltimento è
Vittorio Amato 104
vasta, e spesso nemmeno comprende in modo sostanziale l’ambito ter-ritoriale direttamente interessato alle localizzazioni, mentre gli svan-taggi (soprattutto, ma non soltanto ambientali) sono per lo più concen-trati in un’area relativamente ristretta (talora nemmeno compresa, co-me si diceva, nella più vasta area di ricaduta dei benefici).
Ne consegue che le imprese coinvolte ed i governi di livello supe-riore (regionale e nazionale) acquisiscono i benefici generali, senza sopportare direttamente i costi locali, mentre i governi e le comunità locali subiscono i costi di tipo ambientale e sociale, non percepiscono vantaggi economici rilevanti, e sono, di norma, perciò sfavorevoli – da un punto di vista del tutto razionale ed accettabile – alla decisione di insediamento. Pertanto, se quando le aree di ricaduta dei costi e dei benefici sono coincidenti, l’ente responsabile è, presumibilmente, in grado di assumere decisioni ottimali per la collettività amministrata, nel caso in cui invece le aree di ricaduta dei costi e dei benefici non coincidono, le decisioni assunte dai decision-makers non conducono ad una dimensione ottima nella produzione di un dato servizio. L’ente superiore o l’impresa interessata, tendono, infatti, a sovradimensionare l’impianto poiché nel loro calcolo trascurano o sottovalutano i costi locali mentre l’ente inferiore è favorevole a drastici sottodimensiona-menti poiché internalizza soltanto i costi locali.
Si pone quindi un problema di compensazione per i costi sopportati dalla comunità locale interessata all’insediamento rischioso, la tabella n. 3 sintetizza nelle grandi linee quelli che possono essere i costi ed i benefici connessi ad un insediamento del tipo di cui si tratta.
I problemi tuttavia sembrano emergere, proprio sulla natura delle azioni di compensazione. La via forse più praticabile dall’ente locale che subisce un LULU, nel momento in cui ne accetti la localizzazione, va ricercata nella monetizzazione del danno ipotizzabile. Tale mone-tizzazione potrebbe consentire la disponibilità di una massa finanziaria da gestire in azioni di sviluppo economico del proprio territorio con una notevole dose di flessibilità.
Viceversa l’alternativa di coinvolgere direttamente l’azienda o l’ente proponente il LULU in azioni di sviluppo e valorizzazione del territorio risulta poco pagante poiché è difficile coinvolgere un sogget-to abituato a perseguire esclusivamente i propri fini istituzionali ad in-traprendere azioni su un terreno che non è il suo proprio.
Conflitti ambientali e territorio 105
Tabella 3 – Benefici e costi localizzati di discariche e termovalorizzatori BENEFICI COSTI
1) Creazione di posti di lavoro temporanei e permanenti 2) Aumento del valore aggiunto regionale 3) Creazione e miglioramento delle reti di trasporto locali 4) Migliore conoscenza dell’ambiente in ragione delle ricerche ecologiche e del monitoraggio
1) Rischi per la salute e la sicurezza della popolazione 2) Alterazione dei valori connessi al tempo libero, all’estetica e al valore della natura 3) Riduzione dei valori delle proprietà immobiliari 4) Possibile riduzione di certi tipi di reddito 5) Vincoli e sovraccarichi temporanei ai servizi pubblici durante la costru-zione dell’impianto
Bibliografia
AMATO V., 1989, Rapporti tra impresa e ambiente, in “Ambiente Ri-sorse Salute”, n. 83.
AMATO V., 1991, Aspetti di politica per l’ambiente, Napoli, CUEN. AMATO V., 1995, Rischio tecnologico, ambiente e territorio, Napoli, ESI. ALEXANDER D.E., 1993, Il tempo e lo spazio nello studio dei disastri,
in G. BOTTA (a cura di), Eventi naturali oggi. La geografia e le al-tre discipline, Milano, Cisalpino.
ARCURI L., SCHENONE G., 1987, La percezione del rischio per impianti di produzione di energia elettrica, in “Energia e Materie Prime, n. 58.
BRUNNER R., 2008, La grande città e i suoi rifiuti, Conferenza tenuta presso la Sala Congressi di Monte Sant’Angelo, Università degli Studi di Napoli Federico II, 15 gennaio.
BRION D.J., 1991, Essential Industry and the NIMBY Phenomenon, New York, Quorum Books.
BURTON I., KATES R.W., White G.F., 1978, The environment as Haz-ard, New York, Oxford University Press.
CHIARIELLO P., 2008, Monnezzopoli, la grande truffa, Napoli, Pironti. COVELLO V.T., 1983, The perception of technological risks: a literature
review, in “Technological Forecasting and Social change”, n. 23.
Vittorio Amato 106
DE MARCHI B., PELLIZZONI L., UNGARO D., 2001, Il rischio ambien-tale, Bologna, il Mulino.
DUNLAP R.E., 1991, Trends in public opinion toward environmental issues: 1965-1990, in “Society and Natural Resources”, n. 4.
FUBINI A., ZEPPETELLA A.(a cura di), 1986, Local impacts of nuclear power plants. An international Comparison: the British Experience and the Piedmontese Case, Torino, CELID.
HOHENEMSER C., KATES R.W., SLOVIC P., 1983, The nature of tech-nological hazard, in “Science”, n. 220.
LAVANCO G., 2003, Psicologia dei disastri. Comunità e globalizza-zione della paura, Milano, Angeli.
LOMBARDI M., 1997, Rischio ambientale e comunicazione, Milano, Angeli.
MAINARDI R., 1993, Il rischio di eventi estremi in due regioni chiave dello spazio economico mondiale, in G. BOTTA (a cura di), op. cit.
MILLER T.A.W., KELLER E.B., 1991, What the public thinks, in “EPA Journal”, n. 17 (2).
PEDDITZI R., 2008, Rifiutopoli. Napoli: dal Regno delle due Sicilie a capitale della Munnezza, Reggio Emilia, Aliberti.
PERUSSIA F., 1991, Sulla natura soggettiva del rischio, in G. BOTTA (a cura di), Prodigi paure ragione. Eventi naturali oggi, Milano, Guerini.
PORTNEY K.E., 1991, Siting Hazardous Waste Treatment Facilities: The Nimby Syndrome, Greenwood.
ROWE W.D., 1977, An Anatomy of Risk, New York, Wiley. SAVARESE R., 2002, Comunicazione e crisi: media, conflitti e società,
Milano, Angeli. SAVARESE R., 2009, Galli sulla mondezza. Silenzi, grida e bugie sui
rifiuti in Campania, Milano, Angeli. SLOVIC P., 1987, Perception of risk, in “Science”, n. 236 (4799). STARR C., 1969, Social Benefit vs. Technological Risck, in “Science”,
n. 165. TOMKINS J., 1991, NIMBY, Simon & Schuster. WILCOX S.F., 1992, The Nimby factor, Saint Martin’s Press. ZEIGLER D.J., JOHNSON J.H., BRUNN S.D., 1983, Technological Haz-
ards, Washington DC: Association of American Geographers Re-source Publication.