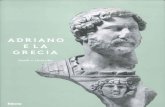Ibridi. Enti urbani di nuova generazione a funzioni complesse
Transcript of Ibridi. Enti urbani di nuova generazione a funzioni complesse
303
Ibridi. Enti urbani di nuova generazione a funzioni complesse.Nuove tipologie e spazi ibridi
Paolo Vitali
1. Il principio del “vigor ibrido” e l’invenzione delle nuove tipologie
Nel 1985 Joseph Fenton pubblica il saggio Hybrid Buildings.Si tratta di un “catalogo tipologico” che, attraverso un’impostazione classificatoria, colma finalmente un vuoto. Fenton infatti, indagando il tema del mix funzionale secondo una prospettiva fortemente innovativa, individua uno specifico - l’ibrido - fino ad allora ignorato come tipologia vera e propria con caratteristiche peculiari (a differenza dei mixed-use, “negli edifici ibridi i singoli programmi si relazionano tra loro e iniziano a condividere intensità”) e soprattutto mette in evidenza il potenziale dell’ibrido come strumento “per occuparsi della complessità della città del XX secolo”.Sulla base di questa intuizione Fenton mette a fuoco l’idea di ibrido rispetto a una triplice problematica: storia, funzione, forma. La funzione non è più considerata una chiave interpretativa che da sola è sufficiente per comprendere l’identità dell’oggetto architettonico.Mentre le esperienze e i modelli modernisti (vedi capitolo primo) subordinano tutto alla funzione, Fenton prefigura un approccio definito da tre elementi: mix funzionale, forma contenitore e rapporto con la città. L’analogia con la biologia (genetica) è quindi da interpretare come la ricerca di un modo per superare il macchinismo/meccanicismo che connotava le proposte di matrice funzionalista. Il rapporto forma-funzione viene visto non più in termini di causa-effetto ma in chiave interattivo/dialettica.Il concetto di “vigor ibrido” (il miglioramento di alcune caratteristiche nell’esito dell’ibridazione), trasposto per analogia all’ambito dello studio della città contemporanea, viene utilizzato per riconoscere e valorizzare alcune specificità generatesi all’interno della complessità del fenomeno urbano e allo stesso tempo per ridefinire le categorie tipologiche (tipologie del XX secolo) in modo più pertinente rispetto ai nuovi paradigmi.
UH_DEFINITIVO.indd 303 19/06/2012 00:16:27
304
L’indagine di Fenton è per certi versi fortemente legata al contesto culturale americano e alle “urgenze” che la città americana poneva in quel momento, ovvero l’impoverimento e lo svuotamento dei centri urbani.Contiene però una componente fortemente attuale: quella di avere delineato la necessità di definire le caratteristiche che prefigurano un ruolo strategico dell’ibrido ovvero la sua capacità di includere e integrare eterogeneità e densità.Oggi si assiste a un ritorno dell’ibrido come oggetto di attenzione da parte della cultura architettonica (cfr. la serie monografica apparsa sulla rivista spagnola “a+t” nel 2008). Rispetto a Fenton il termine viene declinato in modo nuovo, per definire enti urbani che non sono né il blocco, né il grattacielo e, in questo senso, acquisisce anche un significato più pregnante rispetto ai processi trasformativi che caratterizzano la contemporaneità. Sembra interessante quindi incrociare il significato che ha assunto nella lettura di Fenton con il termine “megaforma” secondo l’accezione coniata da Frampton, che cerca di chiarire (individuare), rispetto alle attuali dinamiche urbane, il “potenziale urbano” ovvero sviluppare strategie alternative per uno sviluppo e/o una modifica della forma urbana graduali e resistenti rispetto a logiche economiche devastanti e pervasive.
1.1 “Hybrid buildings” - la fine delle tipologie monovalenti
“Negli Stati Uniti siamo liberi dalle tradizioni artistiche. La nostra libertà è fondata sulla ‘licenza’, è vero. Facciamo cose scioccanti, produciamo opere di architettura incorreggibilmente brutte; mettiamo in atto esperimenti crudi con risultati disastrosi. Ciononostante, in questa massa di energie ingovernabili sta il principio della vita”1.Prendere in prestito il linguaggio della biologia non è solo un pretesto utilizzato da Fenton per colmare una carenza terminologica. La metafora organica, ricorrente nella cultura americana, viene utilizzata per dare atto di una forza vitale connaturata alla sperimentazione sull’architettura interpretata come un fenomeno vivo, complesso.La comprensione del fenomeno urbano passa così anche attraverso un metodo di analisi critica simile a quello di un laboratorio, per le analogie
UH_DEFINITIVO.indd 304 19/06/2012 00:16:27
305
che esso presenta, nelle sue dinamiche evolutive, con la natura e la sua capacità innata di autorigenerarsi.Questo suggestivo parallelo, lungi dal rappresentare una facile semplificazione di lettura di un fenomeno che resta eminentemente culturale, ci introduce a un approccio specifico e a un altrettanto specifico contesto.Nonostante questa forte connotazione geografica, e una definizione di obiettivi fortemente connessi all’ambito di studio (la città nordamericana), gli strumenti di indagine e la conseguente classificazione dei risultati rappresentano dal punto di vista metodologico un approccio originale per interpretare la complessità architettonica e di conseguenza arrivare a una concettualizzazione più articolata dello spazio e delle sue implicazioni nei processi di formazione urbana.Uno spazio che, nelle sue sempre più complesse articolazioni di scala rivendica, pur all’interno della grande dimensione (esito dell’intensificazione dei fenomeni urbani), una attenzione specifica per la dimensione della prossimità, nel rapporto 1:1 con le architetture e i luoghi. Uno spazio topografico, esperienziale, uno spazio della vita.Il tema edifici ibridi (tipologie ibride) è affrontabile secondo chiavi di lettura molto diverse, e in parte non attinenti specificamente all’architettura. La stessa definizione prende a prestito un termine dalla genetica (secondo l’accezione di “vigor ibrido”, ovvero di mescolanza di energie creative generatrici di nuove opportunità), per definire un ambito di ricerca assai interessante e ricco sul quale recenti importanti contributi e studi stanno facendo chiarezza (mettendo in luce possibili letture tematiche). Dal punto di vista storico-critico l’operazione di una ricerca di parentela delle attuali esperienze (“antecedenti storici”) che vengono in qualche modo ricondotte a questa etichetta sembra un’operazione in parte legata a quello spirito che già R. Banham, nel suo famoso Megastructures. Urban future of the recent past (1976), evidenziava per le vicissitudini delle megastrutture, parlando di “consapevolezza storica senza precedenti tra gli architetti moderni”. L’immagine del ponte abitato (Ponte Vecchio), così potente ed evocativa da essere recuperata da S. Holl in un famoso Pamphlet (#7, Bridge of Houses, 1981) addirittura come tema di progetto, definisce in modo interessante uno spazio nel quale si incontrano, pur con tutte le specificità e le differenze di
UH_DEFINITIVO.indd 305 19/06/2012 00:16:27
306
sorta, l’esperienza megastrutturale e l’esperienza “ibrida”. Non è un caso se, a distanza di qualche decennio, la rivista “a+t” propone, in un numero monografico dedicato all’architettura ibrida (HYBRIDS II. Híbridos horizontales, a+t, 32, 2008), una rilettura storica delle origini di alcuni concetti che sostengono questa idea, citando alcune delle più significative e articolate esperienze megastrutturali.L’intuizione di Fenton, primo autore a interessarsi in modo sistematico del tema, è quella di individuare un contesto specifico, l’habitat potremmo dire dell’ibrido.L’analisi (lo sguardo) di Fenton, come ogni sguardo critico, è parziale, e finalizzata a individuare dei processi e delle strategie per rivitalizzare il contesto urbano americano. E’ necessario quindi capire bene l’ottica culturale nella quale nasce la sua operazione analitico-critica e interpretativa. E’ anche vero che l’ambito di riferimento su cui Fenton fonda la sua ipotesi è, per le sue caratteristiche intrinseche (la griglia, come supporto dell’edificato, impone delle condizioni di partenza uguali per tutti/omogenee, rendendo più evidenti gli eventuali sviluppi differenti), quello più prossimo a un laboratorio nel quale si analizzano, come in ambiti disciplinari più rigorosi, le dinamiche di crescita a conferma o smentita delle proprie ipotesi iniziali.La sfumatura di significato che il termine ibrido assume nel dibattito architettonico ha origine nella genetica, ovvero nel suo percorso di consolidamento scientifico a seguito dei decisivi contributi di Mendel e Kölreuter.Una delle constatazioni più importanti che emergono dagli esperimenti di genetica è la verifica di un esito di un processo di incrocio tra due qualità differenti.L’operazione può avere due esiti: la sterilità e il cosiddetto “vigor ibrido”, ossia una particolare propensione nella specie risultante dall’incrocio, alla resistenza e al rafforzamento delle sue caratteristiche. Questa constatazione scientifica viene presa a prestito da J. Fenton per definire le caratteristiche di un certo tipo di architettura, che, allontanandosi dai codici formali riconosciuti, viene definita ibrida. Secondo Fenton gli edifici ibridi avrebbero le stesse caratteristiche di forza che vengono attribuite alla selezione che si consolida nell’esito del vigor ibrido. Questi particolari edifici avrebbero caratteristiche vincenti in termini di capacità
UH_DEFINITIVO.indd 306 19/06/2012 00:16:27
307
di raccogliere le istanze della modernità urbana e saperle trasformare in unità formali interessanti e integrate.“Fino al catalogo tipologico del 1985 di Joseph Fenton, gli edifici ibridi erano stati ignorati in quanto tali (come tipologia di edificio vera e propria) e venivano catalogati come mixed-use. Secondo Fenton c’è una netta differenza tra ibrido e mixed-use, nel senso che negli edifici ibridi i programmi individuali si relazionano tra loro e iniziano a condividere intensità”2.S. Holl, nella prefazione a Hybrid Buildings, nel tentativo di restituire i caratteri peculiari dell’ibrido, dichiara esplicitamente che l’interesse verso di esso è motivato non tanto dalla capacità dell’edificio di assemblare funzioni diverse, ma da quella di concentrarle e definirle in termini di struttura urbana.“[Il saggio di Fenton] non si concentra sulle questioni tecniche o sui linguaggi utilizzati per esprimere la funzione, ma pone l’attenzione sull’edificio urbano e la sua capacità di concentrare le funzioni. Il termine ‘ibrido’ non denota quindi solo un ‘uso misto’, definizione spesso utilizzata per descrivere le megastrutture estensive della metà di questo secolo. Ogni struttura [qui illustrata] ha una forma individuale che sostiene il pattern sottostante della griglia urbana”3.Nel primo studio organico realizzato sugli ibridi Fenton colloca la loro nascita nel primo quarto del XX secolo, con l’obiettivo di rivitalizzare le città americane e rendere redditizio l’utilizzo del suolo. Si parla contemporaneamente di un contesto storico e geografico. La lettura critica e lo sforzo classificatorio sono tutti dentro la realtà americana, dove l’idea di città è molto diversa da quella europea e dove le dinamiche economiche che condizionano le strategie di formazione dei tessuti urbani, seppure non esclusivamente legate a quel contesto geografico, hanno delle forti specificità e una dimensione impensabile fino a pochi anni fa in altri ambiti.Non è un caso che la necessità di uno studio specifico sia nata nel contesto culturale americano. Oltre a tratti di specificità che si riferiscono direttamente a elementi di tecnologia e di modalità di impianto urbano, è a mio avviso il pragmatismo di una certa cultura anglosassone il contesto culturale dove nasce e si consolida l’idea di ibrido, con un forte accento su una componente sperimentale, di vero e proprio laboratorio
UH_DEFINITIVO.indd 307 19/06/2012 00:16:27
308
di idee sulla città, verificate nella loro fattibilità reale. Questa verifica chiarisce a posteriori un aspetto importantissimo: la natura non ideologica di quei primi esperimenti.“No es un prototipo disciplinar, sino una concentración de intereses, no se basa en la tradición sino en el futuro y su supervivencia depende del consenso”.Questo elemento rappresenta a mio avviso l’essenza dell’operazione ibrida, e la conseguente capacità di penetrazione in altri contesti culturali: “Desprovisto de carga ideológica y dotado de una gran versatilidad, el híbrido está encontrando también su lugar en Europa, por no hablar de Asia, donde la mezcla de usos ha sido consustancial al desarrollo de sus ciudades. (…) el híbrido es una criatura que sale de la entraña del sistema capitalista. Es el resultado mercantil de una suma de intereses privados y de una resta de condicionantes urbanos. La especulación y la rentabilidad fueron sus progenitores; la ciudad americana, su jardín de infancia. Mientras el condensador era la concreción de una ideología e incluso una loa a la arquitectura, la historia del híbrido se escribía en los libros de contabilidad”4.Nonostante le innovazioni tecnologiche e le nuove concezioni dello spazio, le categorie descritte da Fenton sembrano ancora assai efficaci per descrivere le caratteristiche principali degli edifici ibridi. Il suo approccio è ancora interessante, sia come tentativo di sistematizzazione classificatoria rispetto ai caratteri formali dell’edificio (secondo termini eminentemente architettonici), sia come tentativo di istituire una linea di demarcazione tra ibrido e uso misto. Infine è interessante nella sua prospettiva di strategia urbana, nella consapevolezza che la differenza di contesto rende necessario un utilizzo critico e ri-orientato delle sue intuizioni per restituire loro la forza di strumenti operativi in grado di affrontare la riflessione sulla città diffusa con tecniche innovative e alternative.
UH_DEFINITIVO.indd 308 19/06/2012 00:16:28
310
2. Oltre Fenton
“Il mito dell’autonomia disciplinare, così ascetico e rassicurante, non può non fare i conti con il mutamento eteroclìto, il ‘continuo scorrere’ delle pratiche sociali, dei comportamenti e degli immaginari. Di fronte a tutto questo, l’autonomia disciplinare diviene una mitologia conservativa”5.A quasi un quarto di secolo dall’indagine di Fenton e dal suo catalogo (Hybrid Buildings, 1985), uno dei contributi critici più importanti, in ambito teorico, nel percorso di definizione del significato del termine “ibrido” in relazione al tema tipologico e più in generale alla disciplina architettonica, viene riproposto l’interrogativo con il quale S. Holl apriva la sua premessa a quel saggio - “Quale effetto hanno i programmi complessi sulla forma architettonica?”.Questo ritorno di interesse per l’ibrido, come risposta progettuale e strategia consapevole nei confronti della complessità contemporanea, viene sancito dal convergere delle riflessioni di alcuni protagonisti verso il tema con una serie di testi critici e progetti che, pur nell’eterogeneità dei percorsi di indagine, tornano prepotentemente a investire un grosso sforzo conoscitivo su di esso.Qui verranno prese in considerazione alcune esperienze specifiche, alcuni angoli visuali con cui è stato approcciato il tema (storico, concettualizzazione spaziale, tecniche, ricerche sul campo), con l’intenzione di offrire una panoramica su alcuni dei percorsi di indagine in corso, ma senza la pretesa della sistematicità, vista la quantità e la qualità dei sottotemi attinenti (programma, spazio, tipo, tecniche, densità, congestione), e la statura intellettuale degli autori coinvolti.Tutto ciò tenendo presente che una serie di rivoluzioni culturali (la post-modernità, la rivoluzione digitale, …) hanno messo e stanno mettendo fortemente in discussione il ruolo dell’architetto e dell’architettura nella loro capacità di sintetizzare le nuove istanze sociali per ideare e definire gli habitat del futuro.
2.1 Il ritorno dell’ibrido - nuove letture, nuove classificazioni
E’ significativo che la rivista “a+t” esca negli ultimi due anni con una serie di numeri monografici sull’ibrido. Viene ripercorsa e aggiornata la
UH_DEFINITIVO.indd 310 19/06/2012 00:16:30
311
storia degli ibridi, si rivisitano alcune tappe storiche considerate decisive nella formazione del concetto di ibrido architettonico. Le caratteristiche morfologiche, così come per Fenton, costituiscono ancora il principale criterio catalogatorio, gli edifici in prima istanza vengono divisi tra ibridi verticali e ibridi orizzontali.Il testo che introduce la serie, a cura di Martin Musiatowicz, si intitola Vigor ibrido e l’arte del mischiare ed è sottotitolato Il ritorno dell’ibrido. I riferimenti alla terminologia della genetica nel titolo e le numerose citazioni nel testo denunciano apertamente il debito culturale nei confronti dello storico Hybrid Buildings.Con queste parole veniamo introdotti al tema: “Le premesse che per il Movimento Moderno avrebbero condotto a un nuovo e migliore ordine sociale non furono in grado, nella pratica, di lottare contro la complessità della vita reale. Le critiche del postmodernismo a questo aspetto portarono con sé un rinnovato interesse per la sperimentazione sul programma e una sfida ai modelli tipologici dominanti. Ancora di più, il pensiero post-strutturalista concepì una posizione secondo cui i concetti dialettici, nel nostro caso le funzioni, coesistevano e si relazionavano tra loro. Diversi scrittori e architetti si sono occupati nel corso degli ultimi trent’anni di esplorare le implicazioni del programma sulla forma architettonica. Rem Koolhaas identificò le condizioni eccezionali dei grattacieli di Manhattan nel suo libro Delirious New York (1978). In esso, rispetto all’approccio catalogatorio di Fenton, Koolhaas mise a fuoco la qualità generica dei grattacieli come contenitori di qualsiasi combinazione di programmi ripartiti sui differenti livelli dell’edificio. In questo senso, la sede del Downtown Athletic Club, descritta anche nel catalogo di Fenton, affascinò Koolhaas per il suo ‘sereno’ e monolitico involucro in grado di ospitare il massimo della ‘congestione urbana’ e come‘(…) condensatore sociale costruttivista: una macchina per generare e intensificare forme desiderabili di relazione umana’”6.La storia dell’ibrido sembra definirsi all’interno di due polarità: da una parte un estremo pragmatismo, ovvero la ricerca di soluzioni ottimali (“antitipologiche”) di assemblaggio di programmi, con l’obiettivo di rispondere efficacemente a esigenze legate a dinamiche economico- sociali sempre più pervasive; dall’altra un approccio più “intellettuale”, ossia la definizione di un nuovi paradigmi, la concettualizzazione di
UH_DEFINITIVO.indd 311 19/06/2012 00:16:30
312
nuove modalità di interpretazione e di formalizzazione dello spazio. Entrambe sono risposte che nascono nel contesto denso della città. Entrambe hanno avuto un ruolo decisivo nel fare emergere nuovi criteri di definizione di temi di progetto complessi.La cultura architettonica a sua volta elabora due percorsi di concettualizzazione del tema dell’ibrido: uno più “manierista”, che assume e sviluppa il tema del mix funzionale in termini più formali, quasi trasferendo in modo acritico in forme le informazioni di un diagramma; un altro più radicale, che prende in considerazione l’ibridazione dal punto di vista della tecnica, come processo (Van Berkel)Con il numero 31 del 2008 la rivista “a+t” ripropone, a più di 20 anni di distanza dal catalogo di Fenton, una indagine approfondita sul tema degli edifici ibridi e cerca di farlo con la sistematicità e il livello critico del suo nobile predecessore. L’interesse per l’argomento sta nelle qualità intrinseche dell’ibrido: come struttura in grado di ospitare programmi differenti, promuovere l’interazione di usi urbani distinti, combinare attività private e sfera pubblica, esso è portatore di potenzialità ancora fortemente inespresse, rispetto alle strategie urbane contemporanee.“(...) il termine ibrido implica la partecipazione congiunta di iniziativa privata e pubblica nella promozione di residenza, spazio pubblico e attrezzature e dà risposta a tre dei principali problemi della nostra società: - scarsità e costi dei terreni; - necessità di intensificare l’uso del suolo per contribuire a uno sviluppo sostenibile; - necessità di densificare gli usi per rivitalizzare i centri urbani. In altre parole l’urgenza di contrapporre artefatti capaci di esercitare una forza centripeta verso gli elementi e le attività limitrofe per contrastare la forza centrifuga prodotta da interessi eminentemente privati che ha come conseguenza la città dispersa”7.L’articolo Vigor híbrido y el arte de mezclar di Martin Musiatowicz fa un excursus storico, e cerca di ridefinire le categorie classificatorie aggiornandole alle più recenti esperienze progettuali.- Ibrido compatto - Città nella città - Strutture amalgamate (combinate)- Giustapposizione di sezioni e indeterminazione spaziale - Paesaggi integrati.Attraverso una sintesi del percorso storico di alcune idee sullo spazio e la città contemporanea, Javier Mozas in un articolo sul numero successivo (“a+t”, 32, numero monografico intitolato HYBRIDS II. Híbridos horizontales,
UH_DEFINITIVO.indd 312 19/06/2012 00:16:30
313
2008) sviluppa in modo interessante il tema dell’ibrido, come esito del consolidamento di alcune idee guida in forte antitesi con il pensiero architettonico dominante degli ultimi 50 anni. Sembra interessante riportare alcune delle intuizioni più significative e una sorta di tentativo di classificazione delle caratteristiche principali dell’idea di ibrido, secondo una rivisitazione aggiornata del tentativo fatto nel 1985 da J. Fenton. L’obiettivo è quello innanzitutto di spostare la prospettiva geografica (non si parla più solo di realtà nordamericana), in secondo luogo quello di integrare nella definizione alcuni elementi meno esplicitamente formali, ma molto significativi sia in termini critico-interpretativi, sia in termini operativi, ovvero come strumenti e tecniche da utilizzare consapevolmente per dare una risposta alle questioni strategiche della città contemporanea.Il tentativo di tracciare una linea di demarcazione tra ibrido e non ibrido fatto da Fenton viene integrato con nuove categorie che definiscono le caratteristiche degli edifici ibridi e ne determinano la loro specificità.Personalidad - complessità/varietà di programma, novità di impianto, molteplicità di linguaggi (eccezione urbana, scultura, paesaggio o volume anonimo).Sociabilidad - pubblico/privato, permeabilità, edificio aperto 24 ore.Forma - non corrispondenza forma/funzione, frammentazione/integrazione.Tipología - integrazione funzionale, anti-tipologia.Procesos - ibridazione di struttura, costruzione, gestione.Programas - mix funzionale, programmi multipli interconnessi.Densidad - contesto denso.Escala - superedificio, superisolato, megastruttura, edificio-città.Ciudad - strategie della composizione urbana, griglia, spazio pubblico, ambiti disciplinari.Analizzando le caratteristiche di alcuni dei progetti presentati da “a+t”, emergono, a mio avviso, due elementi di riflessione:- una certa letteralità nella traduzione in architettura del concetto di spazio ibrido, ovvero operazioni un po’ retoriche nelle quali il tema è risolto esclusivamente in termini formali;- una certa ambiguità rispetto a quelle che per l’autore sono delle potenzialità dell’ibrido.Mi riferisco soprattutto al tema della combinazione di sfera pubblica e
UH_DEFINITIVO.indd 313 19/06/2012 00:16:30
314
privata. Rispetto ad alcune esperienze megastrutturali che proponevano una sorta di attrezzatura dello spazio in funzione e a supporto di una libera colonizzazione dello stesso, con il carico di potenzialità e allo stesso tempo di ambiguità che poteva avere questa indeterminatezza programmatica, l’istanza che caratterizza le maggiori esperienze progettuali degli ultimi anni rispetto al tema della creazione di una complessità urbana, che combina nella sua articolazione pubblico e privato, confina pericolosamente con la proposta di spazi e usi predeterminati (predefiniti) tipica dei centri commerciali.
2.2 Forme - lo spazio dei flussi e la svolta anti-tipologica
“Sebbene tutti gli edifici inclusi in questa ricerca siano stati selezionati secondo criteri funzionali, le seguenti classificazioni sono disegnate a partire da un’analisi formale”9.
(fig. 2)
UH_DEFINITIVO.indd 314 19/06/2012 00:16:31
315
Nel saggio di Fenton c’è un capitolo intitolato “Form”. E’ interessante notare come l’autore, nonostante una selezione fatta in base ai programmi, costruisca un approccio classificatorio che fa esplicito riferimento, in ultima istanza, a un’analisi formale. Questa apparente contraddizione ci racconta bene della natura dell’architettura e di una sua fondamentale irriducibilità a concetto astratto, scisso dalla sua fisicità. E implicitamente anche di una doppia natura dell’ibridazione: riferibile alla forma, come esito finale, e riferibile al processo, ossia come vera e propria tecnica (Van Berkel). Rispetto a questa seconda accezione il termine ibrido sembra prefigurare più un processo di integrazione totale che non un meccanismo di assemblaggio e una strategia di progetto innovativa, più riferibile allo studio della sezione e dello spazio tridimensionale.“Secondo Koolhaas la pianta era protagonista quando apparve il grattacielo, mentre oggi questo protagonismo è ad appannaggio della sezione e delle simulazioni tridimensionali. Così la tradizionale separazione verticale, frutto dell’impilamento di piani viene sostituita dalla distribuzione di uno stesso programma su differenti livelli, come accade nei progetti di OMA per la Biblioteca Jussieu e la Biblioteca pubblica di Seattle che, sebbene non combinino diverse funzioni urbane al loro interno, contengono una certa ibridazione di programma”10.Rispetto alla lettura di Fenton, l’approccio progettuale, per quel che concerne l’apporto dell’architetto, ossia la sua capacità di immaginare uno spazio integrato dove rendere possibile la convivenza di molteplici funzioni, si è arricchito e ha individuato alcune nuove priorità nell’assemblaggio del programma, intuendo in questo senso il ruolo degli spazi di transizione, la possibilità di interpretarli e le loro potenzialità nella definizione complessiva del progetto e nella demolizione delle tipologie consolidate.“Molti degli edifici recenti o in progetto che contemplano l’ibridazione di funzioni o qualche tipo di chimica programmatica potrebbero tranquillamente essere inclusi nelle categorie descritte da Fenton nel suo catalogo. Per questo motivo è necessario prefigurare una classificazione degli ibridi basata su una serie di tendenze che possono essere considerate come strategie per avvicinare (approssimarsi, accostarsi) l’eterogeneità e la densità”11.
UH_DEFINITIVO.indd 315 19/06/2012 00:16:31
316
Dentro questa intuizione, l’architettura cerca una sua dimensione specifica nella gestione del tema progettuale e lo trova probabilmente nella dimensione formale, ossia mettendo a fuoco le possibili articolazioni di un programma complesso in termini spaziali, facendo ricorso a strategie di rivisitazione delle implicazioni del programma, intuendo le conseguenti nuove opportunità di definizione delle funzioni e soprattutto della loro interconnessione (interno/esterno, svincolando l’edificio da un obbligo “etico” nei confronti della sua forma).“El diseño de las circulaciones consideraba a los flujos, por primera vez, como oportunidades para el evento y la socialización”12.
2.3 Tecniche - la gestione della complessità
“E’ proprio il concorso per il parco della Villette (1982) a rappresentare di nuovo uno snodo fondamentale per gli sviluppi dell’architettura successiva anche sotto questo specifico aspetto. Sia Tschumi che soprattutto Koolhaas mostrano in questa occasione (e in molti successivi progetti) come il diagramma costituisca lo strumento specifico per controllare processi progettuali complessi e innovativi, progressivamente svincolati da obiettivi di carattere formale e in grado di produrre architetture capaci di confrontarsi in termini strategici con l’aleatorio e l’inaspettato”14.
(fig. 3)
UH_DEFINITIVO.indd 316 19/06/2012 00:16:32
317
Alcuni autori, a partire dagli anni ‘80, si rendono conto che, per fronteggiare la nuova complessità figlia della società post-industriale e rendere ancora incisiva la pratica architettonica nella sua capacità di definizione degli scenari fisici dei fenomeni urbani, è ormai necessario verificare e aggiornare non più solo gli strumenti di indagine, ma anche gli strumenti operativi, ovvero le tecniche.Rispetto a questa intuizione, e con una consapevolezza sempre maggiore nei confronti del peso e dell’influenza di argomenti extradisciplinari, verso la fine degli anni ‘90 diversi contributi teorici innovativi si concretizzano in trattazioni e saggi sistematici che esaminano il ruolo dell’architetto all’interno delle mutazioni contemporanee. Tra questi uno dei più significativi è sicuramente Move di Van Berkel + Bos (UN Studio), del 1999.“Move è un vero e proprio saggio sulla figura dell’architetto nella realtà contemporanea. All’aspetto critico e di riflessione sul fare architettura oggi è infatti dedicato sicuramente peso maggiore rispetto alla presentazione - peraltro elegantissima - delle architetture. Al centro della produzione del periodo ci sono, secondo gli autori, tre ‘topics’ (immaginazione, tecniche, effetti) - considerati come invarianti dell’architettura - e la loro trasformazione nell’architettura contemporanea. I tre ‘topics’ vengono utilizzati anche come base della struttura narrativa del libro: Immaginazione, Tecniche, Effetti”15.Per quello che riguarda la nostra trattazione la sezione che ci interessa maggiormente è la seconda, Tecniche.“2. Tecniche (Network Spin). Nel secondo volume viene analizzato l’impatto delle nuove tecnologie sulla progettazione, la comunicazione e la realizzazione dell’architettura. Rilevato il ritardo dell’architettura rispetto ad altre arti (musica, cinema,...) nell’assimilare i nuovi media e trasformarsi di conseguenza, gli autori sottolineano i tre punti di maggiore interesse e potenzialità delle nuove tecnologie applicate al fare architettura: l’espansione dell’immaginazione spaziale, la fine della progettazione gerarchica, e l’introduzione di nuove discipline (animazione, montaggio, ecc.) nel processo progettuale”16.E’ in questa sezione che si trovano i saggi “Diagrams” e “Hybridization”.Il diagramma viene utilizzato da Van Berkel come dispositivo (strumento in grado di affrontare la complessità), e non come prefigurazione del
UH_DEFINITIVO.indd 317 19/06/2012 00:16:32
318
progetto.L’ibridazione viene esaminata in quanto tecnica, sotto il profilo della possibilità di controllo degli esiti, delle potenzialità intrinseche e del riferimento all’autorialità, tema quanto mai all’ordine del giorno nei processi contemporanei. A tale proposito si legge: “Anche l’architettura deve abituarsi a questioni di autorialità ambigua, confrontandosi con i processi di progettazione che hanno molti, talvolta invisibili, responsabili, tentando allo stesso tempo di conservare una posizione di leadership”17.Con queste parole Van Berkel descrive le caratteristiche specifiche degli ibridi: “Un intenso mix di costruzione, materiali, circolazione e spazi di rappresentazione crea incertezza nei confronti delle proprietà esatte dei componenti con i quali queste strutture sono assemblate; essi sono ibridi che non conoscono la loro storia. Lavori di architettura come questo derivano da un olistico assorbimento di elementi disparati, che causano vaghezza rispetto alla scala e alle proporzioni della struttura. L’amalgama genera una nuova nozione di identità. Le diverse caratteristiche del lavoro si perdono ed esistono in layer che non sono necessariamente collegati tra loro o alla scala e alla struttura delle forme e dei materiali dalle quali originano. Le strutture ibride non hanno una scala autentica, riconoscibile, la loro organizzazione mira a permettere l’espansione e contrazione nelle funzioni e ciò risulta in sovrapposizioni e spazi indeterminati che fluiscano uno nell’altro”18.E termina dicendo: “L’architettura dell’ibridazione, il mischiarsi fluido delle parti costitutive in un’unità sempre cangiante, equivale all’organizzazione di continue differenze e ha come esito strutture senza scala, soggette a evoluzione, espansione, inversione, e altre contorsioni e manipolazioni. Libera di assumere differenti identità, l’architettura diventa infinita”19.L’utilizzo consapevole di tecniche di “controllo” della complessità è sempre più presente nelle esperienze progettuali innovative. E’ il caso per esempio dello studio Morphosis. Nel progetto Newcity Park, New York, questa strategia viene messa in atto con l’obiettivo di “illustrare l’idea di un processo di trasformazione dinamico nel quale i vari scenari rappresentati costituiscono la risposta dell’organismo urbano a diverse forze. La città tradizionale si reggeva sulla stabilità della sua struttura economica e produttiva, sulla relativa omogeneità della sua composizione sociale e sulla presenza di un potere politico
UH_DEFINITIVO.indd 318 19/06/2012 00:16:32
319
concentrato, di forma oligarchica. Queste condizioni venivano tradotte in un’organizzazione spaziale gerarchica, stabile e omogenea. Oggi è sempre più difficile vedere la città come il risultato di un processo di tipo lineare; sono proprio l’instabilità dei regimi di accumulazione economica e i ritmi accelerati delle trasformazioni a imporre una maggiore attenzione per le condizioni variabili delle nuove strutture
(fig. 5)
(fig. 4)
UH_DEFINITIVO.indd 319 19/06/2012 00:16:34
320
urbane e a mettere in dubbio le strategie tradizionali di costruzione della città. Si propone pertanto di operare secondo un processo dinamico che offra diverse risposte e diversi scenari che rispondano alle mutevoli forze in gioco. Il progetto è stato costruito operando lungo linee di connessione e dislocazione, secondo un procedimento topologico piuttosto che euclideo. Le geometrie irregolari rappresentano trasformazioni che derivano da contrasti soffocati di sistemi tra loro in concorrenza - una sorta di maglia all’interno della quale vengono privilegiate le relazioni tra elementi differenti rispetto allo sviluppo indiscriminato di una singola forma. La giustapposizione spaziale e le prossimità programmatiche che si registrano all’interno di edifici ibridi favoriscono un’organizzazione tridimensionale della città, contrapposta alla sua attuale organizzazione planimetrica”20.
2.4 Spazio ibrido - intuizione dello spazio topologico
“Se è vero che l’architettura è fatta di materiali specifici (pattern funzionali, concept spaziali, metodi costruttivi e tecnologie, ricerche sui linguaggi), è anche vero che un contributo decisivo arriva anche da altri materiali, esterni all’architettura, ma che in realtà costituiscono l’ossatura portante di un più vasto e profondo legame tra l’architettura e la società, con i concetti scientifici e filosofici contemporanei (ibridazione delle aree di pensiero, delle tecniche e degli spazi). Nel corso degli anni ‘90 si consolida una nuova concezione dello spazio, dell’architettura e del territorio. Ciò è dovuto a molteplici fattori tutti correlati al passaggio (dell’intera società) da un modello industriale a un modello postindustriale (era dell’informazione). Tra le conseguenze di questo passaggio una nuova attenzione verso le istanze ambientali e l’emergere di un concetto chiave: quello di paesaggio, concetto ibrido.L’architettura può diventare un paesaggio reattivo, complesso, animato e vivo combinandosi con altri elementi tecnologici”23.L’aggettivo ibrido può essere riferito anche alla concezione dello spazio: spazio ibrido è forse l’intuizione di una nuova dimensione possibile dello spazio, materia prima per chi si occupa di architettura. Una “natura” che rende concepibili nuove forme e nuovi modi di abitare.Questo tema, che ha risvolti decisivi sull’architettura, è assai vasto e
UH_DEFINITIVO.indd 320 19/06/2012 00:16:34
321
non può essere semplificato in poche righe. Qui ci interessa soltanto suggerire l’idea che alcune sue implicazioni coinvolgono direttamente la nostra trattazione.A. Saggio, in un suo testo recente, porta dei contributi assai interessanti sul significato di spazio ibrido, riconducendo a una prospettiva storica tutta italiana i termini del dibattito.Sarebbe stata la svolta tardo-rinascimentale del XVI secolo e il suo mettere in discussione il sistema prospettico e le sue implicite coerenze (geometria, sistemi modulari, proporzioni) a favorire la svolta verso un approccio dove operazioni come fusione, assemblaggio, coesistenza di elementi a scala differente e ibridazione iniziavano a influenzare le scelte progettuali di alcuni dei principali protagonisti dell’epoca, con esiti esplicitamente originali e innovativi rispetto ai canoni di riferimento.Lo spazio ibrido nasce appunto “dall’idea di fondere tra loro differenti elementi e sistemi” attraverso operazioni progettuali che consapevolmente operano un salto concettuale e che oggi noi riusciamo a leggere e identificare.Questa consapevolezza, nel corso della storia e soprattutto in anni recenti, è stata molto più presente in altri ambiti disciplinari. Pietro Valle, in un suo saggio intitolato Paesaggio non indifferente (“Arch’it”, 25.04.2003) mette in luce l’importanza che ha avuto l’apporto di diversi movimenti artistici negli ultimi trent’anni sul tema dello spazio e dell’architettura, in modo speciale attraverso la ricerca ambientale dell’arte Minimalista e Post-Minimalista degli anni ‘60 e ‘70. Gli importanti contributi teorici della Land Art, del Concettuale, della Body Art e della Process Art sottolinea, “hanno anticipato problematiche emerse solo recentemente nel dibattito architettonico”. L’architettura contemporanea a suo avviso “non può semplicemente mutuare suggestioni formali da queste esperienze artistiche ma deve comprenderne le ragioni profonde che hanno modificato la nozione di ambiente e di spazio pubblico”.“L’oggetto artistico tradizionale, sia esso un dipinto, una scultura o un pezzo di architettura, non va più visto come un’entità isolata, ma deve essere considerato all’interno di un ambiente più ampio. L’ambiente diviene importante quanto l’oggetto, anzi forse di più, perché l’oggetto si espande nell’intorno e assorbe la realtà qualunque essa sia, vicina o lontana, interna o esterna. Nessun oggetto, naturale o artistico, esiste
UH_DEFINITIVO.indd 321 19/06/2012 00:16:34
322
senza ambiente. A dire il vero, l’oggetto può espandersi fino a diventare il proprio ambiente”24.Un altro autore molto interessante per i suoi contributi nella ricerca di una definizione del termine “spazio” e delle implicazioni sulla città contemporanea è A. Corboz.“Corboz rivela angoli che non avevamo mai visto così. Per esempio nello scritto Avete detto spazio? spiega come la concezione del vassoio del funzionalismo Ciam (spazio illimitato, isotropo su cui poggiare architetture-volume) si leghi al neopositivismo, all’illuminismo, all’utopia, alla concezione di Isaac Newton. D’altronde per Corboz, e non solo per lui, ‘il mondo non è mai da leggere’, ma sempre da ‘scrivere’. Ecco perché il destino ultimo dello sguardo è sempre e comunque il progetto”25.Corboz, nel suo testo Avete detto spazio? (1993) tratta la questione dello spazio nella sua qualità di “materia prima della città, concetto in realtà mai definito”, e individua nella mancata rivoluzione concettuale dello spazio architettonico e nella conseguente mancata mutazione del nostro rapporto con lo spazio la vera occasione persa della modernità per comprendere il fenomeno urbano e definire strumenti operativi adeguati (l’autore parla di “ridotta sensibilità epistemologica del Modernismo”). Lo spazio protagonista della generazione dei Ciam è, a suo avviso, ancora debitore delle intuizioni di fine ‘700 (si riferisce alle proposte urbanistiche influenzate dagli ideali rivoluzionari).“Per esprimere l’idea di eguaglianza si elabora in quell’epoca una visione urbana caratterizzata dall’apertura in ogni senso e dalla trasparenza. Un’urbanistica ripetitiva, interamente costituita da parallelepipedi identici e giustapposti, senza che essi mirino a un edificio importante, cioè senza gerarchia: tale è l’ideale dello spazio ‘utopiano’”26.E’ significativo come in ambito architettonico “la nozione di spazio-tempo (cfr. Giedion, 1941) viene tradotta nei progetti più come retorica. (…) le prime case cubiste si limitano a sfaccettare degli edifici tradizionali e non hanno assolutamente niente a che vedere con l’abolizione cubista del punto di vista unico”.In realtà verso la fine del XIX secolo è leggibile in alcuni contributi un salto concettuale decisivo, anche se l’intuizione di uno “spazio topologico” non ha la forza di determinare un nuovo corso per l’architettura per
UH_DEFINITIVO.indd 322 19/06/2012 00:16:34
323
ancora parecchio tempo.“L’arte di costruire la città (Sitte, 1889) cerca di instaurare uno spazio che ha smesso di essere assoluto. (…) Contro l’isotropia e l’immobilità della vulgata newtoniana Sitte valorizza una sorta di campo qualitativo le cui proprietà sono definite sia dai suoi limiti sia dagli oggetti che in esso sono stati immersi”27.Nonostante l’analisi di Sitte non contenga una sola riga sulla natura dello spazio in quanto tale, essa viene definita topologica, in quanto è presente una forma di interazione tra lo spazio e i corpi che contiene.“I moderni non sembrano aver compreso la svolta attuata da Sitte. (…) tutto continua, per gli architetti e gli urbanisti, a svolgersi nelle trappole della sacrosanta prospettiva, prima matrice dello spazio assoluto, poiché anch’essa presuppone uno spazio omogeneo. E non è nemmeno la generalizzazione del computer CAD, prospettivista al cento per cento, che sta mutando i modi della percezione, dunque la routine mentale, o ancora le pratiche”28.Solo di recente per Corboz si possono individuare spunti di un approccio nuovo. Vengono citati alcuni autori che attraverso le loro opere propongono un modo nuovo di trattare lo spazio.E si sottolinea come non a caso il contesto culturale di provenienza di questi autori sia quello dei ribelli ai Ciam in un primo tempo e successivamente quello decostruttivista. Vengono citate la concezione delle reti di relazione del progetto per il Centraal Beheer di Hertzberger (1968), Gehry (Familian House 1978), Coop-Himmelblau, Eisenman, e il procedimento utilizzato da Tschumi per il Parco de la Villette (1982).“A quasi due secoli dai primi lavori che sottomettono la geometria euclidea a una critica radicale per costituirsi in una disciplina autonoma, o analysis situs o topologia; a più di ottant’anni dalla rivoluzione cubista, che congeda un dispositivo pittorico, nato intorno al 1400, che permetteva di ridurre lo spazio a piano; a poco meno di un secolo dalla formulazione della teoria dei quanti che sconvolge totalmente la concezione tradizionale della materia, e da quella della relatività che pone fine alla rappresentazione newtoniana dell’universo, non sarebbe finalmente giunto il momento che i Sigg. Architetti e Urbanisti prendessero atto del fatto che Newton è morto e che perciò lo spazio assoluto è ormai fuori uso?”29
UH_DEFINITIVO.indd 323 19/06/2012 00:16:34
324
Ancora una volta però si mette in evidenza come, nonostante i contributi teorici di parecchi scienziati abbiano ampiamente argomentato e illustrato il salto concettuale dell’idea di spazio contemporanea (cfr. le figure omeomorfe come il nastro di Moebius, per esempio), siano stati altri ambiti disciplinari e non l’architettura a verificare nell’esperienza fisica queste intuizioni, ovvero la mutazione del nostro rapporto con lo spazio: alcuni artisti, rimarca Corboz, hanno già sperimentato dispositivi spaziali che non hanno più nulla in comune con la prospettiva o con lo spazio assoluto newtoniano (Richard Serra, Shift, 1970), ma fanno emergere uno spazio topologico definito. In conclusione, secondo Corboz, è quanto mai necessario acquisire una sensibilità topologica per afferrare la natura dei nuovi fenomeni urbani e non commettere ulteriori errori, legati a un modo di vedere lo spazio ormai improponibile come l’estetica dell’armonia e il suo modello ideale, lo spazio assoluto.
2.5 Ibridi senza architetti - Made In Tokyo
Una delle più interessanti esperienze di indagine sul campo, con riferimento al tema dell’ibrido, è quella del gruppo di ricerca MIT - Made in Tokyo (Momoyo Kaijima, Yoshiharu Tsukamoto, Junzo Kuroda, 1996).La città, nella fattispecie quel particolare agglomerato urbano che è Tokyo, è trattata alla stregua di vero e proprio laboratorio. Alcune sue caratteristiche come la densità, la congestione, la “fame” di spazio, la velocità e la reattività alle “perverse” dinamiche della modernità, la rendono un contesto ideale per questo tipo di studio.La ricerca, nella sua originalità, sembra condividere alcuni aspetti con il contesto americano analizzato da Fenton: da una parte la constatazione dell’importanza della densità come precondizione ideale per un habitat dell’ibrido; dall’altra il ricorrere di un approccio non ideologico e non codificato in modelli accademici, per questo in grado di reagire velocemente secondo strategie di adattamento e versatilità a un contesto in stato di continua mutazione.Gli “edifici” oggetto di indagine (che sfuggono per le loro stesse caratteristiche a una categorizzazione formale) sono catalogati in funzione della ricorrenza di alcune proprietà secondo un criterio a
UH_DEFINITIVO.indd 324 19/06/2012 00:16:34
326
matrice, all’interno del quale si generano tutte le combinazioni possibili tra categoria, uso e struttura che definiscono le loro qualità in quanto “unità ambientali”, ovvero non come oggetti d’architettura ma come catalizzatori di relazioni urbane.MIT - Made in Tokyo (Momoyo Kaijima, Yoshiharu Tsukamoto, Junzo Kuroda), 1996“MIT è una serie di edifici anonimi, a volte divertenti, a volte tristi, a volte troppo seri. Nell’enorme città di Tokio, dove si concentrano una quantità incredibile di persone o cose, questi edifici sono il risultato di una onesta proliferazione dei bisogni urbani. Questo vago e incomprensibile luogo (posto) chiamato ‘Tokyo’ in qualche modo si manifesta attraverso questa collezione. L’urbanistica (l’idea di città) resta registrata direttamente attraverso la forma: le condizioni del luogo e le funzioni possono essere lette in questo sistema definito fisicamente, nel quale ogni edificio è l’incontro armonico di beni, traffico, informazioni, produzione, servizi, alloggi, ecc. Questi edifici non sono limitati da giochi di potere specifici o dall’espressione individuale dell’architetto; non si preoccupano di temi come la scala, il valore culturale o della storia, temi dai quali l’architettura ha sempre dipeso fino a oggi. Essi derivano dall’utilitarismo più avido: ‘qui resta uno spazio, utilizziamolo per altro’; ‘non sarebbe utile collocare questo qui e quello là?’. In questi esempi gli edifici si mischiano con gli elementi del contesto, e costruiscono una totalità significativa e impensabile. Per esempio, fondono i binari del treno, le autostrade, i muri di contenimento e altre opere civili, per fare qualcosa nel quale il limite dell’edificio sia definito in modo vago. O possono anche mischiare funzioni che siano praticamente incompatibili semplicemente perché entrambe richiedono una superficie o una lunghezza simili, o perché un piccolo spazio sembra sprecato. Come risultato le persone e i veicoli, le persone e gli oggetti coesistono senza gerarchia nello stesso spazio e nella stessa forma e strani organismi urbani si sovrappongono uno all’altro (si aggregano). Ognuno di essi occupa un piccolo spazio a Tokio, però sembra che siano permeabili a poteri enormi come il capitalismo, il sistema sociale e la politica. La comunità non li protegge dall’attacco del potere sociale. Si potrebbe pensare che questi edifici, in ogni caso concreto, articolano un nuovo stato dello spazio urbano-architettonico. (Si potrebbe pensare che la
UH_DEFINITIVO.indd 326 19/06/2012 00:16:36
327
nuova condizione dello spazio architettonico urbano venga articolata da questi edifici per ogni caso specifico). Le categorie di edificio e opera di ingegneria, architettura e paesaggio, iniziano a perdere significato e la ragione originaria della loro esistenza viene superata da significati casuali (contingenti) attribuiti posteriormente. I concetti di categorizzazione o di relazione causa-effetto iniziano a disintegrarsi. Se pensiamo all’estensione dell’architettura, stiamo considerando un’architettura che esiste al di là del proprio campo (disciplinare), un’architettura della quale non si può parlare senza considerare le (sue) connessioni con elementi non architettonici; tutto ciò è ‘Made in Tokyo’”31.
(fig. 7)
UH_DEFINITIVO.indd 327 19/06/2012 00:16:36
328
Indice delle illustrazioni:
fig. 1 - Utilizzo del Vigor Ibrido nella selezione del mais (Fonte: J. Fenton, Hybrid Buildings, Pamphlet architecture #11, New York, 1985).fig. 2 - OMA, Dubai Renaissance, 2006. “Come se si trattasse di un pezzo di città disposta verticalmente, l’edificio Dubai Renaissance contiene una porzio-ne di tessuto urbano totalmente accessibile mediante ascensori. Dal progetto fino all’esecuzione, la forma dell’edificio si basa su una logica essenziale che integra architettura, costruzione, servizi e climatizzazione. L’obiettivo del pro-getto è porre fine all’attuale tendenza dell’idolatria architettonica (era dell’i-cona) nella quale l’ossessione per la genialità individuale si dimentica dello sforzo collettivo che implica la costruzione della città… Di fronte all’architettura della forma e dell’immagine proponiamo una nuova integrazione tra archi-tettura e ingegneria nella quale l’intelligenza non si sperperi in effetti, ma in una logica strutturale e concettuale capace di offrire nuovi servizi e funzioni”8. (Fonte: “a+t”, 31, 2008, HYBRIDS I. Híbridos verticales).fig. 3a, 3b - OMA, Seattle Public Library, 2004. - 3a. Proposal (December 1999), modello. - 3b. Diagramma di progetto (suoli e spazi intermedi: gruppi programmatici sta-bili e instabili). “At a moment when libraries are perceived to be under threat from a shrinking public realm on one side and digitization on the other, the Seattle Central Library creates a civic space for the circulation of knowledge in all media, and an innovative organizing system for an ever-growing physical collection - the Books Spiral. The library’s various programs are intuitively arranged across five platforms and four flowing ‘in between’ planes, which together dictate the buil-ding’s distinctive faceted shape, offering the city an inspiring building that is robust in both its elegance and its logic”13 (Fonte: 3a. http://www.spl.org/prebuilt/cen_conceptbook/page56.htm; 3b. “Pasajes. Arquitectura y Crítica”, n. 59, 2004).fig. 4 - The Manimal (original artwork by Daniel Lee, 1996). “Il Manimal è un’immagine generata a computer dell’ibridazione di un leone, un serpen-te e un uomo. Il Manimal non trasmette nessuna informazione concreta ri-spetto alla propria genesi complessa. Tutte le tracce delle identità precedenti sono state perfettamente assorbite nel ritratto; esse esistono simultaneamente e completamente dentro un’unica organizzazione integrata”21 (Fonte: UN Stu-dio, Move, 1999).
UH_DEFINITIVO.indd 328 19/06/2012 00:16:36
329
fig. 5 - UN Studio, Moebius House, 1993-98 - diagramma di progetto. “The organizational and formal structure of the private house is based on a double-locked torus, the Moebius loop. The intertwining trajectory of the loop relates to the 24-hour living and working cycle of the family, where individual wor-king spaces and bedrooms are aligned but collective areas are situated at the crossing points of the paths. In a similar manner these unfolding lines are materialized with glass and concrete, swapping the conventional use of these materials”22 (Fonte: UN Studio, Move, 1999).fig. 6 - Richard Serra, Shift, 1970. “Nel 1970, Richard Serra costruisce in un prato al confine tra Stati Uniti e Canada Shift (cambiamento-modificazione): l’opera, composta da una serie di muri spezzati che affiorano e sprofondano nel terreno, descrive gli assi visivi tra due persone che camminano paralle-lamente a distanza nel prato e registra i punti e le direzioni attraverso cui i due si vedono e si perdono di vista a causa del terreno ondulato. Shift è così parallelamente trascrizione della percezione, mappa orografica restituita alla realtà e dispositivo visivo che si sovrappone al paesaggio presupponendo un osservatore in movimento. La visione che esso descrive è continuamente mu-tante, irregolare e profondamente fisica perché legata al terreno e al corpo”30
(Fonte: http://historyofourworld.wordpress.com/index.php?s=SERRA).fig. 7 - Made in Tokyo, 1996 - unità ambientale n. 03. categorie/strutture/usi. “Nella densità urbana di Tokyo ci sono esempi di una coerenza che va al di là delle categorie o dei limiti fisici degli edifici. E’ qualcosa che si allontana da una architettura completa (in senso compiuto) e autosufficiente. Al suo posto, ogni edificio di questo tipo può giocare un ruolo differente in scenari urba-ni multipli. Non possono essere classificati specificamente come architettura o ingegneria, città o paesaggio. Abbiamo deciso di chiamare questi contesti coerenti di contiguità ‘unità ambientali’ (‘Environmental Units’). (Il progetto ne cataloga 70). Possiamo incontrare una sovrapposizione di tre ordini che for-mano l’Unità Ambientale. Questi ordini sono categoria, struttura, uso. Si può dire che quando ognuno dei tre ordini è operativo (attivo) è On, mentre quan-do non esercita alcuna influenza sull’unità ambientale è Off. Questo sistema incorpora il riconoscimento di tutti i poli di valore e la realtà dell’architettura. Gli esempi di Made in Tokyo rappresentano sempre ‘tipologie’ con un aspetto Off”32 (Fonte: “Pasajes. Arquitectura y Crítica”, n. 29, 2001).
UH_DEFINITIVO.indd 329 19/06/2012 00:16:37
330
Note:
1 J. Wellborn Root, in J. Fenton, Hybrid Buildings, Pamphlet architecture #11, New York, 1985, p. 3.2 “a+t”, 31, 2008, p. 6.3 S. Holl, Foreword, in J. Fenton, Hybrid Buildings, cit., p. 3.4 A. Fernández Per, Hybrid versus Social Condenser, “a+t”, 34, 2900, HYBRIDS III. Híbridos residenciales.5 L. Manzione, “Descrivere il resto”. Altri sguardi sulla città, 2000 (http://architettura.supereva.com/files/20000831/index.htm).6 M. Musiatowicz, Vigor híbrido y el arte de mezclar, “a+t”, 31, 2008, HYBRIDS I. Híbridos verticales, p. 6.7 “a+t”, 31, 2008, introduzione.8 “a+t”, 31, 2008, HYBRIDS I. Híbridos verticales, pp. 114-115.9 J. Fenton, Hybrid Buildings, cit., p. 7.10 M. Musiatowicz, Vigor híbrido y el arte de mezclar, cit., p. 14.11 Ivi, p. 12.12 A. Fernández Per, Hybrid versus Social Condenser, cit.13 http://oma.eu/projects/2004/seattle-central-library14 G. Corbellini, Parole chiave - Diagramma, 2004 (da “Arch’it”).15 F. Fici, Move, “Arch’it”, Books Review.16 Ivi.17 B. van Berkel, C. Bos, Diagrams, in: UN studio, Move (II Tecniques), Amsterdam, 1999, pp. 18-25.18 B. van Berkel, C. Bos, Hybridization, in: UN studio, Move (II Tecniques), cit. pp. 78-85.19 Ivi.20 P. Giaconia, Morphosis. Newcity Park, “Arch’it”, Architetture, 26.05.2002(http://architettura.it/architetture/20020526/index.htm).21 Da Hybridization, in: UN Studio, Move, 1999, pp. 78-85.22 Da Moebius House, in: UN Studio, Move, 1999, pp. 40-69.23 A. Saggio, Evolution of hybrid space, Seoul Conference (October 30, 2006)(http://www.arc1.uniroma1.it/saggio/Conferenze/Seul/Seul.htm).24 F. Kiesler, Second Manifesto of Correalism, 1965.25 A. Saggio, Lo sguardo di Corboz, ”Arch’it”, Coffee Break, 21.12.2000 (http://spazioinwind.libero.it/loading_room/coffeebreak2/20001221/index.htm).
UH_DEFINITIVO.indd 330 19/06/2012 00:16:37
331
26 A. Corboz, Avete detto “spazio”? (1993), in id., Ordine sparso, Milano 1998, p. 228.27 Ivi, p. 230.28 Ivi, p. 231.29 Ivi, pp. 231-232.30 Da P. Valle, Paesaggio non indifferente - 1, “Arch’it” - Artland, 25.04.2003 (http://architettura.supereva.com/artland/20030425/06.htm).31 MIT - Made in Tokyo ©Momoyo Kaijima, Yoshiharu Tsukamoto, Junzo Kuroda, 1996 (http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/madeintokyo_e/mit.html#2 – trad. it. Paolo Vitali).32 http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/madeintokyo_e/mit.html#2
UH_DEFINITIVO.indd 331 19/06/2012 00:16:37