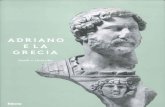Significato e funzioni della cd. Biblioteca di Adriano ad Atene
M. Tortorelli Ghidini (ed.), Aurum. Funzioni e simbologie dell'oro nelle culture del Mediterraneo...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of M. Tortorelli Ghidini (ed.), Aurum. Funzioni e simbologie dell'oro nelle culture del Mediterraneo...
Università degli stUdi di PalermodiPartimento CUltUre e soCietà
MYTHOS
(21 serie continua)
s a l v a t o r e s C i a s C i a e d i t o r e
8 2014
n.s.s
alv
ato
re
sC
ias
Cia
ed
ito
re
In copertina:Mort héroïsé, avec le cheval, le serpent et les armesdisegno tratto da C. Daremberg - E. Saglio - E. Pottier,Dictionnaire des Antiquités grecques et romainesIII 1 - Paris 1877-1919, p. 154, fig. 3829
MYTHOS
82014n.s.
ISBN 978-88-8241-451-1
ISSN 1972-2516
Rivista di Storia delle Religioni
DirezioneCorinne Bonnet [email protected] Cusumano [email protected]
Segretaria di redazioneDaniela Bonanno [email protected]
Comitato scientificoNicole Belayche (École Pratique des Hautes Études -
Section des sciences religieuses)David Bouvier (Université de Lausanne)Antonino Buttitta (Università di Palermo)Claude Calame (École des Hautes Études en Sciences
Sociales - Centre AnHiMA)Giorgio Camassa (Università di Udine)Ileana Chirassi Colombo (Università di Trieste)Riccardo Di Donato (Università di Pisa)Françoise Frontisi-Ducroux (Collège de France - Centre
AnHiMA)Cornelia Isler-Kerényi (Universität Zürich)Emily Kearns (University of Oxford)François Lissarrague (École des Hautes Études en
Sciences Sociales - Centre AnHiMA)Vinciane Pirenne-Delforge (FNRS - Université de Liège)François de Polignac (École Pratique des Hautes Études
- Section des sciences religieuses)Beate Pongratz-Leisten (New York University)Sergio Ribichini (CNR - Istituto di Studi sulle Civiltà Ita-
liche e del Mediterraneo Antico)Leonard Rutgers (Universiteit Utrecht)John Scheid (Collège de France - Centre AnHiMA)Giulia Sfameni Gasparro (Università di Messina)Dirk Steuernagel (Universität Regensburg)Paolo Xella (CNR - Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e
del Mediterraneo Antico - Università di Pisa)
Comitato di redazioneDaniela Bonanno (Università di Palermo)Corinne Bonnet (Université de Toulouse Jean Jaurès)Marcello Carastro (École des Hautes Études en
Sciences Sociales - Centre AnHiMA)Maria Vittoria Cerutti (Università Cattolica - Milano)Nicola Cusumano (Università di Palermo)Esther Eidinow (University of Nottingham)Ted Kaizer (Durham University)Francesco Massa (Università di Pavia)Gabriella Pironti (Università di Napoli-Federico II)Francesca Prescendi (Université de Genève)
© Salvatore Sciascia Editore s.a.s. Caltanissetta© e-mail: [email protected]© http://www.sciasciaeditore.it
Sede: Università degli Studi di PalermoViale delle Scienze ed. 1290128 Palermo - Tel. +39.091 238 99423;Fax + 39.091 421737
Volume pubblicato con i fondi ex-prin 2010-2011
[email protected]://www.portale.unipa.it/dipartimenti/beniculturalistudiculturali/riviste/mythos/
Direttore responsabileNicola Cusumano (Università di Palermo)
Registrazione TribunaleAutorizzazione n. 28 del 18 dicembre 2009
ISSN 1972-2516
ISBN 978-88-8241-451-1
Prezzo del volume: Italia privati e 30,00 enti e 35,00 Estero privati e 35,00 enti e 45,00Distribuzione: Salvatore Sciascia Editore s.a.s. - Corso Umberto I n. 111 - 93100 Caltanissetta
Università degli Studi di PalermoDipartimento Culture e Società
Rivista di Storia delle Religioni
8MYTHOSnumero 8 - 2014nuova serie(21 serie continua)
S A L V A T O R E S C I A S C I A E D I T O R E
4
I N D I C E Dossier Des hommes aux dieux. Processus d’héroïsation et de divinisation dans le monde méditerranéen
à l’époque hellénistique
9 S.G. Caneva – S. Paul, Introduction 13 F. Muccioli, Cultes héroïques et cultes divins aux IVe et IIIe siècles av. J.-C. Tradition, innovation
et reflets littéraires 35 P. P. Iossif, Seleucia on the Tigris under the Seleucids: “Monetary” Pantheon vs. “Glyptic”
Pantheon 55 S.G. Caneva, Paradoxon ! Perception de la puissance divine et du pouvoir royal dans l’Alexandrie
des Ptolémées 77 G.R. Dumke – S. Pfeiffer, The Political Occupation of Sacred Space: The Ptolemaic Royal
Household on Cyprus
Varia 93 D. Bonanno, “She Shuddered on her Throne and Made High Olympus Quake”. Causes, Effects
and Meanings of the Divine Nemesis in Homer 113 G. Cursaru, Χώρα au cœur des enjeux politico-religieux et de la rhétorique patriotique dans les
tragédies grecques. Étude de cas: Œdipe à Colone de Sophocle 137 V. Andò, Cronaca di una morte misteriosa. Variazioni sul mito di Ifigenia
Recensioni e schede di lettura 153 B. Lietz, La dea di Erice e la sua diffusione nel Mediterraneo. Un culto tra Fenici, Greci e
Romani, Pisa, 2012 (C. Bonnet) 155 À.A. Nagy, F. Prescendi (dir.), Sacrifices humains. Dossiers, discours, comparaisons, Turnhout
2013, & P. Bonnechere, R. Gagné (éds), Sacrifices humains. Perspectives croisées et représentations/ Human Sacrifice. Cross-cultural Perspectives and Representations, Liège 2013 (C. Pisano)
158 R. Pettazzoni, Saggi di storia delle religioni e di mitologia [1946], a cura di Giovanni Casadio, Napoli 2013 (V.S. Severino)
162 E. Stavrianopoulou (éd.), Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period. Narrations, Practices, and Images, Mnemosyne Supplements 363, Leiden – Boston 2013 (C. Bonnet)
166 D. Sterbenc Erker, Religiöse Rollen römischer Frauen in “griechischen” Ritualen, Stuttgart 2013 (F. Van Haeperen)
167 A. Testa, Il carnevale dell’uomo-animale. Le dimensioni storiche e socio-culturali di una festa appenninica, Napoli 2014 (S. Mannia)
171 M. Tortorelli Ghidini (a cura di), Aurum. Funzioni e simbologie dell’oro nelle culture del Mediterraneo antico, Roma 2014 (V. D’Alessio)
177 E.R. Urciuoli, Un’archeologia del “noi” cristiano. Le «comunità immaginate» dei seguaci di Gesù tra utopie e territorializzazioni (I-II sec. e.v.) (F. Massa)
181 Gli autori 185 Istruzioni per gli autori
5
C O N T E N T S Dossier From Men to Gods. Heroisation and Divinization in the Hellenistic Mediterranean
9 S.G. Caneva – S. Paul, Introduction 13 F. Muccioli, Heroic and Divine Cults in the Fourth and Third Centuries BC: Tradition, Innovations
and Literary Echoes 35 P. P. Iossif, Seleucia on the Tigris under the Seleucids: “Monetary” Pantheon vs. “glyptic”
Pantheon 55 S.G. Caneva, Paradoxon ! Perception of Divine and Royal power in Ptolemaic Alexandria 77 G.R. Dumke – S. Pfeiffer, The Political Occupation of Sacred Space: The Ptolemaic Royal
Household on Cyprus
Miscellanous 93 D. Bonanno, “She Shuddered on her Throne and Made High Olympus Quake”. Causes, Effects
and Meanings of the Divine Nemesis in Homer 113 G. Cursaru, Χώρα, Patriotic Rhetoric, Political and Religious Issues in Greek Tragedy. Study
Case: Sophocles, Oedipus at Colonus 137 V. Andò, Chronicle of a Mysterious Death. Variations on the Myth of Iphigenia
Reviews 153 B. Lietz, La dea di Erice e la sua diffusione nel Mediterraneo. Un culto tra Fenici, Greci e
Romani, Pisa, 2012 (C. Bonnet) 155 À.A. Nagy, F. Prescendi (dir.), Sacrifices humains. Dossiers, discours, comparaisons, Turnhout
2013, & P. Bonnechere, R. Gagné (éds), Sacrifices humains. Perspectives croisées et représentations/ Human Sacrifice. Cross-cultural Perspectives and Representations, Liège 2013 (C. Pisano)
158 R. Pettazzoni, Saggi di storia delle religioni e di mitologia [1946], a cura di Giovanni Casadio, Napoli 2013 (V.S. Severino)
162 E. Stavrianopoulou (éd.), Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period. Narrations, Practices, and Images, Mnemosyne Supplements 363, Leiden – Boston 2013 (C. Bonnet)
166 D. Sterbenc Erker, Religiöse Rollen römischer Frauen in “griechischen” Ritualen, Stuttgart 2013 (F. Van Haeperen)
167 A. Testa, Il carnevale dell’uomo-animale. Le dimensioni storiche e socio-culturali di una festa appenninica, Napoli 2014 (S. Mannia)
171 M. Tortorelli Ghidini (a cura di), Aurum. Funzioni e simbologie dell’oro nelle culture del Mediterraneo antico, Roma 2014 (V. D’Alessio)
177 E.R. Urciuoli, Un’archeologia del “noi” cristiano. Le «comunità immaginate» dei seguaci di Gesù tra utopie e territorializzazioni (I-II sec. e.v.) (F. Massa)
181 Contributors 185 Instructions for Authors
171MYTHOS • NUMERO 8, n.s. • 2014
Recensioni e schede di lettura
Marisa Tortorelli Ghidini (a cura di)Aurum. Funzioni e simbologie dell’oro nelle culture del Mediterraneo antico
L’Erma di Bretschneider (Studia Archeologica, 193), Roma 2014, pp. 458, ISBN cartaceo 978-88-913-0482-7, € 220.00, ISBN digitale 978-88-913-0480-3, € 176.00
Valentina D’Alessio – Università degli studi di Roma La Sapienza – [email protected]
Nel giugno 2011, presso i locali dell’Ac-cademia Pontaniana di Napoli, si è tenuto un convegno organizzato dalla prof.ssa Ma-risa Tortorelli Ghidini, curatrice del presente volume che raccoglie i relativi atti. Il tema dell’incontro ha riguardato le funzioni simbo-liche dell’oro nelle culture gravitanti intorno al Mediterraneo antico.
Come premette la curatrice, all’origine di questo imponente progetto vi è l’interesse della stessa per le lamine orfiche rinvenute in complessi tombali distribuiti in più luoghi della Grecia e isola di Creta. Il materiale di supporto è uno degli elementi che acco-muna questo genere di reperti e l’interesse per le sue valenze simboliche costituisce lo spunto per un’ampia ricerca, rivolta a più campi dell’antichistica, e di cui il volume è il faticoso risultato.
Il taglio storico-religioso conferito al con-vegno rende quest’opera, unica nella sua genesi e nei presupposti metodologici sui quali si fonda, un documento che d’ora in avanti, negli studi sull’argomento, costituirà un lavoro di riferimento e un utile strumento di ricerca. Ciò non avverrà solo per gli storici delle religioni, bensì per qualunque studioso che affronti l’esame di pratiche, dati archeo-logici, o terminologie nei quali sia variamen-te o vagamente implicato il valore simbolico dell’oro o di altre funzioni auree. Tale eviden-te merito dell’opera è non solo da valutare in prospettiva di riferimenti o interessi che vertono su una singola cultura e il valore da essa conferito al materiale aureo, ma l’ap-porto del volume è da rinvenirsi più propria-mente nella prospettiva ampliata al confron-to tra diverse culture e loro tradizioni.
Nel tentativo di conferire un ordine ai nu-
merosi contributi, il volume si suddivide in tre aree tematiche (Fra Oriente e Occidente; Tradizioni mitiche e cultuali; Storia e lettera-tura) le quali, come normale per un lavoro dall’ampio respiro come questo, non risulta-no monolitiche ma si compenetrano a vicen-da completandosi tra loro. Da uno sguardo molto generico alle tre sezioni è evidente non solo l’articolata varietà culturale ogget-to di studio, ma soprattutto l’assortimento proposto e la complessità delle funzioni au-ree in singoli contesti sacrali e culturali.
Le culture in cui si rinvengono funzioni auree sono molte e diverse di esse trovano spazio in questo libro che si apre con una breve presentazione di reperti provenienti dall’Asia Anteriore (M. Salvini, Lo “scettro” d’oro della regina di Urartu, 13-23) per poi entrare in ambiente culturale mesopotami-co con il contributo di P. Mander (L’oro nella mitologia sumerica, 25-39) che, attraverso una scelta di scritti tratti dal corpus dei te-sti letterari sumerici in cuneiforme, propone una riflessione su temi mitologici che coin-volgono nel dibattito anche gli studi alche-mici. Le funzioni auree rinvenute da Mander in questa tradizione sacrale emergeranno, come si vedrà, anche in altri contributi. Si tratta dell’oro quale simbolo della potenza divina con i suoi risvolti cosmici e espressio-ne di regalità che si esplica a livello estetico nei paramenti sacri. Un elemento di interes-se è anche l’osservazione del rapporto tra oro e altri materiali preziosi, il lapislazzulo in questo caso, che veicolerebbe una simbolo-gia pertinente al rapporto tra luce solare e cielo.
L’antico Egitto, in relazione al tema dell’oro, offre senz’altro una grande
172
Marisa Tortorelli Ghidini (a cura di), Aurum. Funzioni e simbologie dell’oro nelle culture del Mediterraneo antico
MYTHOS • NUMERO 8, n.s. • 2014
opportunità di approfondimento, come evidente nelle riflessioni di M. Nuzzolo (L’oro del valore, il valore dell’oro. I significati dell’oro nella tradizione culturale dell’antico Egitto, 41-51) il quale definisce quello della cultura egizia e dell’oro un vero e proprio sodalizio anche per via dell’abbondante disponibilità del materiale nel paese, tanto da costituire mezzo fondamentale per scambi e rapporti con le regioni vicine oltre che fattore basilare nella regolamentazione della sua ordinaria amministrazione interna. Elementi questi che si riflettono nella religione in cui l’oro è componente del corpo divino e immagine del dio Sole Ra. Torna dunque ad imporsi il ricorrere del rapporto oro/sole e oro/incorruttibilità, da cui l’imponente presenza del metallo nei complessi tombali egizi. Ancora interessanti considerazioni sono rivolte a rituali di cui erano oggetto statue o mummie e l’oro, in questo caso, sembra svolgere la funzione di mezzo atto a conferire prerogative divine ad un oggetto. A livello privato, Nuzzolo esamina il ruolo del metallo in contesti magici, ne rileva le qualità profilattiche e apotropaiche per poi soffermarsi sulle singolari pratiche dell’ “oro del valore” e della “collana delle mosche” o “mosca del valore”. Con P. Xella e G. Scandone Matthiae (Il possesso dell’oro nelle tradizioni mitologiche del Vicino Oriente Antico, 53-60) ci si sofferma sulla simbologia dell’oro in ambiente culturale siro-palestinese del Tardo Bronzo attraverso lo studio di testi ugaritici che veicolano concezioni comuni a tutta l’area siro-palestinese. Si mostra come in queste tradizioni oro e argento rivestano ruoli notevoli sia per la vicinanza all’ambito del divino sia quali offerte. Della costruzione del palazzo del dio Baal, alle cui fondamenta sono placche d’oro, si mostra anche qui il binomio oro-lapislazzuli, come già accennato nell’intervento di Mander. Nelle culture vicino orientali antiche e nei loro sistemi politeistici, osservano gli autori, la presenza dell’oro tra gli dei originava contese dalla posta molto alta, come la sovranità sugli altri dèi o il dominio sul
cosmo. Le prospettive comparative del contributo, molto apprezzabili, mettono in luce, come grazie agli elementi desunti dalle concezioni egiziane (per lo più presentate nell’intervento di M. Nuzzolo), il possedere metalli preziosi equivalga, nel linguaggio mitologico ugaritico, ad essere depositari di una riserva di energie vitali. Nell’interesse degli autori quindi viene presentato un caso di “trasferimento/acquisizione di una particolare ideologia” che vede una forma di contatto tra due aree culturali. Il particolare legame che avvicina oro e divinità viene analizzato da R. Schlesier (Gold as a mediator between divinities and humans in Homer and Sappho’s poetry, 291-302) nella funzione della mediazione che l’oro verrebbe a svolgere nel rapporto tra piano umano e divino. Nell’Iliade si rilevano le occasioni in cui l’oro influisce nel determinare le sorti di un’azione o quale strumento di potere, mentre nell’esame di Saffo si cerca di delineare la funzione dell’oro in relazione al suo collegamento con prerogative femminili e di Afrodite, principalmente nel campo della seduzione. La scelta della poesia greca soprattutto arcaica, quale campo di indagine per le funzioni auree, ha riguardato anche un discorso su Pindaro, proposto da A. Bernabè (Riferimenti all’oro nei poemi di Pindaro: simboli e connotazioni, 303-314). Anche qui si mostrano i frequenti collegamenti tra oro e divinità e il ruolo di questo metallo quale mezzo di comunicazione con il divino. Nello specifico, trattandosi di contesti aristocratici, Bernabè esamina l’oro quale attributo di classe volto a sanzionare l’origine divina o semidivina dell’aristocratico greco. Tratti di originalità sono riscontrabili là dove lo studioso analizza la relazione tra oro e canto che appare come l’unione di due mezzi volti ad uno stesso fine, quello di conferire prestigio e memoria ad un evento occasionale.
Con A. Franceschetti (L’oro nella documentazione micenea, 61-73) le proposte di indagine si indirizzano anche verso l’area culturale greca micenea, nello specifico nella fase finale dell’età
173MYTHOS • NUMERO 8, n.s. • 2014
Recensioni e schede di lettura
del Bronzo. Le osservazioni pertengono alle funzioni auree in relazione ai mezzi di autorappresentazione e autocelebrazione dell’élite aristocratica micenea. Il contributo presenta anche un’interessante analisi della tavoletta Tn 316, che illustra un’importante cerimonia religiosa, in cui l’autrice coglie l’occasione per proporre una nuova interpretazione dell’ideogramma *141 AUR, designante l’oro, cui si aggiungerebbe un nuovo ideogramma considerato non più una variante scribale del *141 AUR e con probabilità designante l’argento. Restando nel campo dell’oro abbinato a manifestazioni di potere, P.G. Guzzo (L’oro del potere. Il potere dell’oro, 75-85) analizza tre reperti archeologici in materiale aureo e nel complesso l’autore mostra come l’utilizzo del metallo abbia, tra i suoi scopi principali, quello di evidenziare la posizione sociale di coloro che ne disponevano.
All’interno del volume trovano spazio interventi dedicati a grandi temi della mito-logia greca e, in particolare, a rivestire un notevole interesse sembrano essere state le vicende legate all’ariete dal vello d’oro. Ad interessarsi a questo tema è G. Greco (L’a-riete dal vello d’oro, 87-102), la quale ricor-da l’origine tessalica del mito e l’intrecciarsi di due racconti coinvolgenti Giasone, nelle peripezie per ottenere il vello e poi Eracle nel suo scopo di appropriarsi dei pomi delle Esperidi. L’intervento pone l’accento, come corretto per un approccio a questo genere di racconti, sulla non casualità delle scelte che legano l’ariete ad una pianta di pomi e relazionano entrambi al materiale aureo. Per questo le scelte operate dalla tradizione che costruisce i propri miti vengono oppor-tunamente collegate ad una ben concreta realtà della natura così che una pelle di montone divenga paradigma diretto dell’oro fluviale, se studiata alla luce di modalità di reperimento del metallo. Quanto ad Eracle, diretto ai confini dell’Occidente ove si collo-cavano miniere auree, si effettuano osser-vazioni pertinenti alla simbologia del pomo in collegamento all’estrazione dell’oro in for-ma di pepite. Una differente lettura del mito
dell’ariete dal vello d’oro è quella proposta da C. Pisano (Frisso e l’ariete d’oro: una let-tura “tautegorica” del mito, 163-172) che segue il metodo teorizzato da M. Detienne, concentrandosi quindi sul ruolo dell’ariete dal vello d’oro all’interno del tessuto narrati-vo in cui si colloca. Egli giunge a ripensare il ruolo dell’ariete che, in precedenti interpre-tazioni, fungeva da sostituto di un sacrificio umano, quello di Frisso. Si tratterebbe dun-que indubbiamente di una vittima sacrificale che tuttavia non può essere concepita quale sostituto di una vittima umana bensì più pro-priamente quale anathèma aureo donato alla divinità, un’offerta che riproduce in oro la vittima sacrificale al fine di perpetuare la memoria di un atto di devozione.
Ancora sulla simbologia dei pomi è l’in-tervento di G. Arrigoni (Pomi d’oro per Ata-lanta da Afrodite d’oro, 137-151) la quale si dedica all’esame di un passo esiodeo (Hes., F76 M-W=*4 Hirschberger=48 Most) e al legame tra i pomi aurei e la dea Afrodite. L’autrice esamina la tradizione in tutte le sue varianti e nelle precedenti interpretazio-ni, fino a concludere che i pomi d’oro sono emblema di felicità sessuale per Atalanta, nello specifico del passo esaminato. Un più generico quadro della percezione che si ave-va del giardino delle Esperidi è il tema scelto da A. Però (Eracle e i pomi d’oro delle Espe-ridi, 153-162) che amplia la sua prospettiva anche alla ricezione di questo tema nella cultura romana.
La colonizzazione greca è stato un argo-mento che ha interessato diversi contributi seppure in considerazioni secondarie; l’in-tervento proposto da M.C. D’Ercole (Il tema dell’oro nella colonizzazione greca, tra rap-presentazioni simboliche e realtà storica, 103-115) si incentra su questo campo con-nettendolo alla ricerca dei metalli.
Il tema dell’età dell’oro nelle culture classiche, in cui la simbologia veicolata da questo metallo presenta aspetti di rilievo, per le sue varie declinazioni, non poteva non incidere nelle scelte operate dagli autori del volume. Ad iniziare da L. Cerchiai e M. Menichetti (Il codice dell’oro tra maschile
174
Marisa Tortorelli Ghidini (a cura di), Aurum. Funzioni e simbologie dell’oro nelle culture del Mediterraneo antico
MYTHOS • NUMERO 8, n.s. • 2014
e femminile, 127-133), sono diversi i con-tributi che affrontano e propongono osser-vazioni sull’età aurea nella sua percezione da parte della cultura greca e successiva-mente romana. Prendendo le mosse dalla descrizione esiodea del chryseon ghenos i due autori effettuano rilievi sul ruolo del pre-zioso materiale nel tema in oggetto. Anche qui compaiono richiami, presenti in molti degli interventi, al mondo divino e al rango eroico. Oltre a ciò sono presenti considera-zioni relative al valore dell’oro rispetto alla vestizione e ad altri attributi femminili che vengono inquadrati a livello del potere della seduzione. Di qui si passa all’ambiente cul-turale etrusco e al noto tema del lusso dei Tyrrhenoi, tuttavia associato dalla cultura greca a hybris e superbia, in un pericoloso oscillare tra umano e divino. Il tema delle età dell’uomo viene affrontato anche da G. Ricciardelli (Oro degli uomini e oro degli dèi, 173-180) partendo da Esiodo ma con una prospettiva tesa a rintracciarne l’interpre-tazione o riproposizione in altri autori greci, con una particolare attenzione al suo ricor-rere in Platone nella Repubblica con il parti-colare significato che il filosofo attribuisce al chryseon ghenos, non più un’epoca o una generazione, bensì qualità di determinati in-dividui cui gli dèi avrebbero immesso nell’a-nima dell’oro conferendogli una sorta di superiorità morale ed etica. Lo stesso tema, affrontato nel suo ricorrere nella cultura ro-mana, è stato scelto da A. De Vivo (Aurum in Tacito: moralismo e prospettive politiche, 397-404). Ad interessare l’autore sono le occorrenze in Tacito e il taglio moralistico e politico con il quale lo storico intesse le sue argomentazioni. Sempre all’interno di un’o-pera contenente argomentazioni di stampo moralistico, il contributo di G. Sfameni Ga-sparro (L’oro, l’anima e il suo destino. Os-servazioni su un passo di Plutarco e sulla klimax eptapylos mitriaca secondo Celso, 199-210) esamina alcune funzioni auree contenute nel trattato plutarcheo “Sui ritardi della punizione divina” e mostra come que-ste funzioni attengano precipuamente alle valenze negative dell’oro, posto per lo più
all’origine della bramosia e avidità umana. In secondo luogo, ad interessare la storica delle religioni è una notizia di Celso, conte-nuta nell’ampio trattato di Origene teso alla sua confutazione, riguardante i misteri di Mithra. L’autrice presenta un’interessante disamina della simbologia delle sette por-te, sormontate da un’ottava, ciascuna delle quali è associata ad un metallo, la settima è d’oro ed è in relazione al sole. Non è chia-ro il valore di questa klimax e i suoi nessi con l’ordine planetario o con i giorni della settimana. Si rilevano comunque elementi comuni con i gradi dell’iniziazione mitriaca nel suo porsi in relazione a temi astrali. Ciò che tuttavia interessa Sfameni Gasparro è, come altri interventi, la connessione tra pia-neti e metalli e la ricorrente valenza solare dell’oro, seppure nella sua più specifica re-lazione con il motivo della successione delle ere che sembrerebbe caratterizzare la pro-spettiva mitriaca e che, nello specifico della notizia di Celso, potrebbe essere interpreta-ta come un passaggio attraverso diversi cicli cosmico-temporali cui soggiace una sorta di dinamismo ascensionale.
Si è già accennato alla frequente as-sociazione di oro e lapislazzuli, ma non dell’altrettanto preziosa associazione con l’ambra. G. Scalera Mc Clintock (Le dorate lacrime d’ambra, 181-190) affronta il tema su un piano mitico mostrando il ricorrente attributo della luminosità che caratteriz-zerebbe questo minerale già nella sua de-nominazione greca di elektron o elektros. Questo della luminosità, ma esclusivamente dell’oro, è un carattere esaminato anche da M.M. Sassi (Sul colore dell’oro, 349-360) che presenta una particolareggiata analisi della terminologia pertinente al materiale aureo. Ancora sui materiali ma più incentra-to nel loro aspetto di supporto alla scrittura è il contributo di A.I. Jiménez San Cristóbal (Usi dell’oro e del piombo nei testi religiosi greci, 233-248) che confronta, attraverso una sommaria rassegna, alcune delle pecu-liarità e delle caratteristiche dei testi scrit-ti su oro con quelli redatti su piombo. Più ampiamente incentrato sull’utilizzo cultuale
175MYTHOS • NUMERO 8, n.s. • 2014
Recensioni e schede di lettura
dell’oro nella cultura greca, l’intervento di S. Georgoudi (Chruseos Kosmos. L’usage ambivalent de l’or dans les pratiques rituel-les grecques, 249-275) evidenzia in primo luogo le difficoltà di circoscrivere tale uso, in relazione al culto, senza fare riferimento alle suddette associazioni con altri metalli o materiali preziosi. L’articolato intervento è costituito da diverse sezioni che pertengo-no all’uso dell’oro per la fattura di armi, in alcuni racconti mitici, e il suo avvicinamen-to al fuoco con la possibilità di mutarsi in esso. Ulteriori considerazioni riguardano la presenza di oro nei santuari, la fattura del-le statue divine con le loro suppellettili e le offerte votive. Anche Georgoudi, come altri autori, vede un proficuo campo di indagine nello studio delle terminologie, nello speci-fico si studiano gli aggettivi utilizzati nei di-versi contesti. Interessanti riflessioni sono quelle presentate sul tema del legame tra oro e sacerdozio nell’esame della presenza del metallo nell’abbigliamento degli atto-ri del culto e la valutazione, oltre che della presenza, anche delle interdizioni dell’oro in diversi contesti sacri o il suo impiego quale mezzo di purificazione.
Tra i tanti e vari termini greci afferenti al campo semantico dell’oro si distingue, nel volume, un accurato esame del valore o dei valori rivestiti dall’epiteto chrysothronos, proposto da G. Pironti (Chrysothronos: note in margine ad un epiteto aureo, 211-222) con interessanti osservazioni sulla polise-mia del termine e la sua funzionalità rispetto al politeismo cui pertiene.
Diversi interventi, come in parte quello di Georgoudi, si incentrano su questioni atti-nenti paramenti sacri o accessori, tra questi anche il contributo di L. Arcari (La corona d’o-ro del “simile a figlio d’uomo” (Apocalisse 14, 14-20), 191-198) che prende in esame un passo dell’Apocalisse in cui si tratta dell’im-minente arrivo del giudizio. Dopo una breve spiegazione riguardante la struttura del pas-so, lo studioso riflette sul contesto visionario in cui si colloca, che vede la presenza di un soggetto definito “simile a figlio d’uomo”, e i problemi esegetici che hanno interessato la
ricerca. A richiamare da vicino il tema del con-vegno sono gli attributi di questo personag-gio, il quale è caratterizzato da una corona aurea, e Arcari incentra le sue argomentazio-ni sulla decifrazione di questo simbolo.
Il rapporto dei Pitagorici con l’oro è l’ar-gomento scelto da A. Mele (L’oro di Pitago-ra, 279-290) e anch’egli prende spunto da aspetti estetici, caratterizzanti l’abbiglia-mento di Pitagora, per tessere un discorso che riguarda anche il rapporto tra materiale aureo, abbigliamento e simbologie evocanti l’armonia cosmica. Anche Mele, come Geor-goudi, rileva una componente purificatoria dell’oro, nel suo impiego da parte dei Pita-gorici.
Ulteriori aspetti dell’immaginario antico, scelti dai partecipanti, coinvolgono anche il rapporto tra oro e animali, come nel con-tributo di E. Federico (Bella circa metalla e grifoni chrysophylakes. Usi e abusi mitici dell’oro, 315-326), che illustra come anima-li fantastici venissero immaginati a guardia dei giacimenti d’oro, nelle lontane regioni del nord e della Battriana.
Due interventi sono specificamente incentrati sull’analisi di funzioni auree presenti nella tragedia greca. U. Crisciuolo (Aurum tragicum, 327-340) sceglie la Medea e L’Ecuba per mostrare come qui l’oro svolga la funzione di δόλος e mezzo per raggiungere determinati intenti. L’analisi di questa funzione aurea si colloca all’interno di una più vasta problematica che coinvolge a tratti l’opera euripidea: si tratta della diffidenza verso la ricchezza a vantaggio di altri valori, evidenziando un mutamento, occorso nel tempo, nella sensibilità comune, e che sarebbe ben evidente, ad esempio, comparando questa visione a quella precedente e dal carattere trionfalistico rinvenibile nei canti di Pindaro. La scelta di A. Saggioro (Funzioni auree. Occorrenze nello Ione di Euripide, 341-348) verte sullo Ione al fine di analizzare alcune delle molte funzioni auree presenti. Dopo un sintetico inquadramento della tragedia e della chiave di lettura prescelta, lo studioso inizia le sue argomentazioni a partire da
176
Marisa Tortorelli Ghidini (a cura di), Aurum. Funzioni e simbologie dell’oro nelle culture del Mediterraneo antico
MYTHOS • NUMERO 8, n.s. • 2014
due oggetti: un bracciale di Creusa, con al suo interno gocce del sangue della Gorgo, e un ciondolo a forma di serpente. Si mostra la complementarità delle funzioni dei due oggetti e si giunge anche a meglio determinare, sullo sfondo propriamente aureo di questa tragedia, una funzione non ancora evidenziata dalla ricerca sull’opera, ovvero l’oro quale custodia di reliquie, le quali sembrano acquisire valore e senso nella loro connessione con il prezioso metallo.
Nell’ambiente culturale dell’Italia prero-mana, P. Poccetti (Nome e “pratiche” dell’o-ro nell’Italia pre-romana, 361-386) nota come l’oro faccia da supporto alle prime at-testazioni della scrittura in lingua latina ed etrusca, inserite in contesti di scambio tra comunità appartenenti alle principali com-ponenti linguistiche italiche, egee e del Vi-cino Oriente antico. Egli nota, attraverso l’e-same di note iscrizioni, come sia la scrittura a beneficiare di un valore aggiunto costituito dal supporto aureo; inoltre è notevole il fatto che anche nel lessico latino, come eviden-ziato in altri interventi pertinenti la cultura greca, torni a mostrarsi il legame tra oro e aurora e quello, più legato alla componen-te culturale sabina, tra oro e luminosità del sole, notevolmente manifestatosi nel corso dei diversi contributi. Il campo della numi-smatica romana è quello cui ha attinto la riflessione di R. Pera (“Preziose” tipologie negli aurei romani, 387-396) che si incentra principalmente sulle emissioni monetali in oro, che compaiono nella monetazione ro-mana, in relazione ad eminenti personalità dell’ultimo periodo repubblicano. L’autrice
mostra come sussista un legame tra il ma-teriale prezioso e le tipologie iconografiche, sottilmente innovative, in relazione a scritte con messaggi di impatto.
A conclusione dell’imponente varietà dei temi si inserisce un contributo di P. Scarpi (Dall’oro per i morti all’oro per la vita. Picco-la difesa della letteratura, 405-412), molto apprezzabile in quanto incentrato sul recu-pero dei temi aurei nella letteratura, con particolare riguardo all’opera di Gabriele D’Annunzio. Le conclusioni dell’incontro, e del prezioso lavoro che ne raccoglie gli atti, sono affidate a N. Spineto (Aurum: da voce di catalogo a tema culturale, 413-421) che porta all’attenzione del lettore importanti questioni metodologiche come l’uso del me-todo comparativo, il concetto di simbolo in relazione ad un elemento della natura come l’oro e dei diversi livelli documentati dal li-bro, il tutto all’interno di un discorso di tipo storiografico.
Come si deduce dalla varietà delle pro-poste presentate, e qui sommariamente descritte, ciò che risulta da questo lavoro è un’indagine collettiva che vede innanzitutto una profonda compenetrazione tra discipli-ne affini o molto diverse che concorrono a proporre, in una prospettiva interculturale, una ricerca fondata su un approccio storico-critico intorno ad un unico grande tema. Ne risulta un valido strumento di lavoro che apre ad un inizio e non costituisce affatto un punto di conclusione di uno studio, poi-ché gli spunti di approfondimento che man mano emergono dai singoli testi, gettano il seme per future e promettenti ricerche.