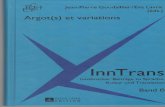Le bande e la città. Conflitti e spazio pubblico nella Spagna contemporanea
Transcript of Le bande e la città. Conflitti e spazio pubblico nella Spagna contemporanea
ETNOGRAFIA E RICERCA QUALITATIVA - 3/2014
Luca Giliberti e Luca Queirolo Palmas
Le bande e la città
Conflitti e spazio pubbliconella Spagna contemporanea
1. 1. La banda come metonimia e come sintomo urbano
Il presente contributo riflette sui conflitti e i dispositivi di stigmatizzazione edespulsione dallo spazio pubblico che coinvolgono un segmento specifico, ber-saglio di ricorrenti discorsi mediatici, della gioventù di origine migrante nellaSpagna contemporanea: le bande1. Tali processi, che interessano anche altrisegmenti della gioventù di classe popolare, presentano qui un elemento aggiun-tivo legato all’origine migrante – maggioritaria tra i membri di questi gruppi –
xLe riflessioni e i materiali di questo articolo nascono da una doppia esperienza di ricercarealizzata dagli autori sulla costruzione sociale della gioventù migrante nella Spagna con-temporanea, tra Barcellona e Madrid. Da un lato il progetto europeo YOUGANG (Gangs Po-licies: youth and migration in local contexts, Marie Curie Intra European Fellowship – 7thEuropean Community Framework Programme) da cui nasce il volume Enemigos públicos.La fabricación de las bandas en la España contemporánea (Queirolo Palmas, 2015), dall’al-tro lato una ricerca di dottorato presso l’Universitat de Lleida - La condición inmigrantey la negritud en la experiencia escolar de la juventud dominicana; estigmas y formas deagencia – realizzata grazie alla borsa FPU del Ministero dell’Educazione spagnolo (Giliberti,2013). L’etnografia, caratterizzata dall’osservazione partecipante e dalla ricerca-azione condiversi gruppi giovanili di strada, ha anche comportato la realizzazione di 80 interviste adifferenti attori istituzionali e leaders di bande nel primo caso; nel secondo sono state rac-colte 25 biografie di giovani migranti, e allo stesso tempo sono stati intervistati 160 attorisociali che partecipano alle traiettorie vitali dei soggetti studiati (professori, presidi, educa-tori, operatori sociali, familiari). I nomi degli informatori citati nel presente testo sono difantasia.
1 La parola banda, una categoria diffusa dalle agenzie di controllo sociale, non corrispondeal linguaggio dei giovani membri di tali gruppi, che preferiscono viceversa parlare di coro,gruppo, nazione, associazione, organizzazione, clica, famiglia. Utilizzeremo anche il termi-ne scena per risaltare il carattere fluido, turbolento ed eterogeneo delle appartenenze nellesocialità di strada. Per una lettura del fenomeno a partire da un focus rizomatico, centratosull’idea dell’indeterminazione, versus uno arboreo, che assume la banda come un’organiz-zazione piramidale, si veda Hallsworth (2013). Segnalati i limiti, d’ora in poi il termine bandaverrà utilizzato senza il formato corsivo.
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 424 –
e alla predilezione da parte del pensiero di Stato (Sayad, 1996) per una classi-ficazione in termini di criminalità.
Secondo l’analisi di Brotherton (2010), la letteratura internazionale sulle«bande» si articola almeno lungo tre prospettive. La prima fa riferimento aglistudi classici di Thrasher (1927) e di Whyte (1943) nel quadro della scuoladi Chicago; secondo questi autori le bande, sedimenti di una immigrazionedi massa, crescono negli interstizi urbani e si configurano come formazioniculturali dinamiche in un contesto di esclusione e di trasformazione sociale.Secondo la visione di Thrasher, questi gruppi nel loro sviluppo risignificano intermini di valore di uso gli spazi privi di sorveglianza, oltre che marginali per gliinteressi delle autorità e degli attori economici; lo spazio urbano, i suoi interstizie le zone d’ombra divengono luoghi di una socialità giovanile priva di uno scopomanifesto. Le bande, per così dire, occupano quei vuoti che il progredire deltessuto urbano ha dimenticato, non ancora accorpato né mercificato.
La seconda prospettiva, inaugurata negli anni ’70 da Klein (1971) e oggitra le più utilizzate tanto dalla doxa accademica quanto nel discorso pubblico,definisce come banda un aggregato di giovani che produce crimine e violenza emette a rischio l’ordine costituito, generando così una reazione sociale da partedi chi ha il compito di proteggere la comunità. Questa visione, uno «sguardopatologizzante» secondo Brotherton (2010), include ed abilita anche una seriedi discorsi e pratiche di correzione, di prevenzione e soppressione; in più, l’in-sistenza sulla pericolosità penale e sociale dei giovani delle bande occulta leviolenze strutturali di cui gli stessi sono vittime, invisibilizzando ciò che perBourdieu (1998) è appunto la legge della circolarità e della conservazione dellaviolenza. Lo spazio urbano, in questo secondo filone di lettura, diviene un ter-reno di esercizio del crimine, un sostrato su cui si dispiega un’economia dellastrada e una politica della paura. La produzione di un valore d’uso – la socialitàe la sua territorializzazione di cui possono essere protagonisti questi gruppi – èdunque pensato come artifizio o risorsa utile alla costruzione di un contro-valoredi scambio, in cui attraverso il crimine soggetti pericolosi generano un’appro-priazione indebita della città e attentano al monopolio statuale sulla regolazionedegli scambi economici. L’interstizio urbano diviene, agli occhi dei pianificatorie dei funzionari di diverse agenzie di controllo, una zona d’ombra in cui fiori-sce un’economia dell’illecito che annovera le bande fra i suoi attori principali.Le bande non sono più confinate in luoghi marginali ma occupano la città; inessa si muovono come primitivi urbani, soggetti razzializzati che rifiutano lacondizione del suddito silenzioso. In questo senso, come segnala Conquergood(1994, p. 216):
Il termine banda ha preso la forma di uno degli ultimi termini più satanizzatidella società contemporanea, creato per inglobare e condensare una enormediversità e complessità di esperienze in una sola immagine feticizzata di di-sordine senza senso e cattiveria. La banda proietta e catalizza le paure e leansietà delle classi medie attorno al disordine sociale, la disintegrazione e ilcaos che sono palpabili in queste figure demonizzate di improduttivi, preda-tori, patologici e incomprensibili.
LE BANDE E LA CITTÀ
– 425 –
Un terza prospettiva, di segno critico, enfatizza la capacità creativa e diagency di questi giovani subalterni, le loro produzioni culturali e le loro formedi socialità come pratiche di resistenza a processi di discriminazione per cultu-ra, razza, classe; Barrios e Brotherton propongono di abbandonare il terminebanda, viziato dall’idea del crimine come qualità ontologica dei gruppi, per so-stituirlo con quello di organizzazione della strada (2004, p. 23):
Gruppi formati in gran parte da giovani e adulti, provenienti da classi margina-lizzate, che hanno come obiettivo fornire ai propri membri un’identità di resi-stenza, un’opportunità di empowerment sia a livello individuale che collettivo,una possibilità di voice capace di sfidare la cultura dominante, un rifugio dalletensioni e sofferenze della vita quotidiana nel ghetto, ed infine una enclavespirituale dove possano essere sviluppati e praticati rituali considerati sacri.
Le nostre stesse ricerche (Queirolo Palmas, 2009, 2010, 2015; Giliberti,2013, 2014; Porzio, Giliberti, 2009) si iscrivono in questa prospettiva e cercanodi descrivere e interpretare lo sviluppo di alcuni meccanismi cruciali di agency edi resistenza allo stigma, seguendo la grammatica della sociologia di Bourdieu,assumendo le bande come un vettore di accumulazione e circolazione di distinticapitali (simbolico, sociale, culturale, economico, corporeo-guerriero) per certisegmenti della gioventù.
Sempre nell’ambito di un approccio critico, Hallsworth (2011) introduce ilconcetto di gang talk, un discorso che istituisce le rappresentazioni sulle bande(representation of gangs) – invece che illustrare le rappresentazioni prodottedalle bande (gang representations) – e articola contemporaneamente un campoeconomico (gang industry) i cui protagonisti principali sono costituiti dagli ope-ratori della polizia e della sicurezza pubblica. Anche partendo da qui, è possi-bile comprendere il funzionamento della retorica sulle bande, oltrepassando losguardo della doxa sociologica e criminologica sul tema.
Nel nostro campo di ricerca, i mezzi di comunicazione, e attraverso di essila società spagnola, scoprono e fabbricano il fenomeno delle bande latine inparallelo alla crescita dei flussi migratori e dei ricongiungimenti familiari. Findal principio, questi gruppi vengono battezzati come bande criminali, associatia notizie di cronaca nera, con una chiara tendenza alla stigmatizzazione dellaloro estetica e delle loro pratiche culturali (Feixa et al., 2006; Canelles, 2008;Lahosa, 2008a, 2008b). In questo senso, il termine «banda latina» è un signi-ficante metonimico attraverso cui parlare di violenza giovanile e delle formedi socialità dei figli dell’immigrazione (Recio, Cerbino, 2006; Porzio, Giliberti,2009; Giliberti, 2011). Il risultato di tale operazione sarà un’associazione di-retta e naturalizzata fra violenza, criminalità e gioventù subalterna di originelatinoamericana (Feixa, Canelles, 2006; Feixa et al., 2008; Giliberti, 2011).
La narrativa mediatica sulle bande permette di cristallizzare, ed etnicizza-re, un’immagine di pericolo e minaccia attorno a questi nuovi soggetti giovanilidi origine migrante che circolano nello spazio urbano; alcuni Stati di provenien-za – Repubblica Dominicana, Ecuador, Colombia – sono così presentati comecontesti privilegiati di produzione delle culture di banda. Detto in altre parole,
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 426 –
secondo tale narrativa questi gruppi approdano in Europa come modelli collet-tivi di violenza importata (Botello, Moya, 2006), una lettura chiaramente auto-assolutoria dato che le bande – formazioni di una specifica cultura giovanile su-balterna – si costruiscono e riproducono nella società di accoglienza in terminigenerazionali e in piena epoca di globalizzazione. L’ascrizione sotto l’etichettadi latinos è il frutto di una etnogenesi (Feixa et al., 2006), ossia la creazionedi una nuova identità giovanile transnazionale che si costruisce nel paese diarrivo. Peraltro, occorre sottolineare che il fenomeno, ed il suo discorso, nonsono nuovi in Spagna, ma abituali nelle cronache sul disordine morale dellagioventù e delle metropoli sin dagli anni ’60 (Lahosa, 2008a, 2008b).
Nello specifico, dalla transizione democratica in poi, una gioventù di classepopolare, e in parte legata alla cultura gitana e alla migrazione interna andalusa,ha costruito estetiche e pratiche delittive di riappropriazione della ricchezza.Questi soggetti – classificati come bande e etichettati con il termine Quinquis(da quincalla, ferraglia, attività alla quale si dedicavano molti gitani) o quillos(da chiquillos, appellativo comune per indicare i giovani in Andalusia) – diven-gono rapidamente eroi e protagonisti delle notizie di cronaca nera, inauguran-do persino un genere narrativo e cinematografico (Cuesta et al., 2009). Questoprecedente storico ci aiuta a capire come l’oggetto sociale banda sia anche undispositivo utilizzato per designare certe forme di socialità delle classi pericolo-se, nello specifico di quel segmento spesso etnico o etnicizzabile – i poveri nonmeritevoli – delle gioventù di origine proletaria.
Le bande stanno dentro un’epoca ed un contesto; in tal senso Mauger (2006)riconduce questi gruppi giovanili agli stili delle classi popolari che valorizzanola forza come capitale e che nell’epoca fordista trovavano un’omologia e unaconversione probabile del valore del corpo e della virilità nella cultura dellafabbrica; in altre parole, nel culto del corpo e della forza i giovani delle ban-de potevano sperimentare quegli stessi capitali cruciali per la posizione e larappresentazione della classe operaia nello spazio della fabbrica. Oggi tuttavia,questa conversione in virilità e dignità operaia si interrompe di fronte alla di-minuzione degli impieghi articolati sulla forza e al disconoscimento simbolicodella relativa cultura di classe. Nello spazio della città, come fabbrica diffusa direlazioni di lavoro precarie nei servizi o nell’economia informale e dell’illecito,i giovani che attraversano o hanno intercettato le bande come culture giovanilidella strada provano a trasformare il capitale fisico e corporeo lì accumulato inrispetto e capitale simbolico. Pertanto, la città e lo spazio urbano sono ancheun luogo di visibilizzazione di pratiche (Brighenti, 2008), fra cui la violenza2 ela forza come linguaggio del rispetto, che non trovano una conversione facile e
x2 Secondo un’autorevole fonte ufficiale – la polizia catalana – il crimine prodotto dalle bande
rappresenta lo 0,18% del totale delle infrazioni penali denunciate nel 2010 (Mossos d’Esquadra,2011). In effetti, le attività delittive non hanno connessioni con le grandi piattaforme delcrimine (traffico e vendita di droga, ricettazione, vendita e traffico di armi, organizzazionedella prostituzione, ecc.); il crimine principale è la violenza inter-personale, un linguaggioper affermare la superiorità di un gruppo sull’altro, un codice e un alfabeto condiviso chepermettono di andare in cerca del rispetto (Bourgois, 2010), risorsa sociale e simbolica dicui sono strutturalmente privati.
LE BANDE E LA CITTÀ
– 427 –
pacificata in altri capitali e valori sociali dotati di un riconoscimento pubblicoe allargato.
Per quanto riguarda l’immaginario sociale, a partire dal nuovo millennio,si consolida la relazione tra bande giovanili e immigrazione latinoamericana,identificandone i membri attraverso caratteristiche sociali (giovani di classe po-polare privi di risorse culturali) ed estetiche (per i vestiti larghi e lo stile gang-sta), oltre che morali-comportamentali (la violenza e gli usi illegittimi, incivi-li dello spazio urbano). Inoltre, l’apparizione del fenomeno banda, con la suaconstante aggettivazione etnica (latina), anticipa e segna il dibattito pubblicosulla nascita di una seconda generazione dell’immigrazione (Queirolo Palmas,2012). Come segnala Iñaki García (2003), alla divisione dicotomica fra migrantie non-migranti corrisponde la divisione fra seconde generazioni e gioventù inastratto; le bande appaiono in questo quadro come il segno, violento e collettivo,che nello sguardo della società di arrivo cristallizza le pratiche di socialità deifigli delle migrazioni, trasformandoli in un oggetto-problema. Canelles (2008),nella sua analisi sulla costruzione sociale delle bande latine a Barcellona, so-stiene inoltre che tale oggetto non sia altro che un sintomo, un’espressione dialtri fenomeni urbani, oggi enfatizzati peraltro dalla crisi e dall’esclusione dalmercato del lavoro. Questi gruppi sono sintomi della maniera in cui nella societàdi accoglienza si legge la presenza subalterna di origine migrante, in chiavedi semplificazione della realtà, stereotipizzazione e discriminazione; il modo incui sono visti risponde bene all’intuizione di Balibar (1991) secondo cui in unasocietà post-coloniale il discorso sull’immigrazione, e la sua culturalizzazione,sostituiscono il discorso sulla razza, mantenendone però le funzioni. In questosenso, attorno e grazie alle bande, si costruisce una linea del colore che divideun noi da gli altri, con un’assegnazione implicita di colpa a tali altri – i giovanifigli delle migrazioni e le loro forme di socialità potenzialmente criminose –e l’auto-assoluzione della società di ricezione. Infine, tali gruppi sono sintomiurbani in quanto evidenziano una trasformazione più generale della città, incui la progressiva valorizzazione mercantile del territorio e l’incorniciamentodi molti spazi pubblici dentro normative di uso stringenti, e nei fatti selettivein funzione della classe sociale, rendono certe categorie di soggetti inadeguatie inappropriati.
Dal 2008 al 2013 abbiamo sviluppato il lavoro etnografico in due grandiaree metropolitane – Barcellona e Madrid, scenari di massicci processi di arri-vo e inserimento subalterno della manodopera immigrata – per la polarità cheesprimono, e per la quale si narrano pubblicamente, in termini di interventiistituzionali di gestione del fenomeno delle bande3. A Barcellona, nell’ottobre2003, un omicidio all’uscita da scuola segna la nascita mediatica e sociale dellebande: gruppi di giovani di origine migrante, pericolosi ed esotici nei loro nomi(Latin Kings, Ñetas, Mara Salvatrucha, Trinitarios, Dominicans Don’t Play, ecc.)che confliggono per garantirsi l’esclusività di un territorio divenendo protago-
x3 Per maggiori dettagli sul caso di Barcellona, si veda: Feixa et al. (2011), Canelles (2008),
Queirolo Palmas (2013), Giliberti (2013), Romaní (2009). Sul caso di Madrid: Aparicio, Tornos(2009), Martín et al., (2009), Scandroglio, López (2010).
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 428 –
nisti di atti di violenza percepiti come inediti e gratuiti. Tre anni dopo, comeeffetto di una politica esplicita del Comune, questi stessi gruppi sono trasformati– normalizzati4 – in associazioni culturali giovanili, iscritte nel registro dellaGeneralitat de Cataluña. Nel mentre, a Madrid, le bande sono considerate as-sociazioni illecite, verso cui l’unica reazione istituzionale è la repressione; lesentenze dei tribunali rendono illegali questi gruppi, considerando come attocriminale la semplice appartenenza, arrestandone e deportandone membri eleadership.
A fine 2011, in Catalogna, la politica di normalizzazione si conclude: leassociazioni legalizzate sono effimere e svuotate di qualsiasi rilevanza pubblica,mentre un nuovo discorso egemonico, politico e mediatico, invita a superare «ilbuonismo che sovvenziona le bande». Allo stesso tempo, a Madrid, le istituzionicercano di tenere bassi i toni del discorso sulle bande, privilegiando una politicapiù discreta, e meno gridata, di tolleranza zero. Nei due contesti, nuovi e vecchigruppi continuano però a popolare le strade – e gli immaginari della gioventùmeticcia e di classe popolare – nel mezzo della crisi: tagli sociali di tutti i tipi insettori di base della vita sociale (educazione, sanità, pensioni, salari pubblici,cultura e politiche giovanili) e tassi esorbitanti di disoccupazione (circa il 50%dei giovani e il 25% della popolazione attiva nel 2012), ancora più intensi per lapopolazione di origine migrante a causa del collasso del settore della costruzio-ne, segnano lo spazio – materiale e simbolico – entro cui le bande come attorisociali si riproducono.
Il presente articolo utilizza i materiali che provengono dai nostri archivi diricerca per riflettere sulle soluzioni antropoemiche – in linea con la metaforadi Bauman (1999) – al fenomeno delle bande5: la visibilizzazione di uno stigmae una deliberazione collettiva di molteplici agenzie che concordano nel defini-re certi gruppi come pericolosi per la società. Oltre ai processi di esclusionee inferiorizzazione che vivono questi gruppi negli spazi pubblici, osserveremoanche le pratiche situate di resistenza di cui sono protagonisti. Infine, la rifles-sione sul trattamento dell’oggetto-banda si fonda sui racconti e l’osservazionedelle pratiche di alcuni attori rilevanti della mano sinistra dello Stato (Bourdieu,2012) che intervengono sulla relazione tra spazio pubblico e bande, ma anchedei membri e leader di tali gruppi incontrati nel corso della ricerca etnografica;l’uso dello spazio e del tessuto urbano è infatti un elemento chiave, come giànelle analisi di Thrasher, per comprendere il conflitto e lo stigma di cui sonoprotagonisti e vittime queste categorie di giovani.
x4 Normalizzazione é la parola utilizzata da molti nostri informatori per indicare una
politica di integrazione e conversione rivolta ai membri delle bande.5 Bauman (1999) individua due strategie che le società di accoglienza mettono in atto
per la gestione dell’immigrazione; le prime, antropofagiche, implicano l’incorporazione dellostraniero affinchè smetta di essere tale; le seconde, antropoemiche, consistono nel rifiuto dellostraniero, cancellandolo simbolicamente dallo spazio sociale.
LE BANDE E LA CITTÀ
– 429 –
2.2. Una lotta continua. Evacuare e riempire gli spazi urbani
Le bande sono attori protagonisti di un rapporto creativo con la città e proprioper questo catalizzatori di dibattiti, denunce e polemiche sull’uso del territorio.Secondo Canelles (Feixa, Canelles, 2006) la descrizione della presenza di taligruppi nello spazio pubblico in termini di paura, fastidio, disordine e occupa-zione nasconde in realtà processi di discriminazione. In effetti, l’inferiorizza-zione della negritudine (Giliberti, 2013; Wallerstein, 1991) e il razzismo sonoesperienze che segnano e caratterizzano le vite di questi giovani nella società diarrivo. Come sostiene Antonio, ad esempio:
È chiaro che qua sei il negro e ti senti discriminato… Quando sei bambino, peresempio, vari amichetti non vogliono che tu vada a casa loro… E alla loro festadi compleanno invitano tutti eccetto te… perché sei negro e addirittura alcunite lo dicono in faccia… questo succede… è molto complicata la cosa… uno vivefrustrato qua (dominicano, 21 anni, disoccupato, da 11 anni a L’Hospitalet).
La strada è un luogo di vita ed esperienza importante per i giovani di ori-gine migrante, che in alcuni casi hanno appreso tale habitus nella società diprovenienza. Ma l’uso dello spazio pubblico dipende, anche e soprattutto, dallacondizione di classe dei giovani, in quanto consente lo sviluppo di attività ludi-che gratuite. In questo senso, non è casuale che la presenza autoctona, mino-ritaria negli spazi pubblici, corrisponda maggiormente alla classe lavoratrice,figlia dell’immigrazione del centro e del sud della Spagna durante il XX secolo(Porzio et al., 2010). Spesso, su tali pratiche giovanili si riversa un fastidio so-ciale che innesca dispositivi di controllo istituzionale; osserviamo ad esempio ilframmento di un dibattito tra due funzionari del Dipartimento della Giustizia edel Dipartimento dell’Interno in Catalogna:
Funzionario (Giustizia): Le bande rappresentano un fastidio visuale, i vicini silamentano. Però dal Comune mi dicono che se i ragazzi rimangono là senzafare nulla di male, non si può far nulla.Funzionario (Polizia): A noi, come polizia, viene bene che stiano per strada. Lipossiamo controllare più facilmente. (marzo 2012, Dipartimento dell’Interno,Generalitat de Catalunya)
La presenza di bande è resa invisibile in certi settori della città per nonpregiudicare il mercato della casa. Interi quartieri, edifici pubblici e privatisoffrono la presenza di questi gruppi giovanili; l’immagine, di un territorio o diuna struttura pubblica (una scuola o un centro giovanile), può perdere valorenelle aspettative e nelle quotazioni degli autoctoni quando è percepito come unluogo di sviluppo di tali culture giovanili: le bande indossano uno stigma chegenera una caduta del plus-valore simbolico, e quindi anche materiale, dellospazio urbano. Così continua il funzionario del Dipartimento di Giustizia
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 430 –
Se vogliamo un rinnovamento urbano non possiamo essere invasi dalle bande.È un tema politico e allo stesso tempo un tema economico. A L’Hospitalet ildiscorso ufficiale consiste nel negare. C’è una lotta tra diverse bande nellapolizia su cosa fare e come agire. Se reprimi troppo deprimi i valori degliimmobili, ma se reprimi poco generi insicurezza e fai sì che altri comunquelucrino sul panico. A Castelldefels abbiamo Maras e Latin, però là, che sonozone più borghesi, non si può dire nulla, non deve apparire nulla.
Più in generale, lo spazio pubblico – ossia ciò che non è totalmente subor-dinato alla mercificazione – ha accolto una nuova generazione di utenti conl’arrivo dei figli dell’immigrazione. Come mette in evidenza Canelles (2007), piùche «rubare la piazza», questi giovani cominciano a utilizzare uno spazio chetrovano quasi vuoto.
I ragazzi scherzano fra loro seduti sulla panchina, mettono la musica con icellulari, cantano… poi si alzano e giocano un po’ a pallone, poi qualcuno fuma,altri fanno dei giri intorno alla piazza, ritornano poi sulla panchina…insomma,passano il tempo insieme socializzando e divertendosi fra amici. Insistonoripetutamente sul fatto che quando sono arrivati qua anni fa non c’era quasinessuno nella piazza o nelle strade, hanno la percezione di aver popolato e datovita alla piazza e alle strade del quartiere. Non si è trattato di un progetto chehanno pensato e realizzato, ma in modo spontaneo i ragazzi si sono conosciutie hanno cominciato a darsi gli appuntamenti per strada e hanno pian pianoscelto i luoghi di riunione dei loro cori, gruppi di amici di quartiere. In effetti,i ragazzi non parlano di bande, bensì di cori. Come ci spiega Leandro (18anni, da 9 anni a L’Hospitalet), per coro loro intendono «un gruppo di personeche stanno insieme, parlano tra loro, si capiscono, fanno insieme le feste enon cercano problemi. Un coro ha anche un nome, con il quale noi membri ciriconosciamo…» (Diario di campo, settembre 2011)
Eppure questi usi generano allarme. A tal proposito, l’intervento dei fun-zionari del Servizio di Gestione dei Conflitti – un’unità del Comune di Barcel-lona che ha come obiettivo specifico regolare gli usi dello spazio urbano – èattivato spesso dalle chiamate di vicini e anziani autoctoni (a testimonianza diuna dimensione generazionale del conflitto) che denunciano la permanenza el’indebita appropriazione da parte di giovani di origine migrante.
Inoltre il rapporto con lo spazio urbano è progressivamente normato, invirtù di una filosofia pratica e di codici amministrativi diffusi che prendono ilnome di civismo e ambiscono a regolare gli usi penalizzando certe condotte.
A Barcellona dal 2005, e non diversamente da altre città spagnole ed eu-ropee, «L’ordinanza di misure per favorire e garantire la convivenza cittadinanello spazio pubblico», in virtù della retorica del civismo, introduce sanzionicontro i mendicanti (per occupazione dello spazio pubblico senza autorizza-zione), contro le lavoratrici del sesso ed altre categorie di poveri per le lorocondotte inappropriate; si tratta in breve della costruzione di un contesto diintimidazione permanente e della messa in atto di una repressione preventiva.
LE BANDE E LA CITTÀ
– 431 –
Delgado (2007, pp. 224-5) riconduce questi dispositivi istituzionali alla ricercada parte delle classi dominanti di un nuovo igienismo sociale, espressione deldesiderio di una città trasformata in un parco tematico, impregnata di buonaeducazione e da cui si evacua ogni segno macchiato dalla diseguaglianza so-ciale:
Il civismo concepisce la vita sociale come un grande proscenio del e per il con-senso, nel quale cittadini liberi ed eguali si accordano per vivere in armonia,soddisfacendo un insieme di precetti astratti di buona condotta. Lo scenarioprediletto di questo limbo è uno spazio pubblico idealizzato in cui una classemedia universale si dedica all’esercizio di buone pratiche civiche. In questospazio-modello il conflitto non è previsto, dato che la strada e la piazza riflet-tono la realizzazione di un’utopia di superamento sociale delle differenze diclasse e delle contraddizioni sociali attraverso l’agire di un «saper comportar-si appropriatamente» che rende uguali i soggetti. Per l’urbanistica ufficiale,spazio pubblico vuole dire altro: un vuoto fra edifici e costruzioni che occorreriempire in forma adeguata agli obiettivi dei promotori immobiliari e delleautorità, obiettivi che di solito sono convergenti.
A Barcellona la politica di convertire le bande in associazioni formali ècontemporanea alle ordinanze sul civismo, quasi un riflesso non dichiarato eun’applicazione di quel tipo di ideologia: l’obiettivo è allora civilizzare le con-dotte di soggetti pensati come barbari e primitivi urbani, incorniciandole den-tro una panoplia di statuti, norme e protocolli. Il diritto con i suoi dispositiviamministrativi diviene una macchina di esclusione, votata a contrastare il libe-ro accesso alla città. Come sottolineano Cerbino e Rodriguez (2012, p. 177),riflettendo sul rapporto fra bande e parchi urbani a Madrid, «una delle cose chepiù sorprende i giovani migranti appena arrivati è che lo spazio pubblico non èdella comunità: gli usi legittimi non sono il frutto di una negoziazione, ma sonoricondotti ad un astratto diritto di tutti che prescinde dalla negoziazione fra gliutenti». Accedere ad un campetto da calcio dipende dalla capacità di rappor-tarsi con una burocrazia, adeguarsi ad un protocollo, produrre una domanda,inserirsi in una lista. Manuel Delgado, in un’opera seminale su Barcellona comecittà paradigmatica (2007), evidenzia in tale prospettiva come l’urbanistica, idispositivi di regolazione e pianificazione della città, si trasformino in un mostronemico del modo di vita urbano, delle capacità degli abitanti di produrre società,incontri, legami, conflitti ed equilibri.
I mezzi di comunicazione hanno peraltro agganciato la rappresentazionesulle bande al tropos della paura per l’occupazione del territorio dei nativi; leistituzioni locali fabbricano delle soluzioni a tali paure. I giovani che iscrivonola loro socialità in questi gruppi sono accusati di utilizzare lo spazio pubblicoin modo improprio, eccessivo nella sua intensità, e di conseguenza escludentenei confronti di altre tipologie di utenti. In breve, il reato di cui sono accusati– l’uso privatistico del territorio - consiste nella monopolizzazione dello spazioe nella sua conseguente privatizzazione: un’accusa quanto mai singolare pro-prio perché rivolta da soggetti che hanno fatto della privatizzazione dello spa-
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 432 –
zio pubblico e del culto del valore-merce del territorio il dogma della torsioneneo-liberista nella gestione della città.
Osserviamo la definizione di tale crimine ad opera dei funzionari del Ser-vizio di Gestione dei Conflitti, uno dei cui target è appunto costituito dai giovaniorganizzati in banda e la cui nascita come unità amministrativa è inscritta nellastessa ordinanza sul civismo:
Cosa significa uso intensivo e massivo del territorio? Semplice, stare in unapiazza… quando tu vai in una piazza alle 10 del mattino e alle 2 di notte c’èancora qualcuno del tuo gruppo. I parchi che questi ragazzi utilizzano, glispiazzi che gli ecuadoriani inventano per improvvisare partite di volley, o lapanchina che il senza fissa dimora adopera per dormire e accamparsi….benequeste sono pratiche di uso intensivo e massivo. Massivo, quando c’è moltagente, intensivo quando la fruizione dura molto tempo. Ovvio, in uno spaziopubblico passare un’ora o mezz’ora ha un impatto diverso dal rimanere tuttala giornata. (Servizio di Gestione dei Conflitti, Comune di Barcellona, altofunzionario, settembre 2013)
Secondo questi attori dell’Amministrazione, interpreti più o meno consa-pevoli di interessi economici ben più forti, la città deve essere abitata da flussi inmovimento dai quali è possibile estrarre valore, non da permanenze incontrol-labili. È proprio questa permanenza senza tempo e senza possibile estrazionedi valore che contraddistingue le pratiche di uso della città da parte delle ban-de. Il tropos dell’occupazione del territorio nativo – uno dei discorsi costituentidelle bande come fenomeno sociale – viene inoltre correlato al conflitto che talipresenze innescano con altri gruppi simili e con altri tipi di utenti: in questachiave di lettura – fantasmatica, data l’evidenza che nessun gruppo giovanilesubalterno privo di risorse e bersaglio di un tale stigma può occupare alcunché– se il territorio è di un gruppo non può essere di un altro, e di conseguenza lalotta per il territorio diviene una minaccia realistica da cui proteggere la socie-tà. Nonostante le retoriche più o meno interessate, il fatto che questi soggetticollettivi si radichino in uno spazio non preclude la possibilità di condividernel’uso (Porzio et al., 2008, 2010), così come, ovviamente, non preclude la possi-bilità contingente del conflitto. Osserviamo ad esempio il seguente frammentodel nostro diario di campo:
Mi fermo come spettatore alla partita di baseball che un coro di ragazzi domi-nicani gioca nella parte bassa del parco, animata dalla musica che provieneda un paio di cellulari ad alto volume. In un determinato momento osservocon attenzione che tre ragazzi di un altro coro – popolarmente definiti in con-flitto con i ragazzi che giocano – si fermano a guardare e vengono invitati agiocare insieme a loro, perché nelle squadre mancano tre giocatori. Non selo fanno ripetere due volte ed entrano nel gioco. Questa scena mi sembra laconferma del fatto che l’uso dello spazio può essere condiviso in maniera fluidadai ragazzi di diversi cori e che oltre al conflitto si generano altre interazioni
LE BANDE E LA CITTÀ
– 433 –
tra gruppi, per esempio attraverso la musica e lo sport (Estratto del diario dicampo, giugno 2012).
Questo tipo di esperienza del parco è antitetica al racconto dei principalimezzi di comunicazione e alla rappresentazione veicolata dai funzionari dellasicurezza oggi egemonici; nella primavera del 2012, così si esprime uno deimassimi dirigenti dell’unità di polizia specializzata in Catalogna, protagoni-sta di spettacolari operazioni e di centinaia di arresti fra Latin Kings, Trinita-rios e Black Panthers con l’obiettivo di eliminare le bande, colpendone la lea-dership:
Io sono un padre di famiglia e da quando sono arrivati questi giovani i miei figlinon sono più liberi di circolare nei parchi. Questa è la nostra società, si devonoadeguare loro a noi, non noi a loro. (Dipartimento dell’Interno, Generalitat deCatalunya, Alto funzionario di polizia, maggio 2012)
I cori e le bande, espressioni informali di socialità, utilizzano in modo in-tenso lo spazio pubblico anche perché non hanno facile accesso alle infrastrut-ture gestite dalle istituzioni locali (centri giovanili, centri sportivi, etc..), nono-stante nel passato vi siano stati tentativi politici e amministrativi, dagli esiti in-certi, di ridurre la socializzazione di strada, normalizzare i gruppi e civilizzarnegli usi dello spazio. Ascoltiamo ora la testimonianza di uno dei protagonisti ditale politica di normalizzazione:
Purtroppo alcuni colleghi e funzionari ritengono che questi gruppi siano nocivie hanno paura che se una banda inizia a frequentare un centro giovanile,poi ne verrà un’altra e poi un’altra ancora; si aprirebbe così un conflitto e ilcentro subirebbe uno stigma per il suo tipo di frequentazione, svuotandosi dialtri soggetti e utenti. Insomma non vogliono che il loro centro giovanile, agliocchi dei vicini, sia collegato al tema delle bande. (Funzionario, Direzione diPrevenzione, Comune di Barcellona, maggio 2012)
Nel periodo della nostra etnografia, l’etichetta e lo stigma associato a que-sto tipo di culture e pratiche giovanili delle classi subalterne di origine migranteimpediva o ostacolava l’accesso ai centri giovanili gestiti dalle istituzioni locali,rendendo visibile il conflitto fra funzionari della prevenzione (il cui intento eraspostare dall’aperto al chiuso la socialità delle bande) e direttori dei centri gio-vanili e di altre infrastrutture dedicate che cercavano di mantenere la reputa-zione pubblica della propria struttura. Fra questi ultimi, alcuni manifestavanouna disponibilità a permettere l’accesso di queste tipologie pericolose di utentisolo a condizione di un ampliamento delle risorse di personale ed economiche;la paura che verbalizzavano nelle interviste rimandava inoltre alla possibilitàche i gruppi utilizzassero gli spazi dei centri giovanili per realizzare rituali vio-lenti e lesivi della dignità: punizioni interne, violenze di genere, organizzazionee pianificazione di crimini.
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 434 –
Eppure dal 2006 con l’avvio della politica di normalizzazione, secondo ildiscorso degli amministratori di Barcellona nei confronti delle leadership diLatin Kings e Ñetas (i due gruppi che in quel momento accettano di convertirsiin associazione), dotarsi di uno statuto e di una personalità giuridica è la condi-zione per accedere alle risorse e agli spazi pubblici su un piano di eguaglianzacon tutte le altre tipologie di soggetti: il riconoscimento e i diritti di accesso ven-gono così legati al passaggio dall’informalità della socialità alla formalità giuri-dica. Oggi, a distanza di molti anni, rimangono in vigore molte pratiche e moltidispositivi di ostracismo che ostacolano la fruizione delle risorse istituzionalisu un piano di parità; peraltro, anche nell’epoca d’oro della normalizzazione,l’accessibilità delle bande convertite ai centri giovanili è stata punteggiata daconflitti, sorveglianza e controllo. Racconta ad esempio Melody, una leader delleLatin Queens:
A un certo punto ci siamo resi conto che la polizia aveva collocato delle pulcinel centro giovanile in cui ci riunivamo per poter registrare le nostre riunioni.Insomma sentivamo che da un lato ci davano fiducia, dall’altra ci controllava-no permanentemente. Certo, rispetto a prima, abbiamo imparato delle cose:come utilizzare uno spazio pubblico, che moduli riempire, a chi chiedere leinformazioni e con quali tempistiche. E come far sì che, così facendo, nonvenga subito la polizia e stare un po’ tranquilli e in pace. Però sempre ogniequilibrio è fragile e rimane uno stato di sfiducia nei nostri confronti… (LeaderLatin Queen, ottobre 2012)
Nonostante gli sforzi del civismo di imbrigliare le pratiche di uso dellacittà, è irrealistico immaginare che la socialità di questi gruppi possa venir in-teramente ricondotta sotto un ombrello istituzionalmente regolato. Lo spaziopubblico, in molti casi, è semplicemente una seconda casa dove stare insieme,dove realizzare attività ludiche e sportive improvvisate, dato che la prima casasconta una serie di vincoli e limitazioni legate essenzialmente alla condizionedi classe e alla precarietà dei nuclei familiari. Continuiamo ad ascoltare la te-stimonianza di Melody:
Un’altra volta ancora stavamo giocando a pallone, arriva la polizia e ci mettonotutti contro un muro e chiedono i documenti. Passiamo ore in questa posizione,in attesa. Eravamo a disagio, pieni di vergogna, tutti i vicini dalla finestra checi guardavano come fossimo delinquenti. Sembrava la scena di un film.. allafine della retata non hanno trovato nulla: un pallone, delle collane, dei libriche noi consideriamo sacri per la nostra organizzazione. Ci hanno portato viaquesti oggetti come prova di un qualche delitto. Ma perché diamo così fastidio?Forse perché siamo stati i primi ad organizzare i giovani migranti. Ci siamoprestati a chiedere permessi, a capire le normative di uso, per non creareproblemi ai vicini... ma anche così continuiamo ad avere problemi. (LeaderLatin Queen, ottobre 2012)
LE BANDE E LA CITTÀ
– 435 –
La città è lo scenario per la costruzione e la rappresentazione delle identi-tà collettive e individuali, ma anche un territorio dove questi giovani di classesubalterna vivono, agiscono, sviluppano pratiche culturali, sperimentano l’e-sclusione, inventano la resistenza; in parte provano a fabbricare i luoghi di unnoi collettivo, ricreando con nuovi e vecchi usi la dimensione pubblica di unospazio catturato sempre più da pratiche mercantili, generando ciò che MikeDavis (2012) a proposito di migranti latino-americani in California ha definitourbanismo magico.
Seguendo De Certeau (1999) tale urbanismo magico può essere immagina-to come una tattica di fronte alla macchina amministrativa dello Stato e agliinteressi immobiliari. Il concetto di tattica ci parla di un’arte dei deboli, soggettiil cui campo di visione è oscurato dall’effetto di poteri sovrastanti che coman-dano e progettano il territorio, ambendo a convertire il valore di uso in valoredi scambio. In tali conflitti urbani la tattica è la pratica di coloro che giocano suun terreno imposto e già costituito, che non possono pianificare azioni di lungoperiodo, né prevedere i movimenti altrui, che difendono il valore d’uso dellospazio; al contrario, la strategia, appannaggio di coloro che detengono posizionidi potere e dispongono di una piena visione del campo, ha bisogno di un terri-torio liscio da progettare, pianificare, organizzare in modo da arginare gli usinon mercantili ed estrarre plusvalore dal suolo. Sono le tattiche dell’urbanismomagico che vengono sorvegliate e sanzionate dagli apparati di controllo e daifunzionari del civismo.
Non è un caso che per i giovani della nostra etnografia il funzionario pub-blico più conosciuto sia il poliziotto, nella sua funzione di principale street-levelbureaucracy. Non è un caso che le gang e i giovani con cui abbiamo condotto laricerca a Madrid e Barcellona ci raccontino, in modo quasi ossessivo, dei con-trolli e delle retate di polizia; una pressione ed umiliazione costante che generae produce significati. Così si esprime Luis, un Latin King che ha partecipato alprogetto filmico di Buscando Respeto6: «Qui si riempiono la bocca con la parolademocrazia, ma non capisco perché in questo paese, per noi che siamo giovanie figli di migranti, è proibito, bandito, il diritto di riunione». Da questo tipo diriflessioni – che vincolano l’impossibilità di riunirsi a una condizione di cittadi-nanza subalterna – scaturisce la colonna sonora del film, prodotta dal laborato-rio di sceneggiatura a cui partecipano ragazzi e ragazze di differenti bande ecori. Nel testo, la dimensione dello stigma e della discriminazione intersecanopermanentemente il vissuto dello spazio, il rapporto con altre agenzie statuali,la ricerca del rispetto:
Cammino cercando rispetto, cercando rispetto / Trattami come ti tratto / Nonmi giudicare / Non mi ignorare, Per favore // Non sai quante volte ho piantonel mio letto / Non immagini la fame che ho sofferto / La ignoranza della gente// Quando ho avuto bisogno / Nessuno mi ha dato un bicchiere di acqua quando
x6 Buscando Respeto è un’opera di sociologia visuale, un film documentario (regia di José
González Morandi) che nasce dalle nostre pratiche etnografiche. In libera visione al seguenteindirizzo: http://www.youtube.com/watch?v=kSMHicXO7F0
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 436 –
avevo sete / Nessuno mi ha fatto i complimenti quando ho passato gli esami// Ora non dirmi quello che devo fare / Se ho ucciso, se sono un delinquente/ Questo è colpa del sistema, ficcatelo in testa // Se sono seduto, la polizia mimanda via / E inizia subito a sospettare / E se dico qualcosa, mi regalano unoschiaffo / e tu vorresti che io rispetti il sistema? // Per problemi della stradala mia vita è stata in pericolo / Ho visto cadere il nemico del mio amico / lapolizia è stata sulle mie tracce, ma io sono corso via e ho avuto fortuna / Eun paio di volte sono scappato alla morte // Ogni volta che posso, prego / eringrazio per quello che ho / però non mi basta, voglio di più / mi immaginopieno di soldi / per aiutare la gente, il mondo intero // Dimmi se tu sai cosasi sente quando ti guardano con schifo e cattiveria / Persone che sai bene chenon hanno un odore migliore del tuo / E che non valgono più di te // Rispettamie ti rispetterò / Se mi umili, non ti umilierò / Anzi ti dimostrerò che il rispetto/ si guadagna con rispetto
Le pratiche urbane di ozio e svago sono così oggetto di sorveglianza e san-zione da parte degli attori principali del civismo, nella sua qualità di urbanismorepressivo; una sorveglianza che si traduce spesso in una condizione di umi-liazione simbolica, di privazione del rispetto. Stare in un parco – ci raccontastupito Jonathan, un giovane Trinitario – può infatti essere considerato un reatopolitico:
Gli sbirri stanno sempre sotto le nostre case. Ci dicono che non possiamoinvitare amici perché loro sanno che facciamo le riunioni della banda e che sevedono troppa gente in casa ci deportano tutti. Se siamo per strada con il nostroberretto o con il cappuccio ci fermano e ci perquisiscono. Quando siamo fermiin tanti nei parchi ci accusano di fare manifestazioni non autorizzate, e ci dannomulte di 500 o 1000 euro. Ma io non sono mai andato a una manifestazione invita mia. (Jonathan, membro dei Trinitarios, Lleida, aprile 2013)
A distanza di quasi un secolo dalle riflessioni di Trasher sulle bande e gliinterstizi, l’uso contemporaneo dello spazio da parte di questi attori giovanili,e il conflitto che si determina, si genera non più sui vuoti urbani privi di sor-veglianza e regolazione che vengono momentaneamente occupati, quanto suun tessuto pieno che porta il segno di progettazioni, attrezzature, arredi, infra-strutture, tecnologie di loisir; un pieno che è il risultato sedimentato di conflittisociali che in un passato recente hanno affermato, con successo, il valore d’usodella città. Le bande, come altri attori a basso capitale culturale ed economico,insistono su questo spazio pubblico, lo usano, ne rendono problematica la con-versione mercantile, obbligano pianificatori e funzionari a produrre una pletoradi normative e regolamenti nel tentativo di arginare la carica di resistenza insitain tale urbanismo magico.
LE BANDE E LA CITTÀ
– 437 –
3. 3. Le voci della fuga
La ricerca etnografica ha permesso di visualizzare i molteplici processi di ostra-cismo nei confronti di queste esperienze di socialità trattate come illegittime:gli operatori della sicurezza e le forze dell’ordine invitano i membri delle bandea liberare lo spazio urbano, i vicini evocano il pericolo della loro presenza, imezzi di comunicazione enfatizzano la privatizzazione dello spazio pubblico, ifunzionari dell’amministrazione locale tentano di spostare la socialità di stradain luoghi chiusi e attrezzati provvisti dalle istituzioni; altri funzionari, infine,resistono ad accoglierli argomentando l’inadeguatezza e l’incivismo di questetipologie di utenti. Nascono inoltre nuove categorie per criminalizzarne le pra-tiche: l’uso intensivo e privatistico dello spazio pubblico.
Questo insieme di modi istituzionali e sociali di gestione del fenomenogenera tuttavia molteplici cortocircuiti. Ascoltiamo la testimonianza di alcunifunzionari di un servizio amministrativo istituito dal comune di Madrid al fine diregolare i conflitti urbani e predisporre interventi sulla popolazione giovanile:
Funzionario 1: da circa 4 o 5 anni tutte le persone che hanno tratti fenotipicimigranti (sic!), e sono anche giovani, vengono fermati sistematicamente, ancheall’uscita dai nostri uffici e dalle nostre strutture di sostegno sul territorio; lapolizia cerca gli irregolari, li porta al commissariato e procede con il fogliodi espulsione. Succede anche nei parchi, nelle zone di gioco e svago. È comeuna forma di mobbing...Funzionaria 2: Questa presenza di polizia cosi continua, con lo spettacolo dellesirene e delle uniformi, fa sì che i ragazzi si debbano muovere in continuazione,si debbano disperdere per sfuggire al controllo.Funzionario 3: In più, si genera anche un allarme sociale, un’associazionefra immigrazione e delinquenza, uno stigma sociale. I vicini dicono: «beh seli fermano, ci sarà un motivo…» (Dipartimento di Immigrazione e famiglia,Comune di Madrid, maggio 2012)
Di fronte all’ostracismo, ritirarsi costituisce una necessità, ma anche unaforma di agency attraverso cui le bande provano ad uscire da uno spazio divisibilità sorvegliato e regolato dai poteri urbani. Il ritiro dalla situazione è unacategoria sviluppata da Goffman (2003a) nell’ambito degli adattamenti secon-dari alle istituzioni totali: il detenuto rifiuta la socialità promossa dall’autoritàe, ostentando passività, si chiude in un mutismo verso le regole dell’istituzione.Pensare il ritiro in un contesto diverso da quello delle istituzioni totali significainterrogarsi da un lato sulla generazione e proliferazione di tempi e spazi pa-ralleli (Restrepo, 2007) come luoghi costituenti di questa scena giovanile subal-terna, dall’altro sul mimetismo, ovvero su quei gesti obliqui che gli stigmatizza-ti adottano per confondere gli sguardi esterni producendo segni contradditoridi auto-rappresentazione (Goffman, 2003b). In tale chiave di lettura, possiamoanche interpretare il racconto concorde dei nostri informatori nel mondo del-la polizia e in quello delle bande, sia a Madrid che a Barcellona, secondo cuil’estetica di gruppo (collage, colori, segnali, etc..) è sempre meno esposta nello
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 438 –
spazio pubblico. Il ritiro dalla situazione è l’inverso del dispositivo classico ditrasformazione dello stigma in emblema che, giocando appunto sul piano dellavisibilità urbana dei corpi e delle appartenenze, si presta inesorabilmente amaggiori sanzioni istituzionali.
Come ci hanno insegnato Scott (2006) e Sennett (2004), l’agency dei domi-nati si sviluppa come conseguenza non solo dello sfruttamento materiale, maanche dell’umiliazione simbolica. L’esperienza etnografica realizzata ha rivela-to come in un panorama sociale dove i tagli al welfare proliferano e la disugua-glianza cresce, ciò che diviene cruciale per i membri di questi gruppi subalterniè la ricerca del rispetto, come mezzo di riconoscimento simbolico, nei tempi enegli spazi non interamente colonizzati e sorvegliati dalle istituzioni: nel rap,nei network sociali, nei conflitti fisici, nella forza dimostrata pubblicamente, legang mettono in scena una pratica di cittadinanza culturale al margine. Esclusida tutto, dalla scuola che li disperde, dal mercato del lavoro che non li assorbe,dal diritto che nega loro documenti utili all’esistenza quotidiana, dal pensiero diStato e dai mezzi di comunicazione che li fabbricano simbolicamente come pro-blemi e nemici dell’ordine pubblico, i giovani che abbiamo incontrato vivono leloro organizzazioni ed esperienze collettive di strada come famiglie accoglienti,sperimentano e inventano luoghi dove sviluppare identità collettive, ambigue ecreative, capaci di resistere simbolicamente al peso di una condizione migranteimposta, ereditata e permanentemente enfatizzata dai molti imprenditori delpanico morale.
In molti casi, il ritiro come forma di agency incontra un rifugio: i membridi tali gruppi pensati come difficilmente integrabili da parte di scuole7 e altrestrutture istituzionali, vengono infatti accolti, senza troppe esitazioni, da par-rocchie e da altri luoghi religiosi (Castellani et al., 2014), in affanno di frontealla secolarizzazione crescente delle nuove generazioni e alla ricerca di nuoviclienti. Ciò che da un lato si espelle viene alla fine metabolizzato da altri luoghied altri attori: le chiese, il mercato informale del lavoro, le istituzioni carcerarie,la piccola economia delinquenziale.
La banda si configura così come un luogo di costruzione di un’identità col-lettiva, per quanto labile e provvisoria, uno spazio di integrazione – una familiacalle secondo la definizione di alcuni nostri informatori – e di protezione rispettoai processi di esclusione orchestrati dalla mano destra e dalla mano sinistradello Stato (Queirolo Palmas, 2015; Bourdieu, 2012), ovvero da parte di queglix
7 È frequente che le scuole pubbliche e paritarie (concertadas) dei quartieri popolarisi dotino di codici di dressing. In molti di questi è espressamente previsto il divieto di sfog-giare un’estetica da gang (pantaloni larghi, collane, cappucci, bandane, berretti con visie-re), di esporre colori e segni di un’appartenenza che viene associata ad un incitamento al-la violenza. Nel caso della Catalogna, esistono inoltre dal 2012 specifici «protocolli di in-famia», che invitano/obbligano i docenti a segnalare alle autorità giudiziarie e di polizia iragazzi sospetti di far parte delle gang. Un analogo lavoro di etichettamento degli studentie di deriva verso un trattamento istituzionale viene realizzato a Madrid dai servizi sociali;come ci segnala un informatore nel mondo dell’educazione di strada, «sembra quasi chele scuole abbiano trovato la soluzione perfetta per auto-assolversi, molti studenti di origi-ne migrante e che hanno problemi scolastici sono potenzialmente pensati come membri dibande».
LE BANDE E LA CITTÀ
– 439 –
attori che cercano, secondo le circostanze, di correggere, riabilitare, castigare,vigilare o deportare tali categorie di giovani subalterni e di origine migrante.
La banda è una forma di agency, di resistenza allo stigma sofferto: rendepossibile l’esistenza di un luogo per le vittime dell’ostracismo quando ogni altrospazio si è reso inaccessibile, fabbrica uno spazio di incontro, risignifica ilterritorio urbano attraverso originali processi di home making (Queirolo Palmas,2009).
E tuttavia in Spagna, la grande differenza fra la situazione attuale e gliesordi di queste forme di socialità giovanile nel 2002 è la crisi come orizzontedel presente storico. In uno scenario di opportunità diverse, le bande si ripro-ducono in termini radicalmente diversi: non più figli del ricongiungimento, masedimenti – giudicati inopportuni – dei processi di stabilizzazione delle presen-ze, della naturalizzazione e dell’accesso alla cittadinanza. Più in generale, oggila riproduzione di queste aggregazioni si incornicia in un contesto che vede ilcollasso delle opportunità sia nel campo dell’educazione che in quello del lavoro;fra il 2007 e il 2012, nella fascia di età 16-29 sono stati eliminati 2.329.800 postidi lavoro (INJUVE, 2013, p. 133), il 47% del volume di occupazione esistenteall’inizio della crisi. L’insuccesso e la dispersione scolastica precoce, che primasi ammortizzavano grazie a un rigoglioso mercato del lavoro nel settore dellecostruzioni, collocano ora i membri dei gruppi, così come altre categorie di gio-vani subalterni, in un limbo di assenza di prospettive, in cui la disoccupazionecolpisce ormai metà di una generazione.
In tale situazione sociale, l’economia informale rappresenta, per molti,una necessità e un’attrazione significativa. Indebolendosi le strutture di conte-nimento e le politiche di welfare, si genera un vuoto – un’area di non lavoroe di non studio – nel quale le gang crescono e si riproducono nell’ambito diuna società ormai post-migratoria (Martiniello, 2000). Sotto i colpi della crisi,il risultato finale degli interventi istituzionali sull’oggetto-banda è qualcosa disimile a ciò che Young (1999) ha definito come proprio di una società bulimica:un territorio dove le pretese e le retoriche di inclusione, adeguatezza moralee culturale sono accompagnate, e smentite, da processi radicali di esclusionestrutturale; dove l’ostracismo induce la deriva verso luoghi di contenimento,sfruttamento e inferiorizzazione, generando al tempo stesso pratiche di agencylegate alla fuga.
Le diverse politiche di normalizzazione e/o ostracismo sperimentate nelcorso degli ultimi dieci anni in Spagna non sono riuscite a mettere fine allapresenza inquieta e inquietante delle bande, che anzi sono divenute una com-ponente naturalizzata del paesaggio e della vita culturale del proletariato gio-vanile meticcio e metropolitano. Di fronte a diversi tentativi di gestione, questigruppi subalterni hanno affermato una permanente capacità di autonomia e diresistenza di fronte alle autorità. Le tattiche che abbiamo provato a cartografaresono strutturalmente cicliche: i giovani e i gruppi incontrati nel corso di questaetnografia rivendicano esplicitamente diritti, ottengono posizioni che poi perdo-no o abbandonano, praticano la fuga e il ritiro, ampliano spazi e tempi parallelifuori dalle convenzioni sociali dettate da scuola e lavoro, alternano politica edeconomia della strada, inventano traffici di ogni tipo per poter sopravvivere, oc-
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 440 –
cupano lo spazio pubblico in modo iper-visibile e successivamente scompaiono,per poi reclamare nuovamente diritti di accesso alle risorse di fronte ai potericostituiti. Se da un lato lo Stato produce apparati di cattura, dall’altro le bandesi muovono – seguendo Jensen e Rodgers (2009) nella loro re-interpretazione diGuattari e Deleuze – come macchine da guerra e flussi nomadi: destabilizzanole autorità e lo spazio liscio che queste pretendono organizzare, si oppongonoal dominio senza nessun piano, senza una coscienza politica esplicita, senzafornire alternative, restano ambigue, in movimento, turbano il desiderio del ci-vismo di un uso appropriato, cioè mercantile, del territorio e infine svanisconoquando le incursioni dello Stato divengono insopportabili, per poi riapparire inun altro luogo e sotto altre sembianze.
Riferimenti bibliografici
Aparicio, R., A. Tornos2009 Aproximación al estudio de las Bandas Latinas de Madrid, Madrid,
Ministerio del Trabajo y Inmigración.Balibar, E.1991 «Racismo y crisis», in E., I. Wallerstein, Raza, Nación y Clase, Madrid,Iepala.Barrios, L., D. Brotherton2004 The Almighty Latin King and Queen Nation. Street Politics and the
Transformation of a New York City Gang, New York, Columbia UP.Bauman Z.1999 La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino.Botello, S., A. Moya2006 Reyes Latinos: los códigos secretos de los Latin Kings en España, Ma-
drid, Temas de Hoy.Bourdieu, P.1998 Contre-feux 1, Paris, Raisons d’agir.2012 Sur l’Etat. Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Seuil.Bourgois, P.2010 En busca del respeto. Vendiendo crack en Harlem (1996), Buenos Aires,
Siglo XXI Editores.Brighenti, A.M.2008 «Visuale, visibile, etnografico», in Etnografia e ricerca qualitativa, 1,
1, pp. 91-113.Brotherton, D.2010 «Oltre la riproduzione sociale. Reintrodurre la resistenza nella teoria
sulle bande», in L. Queirolo Palmas (a cura di), Atlantico Latino: ganggiovanili e culture transnazionali, Roma, Carocci, pp. 29-45.
LE BANDE E LA CITTÀ
– 441 –
Canelles, N.2007 «Joves i espai públic. Ens han pres la plaça?», in AA.VV., Joventut i
polítiques de joventut, 25 aportacions, Barcelona, Diputació de Barce-lona.
2008 «Jóvenes latinos en Barcelona: la construcción social de las bandas», inM. Cerbino, L. Barrios (Eds.), Otras Naciones: Jóvenes, transnacionali-smo y exclusión, Quito, FLACSO-Ecuador.
Castellani, S., F. Lagomarsino, L. Queirolo Palmas2014 La banda y la iglesia. Transiciones y espacios de subjetivización de la
juventud latina en Barcelona y Genova (in stampa).Cerbino, M., A. Rodríguez2012 «Otras Migraciones: los Latin Kings en España en el relato de F.», in
Revista Andaluza de Antropología, 3, pp. 148-82.Conquergood, D.1994 «How street gangs problematize patriotism», in H.S. Herbert, M. Billig
(Eds.), After postmodernism. Reconstructing ideology critique, London,Sage.
Cuesta, A., M. Cuesta, E. Fernández, S. Méndez2009 Quinqui del 80. Cine prensa calle, Barcelona, CCCB.Davis, M.2012 Urbanismo Mágico, Madrid, Lengua de Trapo.De Certeau, M.1999 La invención de lo cotidiano, México, Universidad Iberoamericana.Delgado, M.2007 La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del modelo Barcelona, Barcelo-
na, Catarata.Feixa, C., N. Canelles2006 «De bandas latinas a organizaciones juveniles. La experiencia de Bar-
celona», in Jóvenes. Revista de estudios sobre juventud, 24, pp. 40-56.Feixa, C., N. Canelles, L. Porzio, C. Recio, L. Giliberti2008 «Latin Kings in Barcelona», in F. Van Gemert, D. Peterson, I.L. Lien
(Eds.), Street Gangs, Migration and Ethnicity, London, Willian.Feixa, C., L. Porzio, C. Recio2006 Jóvenes latinos en Barcelona. Espacio público y cultura urbana, Bar-
celona, Anthropos.Feixa, C., B. Scandroglio, J. López, F. Ferrándiz2011 «¿Organización cultural o asociación ilícita? Reyes y reinas latinos entre
Madrid y Barcelona», in Papers, 96, pp. 145-63.García, I.2003 «Los hijos de inmigrantes extranjeros como objeto de estudio de la
sociología», in Anduli: revista andaluza de ciencias sociales, 3, pp.27-46.
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 442 –
Giliberti, L.2011 «Negri di Barcellona. Giovani dominicani tra stigma e resistenza», in
Mondi Migranti, 3, pp. 155-80.2013 La condición inmigrante y la negritud en la experiencia escolar de la
juventud dominicana: estigmas y formas de agencia. Una etnografíatransnacional entre la periferia de Barcelona y Santo Domingo, Tesi diDottorato, Universidad de Lleida.
2014 «La construcción social de la negritud y las tácticas de gestión delestigma: jóvenes dominicanos en la periferia de Barcelona», in O. Ro-maní (Ed.), Jóvenes, desigualdades y salud: vulnerabilidad y políticaspúblicas, Tarragona, Publicacions URV.
Goffman, E.2003a Asylum (1961), Torino, Einaudi.2003b Stigma. L’identità negata (1963), Verona, Ombre Corte.Hallsworth, S.2011 «Anatomizing Gang Talk», in M. Cerbino (a cura di), Más alla de las
pandillas: violencias, juventudes y resistencias en el mundo globaliza-do, Quito, FLACSO.
2013 The Gang and Beyond: Interpreting Violent Street Worlds, London, Pal-grave Macmillan.
INJUVE2013 Informe de Juventud en España 2012, Madrid, INJUVE.Jensen, S., D. Rodgers2009 «Revolutionaries, Barbarians or War Machines? Gangs in Nicaragua
and South Africa», in Socialist Register, 45, pp. 220-38.Klein, M.W.1971 Street gangs and street workers, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.Lahosa, J.M.2008a «Pandillas juveniles en España: la aproximación de Barcelona Urvio»,
in Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, 4, pp. 47-58.2008b «Bandas latinas. Una aproximación de recuperación social en Barcelo-
na», in Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 81, pp. 173-89.Martín, M.J., J.M. Martínez, A. Rosa2009 «Las bandas juveniles violentas de Madrid: su socialización y
aculturación», in Revista Panamericana de Salud Pública, 26, 2, pp.128-36.
Martiniello, M.2000 Le società multietniche, Bologna, Il Mulino.Mauger, G.2006 Les bandes, le milieu et la bohème populaire, Paris, Belin.Mossos d’Esquadra2011 Dossier de prensa, 22/11/2011, Barcelona, Generalitat de Catalunya.
LE BANDE E LA CITTÀ
– 443 –
Porzio, L., L. Giliberti2009 «Giovani, gruppi e pratiche culturali. Relazioni e conflitti nello spazio
pubblico della periferia di Barcellona», in Mondi Migranti, 2, pp. 105-18.
Porzio, L., L. Giliberti, I. Mambrillas, N. Hakim, N. Canelles, M. Palou2008 Els joves a L’Hospitalet de Llobregat. Estils i cultures en escenaris
urbans, L’Hospitalet, Ayuntamiento de L’Hospitalet.Porzio, L., L. Giliberti, N., Hakim, A. Rodríguez, T. Muller2010 Escenaris urbans, adscripció identitària i estils: joves i espai públic.
La mirada des dels munici(a cura di)pis, Barcelona, Diputació deBar-celona.
Queirolo Palmas, L. (a cura di)2009 Dentro le gang. Giovani, migranti e nuovi spazi pubblici, Verona, Ombre
Corte.2010 Atlantico latino: gang giovanili e culture transnazionali, Roma, Carocci.Queirolo Palmas, L.2012 «The social construction of the youth-migration nexus in contemporary
Spain. A critical overview», in Italian Journal of Sociology of Education,3, pp. 3-33.
2015 Enemigos públicos. La fabricación de las bandas en la Españacontemporánea, Madrid, Traficantes de Sueños (in stampa).
Recio, C., M. Cerbino2006 «Jóvenes latinos y medios de comunicación», in C. Feixa, L. Porzio,
C. Recio (a cura di), Jóvenes latinos en Barcelona. Espacio público ycultura urbana, Barcelona, Anthropos.
Restrepo, C.M.2007 Con el diablo adentro: pandillas, tiempo paralelo y poder, México, Siglo
XXI.Romaní, O., L. Porzio, A. Rodríguez, N. Canelles, L. Giliberti, G. Maza2008 «De nacions, reialeses i marginacions. La organització dels Reyes y
Reinas latinos de Catalunya, un estudi de cas», in AA. VV., Secretaria pera la Immigració, Recerca i Immigració – Núm. 2, Barcelona, Generalitatde Catalunya.
Sayad, A.1996 «La doppia pena del migrante. Riflessioni sul pensiero di Stato», in Aut
Aut, 275, pp. 10-22.Scandroglio, B., J. López2010 «IAP con la agrupación Latin Kings en Madrid», in AIBR. Revista de
Antropología Iberoamericana, 5, 2, pp. 222-55.Scott, J.2006 Il dominio e l’arte della resistenza. I Verbali segreti dietro la storia
ufficiale, Milano, Elèuthera.Sennett, R.,2004 La dignità umana in un mondo di diseguali, Bologna, Il Mulino.
LUCA GILIBERTI E LUCA QUEIROLO PALMAS
– 444 –
Trasher, F.1927 The gang: a study of 1313 gangs in Chicago, Chicago, University of
Chicago Press.Wallerstein, I.1991 «Universalismo, racismo y sexismo: tensiones ideológicas del capitali-
smo», in E. Balibar, I. Wallerstein, Raza, Nación y Clase, Madrid, Iepala.White, F.W.1943 Street Corner Society. The Social Structure of an Italian Slum, Chicago,
University of Chicago Press.Young, J.1999 The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late
Modernity, London, Sage.