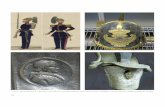Una cittadinanza locale frammentata. La residenza tra conflitti e stratificazione civica
Transcript of Una cittadinanza locale frammentata. La residenza tra conflitti e stratificazione civica
1
Una cittadinanza locale frammentata.
La residenza tra conflitti e stratificazione civica
di
Enrico Gargiulo
Paper for the Espanet Conference
“Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita:
precarietà, invecchiamento e migrazioni”
Università degli Studi di Torino, Torino, 18 - 20 Settembre 2014
Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali,
Università del Piemonte orientale: [email protected]
2
Una cittadinanza locale frammentata.
La residenza tra conflitti e stratificazione civica
Introduzione La residenza riveste un’importanza strategica nel contesto giuridico e politico italiano,
conferendo un riconoscimento formale e consentendo l’esercizio di importanti diritti a co-loro che vivono stabilmente e regolarmente all’interno di un dato territorio comunale. Per tutte queste persone, la condizione di residente costituisce una sorta di “cittadinanza loca-le”.
La rilevanza di tale status si è fatta evidente negli ultimi anni, quando alcuni sindaci hanno ripetutamente tentato di regolare in maniera autonoma – e illegittima – il ricono-scimento dell’iscrizione anagrafica1. Queste iniziative, che si configurano come forme di esclusione a livello locale, pur colpendo trasversalmente i cittadini e i non cittadini sono state spesso indirizzate ai secondi, dando luogo a veri e propri atti discriminatori.
L’esclusione dalla residenza – e più in generale dai diritti per la cui titolarità o per il cui esercizio l’iscrizione anagrafica è una condizione – produce effetti rilevanti, generando a livello locale disuguaglianze che vanno a interagire con altre disuguaglianze dovute alle norme di livello statale e provocando, di conseguenza, una evidente “frammentazione” degli status giuridici. Le differenze già in essere, infatti, vengono esasperate e, al contem-po, nuove differenze vengono create. Il divario tra cittadini e non cittadini, dunque, si va allargando, mentre tanto i primi quanto i secondi vengono suddivisi in categorie di serie A e categorie di serie B. Ne risulta così amplificato il fenomeno a cui Lydia Morris (2002) ha dato il nome di civic stratification2: la gerarchia tra i diversi status giuridici, ossia il si-stema di stratificazione, tende ad articolarsi sempre di più, in quanto le strategie di con-trollo della residenza intaccano le dotazioni di diritti che contraddistinguono alcune posi-zioni – spesso quelle collocate nei punti medio-bassi della scala sociale –, indebolendole.
Non sorprende, pertanto, che attorno alla residenza si sia articolato un vero e proprio conflitto, che vede contrapporsi due schieramenti. Coloro che appartengono al primo pro-vano a imporre una visione ristretta ed escludente della residenza, finalizzata a perimetrare a livello locale la comunità dei “buoni cittadini”, separandola da quella di coloro che, sep-pur regolarmente presenti nel territorio italiano, sono indesiderati. Coloro che appartengo-
1 Negli ultimi anni, la residenza ha acquistato rilevanza non soltanto grazie ai provvedimenti di numerosi sindaci, ma anche in quanto alcune leggi statali e diverse amministrazioni regionali, provinciali e comunali hanno introdotto – spesso in maniera illegittima – un certo numero di anni di permanenza nel proprio territo-rio come requisito d’accesso a determinati diritti. La residenza, dunque, è diventata uno strumento di discri-minazione ed esclusione indiretta dei non cittadini in diverse porzioni del territorio italiano (a riguardo, cfr. Biondi Dal Monte, 2008 e 2011; Gorlani, 2006). 2 Con questa espressione, Morris fa riferimento a un sistema di diseguaglianza basato sulla relazione tra dif-ferenti categorie di individui e lo stato, e sui diritti garantiti o negati in tal modo. Questo sistema costituisce un veicolo per l’esercizio del controllo sociale.
3
no al secondo tentano invece di promuovere una visione più aperta e inclusiva dello status di residente, premendo affinché la normativa statale sia correttamente applicata a livello locale. Entrambe le categorie di attori rivestono un ruolo strategico nell’implementazione effettiva di questo importante istituto giuridico: nonostante la residenza sia chiaramente normata e regolamentata nell’ordinamento italiano, infatti, il suo effettivo riconoscimento nei singoli contesti territoriali avviene con modalità variabili, essendo soggetto – di fatto anche se non di diritto – al potere discrezionale di alcuni attori, ed essendo legato, di con-seguenza, alle capacità negoziali e/o conflittuali di altri attori che provano a contrastare ta-le potere.
Delineato questo scenario, il paper3, basandosi su un materiale di ricerca eterogeneo4, intende ricostruire le strategie di regolazione locale della residenza e analizzare i meccani-smi di controllo ed esclusione attraverso cui queste strategie vengono attuate, evidenzian-do la dimensione conflittuale delle procedure di iscrizione anagrafica.
1. Un complesso sistema di status In ogni sistema giuridico è presente una pluralità di status che esprimono forme diffe-
renti di appartenenza alla comunità statale. Questa pluralità, per semplicità, può essere ri-condotta alla dicotomia che contrappone i cittadini ai non cittadini. A differenza dei primi, infatti, i secondi sono tenuti a sottostare ad alcune condizioni qualora si trovino a fare in-gresso e a soggiornare in un paese diverso da quello a cui appartengono formalmente – o in un qualunque paese, se apolidi.
I non cittadini, tuttavia, non sono tutti uguali: alcuni soddisfano queste condizioni men-tre altri non sono in grado di farlo. Per questo, l’insieme che li comprende si articola in una nuova dicotomia, che contrappone gli “autorizzati” ai “non autorizzati”. Le condizioni richieste per concedere l’autorizzazione, al tempo stesso, sono ampiamente diversificate, variando sulla base della provenienza e delle motivazioni. Ci troviamo di fronte, pertanto, a un’ulteriore dicotomia, che suddivide i non cittadini in due insiemi: da un lato si trovano i cittadini comunitari – ossia i membri di stati appartenenti all’Unione europea – e dall’altro gli stranieri extracomunitari – vale a dire i membri di stati esterni all’Unione eu-ropea – e gli apolidi: i primi possono entrare liberamente in un paese comunitario ma de-
3 Questo paper sintetizza e aggiorna i risultati di un percorso di ricerca, ancora non concluso, che ha per og-getto la residenza come strumento di esclusione a livello locale. Tale percorso si inserisce in un programma di ricerca più ampio incentrato sulla cittadinanza e sulle sue trasformazioni incrociandosi anche, parzialmen-te, con un’ulteriore linea di indagine focalizzata sulle politiche di integrazione degli immigrati. Le ricerche qui menzionate verranno volta a volta richiamate, facendo riferimento ad alcune delle pubblicazioni che ne sono scaturite. 4 Nello specifico, per la conduzione di questa ricerca si è fatto ricorso a diverse strategie di indagine: l’analisi, documentale e del discorso, riferita a documenti di carattere normativo (leggi, decreti, norme di li-vello europeo) e para-normativo (provvedimenti, misure e atti amministrativi) nonché a quotidiani e ad altri tipi di testo (documenti programmatici, delibere regionali, ecc.); interviste con testimoni privilegiati e collo-qui con operatori; dati raccolti a livello comunale.
4
vono soddisfare particolari requisiti se vogliono protrarre il proprio soggiorno oltre un cer-to limite5, mentre i secondi sono tenuti a disporre di specifici documenti per fare ingresso, e successivamente per risiedere, in un paese diverso da quello di origine.
I cittadini comunitari, dunque, sono sottoposti a vincoli meno rigidi rispetto agli stra-nieri extracomunitari: in quanto cittadini europei6, godono di una libertà di movimento maggiore e possono soggiornare per alcuni mesi senza autorizzazione alcuna, disponendo anche della possibilità di cercare un lavoro in maniera legale dopo aver fatto ingresso in Italia. Anche gli appartenenti a stati membri dell’Unione europea, tuttavia, a determinate condizioni possono essere allontanati dal territorio italiano7. Qualora non soddisfino i re-quisiti previsti dalla normativa o rappresentino, a detta delle autorità, una minaccia per la collettività, questi cittadini, pur non essendo definibili come “irregolari” nella stessa acce-zione giuridica riservata agli stranieri extracomunitari privi di documenti di soggiorno, si trovano parimenti in una situazione di “irregolarità”8.
L’articolazione tra status, comunque, non si ferma alla dicotomia tra comunitari e non comunitari. Tanto con riferimento ai primi quanto con riferimento ai secondi, infatti, è presente un’importante distinzione tra coloro che sono autorizzati a soggiornare a tempo indeterminato e coloro il cui soggiorno è invece sottoposto a verifiche periodiche. Nel ca-so dei cittadini comunitari, la possibilità di acquisire il diritto di soggiorno permanente è conferita a coloro che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio italiano. Nel caso degli stranieri extracomunitari e degli apolidi, invece, il di-ritto al soggiorno a tempo indeterminato è riservato – salvo alcune eccezioni – a coloro che dispongano di un permesso di soggiorno da almeno cinque anni, possano dimostrare di avere un reddito superiore a una certa soglia, non siano “pericolosi per l’ordine pubbli-co o la sicurezza dello stato”, superino un test di lingua italiana e dimostrino la disponibi-lità di un alloggio idoneo, nel caso la domanda sia presentata anche per i familiari. Nono-stante la durata del periodo richiesto sia la stessa per i comunitari e per i non comunitari, comunque, i secondi, incontrando ostacoli maggiori per ottenere l’autorizzazione a risiede-
5 Qualora siano intenzionati a soggiornare sul territorio italiano per più di tre mesi, i cittadini comunitari so-no tenuti a dimostrare il possesso di alcuni requisiti, stabiliti dal d.lgs. n. 30 del 2007 – che va ad attuare la Direttiva europea n. 38 del 2004 – e poi modificati e integrati da alcuni decreti e da alcune circolari succes-sive. 6 Per quanto riguarda la nozione di cittadinanza europea e le sue implicazioni in termini di libertà di movi-mento e di soggiorno cfr. Spinaci, 2011 e Strumia, 2013. 7 Queste condizioni, previste dagli articoli 20, 21 e 22 del già citato decreto 30 del 2007 (come modificato dal d.lgs. n. 32/2008 e dal d.l. n. 89/2011) sono essenzialmente di due tipi: il cittadino dell’Unione non pos-siede, o non possiede più, le condizioni per avere diritto al soggiorno; il cittadino dell’Unione o un suo fami-liare rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la sanità (Perin e Bonetti, 2012). 8 I membri degli stati dell’Unione europea, pertanto, sebbene siano ormai designati a livello istituzionale con il termine “cittadini” e nonostante siano formalmente inclusi all’interno della cittadinanza europea, non go-dono appieno del diritto alla libertà di movimento di cui godono invece i cittadini in senso stretto. La sussi-stenza di una limitazione di questo genere, peraltro, è testimoniata dal fatto che essi, legittimamente, posso-no essere detenuti nei Centri di identificazione ed espulsione, luoghi normalmente considerati come “riser-vati” agli stranieri extracomunitari (Granaglia e Rigo, 2013, pp. 343-345). Considerazioni critiche sulla li-bertà di circolazione dei comunitari si trovano anche in Algostino, 2008.
5
re in maniera legale, e di conseguenza per cumulare i cinque anni richiesti, si trovano in una posizione inferiore e più instabile rispetto ai primi.
Gli altri non cittadini legalmente presenti – coloro cioè che si trovano regolarmente in Italia da meno di cinque anni oppure che vi soggiornano da più tempo ma in maniera non sempre regolare – sono tenuti, come già visto, a sottostare a insiemi differenziati di condi-zioni, dando vita quindi a categorie diverse tra loro e rispetto a quella costituita dagli auto-rizzati “di lungo periodo”. I cittadini comunitari, ad esempio, devono presentare requisiti per il soggiorno diversi a seconda della categoria a cui appartengono9, dividendosi così in diversi status. Parimenti, gli stranieri soggiornanti a tempo determinato possono trovarsi in una pluralità di condizioni: i titolari di protezione sussidiaria e i titolari di permessi di sog-giorno annuali rinnovabili per ragioni di lavoro, per motivi familiari o per studio, ad esempio, hanno un legame più solido con lo stato italiano rispetto a coloro che dispongono di permessi per motivi umanitari o per lavoro stagionale.
Il sistema di distinzioni tra i diversi status, dunque, è piuttosto complesso: le posizioni presenti al suo interno non sono semplicemente differenziate ma sono, in molti casi, anche stratificate. In altre parole, i vari status – o meglio, i vari gruppi di status – sebbene si tro-vino a volte “allineati” orizzontalmente, sono spesso incardinati in una gerarchia ordinata verticalmente, a cui corrisponde una stratificazione dei diritti: gli irregolari godono di me-no diritti dei regolari; tra questi ultimi, i titolari di un permesso di soggiorno a tempo inde-terminato si trovano in una posizione di vantaggio rispetto a coloro che sono dotati di permessi a tempo limitato, e così via.
2. Le trasformazioni della cittadinanza e il ruolo della residenza Negli ultimi decenni, la costruzione di un sistema di stratificazione sempre più com-
plesso e articolato quale quello qui descritto è stata accompagnata da un processo parallelo di progressivo scollamento tra lo status di cittadino e i diritti a esso associati: in virtù di questo processo, numerosi benefici e servizi normalmente considerati prerogativa dei membri a pieno titolo della comunità statale tendono sempre più a essere riconosciuti an-che ai non cittadini, soprattutto – ma non esclusivamente – se regolari (Zincone, 2000a, p. 45). L’ordinamento italiano testimonia in maniera emblematica lo scollamento qui descrit-to: numerosi diritti fondamentali – alle cure mediche e all’istruzione per i bambini in età scolare, ad esempio – sono stati estesi progressivamente agli immigrati irregolari; i diritti riconosciuti agli stranieri regolari – come il diritto all’unità familiare e la tutela contro le discriminazioni – sono stati rafforzati, anche su impulso della normativa europea; il diritto di circolazione e soggiorno è stato consolidato nei confronti di coloro che dispongono di un permesso permanente10 (Caponio, 2013).
9 Quattro, secondo il già citato decreto 30/2007: lavoratori, non lavoratori, studenti e familiari. 10 Nello specifico, la direttiva n. 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, la direttiva n. 2003/43/CE sulla parità di trattamento e la direttiva n. 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo. Più di recente, un’altra
6
La cittadinanza, dunque, ha subito un rilevante processo di trasformazione, dovuto principalmente all’intensificarsi dei movimenti migratori nel territorio europeo11. L’esito di queste trasformazioni sembra essere il livellamento delle differenze tra cittadini e non cittadini: i secondi, seppur privi dello status dei primi, godono adesso dei loro stessi diritti. Ha acquistato così importanza la figura del denizen, lo straniero lungo-residente che, in virtù della sua prolungata presenza nel territorio statale, sarebbe equiparato al cittadino, se non nella posizione formale, quantomeno nella titolarità di un insieme di diritti fondamen-tali12.
La figura del denizen è al centro di numerose analisi che, soprattutto a partire dagli anni Novanta del XX secolo, hanno provato a descrivere – e al contempo a promuovere – mo-delli di appartenenza alternativi alla cittadinanza nazionale, denominati e designati come “postnazionali”, “transnazionali” o “oltre lo stato”. Nello specifico, queste proposte – tra cui figurano quelle avanzate da Bauböck (1994), Hoffman (2004), Jacobson (1996), Soysal (1994) – concordano sul fatto che i nuovi modelli di cittadinanza sarebbero inclu-sivi ed espansivi, sia con riferimento ai soggetti che possono accedervi sia rispetto alla gamma dei diritti che vengono loro riconosciuti (Rigo, 2007, p. 52). Secondo gli studiosi che propongono questi modelli, in altre parole, il livellamento delle differenze tra cittadini e non cittadini in termini di titolarità di diritti – ormai “de-territorializzati” e svincolati dall’origine nazionale – avrebbe reso il sistema di stratificazione meno ingiusto e meno escludente, aprendo la strada a forme di appartenenza «più universali» (Soysal, 1994, p. 3).
La fiducia negli effetti benefici delle trasformazioni della cittadinanza, tuttavia, non sembra essere del tutto ben riposta. Le visioni postnazionali o transnazionali, infatti, sem-brano confondere la virtuosità dei modelli “ideali” con la loro realizzazione effettiva, at-tuando uno slittamento implicito del discorso dal piano fattuale a quello normativo (Rigo, 2007, p. 53). Più che dare corpo a un afflato universalistico, tali visioni parrebbero accen-tuare e consolidare la condizione di disuguaglianza dei migranti assumendo «acriticamen-te la differenziazione degli statuti giuridici dei non cittadini» e «basando proprio su tale differenziazione la desiderabilità di un’attribuzione graduale di diritti» (Granaglia e Rigo, 2013, p. 340).
direttiva, la n. 2011/98/CE, che, prevedendo una procedura unica di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno e un corpo di diritti (sociali, economici, etc.) per coloro che sono stati ammessi a soggiornare per motivi di lavoro (o per motivi diversi ma con autorizzazione a lavorare), prova a uniformare le dotazioni di diritti di tutti i lavoratori stranieri nel territorio europeo. 11 La letteratura sulle trasformazioni della cittadinanza e sul legame tra queste e i processi migratori è ormai molto ampia. Rimanendo nel contesto italiano, e senza alcuna pretesa di completezza, si rimanda ad alcuni articoli – Procacci 2009; Zanfrini 2010, Zincone, 2000a e 2000b – e, per un’analisi particolarmente attenta al ruolo dei confini e incentrata sulle riconfigurazioni dello spazio europeo, al volume di Enrica Rigo (2007). 12 Come fanno notare Granaglia e Rigo (pp. 342-343), molti diritti – come ad esempio l’habeas corpus – so-no da lungo tempo riconosciuti anche ai non cittadini. A riguardo, Luigi Ferrajoli ha più volte sottolineato (ad esempio in 1994) che molti diritti erroneamente classificati da Marshall – e da molti studiosi che lo han-no ripreso – come diritti di cittadinanza sono in realtà diritti riconosciuti, nella stragrande maggioranza degli ordinamenti e da numerose convenzioni e carte internazionali, come diritti della persona, e non del cittadino.
7
I promotori dei nuovi modelli di cittadinanza, più in dettaglio, sembrano non considera-re che i diritti di cui i non cittadini godono alla pari dei cittadini sono “condizionati” da diversi elementi, e in primo luogo dalla permanenza dei requisiti legali per l’ammissione e il soggiorno sul territorio; inoltre, sembrano non
preoccuparsi di come si acceda a queste forme alternative di cittadinanza. Quasi che esse pos-sano essere considerate separatamente dal tema della libertà di circolazione, e che la cittadinan-za, “postnazionale” o “transnazionale”, possa essere fotografata in un fermo immagine che ri-trae i migranti in un momento successivo a quello in cui hanno fatto accesso alla sfera di diritti di cui viene riconosciuta loro la titolarità, nonché immediatamente precedente al momento in cui ne vengono, eventualmente, espulsi (Rigo, 2007, pp. 54-55).
Nel dibattito sulle nuove cittadinanze e sulle loro virtù inclusive, inoltre, è spesso as-
sente un’altra questione: quella del ruolo giocato dai livelli di governo locale nel favorire – o viceversa nell’impedire – l’esercizio dei diritti formalmente riconosciuti ai non cittadi-ni dalle norme statali. Eppure, questi diritti, di fatto, sono condizionati anche dagli attori politici e amministrativi che operano a livello comunale, attraverso un’interpretazione quasi sempre arbitraria e illegittima – come si vedrà meglio nei prossimi paragrafi – dell’istituto giuridico della residenza.
L’assenza di attenzione nei confronti dei livelli locali – almeno per ciò che concerne il contesto italiano – può forse essere ricondotta alla polisemia del termine “residenza”. Con questo termine, infatti, negli studi sulle politiche migratorie e sul welfare si fa riferimento a due nozioni non coincidenti: la presenza di un non cittadino in un dato territorio; il rico-noscimento formale da parte di un comune. L’espressione “straniero legalmente residen-te”, ad esempio, è usata generalmente per indicare il non cittadino che gode di un regolare permesso di soggiorno e non lo straniero iscritto all’anagrafe. Allo stesso modo, quando si parla di “stranieri lungo-residenti” si intende denotare i non cittadini che dispongono di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato a prescindere dal fatto che essi siano o me-no iscritti nei registri comunali.
Le due nozioni, dunque, vengono di frequente confuse. O meglio, una delle due – la presenza legale – finisce per oscurare l’altra – il riconoscimento formale a livello comuna-le. Di conseguenza, viene a mancare la consapevolezza che la condizione di residente nel senso di regolarmente presente può non essere accompagnata di fatto – nonostante debba molto spesso esserlo di diritto – dalla condizione di residente nel senso di iscritto in ana-grafe. Questa mancata consapevolezza produce effetti rilevanti, nascondendo un vulnus fondamentale delle nuove cittadinanze: quando la residenza come riconoscimento formale a livello locale viene meno, la residenza come presenza legale ne risulta fortemente ridi-mensionata e, per così dire, de-qualificata. Lo scollamento tra le due residenze, pertanto, favorisce, come si vedrà meglio nei prossimi paragrafi, una moltiplicazione degli status.
8
3. L’ oggetto del conflitto: la residenza e la sua regolazione a livello locale Nell’ordinamento giuridico italiano, la nozione di residenza (art. 43 del Codice civile)
coincide con il luogo di dimora abituale ed è distinta da quella di domicilio, che costitui-sce invece la sede principale degli affari e interessi individuali. Lo status di residente si ca-ratterizza essenzialmente come una condizione di fatto, incentrata sulla presenza stabile di un individuo in un determinato contesto spaziale e indipendente, in larga misura, dalla vo-lontà e dalle intenzioni soggettive (Dinelli, 2011, pp. 151-152; Morozzo della Rocca, 2003, p. 1014).
La condizione di chi è abitualmente presente nel territorio di un comune si traduce in un riconoscimento formale quando ha luogo l’iscrizione anagrafica13, che costituisce la presa d’atto, a fini amministrativi, di tale condizione (ivi, p. 155). La residenza civilistica, in questo modo, si trasforma in residenza anagrafica in quanto a un fatto – la presenza stabile in un dato luogo – fa seguito un effetto giuridico – l’iscrizione nel registro della popolazione residente. Perché ciò accada, tuttavia, è necessario che il fatto sia accertato come vero, vale a dire che sia verificata l’abitualità della dimora. Pertanto, ogni ammini-strazione comunale è chiamata a verificare che le singole dichiarazioni di dimora abituale relative al territorio di sua competenza corrispondano alla realtà. A riguardo, l’ufficiale di
anagrafe – il sindaco, che però può delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni a impiegati del comune, mantenendo comunque la titolarità sulle stesse – è tenuto ad accertare se co-loro che rilasciano tali dichiarazioni chiedendo di essere iscritti nei registri anagrafici vi-vono effettivamente e stabilmente nel luogo dichiarato. L’accertamento, di solito, è effet-tuato dalla polizia locale, ma la decisione finale circa la sussistenza del requisito rimane a carico dell’ufficiale anagrafico.
La residenza è uno status dotato di due facce: in primo luogo, è oggetto di un dovere14, tanto con riferimento ai cittadini italiani quanto con riferimento ai cittadini comunitari15 e agli stranieri extracomunitari16. Ogni individuo che vive stabilmente e regolarmente in un comune è tenuto a dichiarare la sua presenza, richiedendo quindi di essere registrato come residente. La natura di dovere della residenza è riconducibile alla funzione strategica che questa istituzione riveste: garantire l’esatta corrispondenza tra la popolazione presente di
fatto e la popolazione residente di diritto. Tramite i registri anagrafici, infatti, gli apparati
13 Le procedure che regolano l’iter di iscrizione anagrafica sono disciplinate dalla legge n. 1228 del 1954 e dal regolamento attuativo contenuto nel D.p.r. n. 223 del 1989, recentemente modificato dal D.l. n.5 del 2012 (poi convertito nella legge n. 35 del 2012). 14 A riguardo, l’art. 2 della legge n. 1228/1954 prescrive che «è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimo-ra abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche». 15 Come previsto dal già citato decreto 30 del 2007, i cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi sono tenuti a iscriversi all’anagrafe. L’iscrizione nei registri della popolazione residente, dunque, ha sostituito il permesso di soggiorno quale strumento di controllo della regolarità della presenza dei cittadini di stati membri dell’Unione europea. 16 A riguardo, il Testo unico sull’immigrazione, al comma 7 dell’articolo 6, prevede che «le iscrizioni e va-riazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione».
9
dello stato sono in grado di sapere chi è effettivamente presente in ogni porzione del terri-torio italiano17 e possono raccogliere informazioni sulla popolazione locale e sui suoi mo-vimenti da comune a comune. La residenza, dunque, è – impiegando una categoria fou-caultiana – uno strumento di governamentalità, in quanto consente di monitorare, e quindi di controllare, la popolazione locale18.
In secondo luogo, la residenza è un diritto19 per tutti gli individui che dimorano abi-tualmente nel territorio del comune presso cui richiedono l’iscrizione – siano essi cittadini italiani oppure non cittadini regolarmente presenti nel territorio statale20. Il riconoscimento di questo diritto, peraltro, non può essere limitato sulla base delle condizioni dell’alloggio (non necessariamente un’abitazione in senso stretto) in cui i richiedenti vivono. La natura di diritto della residenza è strettamente legata al nesso che intercorre tra lo status di resi-dente e numerosi diritti fondamentali. La residenza, in altre parole, non è soltanto un dirit-to in sé ma è anche – parafrasando Hannah Arendt – un «diritto ad esercitare altri diritti».
La condizione di residente, dunque, riproduce, almeno in parte, l’articolazione in diffe-renti dimensioni che contraddistingue la cittadinanza nazionale21 – è uno status giuridico a cui è legato l’accesso a un insieme di diritti –, e si configura dunque come una sorta di cit-
tadinanza locale. La rilevanza della residenza è ampiamente confermata dal fatto che, nel corso degli ul-
timi decenni, essa è stata ripetutamente oggetto di tentativi di controllo indebito da parte di numerose amministrazioni comunali, le quali si sono distinte in alcuni casi per il ricorso a prassi restrittive e in altri casi per l’emanazione di provvedimenti ad hoc22. L’attenzione per le procedure di iscrizione anagrafica è esplosa tuttavia verso la fine del 2007, qualche mese dopo l’emanazione del già citato decreto 30 – che disciplina la circolazione e il sog-giorno dei cittadini comunitari – e l’entrata in Europa della Romania e della Bulgaria: a
17 Fatta eccezione, ovviamente, per i non cittadini in condizione di irregolarità, esclusi dal diritto/dovere del-la residenza e quindi non rilevabili dai registri anagrafici. 18 A riguardo, come sottolineato da Palidda (2000, 32), la raccolta di informazioni «su tutto e su tutti» è cen-trale nella costruzione di un sapere della polizia. Proprio questa istituzione, nello specifico, ha introdotto e generalizzato «la denominazione sistematica delle strade e delle piazze e le numerazione delle case, come elementi indispensabili all’identificazione standardizzata delle persone» (ibidem). 19 La residenza, nello specifico, si configura come un diritto soggettivo perfetto (Morozzo della Rocca, 2003; Vrenna, 2003), come chiarito in passato dalla Cassazione (Cass. 1081/68), dal Ministero dell’interno con due circolari, nel 1995 e nel 1997 e, più recentemente, dall’Unar (Repertorio n. 15 del 30 gennaio 2012), dal Consiglio di stato (con il parere n. 04849/2012) e nuovamente dal Ministero dell’interno (con la circolare n. 1 del 14/01/2013, che riprende l’appena citato parere del Consiglio di stato). 20 Per quanto riguarda i cittadini comunitari, la regolarità della presenza è dimostrata dal possesso dei requi-siti previsti dal decreto 30/2007 (già menzionati nella nota 5); per quanto riguarda invece gli stranieri extra-comunitari, tale regolarità è manifestata dal possesso di un titolo di soggiorno «di durata anche temporanea, purché prevedibilmente prorogabile e quindi sufficiente a provare la coincidenza tra l’elemento intenzionale e l’elemento di fatto dello stato di residenza» (Morozzo della Rocca, 2006, 60). 21 Quanto alle differenti dimensioni in cui può articolarsi la cittadinanza si rimanda, tra le varie proposte, a Bosniak, 2001 e 2007; Zincone, 200b; Zolo, 2000. Per un’analisi di queste proposte si rimanda a Gargiulo, 2008. 22 Esempi di provvedimenti di questo tipo risalgono quantomeno alla fine degli anni Novanta, come testimo-niato ad esempio da Salvini (1999).
10
partire dal quel momento, alcuni sindaci23 hanno emanato ordinanze, circolari o delibere di giunta tramite cui, facendo leva su una presunta emergenza immigrazione e sui proble-mi di sicurezza che da tale emergenza sarebbero derivati, hanno introdotto criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale – e perciò illegittimi24 – con riferimento, in alcuni casi, ai soli non cittadini e, in altri casi, anche ai cittadini25. In generale, le iniziative dei sindaci hanno attuato, o quantomeno minacciato, forme di discriminazione (Andrisani e Naletto, 2009; Bontempelli, 2009) – a volte diretta, altre volte indiretta o dissimulata – nei confronti di non italiani o di italiani poco “graditi” (appartenenti alle popolazioni ro-
manì, senza fissa dimora o con precedenti penali). Queste iniziative possono essere considerate parte di un più ampio insieme di politiche
locali di esclusione26 (Ambrosini, 2012; Ambrosini e Caneva, 2012), orientate a regolare numerosi aspetti della vita sociale27 e favorite dall’emanazione della legge n. 125/2008 – parte del cosiddetto Pacchetto sicurezza – che ha ampliato i poteri dei sindaci consentendo loro di emanare ordinanze anche al di fuori di situazioni emergenziali in materia di sicu-
rezza urbana. La legge 125, infatti, nonostante sia stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale poco meno di tre anni dopo28, ha tuttavia prodotto un rapido incremento del numero delle ordinanze29.
A parte i cambiamenti apportati al potere di ordinanza, il governo centrale, negli ultimi anni, è intervenuto più volte in materia di iscrizione anagrafica: nel 2009, tramite la legge n. 94 – anch’essa parte del Pacchetto sicurezza30 –, che ha attribuito alle amministrazioni comunali la possibilità, in caso di richiesta di residenza, di effettuare una verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile e modificato i requisiti per l’iscrizione dei senza fissa dimora31; nel 2012, con il Decreto legge n.5 (poi convertito nella legge n. 35),
23 Il “pioniere” è stato il sindaco del comune di Cittadella (Pd) nel mese di novembre, seguito da altri colle-ghi che, spesso, hanno “copiato e incollato” il provvedimento del comune patavino. Per maggiore dettagli circa i contenuti dell’ordinanza di Cittadella e le vicende giudiziarie che hanno fatto seguito alla sua emana-zione cfr. Campo, 2007 e Paggi, 2007. 24 I sindaci, pur essendo soggetti politici eletti dal popolo, in materia anagrafica agiscono come semplici uf-ficiali del governo, e non dispongono quindi di poteri diretti. Questo duplice aspetto del ruolo del sindaco è fonte di una evidente ambiguità (Dinelli, 2010). 25 Un elenco piuttosto articolato delle iniziative dei sindaci in materia anagrafica è contenuto in Lorenzetti, 2009. Per quanto riguarda i criteri introdotti, cfr. Guariso (a cura di), 2012; Usai, 2011. 26 A riguardo, Manconi e Resta (2010) hanno parlato di “xenofobia municipale” e “razzismo federale”. Pen-ninx e Martiniello (2007), invece, in precedenza, e riferendosi a fenomeni soltanto in parte simili, hanno par-lato di “paradigma dell’esclusione” a livello locale. 27 La letteratura sulla “nuove” ordinanze di taglio giuridico è pressoché sterminata. Per approfondimenti di tipo sociologico e politologico sulle caratteristiche di questi strumenti si rimanda a Cammarata e Monteleo-ne, 2014; Pitch, 2013; Simone, 2010. 28 Sulla decisione della Consulta e sulle sue ricadute rispetto ai poteri di ordinanza e alle ordinanze già ema-nate cfr. Manfredi, 2013. 29 Sull’andamento delle ordinanze e sulle loro caratteristiche cfr. Cittalia, 2009; Giovannetti, 2012. 30 Sui cambiamenti dei potere dei sindaci cfr. Zorzella, 2008; sul Pacchetto sicurezza più in generale cfr. Fer-rero, 2010. 31 Il disegno di legge originale era diverso e molto più restrittivo, mentre la norma effettivamente approvata non prevede che la verifica sia obbligatoria né, meno che mai, subordina la procedura di iscrizione a un suo esito positivo. Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Pacchetto sicurezza, cfr. Mariani, 2010. Sull’assenza di un qualsiasi legame diretto tra la mancanza dei requisiti igienico-sanitari dell’immobile e il
11
che ha modificato le procedure di iscrizione, introducendo il cosiddetto “cambio di resi-denza in tempo reale”32; nel 2014, con l’art. 5 del Decreto legge n. 47, il cosiddetto “De-creto Lupi” (approvato dalla Camera il 20 maggio), che, impedendo a chi occupa abusi-vamente un immobile di chiedere la residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi, ha messo in discussione i diritti delle persone che dimorano illegalmente in edifici disabita-ti33.
Le amministrazioni locali, come si vedrà, si sono rapidamente adattate ai cambiamenti, sia quando questi si sono rivelati favorevoli sia quando – più raramente, come nel caso del cambio di residenza in tempo reale – si sono rivelati un possibile ostacolo. Complessiva-mente, i comuni, negli ultimi anni, hanno fatto ricorso a vere e proprie politiche di resi-
denza, vale a dire a strategie, illegittime, che fanno perno sul riconoscimento dello status di residente per ottenere il controllo della popolazione locale34, con riferimento sia alla sua componente straniera sia, seppur in misura minore, alla sua componente italiana.
Le politiche di residenza agiscono attraverso specifici meccanismi, che si configurano come diretti quando introducono requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e come indiretti quando dispongono controlli e/o richiedono documenti senza che sia stabilito un nesso chiaro e automatico tra ciò che è disposto/richiesto e il riconoscimen-to dell’iscrizione anagrafica. In altre parole, i meccanismi del primo tipo prescrivono che per ottenere la residenza in un comune sia necessario sottostare a specifiche condizioni, mentre i meccanismi del secondo tipo prevedono accertamenti e chiedono dati e documen-tazioni che apparentemente non pregiudicano l’iscrizione in quanto, ufficialmente, perse-guono finalità diverse dal controllo sulle procedure anagrafiche.
Entrambi i tipi di meccanismo si qualificano come espliciti se funzionano attraverso l’emanazione di provvedimenti, misure o atti formali e come impliciti se, invece, operano attraverso prassi amministrative. Nello specifico, i meccanismi espliciti introducono requi-siti aggiuntivi (se diretti) oppure dispongono controlli/richiedono documenti (se indiretti) facendo comunque ricorso agli stessi strumenti giuridici: ordinanze, circolari o delibere di giunta. I meccanismi impliciti, per converso, assumono in ogni caso le sembianze di prassi amministrative ma si collocano in momenti diversi del procedimento di iscrizione: se di-retti, si innescano prima che l’iter formale abbia inizio; se indiretti entrano in funzione nel
corso dello stesso.
riconoscimento della residenza, peraltro, si sono espressi anche il Consiglio di stato, con un parere, e il Mi-nistero dell’interno, con una circolare (entrambi richiamati nella nota 19). 32 Più in dettaglio, la persona che dichiara di dimorare abitualmente in un comune viene iscritta immediata-mente e, soltanto successivamente, vengono eseguiti gli accertamenti, il cui eventuale esito negativo deter-mina la cancellazione dell’iscrizione e il ristabilimento della condizione precedente. 33 Ad esempio, moltissimi richiedenti asilo non più inclusi nei programmi di assistenza pubblici. Non a caso, l’Unhcr si è espresso negativamente sul decreto pochi giorni dopo la sua approvazione in Parlamento (a ri-guardo, cfr. http://www.cronachediordinariorazzismo.org/unhcr-decreto-piano-casa-incrementa-marginalita/). 34 L’espressione “politiche di residenza” è ripresa da Dinelli (2010, p. 68), ma è impiegata qui con un signi-ficato in parte diverso (chiarito meglio in Gargiulo 2001b e 2013). A questi due lavori si rimanda anche per quanto riguarda l’interpretazione delle strategie di regolazione della residenza come meccanismi di controllo delle migrazioni (Brochmann, 1999) che agiscono però a livello locale.
12
Esemplificando in maniera più concreta, i meccanismi diretti agiscono nei fatti introdu-cendo un’ampia gamma di requisiti. Quando questi meccanismi sono espliciti, i requisiti introdotti sono imposti “nero su bianco”, sono cioè previsti formalmente da un qualche documento ufficiale prodotto a livello locale; quando invece sono impliciti, gli stessi re-quisiti sono comunicati a voce ai diretti interessati nel momento in cui questi, per la prima volta, si recano presso gli uffici anagrafici.
Se i meccanismi diretti avanzano richieste non previste dalla legge, i meccanismi indi-retti sono invece incentrati prevalentemente su un’interpretazione restrittiva, per non dire assolutamente distorta, delle modifiche apportate dal pacchetto sicurezza del 2009 alla normativa anagrafica: le condizioni dell’alloggio presso cui è richiesta la residenza, in al-tre parole, sono impiegate come pretesto per negare l’iscrizione. Quando i meccanismi in-diretti sono espliciti, essi – attraverso ordinanze o circolari – impongono controlli specifici e/o richiedono documenti che attestino, ad esempio, le dimensioni dell’immobile. Quando invece questi meccanismi sono impliciti, l’esclusione prende corpo successivamente agli accertamenti relativi all’abitualità della dimora svolti dalla polizia locale: in questo caso, le caratteristiche del luogo in cui vive il richiedente l’iscrizione vengono utilizzate come prova del fatto che questi non dimora effettivamente dove ha dichiarato di dimorare.
Il contenuto dei meccanismi qui descritti è riassunto sinteticamente nella tabella se-guente:
Tabella n. 1 – Tipologia dei meccanismi di esclusione dalla residenza
Espliciti Impliciti
Diretti introduzione formale di requisiti necessari per
l’iscrizione
introduzione informa-le di requisiti necessa-
ri per l’iscrizione
Indiretti
prescrizione di controlli e/o di documentazioni
circa le condizioni dell’alloggio
impiego pretestuoso delle condizioni
dell’alloggio
Per comprendere meglio il funzionamento di questi meccanismi, è opportuno passare
dall’analisi degli stessi a un approfondimento delle modalità effettive con cui può prendere concretamente corpo, in maniera illegittima, il mancato riconoscimento della residenza. Il rifiuto dell’iscrizione, infatti, può verificarsi mediante un atto formale oppure in maniera informale.
Il caso più estremo di rifiuto formale si ha quando la residenza viene negata attraverso un provvedimento scritto che adduce come motivazione la carenza dei requisiti previsti da un’ordinanza, una circolare o una delibera. Questa modalità di mancato riconoscimento – piuttosto rara ma comunque adottata da diversi comuni, stando ai dati fin qui raccolti – è
13
effetto dei meccanismi espliciti, tanto di tipo diretto quanto di tipo indiretto (e può essere ricondotta quindi alla prima e alla terza cella della tabella n. 1)35.
Il caso più estremo di rifiuto informale, per contro, si verifica se il richiedente l’iscrizione è invitato a non consegnare la propria dichiarazione di residenza – in altre pa-role, a non presentare la domanda, o comunque a presentarla in un secondo momento – in quanto, dalle risposte fornite a una serie di quesiti rivoltigli dall’operatore, risulta il man-cato soddisfacimento di alcuni requisiti o la mancanza di alcuni documenti36. In questo ca-so, il procedimento amministrativo di iscrizione non ha nemmeno inizio e l’amministrazione comunale non rilascia alcuna comunicazione in forma scritta circa le motivazioni che giustificano la sua decisione. Il richiedente l’iscrizione si allontana così dall’ufficio anagrafico senza aver presentato effettivamente la propria dichiarazione di re-sidenza37 e senza aver ottenuto alcuna ricevuta che testimoni dell’accaduto38. Questa mo-dalità di esclusione è effetto dei meccanismi impliciti diretti (e può essere ricondotta dun-que alla seconda cella della tabella n. 1).
Quando invece ad agire sono i meccanismi impliciti indiretti (quarta cella della tabella n. 1), il rifiuto della residenza avviene in maniera formale e, apparentemente, legittima: l’iscrizione, in questi casi, viene negata attraverso un provvedimento che riporta come ra-gione la mancanza del requisito dell’abitualità della dimora. Tuttavia, la motivazione rea-le, e nascosta, del rifiuto – stante che la persona interessata vive effettivamente nel luogo dichiarato – è l’inidoneità dell’alloggio, desunta nel corso degli accertamenti svolti dalla
35 Un altro caso di rifiuto formale si verifica quando la residenza è negata mediante un provvedimento scritto che riporta come ragione la mancanza di requisiti non previsti dalla legge senza fare riferimento, tuttavia, a misure o provvedimenti emanati dal sindaco: un comune, ad esempio, ha respinto più volte le istanze di iscrizione per via dell’“inidoneità dell’alloggio”. Qui ad agire è un meccanismo esplicito che non si rifà a iniziative comunali ad hoc ma, evidentemente, a un’interpretazione distorta delle leggi statali. 36 A riguardo, la casistica è piuttosto vasta. Ad esempio, per scoraggiare i richiedenti può essere invocata la mancata esibizione del permesso di soggiorno da parte di un dichiarante straniero, nonostante tale esibizione non sia l’unico elemento probante la sussistenza del requisito sostanziale della regolarità del soggiorno (Mo-rozzo della Rocca 2006, p. 56); l’incompleta presentazione dei documenti attestanti la sussistenza dei requi-siti di carattere economico da parte di un cittadino comunitario, sebbene tale attestazione possa passare – esattamente come accade per i cittadini italiani – tramite autocertificazione; le condizioni in cui versa l’abitazione – ad esempio il fatto che non siano stati ancora acquistati mobili, che non siano state attivate utenze della luce o del gas o che manchino le prese della corrente – pur avendo il Ministero dell’interno più volte ribadito – come già segnalato – che tali condizioni non devono influire assolutamente sul riconosci-mento della residenza. In quest’ultimo caso, l’esclusione assomiglia a quella che ha luogo per effetto dei meccanismi impliciti indiretti, in quanto sono chiamate in causa le condizioni dell’abitazione. Tra i due tipi di esclusione, tuttavia, vi è una differenza importante, relativa ai tempi e alle fasi del processo di iscrizione. Per questa ragione è opportuno considerarli come due percorsi diversi. 37 In realtà, un rifiuto dell’iscrizione di tipo informale può verificarsi anche in assenza di una vera e propria interazione fisica tra l’utente e l’operatore – i quesiti, infatti, possono essere rivolti anche telefonicamente, qualora la persona interessata alla registrazione contatti gli uffici anagrafici prima di recarvisi – oppure può prescindere da una qualsiasi interazione tra utente e operatore – se chi intende iscriversi è dissuaso dal farlo dalle informazioni scorrette, o quantomeno poco chiare, rivenute nelle pagine dedicate alle procedure di iscrizione del sito di una data amministrazione comunale. 38 Questa modalità riveste una rilevanza strategica particolare in seguito all’entrata in vigore della residenza in tempo reale, in quanto – a meno che l’interessato non consegni la propria dichiarazione di residenza per via telematica, per posta o per fax – consente di evitare che l’iscrizione diventi immediatamente effettiva.
14
polizia locale39 e impiegata indebitamente per dimostrare, attraverso un discutibile percor-so logico-argomentativo40, che un alloggio inidoneo non è abitabile e che, quindi, non può fungere da dimora abituale.
Spesso, comunque, le modalità di rifiuto formali e informali non sono alternative ma si pongono piuttosto in un rapporto di “sostegno”. Ad esempio, i rifiuti informali opposti da-gli operatori possono essere motivati richiamando in modo colloquiale ordinanze, circolari o liste di requisiti compilate dai sindaci e consegnate informalmente agli impiegati dell’ufficio anagrafe, i quali se ne avvalgono nel momento in cui si rapportano con i di-chiaranti. In questi casi, la negazione della residenza, comunque attuata in forma orale e non scritta, è sostenuta da strumenti amministrativi o da “decaloghi”41 compilati infor-malmente dai sindaci: i meccanismi espliciti, in altre parole, sembrano agire qui in aiuto di quelli impliciti. Un percorso simile si ha quando l’impiego pretestuoso delle condizioni dell’alloggio per desumere la mancanza del requisito dell’abitualità della dimora trova un sostegno in misure o provvedimenti emanati dal sindaco per rendere obbligatori i controlli circa tali condizioni: in questi casi, l’intervento esplicito dell’amministrazione comunale è propedeutico all’innesco di meccanismi impliciti.
La “collaborazione” tra meccanismi espliciti e impliciti, peraltro, evidenzia un altro da-to rilevante: nei contesti di medie e piccole dimensioni quali quelli oggetto della ricerca qui presentata, il sindaco, pur agendo spesso dietro le quinte, rimane sostanzialmente l’attore principale, il vero “protagonista dell’esclusione”. Nonostante infatti gli impiegati e i responsabili degli uffici anagrafici siano street level bureaucrats (Lipsky, 1980) – sog-getti dotati quindi, di fatto più che di diritto, di un’elevata discrezionalità – la prossimità assicurata dalla scala ridotta del contesto in cui avvengono le interazioni fa sì che le co-municazioni tra amministratori locali e personale amministrativo dell’ufficio anagrafe – nonché con la polizia locale – siano continue. I sindaci, in questo modo, riescono a veico-lare in maniera più o meno diretta e formale le proprie posizioni e le proprie scelte, anche a costo – come emerso in alcuni casi – di ritirare la delega agli impiegati quando questi non si sono dimostrati disponibili a “eseguire” i comandi provenienti “dall’alto”42.
39 Desunta, peraltro, da elementi e indicatori molto simili a quelli riportati a proposito delle modalità di rifiu-to informali (ad esempio, assenza di mobilio, mancanza dei rivestimenti delle prese della corrente, ecc.) e seguendo quindi, seppur con modalità e in fasi diverse, la stessa logica di alcuni meccanismi diretti impliciti. 40 A riguardo, è interessante rilevare come un aiuto, seppur indiretto, alla discrezionalità della polizia locale nel corso degli accertamenti possa venire dal modello predisposto dall’Istat (come previsto dal comma 2, articolo 19 del regolamento anagrafico). Questo modello, infatti, prescrive la registrazione di un vasto e det-tagliato insieme di informazioni, relative ad esempio alle caratteristiche dell’alloggio: agli operatori della polizia locale, nello specifico, è richiesto di verificare se questo sia un’abitazione o altro – “roulotte, baracca, grotta, ecc.” La rilevanza delle informazioni raccolte dovrebbe avere carattere strettamente statistico e in-formativo; il loro uso, tuttavia, è spesso strumentale. 41 Vere e proprie liste di requisiti – illegittimi – che, secondo gli amministratori locali, gli impiegati degli uffici anagrafici dovrebbero richiedere a coloro che desiderano registrarsi come residenti. 42 Quanto ai comuni di dimensioni maggiori, è necessario invece un supplemento di ricerca. In questo caso, infatti, la maggiore distanza tra sindaco e operatori – e soprattutto tra sindaco e responsabili/dirigenti – po-trebbe tradursi in una maggiore indipendenza di questi ultimi, la quale potrebbe declinarsi tanto in senso in-clusivo quanto in senso escludente.
15
4. Gli attori del conflitto: la residenza come campo di tensioni Le iniziative portate avanti da numerose amministrazioni comunali per restringere i cri-
teri relativi all’iscrizione anagrafica si sono scontrate, in molti casi, con la resistenza di al-cune organizzazioni. Lo scontro ha avuto come oggetto specifici provvedimenti e decisio-ni municipali ma anche, più in generale, lo stesso significato giuridico e socio-politico del-la residenza. Attorno a questo istituto, dunque, si è andato rapidamente strutturando quello che, mutuando un concetto di Bourdieu, può essere considerato un vero e proprio campo43 di tensione e conflitto. Gli attori che si “contendono” la residenza, infatti, cercano, ognuno dalla sua prospettiva e perseguendo i propri obiettivi, di esplicitare principi pratici di vi-sione e divisione del mondo e di imporre tali principi come categorie legittime di costru-zione della realtà sociale (Bourdieu, 2010, p. 77).
Il campo in cui ha preso forma il conflitto sulla residenza, più in dettaglio, assomiglia molto a quello che Bourdieu chiama campo politico: è cioè un luogo in cui, allo scopo di istituire confini, «si esercita una sorta di lotta cognitiva per imporre con la necessaria isti-tuzionalizzazione la visione legittima della convivenza sociale (o del mondo sociale)», uno spazio in cui «si esercita un “potere di nomina” che alle opportune condizioni può tra-sformarsi in potere performativo» (Cella 2006, 131). All’interno del campo politico, se-condo Bourdieu, gli attori mirano a «produrre e a imporre rappresentazioni (mentali, ver-bali, grafiche o teatrali) del mondo sociale che siano capaci di agire su questo mondo, agendo sulla rappresentazione che ne fanno gli agenti. O, più precisamente, a fare e a di-sfare i gruppi – e, contemporaneamente, le azioni collettive che essi possono intraprendere per trasformare il mondo sociale conformemente ai loro interessi – producendo, riprodu-cendo o distruggendo le rappresentazioni che rendono visibili questi gruppi a se stessi e agli altri» (Bourdieu, 1988, 122). Se si vuole agire sul mondo sociale, infatti, è necessario condizionare la conoscenza che gli attori ne hanno (Ibidem). Nel fare ciò, una posizione di primo piano è occupata dai giuristi, il cui discorso «può essere considerato come la appli-cazione legittimata professionalmente delle rappresentazioni dei politici» (Cella, 2006, 125).
Gli attori che compongono il campo della residenza sono piuttosto eterogenei: tra loro troviamo sindaci, operatori e dirigenti comunali, il Ministero dell’interno, l’Unar, la poli-zia locale, prefetti, politici – a volte di livello statale, più spesso di livello regionale e loca-le –, organizzazioni che tutelano i diritti dei migranti e delle persone vulnerabili, sindacati, giornalisti, magistrati – ordinari e amministrativi –, avvocati e giuristi. Agli attori italiani, inoltre, si aggiungono, seppur indirettamente, gli attori europei – nello specifico, le varie istituzioni dell’Unione e la Corte di giustizia –, in quanto la residenza riveste
43 Nei lavori dello studioso francese, il termine «campo» sta a indicare «un campo di forze all’interno del quale gli agenti occupano posizioni che determinano statisticamente le loro prese di posizione sul medesimo campo di forze. Tali prese di posizione mirano sia a conservare sia a trasformare la struttura del rapporto di forze costitutiva del campo» (Bourdieu 2010, 59).
16
un’importanza strategica nel contesto europeo, sia per ragioni politiche sia per ragioni economiche (a riguardo, cfr. Dinelli, 2011, par. 6, cap. 4).
Il conflitto tra gli attori qui indicati assume, sostanzialmente, tre forme differenti, con-figurandosi come: una disputa legale sul significato giuridico della residenza e sulla cor-rettezza delle procedure che portano al suo riconoscimento; una controversia giudiziaria su casi specifici di rifiuto dell’iscrizione; uno scontro politico sul controllo della popola-zione locale. Queste tre forme, seppur nettamente distinguibili in via analitica, nelle loro manifestazioni concrete spesso sono tra loro intrecciate.
Il primo tipo di conflitto verte su confini giuridico-teorici. Gli attori che lo animano, in altre parole, provano a imporre una specifica visione della residenza e delle procedure che portano al suo riconoscimento, tracciando una linea che, sul piano della teoria giuridica, sia in grado di escludere dal campo le altre visioni. Questa operazione di costruzione e imposizione di confini – che avviene prima dell’applicazione concreta della normativa anagrafica ed è propedeutica ad essa, pur essendo condizionata dai casi effettivi di rifiuto dell’iscrizione e dalle controversie, anche giudiziarie, che possono circondarli – ha luogo in varie sedi. Tra queste, una sede apparentemente minore ma tuttavia particolarmente in-teressante è costituita dalla rivista Lo stato civile italiano, dove sono ospitati contributi di operatori e dirigenti comunali, avvocati ed esperti di diritto, i quali, rivolgendosi a un pub-blico prevalentemente tecnico e non accademico, mettono in campo il proprio sapere pro-fessionale44 per difendere una concezione più o meno rigida dell’iscrizione anagrafica. Dalle pagine di questa rivista, ad esempio, alcuni attori affermano l’esistenza di una di-stinzione quasi “ontologica” tra la residenza intesa in senso civilistico e la residenza intesa in senso anagrafico: la prima sarebbe un diritto soggettivo mentre la seconda un mero in-
teresse legittimo. In altre parole, il diritto soggettivo alla residenza sarebbe condizionato dalla sussistenza di una serie di requisiti che spetta all’ufficiale d’anagrafe, e alla sua di-screzionalità, valutare.
A una concezione così rigida della residenza, nella stessa rivista, si contrappongono poi visioni più inclusive. Visioni simili, inoltre, sono proposte in altre sedi e da altri attori. Il Ministero dell’interno e l’Unar, come già anticipato, sono intervenuti più volte per chiarire quale sia la corretta interpretazione giuridica della residenza, ricordando come essa confi-guri un diritto soggettivo perfetto. Allo stesso modo, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), dalle pagine del suo sito e attraverso schede e approfondimenti, ha fornito un contributo scientifico, diretto e indiretto, sul tema. Anche l’Istat – formal-
44 Questo sapere, come emerso anche dai colloqui telefonici con alcuni operatori e responsabili dei servizi anagrafici, prende la forma di vere e proprie mappe cognitive tramite cui gli attori si orientano non soltanto nella normativa anagrafica, ma anche nel rapporto con i richiedenti l’iscrizione. Queste mappe, più nello specifico, sono fatte di rappresentazioni, categorizzazioni e, in alcuni casi, stereotipi relativi alle strategie di azione da impiegare nel corso della propria attività così come agli utenti e ai loro comportamenti. Il sapere degli operatori anagrafici, inoltre, implica in molti casi un certo tipi di interpretazione della normativa ana-grafica, da cui possono derivare comportamenti escludenti non intenzionali: da alcuni colloqui telefonici, nello specifico, è emerso come la richiesta di requisiti illegittimi a volte non dipenda da una strategia di esclusione deliberata, ma da una visione inconsapevolmente restrittiva delle regole in materia.
17
mente coinvolta dal regolamento anagrafico nella gestione delle procedure di iscrizione45 – ha fornito un ampio apporto, sia pubblicando negli anni manuali e testi orientati a una corretta applicazione della normativa statale (ad esempio, 1992 e 2010) sia emanando cir-colari informative.
Il secondo tipo di conflitto è incentrato invece su confini giuridico-pratici. Qui, la linea oggetto di contesa non è tracciata sul piano teorico ma al livello delle procedure concrete. La controversia, di conseguenza, è successiva a queste procedure, e l’arena in cui prende forma è costituita dai tribunali, amministrativi e civili. Gli attori coinvolti sono da una par-te le amministrazioni comunali – direttamente nella figura del sindaco, titolare delle fun-zioni anagrafiche e autore di provvedimenti illegittimi, e indirettamente in quella degli operatori comunali46 – e dall’altra le organizzazioni del terzo settore che si occupano dei diritti degli immigrati (o comunque degli individui in condizioni di vulnerabilità)47, i sin-dacati (in particolare la Cgil e in alcuni casi la Cisl) e gli avvocati, spesso appartenenti a una o più delle organizzazioni richiamate.
I primi, con le loro scelte pratiche, spostano il confine della residenza, restringendolo in senso escludente; i secondi, con la loro azione legale, contestano questo spostamento, provando a ristabilire un confine conforme alla legge e più inclusivo, svolgendo così un ruolo di advocacy (a riguardo, cfr. Ambrosini, 2013b, 320-321). In mezzo ai due schiera-menti si trovano le Prefetture, coinvolte formalmente in alcune azioni legali (ricorsi gerar-chici) e, più in generale, legalmente sovraordinate ai sindaci in materia di anagrafe (come tali, dunque, dotate di un potere esplicito di vigilanza/controllo sugli amministratori loca-li), e i giudici, che, con le loro sentenze, contribuiscono a ribadire o a riconfigurare i con-fini della residenza.
Il terzo tipo di conflitto, infine, è imperniato su confini politico-sociali. In questo caso, la demarcazione che alcuni attori provano a imporre, e che altri attori si impegnano a con-testare, è quella tra cittadini locali legittimi e cittadini locali “illegittimi”. La disputa, dun-que, può avere luogo parallelamente alla contesa giuridica o indipendentemente da questa – qualora ad esempio un’ordinanza non sia stata applicata o sia stata rapidamente ritirata. In altre parole, il conflitto può scatenarsi in diverse fasi del ciclo della misura di esclusio-
ne (Ambrosini, 2013a): immediatamente dopo la fase dell’ annuncio così come nelle fasi successive. Qualunque siano i tempi della contesa, i suoi protagonisti principali sono i sin-daci, i quali, oltre a emanare provvedimenti particolarmente visibili o a essere comunque
45 A riguardo, l’Istat è coinvolto – come già anticipato – nella predisposizione dei modelli di accertamento relativi ai controlli circa l’abitualità della dimora ma anche in numerose altre funzioni, tra cui, ad esempio, la redazione di schede e modelli per l’inserimento e la conservazione di dati così come la vigilanza sulla ge-stione dei registri anagrafici da parte dei comuni. 46 Ovviamente, non sempre gli operatori anagrafici, e più in generale le amministrazioni comunali, mettono in atto comportamenti escludenti. Può accadere infatti che questi soggetti usino la propria posizione di street level bureaucrats per realizzare strategie inclusive. A riguardo, un esempio interessante è fornito da De Graw, 2014. 47 Senza alcuna pretesa di completezza, è possibile elencare, a scopo puramente esemplificativo e non siste-matico, le seguenti: l’Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere), la Fondazione Piccini di Brescia, la già citata Asgi, le associazioni Avvocati per niente e Razzismo stop.
18
oggetto di contestazioni per iniziative meno evidenti, esternano pubblicamente il proprio punto di vista su quella che dovrebbe essere la composizione della popolazione locale, la-sciando così intravedere la comunità che essi immaginano come legittima (Gargiulo, 2012, p. 106). Spesso, i primi cittadini ricevono un aiuto concreto da attori politici di livello re-gionale48 o, direttamente, dal governo centrale, come si è visto riguardo al Pacchetto sicu-rezza. Accanto ai sindaci, poi, un ruolo di primo piano è rivestito dai giornalisti, che fun-gono a volte da loro cassa di risonanza49.
Sul fronte opposto, è possibile trovare invece un vasto insieme di associazioni50 e sin-goli soggetti che, spesso mediante lo strumento del sito internet o del blog, contrastano e “decostruiscono” le rappresentazioni escludenti e le retoriche securitarie promosse dai sin-daci51, svolgendo così una funzione di protesta (a riguardo, cfr. Ambrosini, 2013b, 320). Anche i quotidiani, in alcuni casi, costituiscono uno strumento di opposizione alle iniziati-ve degli amministratori locali. Poco rilevante, invece, sembra essere la presenza dei partiti e, nello specifico, degli attori politici collocati all’opposizione nei comuni interessati dai provvedimenti in materia di residenza52.
Oltre agli attori coinvolti nelle forme di conflitto che riguardano direttamente la que-stione dell’iscrizione anagrafica, vi sono poi altri soggetti la cui attività si inserisce tra-sversalmente nel campo della residenza. Gli operatori sociali, sanitari e dei servizi per gli immigrati, più in dettaglio, contribuiscono, seppur indirettamente, a ridefinire i contorni dello status di residente, condizionando le modalità con cui questo status funge da canale d’accesso a importanti diritti. A riguardo, tanto le culture professionali quanto le condi-zioni istituzionali rivestono un ruolo centrale. Se da un lato, infatti, alcune ricerche (Cam-pomori, 2007) hanno evidenziato un atteggiamento inclusivo da parte degli operatori dei servizi per gli immigrati, favorito anche dal fatto che molti di essi molti provengono da organizzazioni del terzo settore, dall’altro lato va osservato come i meccanismi formali dell’accesso ai servizi sociali e sanitari non siano sempre chiari e direttamente inclusivi. Il caso del legame tra residenza e iscrizione degli stranieri extracomunitari, ad esempio, è emblematico della complessità e della scarsa chiarezza che circonda la normativa e le pro-
48 Ad esempio, pochi giorni dopo l’emanazione dell’ordinanza di Cittadella, nel sito della Regione Veneto ha fatto la sua comparsa una delibera modello, chiaramente ispirata al provvedimento del comune patavino, che aveva l’obiettivo di fornire un inquadramento tecnico, ma anche una copertura politica, ai sindaci della regione. A riguardo, cfr. http://www.stranieriinitalia.it/ansa-immigrazione_sicurezza_delibera_modello_per_sindaci_veneti_1865.html. 49 Basti pensare, a riguardo, ai numerosi articoli pubblicati dal quotidiano la Padania a sostegno delle inizia-tive dei sindaci lombardi e veneti o a diversi quotidiani locali che hanno pubblicizzato le ordinanze e i prov-vedimenti. 50 A volte si tratta delle stesse organizzazioni – come ad esempio l’Asgi – che si sono battute, sia sul piano giuridico-teorico sia su quello giudiziario, contro le iniziative dei sindaci 51 Nuovamente senza alcuna pretesa di completezza e a scopo puramente esemplificativo, è possibile men-zionare il Progetto Melting Pot Europa, il sito di Sergio Bontempelli, studioso e attivista politico – http://sergiobontempelli.wordpress.com/ – il blog “Ordinanza pazza” – http://ordinanzapazza.wordpress.com/ –, il sito http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ 52 Su questo punto, tuttavia, è necessario un approfondimento a livello di ricerca.
19
cedure amministrative53. Gli enormi spazi di discrezionalità che nuovamente si aprono agli attori rendono, di conseguenza, i loro quadri cognitivi e i loro sapere assolutamente strate-gici.
5. La posta in gioco del conflitto: obiettivi delle strategie di regolazione locale del-la residenza
Le strategie di esclusione dalla residenza qui analizzate, sia dalla prospettiva dei mec-
canismi a loro sottesi sia da quella dei tipi di conflitto che le hanno circondate, rispondono a diverse finalità. Quando sono esplicite, possono avere un obiettivo esclusivamente pro-
pagandistico: chi ne fa uso vuole semplicemente guadagnare la ribalta mediatica e rassicu-rare i cittadini (Ambrosini, 2013a), senza perseguire finalità materialmente escludenti. In questi casi, l’emanazione di ordinanze, circolari o delibere, poi concretamente non appli-cate, è circondata da una vasta eco mediatica, la cui diffusione è chiaramente favorita dai sindaci che hanno preso l’iniziativa. La scelta di fare ricorso a strategie di tipo esplicito, in alternativa, può essere ricondotta alla volontà di uniformarsi ad amministrazioni comunali limitrofe che hanno agito in tal senso. Ad esempio, secondo l’operatrice di un comune si-tuato nello stesso territorio di un’amministrazione che, in un momento precedente, aveva emanato un’ordinanza molto discussa, molti provvedimenti “copia-incolla” rispondono soltanto a una logica di imitazione, orientata a evitare potenziali critiche da parte della po-polazione locale, la quale potrebbe rimproverare al primo cittadino di non aver fatto nulla per affrontare l’“emergenza” immigrazione54.
In questi casi, la posta in gioco delle strategie di esclusione – soltanto minacciate – è di tipo meramente politico-elettorale. Il che non significa, tuttavia, che gli effetti di esclusio-ne non possano comunque diventare in qualche maniera reali. Il solo fatto che alcune mi-sure siano annunciate può contribuire concretamente a produrre distinzioni. Per tracciare un confine, del resto, non sempre è necessario incidere un segno o un solco ma «può ba-stare nominarlo, dirlo» (Cella, 2006, p. 206), a patto che a farlo siano soggetti autorizzati, vale a dire individui a cui è conferita una specifica autorità in materia. Le ordinanze, le circolari e le delibere, dunque, in quanto emanate da soggetti a cui è riconosciuta una le-
53 Sebbene infatti il Tu sull’immigrazione (co. 7, art. 4) e il regolamento attuativo dello stesso (D.p.r. n. 394/1999, al co. 2, art. 42) prescrivano che, in assenza della residenza, il cittadino straniero possa effettuare l’iscrizione dichiarando semplicemente il luogo di effettiva dimora, una circolare emanata successivamente dal Ministero della sanità (la n. 5 del 2000) sembra consentire l’uso del domicilio indicato sul permesso sol-tanto per la prima iscrizione o per alcune categorie (stagionali, lavoro a tempo determinato con contratto di durata inferiore ad un anno, studenti e collocati alla pari). Insomma, se non per l’iscrizione in senso stretto, la residenza sembra essere necessaria quantomeno per il mantenimento della stessa. Se dal piano delle nor-me e delle circolari si passa poi a quella della gestione effettiva delle procedure, il quadro si fa ancora più complesso: dall’analisi di numerosi siti di distretti sanitari e dai colloqui telefonici con gli operatori di alcuni di questi distretti, emerge come la chiarezza sulle modalità di iscrizione sia scarsa. Tali modalità, infatti, cambiano al variare del territorio (in alcuni casi, ad esempio, in alternativa alla residenza non è sufficiente l’indirizzo indicato nel permesso di soggiorno ma è necessario presentare una dichiarazione di ospitalità). 54 Il che spiega, almeno in parte, la presenza di clusters di comuni in territori contigui che hanno emanato ordinanze identiche.
20
gittimità politica – nonostante questi soggetti agiscano al di fuori dei limiti tracciati dalla legge –, possono produrre effetti performativi sulla realtà sociale anche quando sono inat-tuate, veicolando discorsi e diffondendo visioni contenenti, più o meno implicitamente, categorizzazioni negative circa alcuni gruppi di individui. Questi provvedimenti e questi atti, dunque, istituendo differenze, costituiscono strumenti politici in grado di creare bar-riere entro cui riconoscersi e difendersi e oltre le quali «esiliare gli indesiderati e combat-tere i nemici» (Colombo 2006, 282), a prescindere – è opportuno ripeterlo – dal loro grado di attuazione. In quanto fortemente pubblicizzati, inoltre, questi strumenti possono agire come deterrenti nei confronti di chi intende registrarsi come residente, scoraggiando in partenza coloro che, a norma di legge, avrebbero diritto all’iscrizione ma che, per evitare problemi e ulteriori stigmatizzazioni, preferiscono rinunciare alla residenza evitando di presentarsi agli uffici anagrafici e rimanendo così, nei confronti delle amministrazioni comunali, nella condizione di “fantasmi”.
Molto spesso, tuttavia, la posta in gioco delle strategie di esclusione dalla residenza non è soltanto di tipo politico-elettorale ma è anche di tipo politico-sostanziale. Queste strate-gie, in altre parole, possono avere come obiettivo una ridefinizione materiale dei confini della comunità locale, della polity comunale. A riguardo, i meccanismi impiegati possono essere di tipo esplicito – come si è visto in precedenza, alcune amministrazioni locali non riconoscono la residenza appellandosi formalmente alla mancanza di requisiti previsti da ordinanze o circolari – ma soprattutto di tipo implicito o di tipo “misto” (qualora cioè le forme implicite di rifiuto, dirette o indirette, siano portate avanti richiamando provvedi-menti o misure esplicite).
Quando la posta in gioco è di tipo politico-elettorale, dunque, la visibilità e la pubblici-tà sono il punto di forza delle strategie di esclusione dalla residenza. Per contro, quando a essere in ballo è il controllo dei confini materiali della popolazione locale l’agire nell’ombra è una risorsa fondamentale. L’opacità dei meccanismi – il fatto che la “scato-la” che li governa sia, se non del tutto nera, quanto più possibile scura – e la segretezza di molte fasi dei procedimenti e delle prassi – spesso, neanche ai diretti interessati è dato sa-pere, fino in fondo, cosa veramente abbia prodotto la loro esclusione – favoriscono l’uso di un potere che si qualifica chiaramente come arbitrario55.
In questi casi, l’esclusione simbolica – comunque già presente, almeno potenzialmente, anche laddove la posta in gioco sia di tipo politico-elettorale – è seguita da vicino da un’esclusione di tipo materiale, il cui esito è la distinzione tra cittadini locali riconosciuti e non riconosciuti, legittimi e “illegittimi”, e, come conseguenza, il restringimento dei bene-ficiari di un vasto insieme di diritti. Questo restringimento incide sulla sfera politica, ren-dendo ineffettivo il diritto di voto di quei cittadini italiani e di quei cittadini comunitari56
55 Sulla scarsa visibilità e l’informalità di atti, provvedimenti e procedimenti amministrativi che condiziona-no i diritti dei migranti, una prospettiva interessante, che parte dell’analisi delle circolari in materia di immi-grazione per arrivare poi a una teoria più ampia dell’ infra-diritto di prossimità, è quella offerta da Gjergji, 2013. Per un ragionamento più ampio e analitico sulle varie forme e figure che il potere arbitrario può assu-mere si rimanda invece a Cuono, 2013. 56 Ovviamente, con riferimento esclusivo alle elezioni europee e a quelle locali.
21
che non sono riconosciuti come residenti dall’amministrazione del comune in cui di fatto vivono. Ma incide anche, come già anticipato, sulla sfera sociale, ostacolando, ad esem-pio, l’accesso a numerose prestazioni e servizi socio-assistenziali e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e limitando una piena fruizione del servizio sanitario nazionale. Inol-tre, condiziona la sfera economica, producendo effetti sul mercato del lavoro locale e sulla possibilità, da parte soprattutto dei non cittadini, di avviare attività imprenditoriali, dato che i lunghi percorsi burocratici necessari a tal proposito sono resi ancora più impervi dal-la mancanza della residenza.
Quando la posta in gioco è data dai confini materiali, dunque, il conflitto sulla residen-za riguarda direttamente la possibilità di ottenere effetti di regolazione sulla popolazione comunale e, più in generale, sui sistemi socio-economici locali. In altre parole, il controllo sulle procedure di iscrizione anagrafica si configura nuovamente come uno strumento di governamentalità. La logica a cui lo strumento risponde, però, non è più quella del con-trollo inteso come monitoraggio, ottenibile – come si è visto – quando il dovere all’iscrizione è ottemperato da parte dei singoli individui e, soprattutto, delle amministra-zioni locali, così da garantire la corrispondenza tra presenti di fatto e residenti di diritto, ma quella del controllo inteso come selezione57, conseguibile, al contrario, soltanto se si impedisce una tale corrispondenza.
La logica della selezione può avere un duplice obiettivo. Il primo è ottenere la separa-zione spaziale tra presenti indesiderati e residenti riconosciuti e legittimi58, spingendo gli esclusi ad allontanarsi dal territorio comunale. Questo genere di esclusione, tuttavia, può diventare effettiva soltanto indirettamente59. I sindaci, infatti, sebbene abbiano visto in-crementare i propri poteri negli ultimi anni60, non godono dell’autorità necessaria ad allon-tanare dal territorio comunale coloro a cui la residenza è rifiutata. Il secondo, e più prati-cabile, è conseguire una redistribuzione asimmetrica dei diritti legati alla residenza61, così
57 Per un approfondimento della logica della selezione e delle sue modalità si rimanda a Gargiulo, 2014a. 58 In passato, la negazione della residenza era spesso l’anticamera dell’allontanamento dal territorio di un dato comune: al rifiuto dell’iscrizione – riservata a persone che potessero dimostrare di avere un lavoro nel centro urbano in cui volevano trasferirsi – faceva spesso seguito il foglio di via comminato dai prefetti (su questo punto, cfr. Gallo 2011). 59 Sulla possibilità di condizionare indirettamente i movimenti delle persone si rimanda a Gargiulo, 2014b e, con riferimento a contesti diversi da quello italiano, ad alcuni saggi compresi in Varsanyi, 2010. 60 Nello specifico, la già citata legge n. 125/2008, aggiungendo all’art. 54 del TUEL il co. 5 bis, ha istituto un nesso, seppur indiretto, tra la segnalazione dei sindaci e l’espulsione di soggetti ritenuti pericolosi: l’amministratore locale può segnalare alle competenti autorità «la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedi-menti di espulsione o di allontanamento dal territorio Stato». Ai sindaci, inoltre, è stata riconosciuta dal già citato decreto 30 del 2007 la possibilità di segnalare alle prefetture e al Ministero dell’interno i cittadini co-munitari che rappresentano un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico o che non si trovano più nelle condizioni necessarie per avere diritto al soggiorno: i provvedimenti di allontanamento per i due differenti ordini di ragioni possono essere adottati dalle autorità competenti sulla base di segnalazioni provenienti dal sindaco del luogo di residenza o di dimora dell’interessato. I sindaci, tuttavia, sono chiamati a segnalare la condizione di irregolarità dei cittadini comunitari ma non a “certificarla”. Il loro ruolo, dunque, dovrebbe essere esclusivamente consultivo: il potere di “certificazione”, infatti, è di competenza esclusiva del Prefetto (Patriarca, 2009). 61 Il fatto che la redistribuzione avvenga attraverso procedure informali o atti monocratici illegittimi, inoltre, solleva molti dubbi sulla sua democraticità: le decisioni sull’allocazione dei diritti sociali – e quindi sul wel-
22
da contenere i costi della spesa sociale, consolidare i rapporti con la base elettorale costi-tuita dai “veri” cittadini locali e, infine, porre in una condizione di svantaggio giuridico e materiale gli esclusi che non vogliono – o che pur volendo non possono – allontanarsi dal territorio in cui non sono riconosciuti formalmente62. Il che induce a ipotizzare che l’esclusione spaziale, oltre a essere un obiettivo difficile da conseguire, sia anche, da un certo punto di vista, un risultato poco desiderabile: il fatto che siano collocati in una posi-zione di minorità rende infatti questi soggetti più docili e gestibili nel mercato del lavoro locale. Includere i soggetti indesiderati in maniera parziale e differenziale dal punto di vi-sta giuridico e socio-economico, insomma, può essere una scelta conveniente, sia dal pun-to di vista meramente politico-strategico sia dal punto di vista economico.
In sintesi, le strategie di esclusione dalla residenza – ossia le politiche di residenza – costituiscono una categoria particolare nell’ambito delle politiche locali di esclusione: agendo direttamente su un diritto civile ma indirettamente su un vasto insieme di diritti, si configurano come iniziative multidimensionali e, dunque, trasversali alle altre politiche (soprattutto rispetto a quelle orientate all’esclusione sociale, economica e securitaria). Tali iniziative, nello specifico, tracciano un primo confine tra cittadini locali legittimi e “ille-gittimi” – i quali possono essere non soltanto stranieri, ma anche italiani63 – e, in virtù di questo confine, disegnano numerose altre barriere (a livello sociale, economico, lavorati-vo, ecc.). Per questa ragione, i tentativi di negare l’iscrizione anagrafica, quando sono effi-caci, acuiscono la stratificazione civica.
Per comprendere meglio tale stratificazione è utile analizzare gli effetti che i meccani-smi di esclusione dalla residenza possono produrre su coloro che, avendone diritto, deci-dono di richiedere l’iscrizione64. Questi meccanismi, infatti, sono in grado di frammentare la prima e basilare dicotomia tra cittadini e non cittadini. I due poli di questa dicotomia, più in dettaglio, si sdoppiano nel momento in cui alcuni degli aventi diritto sono ricono-sciuti come residenti mentre altri, illegittimamente, non lo sono. Ne deriva una tipologia composta da quattro tipi diversi di status: i cittadini riconosciuti come residenti; i non cit-
tadini riconosciuti come residenti; i cittadini non riconosciuti come residenti; i non citta-
dini non riconosciuti come residenti. Esaminando più da vicino i quattro status, è possibile individuare le caratteristiche che
li distinguono l’uno dall’altro. Il primo status è costituito dai “buoni” cittadini: ossia da quegli italiani che presentano un insieme di tratti tali da renderli socialmente accettabili
fare –, che dovrebbero essere prese da organismi quali i consigli comunali, sono prese in questo caso da or-ganismi non preposti a questa funzione e con metodi non democratici, ossia senza votazione e senza alcuna forma di contradditorio politico (su questo punto, cfr. Ambrosini e Caneva, 2012). 62 Le persone escluse dalla residenza, dunque, si trovano in una condizione simile a quella descritta da Nico-la Negri: dipendono da una data società – poiché a questa è legata la loro sussistenza – pur non essendone riconosciute come parte integrante (1990, p. 6). 63 In questo senso, realizzano una sorta di “democratizzazione” dell’esclusione: considerando un dato territo-rio comunale, lo status degli italiani non residenti è per certi versi più vicino a quello degli stranieri regolari e riconosciuti che non a quello degli italiani residenti. 64 Ossia, su quei cittadini italiani e quei non cittadini in regola con i requisiti richiesti per il soggiorno che dimorano abitualmente nel comune in cui chiedono l’iscrizione.
23
(ad esempio, non sono percepiti, né giuridicamente etichettati, come “socialmente perico-losi” e dispongono di un alloggio adeguato a determinati standard). Il secondo status è composto invece dai non cittadini “accettabili” (quantomeno giuridicamente): cittadini comunitari e stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti e dotati di determinate caratteristiche socio-economiche e culturali. Il terzo status è costituito dai cittadini indesi-
derati: italiani esclusi dalla residenza perché presentano tratti non graditi, spesso in quanto appartengono alle popolazioni romanì, sono senza fissa dimora oppure hanno precedenti penali. Il quarto e ultimo status è costituito dai non cittadini regolari ma “illegittimi” (Gargiulo, 2014b): individui che, sebbene autorizzati al soggiorno dalle leggi italiane, non sono tuttavia riconosciuti a livello comunale in quanto privi – a detta delle amministrazio-ni locali – di caratteristiche ritenute necessarie.
Dunque, tra coloro che, avendone diritto, si recano presso gli uffici anagrafici richie-dendo l’iscrizione, soltanto quelli che rivestono uno dei primi due status possono essere considerati cittadini locali, mentre gli altri appaiono come non cittadini locali.
Tabella n. 265 – tipologia della popolazione locale avente diritto all’iscrizione per cit-tadinanza e residenza
Cittadini Non cittadini
Riconosciuti come residenti
“buoni” cittadini non cittadini “accettabili”
Non riconosciuti come residenti
cittadini indeside-rati
non cittadini regolari ma “illegittimi”
La frammentazione degli status dovuta alle scelte illegittime di alcune amministrazioni
locali, tuttavia, non si ferma qui. Se ci si concentra sulla riga inferiore della tabella n. 2, quella dei non cittadini locali, emerge un nuovo sdoppiamento. Coloro che non sono rico-nosciuti come residenti da una data amministrazione comunale, infatti, possono essere iscritti all’anagrafe di un altro comune italiano o, al contrario, essere privi di una qualsi-voglia iscrizione.
65 Questa tipologia, mirando a illustrare gli effetti dei meccanismi di esclusione su coloro che hanno diritto all’iscrizione (ed effettivamente la richiedono), non ha come obiettivo quello di individuare tutti i tipi possi-bili di persone che fanno parte di una popolazione comunale. Sono esclusi ad esempio, per ovvi motivi, co-loro che non hanno diritto all’iscrizione – i non cittadini irregolari o i non cittadini regolari ma soggiornanti per brevi periodi – così come coloro che, pur avendo diritto all’iscrizione, decidono di non recarsi presso gli uffici anagrafici per dichiarare la propria posizione, sebbene dovrebbero farlo per legge. Per una tipologia orientata invece a individuare, con riferimento alla sola popolazione straniera, tutti i tipi possibili di persone presenti sul territorio, cfr. Busso, 2007, p. 450. L’autore traccia qui, incrociando la variabile dicotomica “iscrizione in anagrafe” con la variabile a tre modalità “permesso di soggiorno”, uno schema estremamente dettagliato della situazione.
24
Tabella n. 3 – categorie di non riconosciuti come residenti
iscritti altrove non iscritti altrove
Non ricono-sciuti come re-sidenti
non-cittadini locali “apolidi comunali”
La prima categoria può essere composta da cittadini italiani che mantengono
l’iscrizione nel comune di nascita o in quello in cui hanno vissuto in precedenza così come da non cittadini (comunitari ed extracomunitari) che hanno già fatto ingresso in Italia e ot-tenuto la residenza altrove prima di spostarsi nel comune da cui non sono riconosciuti. La seconda categoria, invece, può vedere comunque la presenza di cittadini italiani – se nati all’estero e trasferitisi successivamente in Italia – ma è costituita soprattutto da non citta-dini che entrano per la prima volta nel territorio italiano66. Chiaramente, i non residenti non iscritti altrove sono comunque più vulnerabili dei non residenti iscritti altrove: questi ultimi, a differenza dei primi, possono quantomeno fare affidamento, per il soddisfacimen-to di alcuni bisogni, al territorio comunale in cui (paradossalmente, dato che di fatto vivo-no stabilmente altrove) risultano ancora formalmente iscritti67; in questo senso, i primi rappresentano l’equivalente a livello locale dei non cittadini, mentre i secondi assomiglia-no in maniera drammatica agli apolidi.
Infine, gli effetti che le strategie di esclusione dalla residenza sortiscono sul sistema di stratificazione possono essere osservati in maniera ancora più dettagliata tornando alla ta-bella n. 2 e focalizzando l’attenzione sulla seconda e sulla quarta cella, occupate, rispetti-vamente, dai non cittadini riconosciuti come residenti e dai non cittadini non riconosciuti
come residenti. Per effetto di queste strategie, infatti, individui che dispongono dello stes-so titolo di soggiorno finiscono per occupare posizioni diverse: coloro che sono ricono-sciuti come residenti (e che occupano la seconda cella) sono collocati più in alto, mentre coloro a cui il riconoscimento è negato (e che occupano la quarta cella) sono collocati più in basso nel sistema di stratificazione, pur trovandosi in una condizione di parità per quan-to attiene allo status legale. Ne consegue uno sdoppiamento di buona parte degli status con cui un non cittadino può essere legato all’ordinamento italiano: ad esempio, la posizione dello straniero lungo-residente – del denizen in senso stretto – oppure quella del non citta-dino titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato si scindono, rispettiva-mente, in due: i regolari e riconosciuti da una parte e i regolari ma “illegittimi” dall’altra.
66 Gli elenchi dei tipi di individui riconducibili alle due categorie intendono essere meramente esemplificati-vi e non esaustivi: senza dubbio, possono essere presenti altre situazioni e condizioni qui non riportate (a ri-guardo, la condizione degli italiani iscritti all’Aire che, dopo molti anni di soggiorno all’estero, intendono rientrare in Italia andrebbe considerata attentamente). 67 Ovviamente, se il comune di residenza anagrafica è situato a una distanza ragguardevole, la differenza tra le due categorie di individui tende a essere più formale che sostanziale. Inoltre, tale comune potrebbe anche svolgere accertamenti circa la presenza degli interessati e, qualora tali accertamenti fossero negativi, potreb-be decidere di cancellarli, ritenendo che, di fatto, essi vivano altrove.
25
Considerazioni conclusive Come si è cercato di mostrare in questo paper, gli effetti che le strategie di esclusione
dalla residenza possono produrre sul sistema di stratificazione civica e, di conseguenza, sulle forme di cittadinanza poststatale o trans-statale sono notevoli. In particolare, il rifiuto dell’iscrizione anagrafica è in grado di depotenziare i diversi status con cui un individuo può essere riconosciuto dall’ordinamento giuridico italiano, svuotando queste posizioni formali dei diritti a loro connessi. La residenza, pertanto, rischia di diventare un nuovo re-cinto, trasversale a quello costituito dalla cittadinanza: se quest’ultima, riprendendo le pa-role di Luigi Ferrajoli, costituisce l’ultimo «privilegio di status» (Ferrajoli, 1994, p. 288), la condizione di residente può trasformarsi in un nuovo privilegio di status.
Le modalità con cui la residenza viene trasformata in uno strumento di esclusione, inol-tre, costituiscono, a prescindere dagli effetti concreti che possono produrre, una minaccia per la democrazia: l’uso sistematico e spregiudicato di strumenti amministrativi e di prassi burocratiche in luogo dell’applicazione delle norme, giustificato attraverso una retorica securitaria e un richiamo continuo a emergenze quasi sempre immaginarie, produce una pericolosa normalizzazione dell’eccezione68. Il sapere messo in campo dagli attori comu-nali, facendo ampio ricorso alla misura e rifiutando spesso di sottostare al metro della leg-ge, finisce dunque per assomigliare, in maniera preoccupante, al sapere della polizia69.
Quanto agli effetti dei meccanismi di esclusione dalla residenza, il mancato riconosci-mento dell’iscrizione anagrafica, come si è visto, ostacolando l’accesso ai diritti e contri-buendo alla costruzione simbolica e materiale dell’altro, può impattare negativamente sull’integrazione dei non cittadini, incidendo sulle relative politiche70 e condizionandone materialmente i processi. Tuttavia, le strategie analizzate in questo paper, nonostante le lo-ro finalità chiaramente escludenti e contrariamente alle intenzioni di chi se ne fa promoto-re, potrebbero produrre alcuni effetti positivi, attivando o riattivando legami sociali a livel-lo locale e dando così concretezza, paradossalmente, alle dimensioni “sostanziali” della cittadinanza locale. Proprio attraverso la comune opposizione alle politiche di residenza, infatti, è possibile che si consolidi un senso di appartenenza alla comunità territoriale. Per-ché ciò accada, però, sono necessari alcuni passaggi: in primo luogo, deve essere aumenta-to il livello di consapevolezza dei propri diritti da parte dei singoli “cittadini locali”, che devono parallelamente sviluppare una maggiore conoscenza circa i meccanismi dell’esclusione71; in secondo luogo, è necessario migliorare la promozione delle reti (Am-brosini, 2013b) tra gli attori coinvolti nel contrasto alle politiche di residenza, favorendo un ruolo più attivo da parte dei politici locali e una comunicazione più diretta e articolata tra soggetti esclusi e organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti, ma anche tra 68 Su questo punto, cfr. anche Ferrajoli, 2010 e Gjergji, 2013. 69 Per un’analisi del rapporto tra misura e leggi nel sapere della polizia si rimanda a Napoli, 2009. 70 A riguardo, si rimanda a Gargiulo, 2014a. 71 Costruendo quindi, come suggerito da Morozzo della Rocca, «una maggiore cultura della forma nel pro-cedimento amministrativo» (2006).
26
gli ormai numerosi ricercatori che, da prospettive disciplinari diverse o all’interno della stessa area di ricerca, si occupano del tema.
Riferimenti bibliografici Algostino A., 2008, Il “pacchetto sicurezza”, gli stranieri e la Costituzione. Prime no-
te, in «Forum costituzionale», disponibile all’indirizzo: http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/diritti_liberta/0006_algostino.pdf.
Ambrosini M., 2012, Separati in città. Le politiche locali di esclusione degli immigrati,
in «La Rivista delle Politiche Sociali», 1, pp. 69-88 – 2013a, “We are against a multi-ethnic society”: policies of exclusion at the urban
level in Italy, in «Ethnic and Racial Studies», 36, 1, pp. 136-155. – 2013b, Fighting discrimination and exclusion: Civil society and immigration policies
in Italy, in «Migration letters», 10, 3, 313-323. Ambrosini M. e Caneva E., 2012, Local policies of exclusion: the Italian case, Accept
Pluralism Project, Seventh EU Framework Programme, European University Institute, disponibile all’indirizzo: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/22317.
Andrisani P. e Naletto G. (a cura di), 2009, Cronache di ordinario razzismo, in Naletto
G., Rapporto sul razzismo, op. cit.
Basso P. (a cura di), 2010, Razzismo di stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Milano, Fran-
coAngeli. Bauböck R., 1994, Transnational Citizenship, Edward Elgar, Aldershot. Biondi Dal Monte F., 2008, Immigrazione e welfare: condizioni di accesso e principio
di non discriminazione, in «Le Regioni», 6, pp. 1099 ss. – Welfare, immigrazione e non discriminazione. Quando i diritti costruiscono
l’integrazione, paper presentato in occasione del convegno ESPAnet Italia dal titolo Inno-
vare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa, disponibile all’indirizzo http://www.espanet-italia.net/conferenza2011/session-16.php.
27
Bontempelli S., 2009, “Ordinanza pazza” . I Sindaci e il versante grottesco del razzi-
smo, in Naletto G., Rapporto sul razzismo, op. cit.
Bosniak L., 2001, Denationalizing Citizenship, in Aleinikoff T.A. e Klusmeyer D., Cit-
izenship Today. Global Perspectives and practices, Washington DC, Carnegie Endow-ment for International Peace.
Bosniak L., 2007, Varities of Citizenship, in «Fordham Law Review», n. 5, pp. 2449-
2453. Bourdieu P., 1988, La parola e il potere. L’economia degli scambi linguistici, Napoli,
Guida. – 2010, Sul concetto di campo in sociologia, Roma, Armando. Brochmann G., 1999, The Mechanisms of Control, in Brochmann G. e Hammar T. (a
cura di), Mechanisms of Immigration Control. A Comparative Analysis of European Regu-
lation Policies, Berg, Oxford-New York.
Busso S., 2007, Basi informative e politiche di integrazione per gli immigrati, in «Stato
e mercato», 81, pp. 441-473. Cammarata R. e Monteleone R., 2014, La sicurezza al tempo delle ordinanze. Potere
locale e discorso pubblico, in La ragione politica. 2. I discorsi delle politiche, Napoli, Li-guori.
Campo G., 2007, Cittadella e dintorni, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 4, pp.
63-69.
Campomori F., 2007, Il ruolo di policy-making svolto dagli operatori dei servizi per gli
immigrati, in «Mondi migranti», 3, pp. 83-106. Caponio T., 2013, Il quadro normative nazionale e internazionale, in Saraceno C., Sar-
tor N. e Sciortino G. (a cura di), op. cit., pp. 39-60. Cella G.P., 2006, Tracciare confini. Realtà e metafore della distinzione, Bologna, Il
Mulino. Cittalia, 2009, Oltre le ordinanze: I sindaci e la sicurezza urbana. Roma, Anci (Asso-
cia-zione nazionale comuni italiani).
28
Colombo E., 2006, Multiculturalismo quotidiano. Verso una definizione sociologica
della differenza, in «Rassegna italiana di Sociologia», 47, 2, pp. 269-296. Cuono M., 2013, Decidere caso per caso. Figure del potere arbitrario, Madrid-
Barcellona-Buenos Aires-San Paolo, Marcial Pons. De Graw E., 2014, Municipal ID Cards for Undocumented Immigrants: Local Bureau-
cratic Membership in a Federal System, in «Politics & Society», 42, 3, pp. 309-330. Dinelli F., 2010, La stagione della residenza: analisi di un istituto giuridico in espan-
sione, in «Diritto Amministrativo», 18, 3, pp. 639-708. – Le appartenenze territoriali. Contributo allo studio della cittadinanza, della residen-
za e della cittadinanza europea, Jovene, Napoli.
Ferrajoli L., 1994, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona, in Zolo D. (a cura
di), 1994, La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, Roma-Bari, Laterza. – 2010, Politiche contro gli immigrati e razzismo istituzionale in Italia, in Basso P. (a
cura di), op. cit. Ferrero M., 2010, Il “pacchetto sicurezza”: dall'integrazione subalterna degli immi-
grati alla loro criminalizzazione, in Basso P. (a cura di), op. cit. Gallo S., 2011, Senza attraversare le frontiere. Le migrazioni interne dall’Unità a oggi,
Laterza, Roma-Bari.
Gargiulo E., 2008, L’inclusione esclusiva. Sociologia della cittadinanza sociale, Mila-
no, FrancoAngeli. – 2011a, Localizzazione dei diritti o localismo dell’appartenenza? Abbozzo di una teo-
ria della residenza, «SocietàMutamentoPolitica», 2, 3, pp. 241-261. – 2011b, Welfare locale o welfare localistico? La residenza anagrafica come strumento
di accesso ai, o di negazione dei, diritti sociali, paper presentato in occasione del Conve-gno ESPAnet Italia dal titolo Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in
Europa, (Milano, Politecnico di Milano). – 2012, L’“emergenza” dell’esclusione: populismo e controllo locale
dell’immigrazione nel contesto italiano, in «La rivista delle politiche sociali», 9, 1, pp. 89-116.
29
– 2013, Le politiche di residenza in Italia: inclusione ed esclusione nelle nuove cittadi-
nanze locali, in Rossi E., Biondi Dal Monte F. e Vrenna M., La governance
dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Bologna, Il Mulino. – 2014a, Integrazione o esclusione? I meccanismi di selezione degli immigrati tra livel-
lo statale e livello locale, in «Diritto immigrazione e cittadinanza», n. 1, pp. 41-62. – 2014b, Residenza, anagrafe, cittadinanza: la migrazione interna come questione so-
cio-giuridica nell’Italia di oggi, in Colucci M. e Gallo S., Rapporto sulle migrazioni in-
terne in Italia. Edizione 2014, Rona, Donzelli. Gili L., Dragone A. e Bonetti P., Assistenza sanitaria per gli stranieri non comunitari ,
scheda pratica dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, disponibile all’indirizzo: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/scheda.salute.14.12.2012.pdf.
Giovannetti M., 2012, Le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana e
l’impatto sui territori, in Galdi A. e Pizzetti F. (a cura di), 2012, I sindaci e la sicurezza
urbana. Le ordinanze sindacali e i loro effetti, Donzelli, Roma. Gjergji I., 2013, Circolari amministrative e immigrazione, Milano, FrancoAngeli. Gorlani M., 2006, Accesso al welfare state e libertà di circolazione: quanto «pesa» la
residenza regionale?, «Le Regioni», 34, 2-3, pp. 345-362. Granaglia E. e Rigo E., 2013, Eccesso di disuguaglianze?, in Saraceno C., Sartor N. e
Sciortino G. (a cura di), op. cit., pp. 339-364. Guariso A. (a cura di), 2012, Senza distinzioni. Quattro anni di contrasto alle discrimi-
nazioni nel Nord Italia, Associazione Avvocati per Niente Onlus. Hammar T., 1989, State, Nation and Dual Citizenship, in Brubaker W.R. (a cura di),
Immigration and The Politics of Citizenship in Europe and North America, Lanham, Uni-versity press of America.
Hoffman J., 2004, Citizenship beyond the state, London, Sage. Istat, 1992, Anagrafe della popolazione. Legge e regolamento anagrafico, serie B, n.
29, supplemento all’«Annuario statistico italiano».
30
Istat (a cura di Ettore M.G., Silvestrini A. e Cariello S.), 2010, Guida alla vigilanza
anagrafica, Roma, Istituto nazionale di statistica. Jacobson D.,1996, Rights Across Borders. Immigration and the Decline of Citizenship,
London, The John Hopkins University Press. Lipsky M., 1980, Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Ser-
vices, Russell Sage Foundation, New York.
Lorenzetti A., 2009, Il difficile equilibrio fra diritti di libertà e diritto alla sicurezza, in
A. Lorenzetti e S. Rossi (a cura di), Le ordinanze sindacali in materia di sicurezza pubbli-
ca e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti, Jovene, Napoli.
Manconi L. e Resta F., 2010, La xenofobia municipale, in «Mondi migranti», 2, pp.
321-331. Manfredi G., 2013, Poteri di ordinanza, legalità, “stato governativo”, in «Amministra-
re», 43, 3, pp. 407-427. Mariani F., 2010, Iscrizione anagrafica e domiciliation: un breve confronto tra le
istanze di sicurezza italiane e le esigenze di coesione sociale francesi, in «Diritto, immi-grazione e cittadinanza», 12, 1, pp. 78-97.
Morozzo della Rocca P., 2003, Il diritto alla residenza: un confronto tra principi gene-
rali, categorie civilistiche e procedure anagrafiche, in «Il diritto di famiglia e delle perso-
ne», n. 4, pp. 1013-ss.
– 2006, I diritti anagrafici degli stranieri, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», n.
1, pp. 54-71.
Morris L., 2002, Managing Migration: Civic Stratification and Migrants’ Rights,
Routledge, London and New York.
Naletto G. (a cura di), 2009, Rapporto sul razzismo in Italia, Manifestolibri, Roma.
Napoli P., 2009, Misura di polizia. Un approccio storico-concettuale in età moderna,
in «Quaderni storici», 44, 2, pp. 523-547.
31
Negri N., 1990, Saggi sull’esclusione sociale. Povertà, malattie, cattivi lavori e que-
stione etnica, Torino, Il Segnalibro. Olivetti L. e Bonetti P., 2012, Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo, scheda pratica dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, disponi-bile all’indirizzo: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/scheda_permesso_ce_olivetti.18_2_2012.rev_.bonetti.pdf.
Paggi M., 2007, Il ricorso gerarchico contro l’Ordinanza del Sindaco di Cittadella
(PD), disponibile all’indirizzo: http://www.meltingpot.org/articolo11747.html.
Palidda S., 2000, Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale, Milano,
Feltrinelli. Penninx R. e Martiniello M., 2007, Processi di integrazione e politiche (locali): stato
dell’arte e lezioni di policy, in «Mondi migranti», 3, pp. 31-59. Perin G. e Bonetti P. (a cura di), 2012, Allontanamento dei cittadini dell’unione euro-
pea e dei loro familiari e tutele giurisdizionali, scheda pratica dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, disponibile all’indirizzo: http://www.asgi.it/wp-con-tent/uploads/public/allontanamento.cittadini.dell.ue.e.loro.familiari.23.febbraio.2012.perin.corr.bonetti.marzo.2012.pdf.
Petrarca N., 2009, Il matrimonio del cittadino comunitario ed extracomunitario dopo
l’entrata in vigore della Legge n. 94/2009, presentazione in occasione della Tavola roton-da su Legge 94/2009: novità per gli Ufficiali di anagrafe e stato civile, Riccione, Conve-gno nazionale Anusca.
Pitch T., 2013, Contro il decoro. L’uso politico della pubblica decenza, Laterza, Roma-
Bari. Procacci G., 2009, Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione, in
«Rassegna italiana di sociologia», n. 3, pp. 409-432. Rigo, E., 2007, Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell’Unione al-
largata, Roma, Meltemi. Salvini N., 1999, Quando la discriminazione viene dai sindaci, in «Questione giusti-
zia», 2.
32
Saraceno C., Sartor N. e Sciortino G. (a cura di), Stranieri e disuguali. Le disugua-
glianze nei diritti e nelle condizioni di vita degli immigrati, Bologna, Il Mulino. Simone A., 2010, I corpi del reato. Sessualità e sicurezza nelle società del rischio,
Mimesis, Milano. Soysal Y.N., 1994, Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in
Europe, Chicago, University Press.
Spinaci S., 2011, Libertà di circolazione, cittadinanza europea, principio di eguaglian-
za, Napoli, Jovene. Strumia F., 2013, La duplice metamorfosi della cittadinanza europea. Da cittadinanza
sedentaria a cittadinanza itinerante. Da cittadinanza sociale a cittadinanza economica, Napoli, Jovene.
Usai A., 2011, Diritti sociali negati. Un’indagine sulle ordinanze comunali, in E. Be-
sozzi (a cura di), Immigrazione e contesti locali, Milano, Vita e Pensiero. Varsanyi M.W. (a cura di), 2010, Taking local control. Immigration and policy activ-
ism in U.S. cities and states, Stanford University Press, Stanford, California.
Vrenna M., 2003, Rapporti tra stranieri e anagrafe: spunti problematici, in «Gli stra-
nieri», n. 4.
Zanfrini L., 2010, I “confini” della cittadinanza: perché l’immigrazione disturba, in
«Sociologia del lavoro», n. 117, pp. 40-56. Zincone G., 2000a, Cittadinanza e processi migratori: tesi sulle trasformazioni e i con-
flitti , in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», n. 2, pp. 44-56. – 2000b, Cittadinanza: trasformazioni in corso, in «Filosofia politica», n. 1, pp. 71-98. Zolo D., 2000, Cittadinanza. Storia di un concetto teorico-politico, in «Filosofia politi-
ca», 1, pp. 5-18. Zorzella N., 2008, I nuovi poteri dei sindaci nel pacchetto sicurezza e la loro ricaduta
sugli stranieri, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 3-4, pp. 57-73.