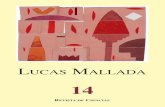Le spiagge fossili delle Arenarie di Aren (Cretacico superiore) nella Valle Noguera Ribagorzana...
Transcript of Le spiagge fossili delle Arenarie di Aren (Cretacico superiore) nella Valle Noguera Ribagorzana...
Jttn •. Soc. Gt~l. lt .. 13 (1974) , 497-687, 28 ff., 1 t .. .,
LE SPIAGGE FOSSILI DELLE ARENARIE DI AREN CCRETACICO SUPERIORE)
NELLA VALLE NOGUERA RIBAGORZANA (PIRENEI CENTRO-MERIDIONALI,
PROVINCE DI LERIDA E HUESCA, SPAGNA) c•J
Memoria dei Soci G. GHIBAUDO (**), E. MuTTI (**) & J. RosELL (***)
(presentata a Roma nella Seduta Scientifica del 12 luglio 1974)
Riassunto Summary Resumen
INDICE
l . Introduzione e scopo del lavoro 2. Stratigrafia ed interpretazione ambientale
2.1. Studi precedenti ed inquadramento geologico 2.2. Metodi di studio 2.3. Risultati e conclusioni .
2.3.1. Premessa . 2.3.2. Quadro stratigrafìco-deposizionale 2.3.3. l depositi litorali delle Arenarie di
Aren s.s . . 3. Descrizione delle facies
3.1. Depositi di spiaggia ed associati sedimenti eolici . 3.1.1. Depositi eolici e di retrospiaggia 3.1.2. Depositi di battigia . 3 .1.3. Depositi di spiaggia esterna 3.1.4. Depositi di transizione
3.2. Depositi pelitici di piattaforma 3.3. Depositi Jagunari 3.4. Depositi di marea .
3.4.1. Depositi intertidali e subtidali 3.4.2. Depositi di delta di marea 3.4.3. Depositi di bocca di marea
3.5. Depositi torbiditici 4. Bibliografia .
R IASSUNTO
pag. 497 }) 497
>> 4U8 >> 499 >> 499 >> 499 >> 500
>> 502 >> 502
>> 504
>> 512 >> 515
>> f>15 >> 5i5 >> 519 >> 519
>> 523 >> 526
>> 528
>> 528 >> 528 >> 531 >> 531 >> 535 >> 535
Jl lavoro compendia i risultati di ricerche condotte tra il 1972 ed il. 1973 su depositi litorali tardocretacici della zona sud-pirenaica e sui sedimenti a questi associati. Le ricerche, afferenti ad un programma interdisciplinare promosso e finanziato dal C.N.R. nell'ambito del Programma Speciale per la << Conservazione del Suolo >>, avevano in particolare lo scopo di definire caratteri di facies e schemi evolutivi di esempi di spiagge fossili. l risultati ottenuti documentano caratteri interni e geometria di una successione di cicli di spiaggia entro la parte sommitale delle Arenarie di Aren. Questi cicli sono
compresi all 'interno di un complesso sistema deposizionale regressivo entro il quale, a causa di faglie sinsedimentarie, associazioni di facies litorali fanno passaggio a depositi torbiditici su distanze• molto brevi. Le relazioni di facies tra sedirr,enti litora li e torbiditici sono comprovate attraverso correlazioni dirette di superfici deposizionali. I cicli di spiaggia propriamente detti risultano composti da facies di retrospiaggia, avanspiaggia e spiaggia esterna. Verso il largo i depositi di spiaggia esterna passano gradualmente, attraverso facies di transizione, a peliti e siltiti di piattaforma. Verso terra, i sedimenti di spiaggia sono sostituiti da facies eoliche o lagunari. In ragione degli eccellenti affioramenti, le relazioni tra queste varie facies sono documentabili sia verticalmente che lateralmente.
SUMMARY
The main purpose of this paper is to describe the nearshore facies of the Upper Cretaceous Aren Sandstone from a selected area bctween the Noguera Ribagorzana and the lsabena valleys in the south-central Pyrenees. The location of the study area is shown on figure l .
The Aren is the uppermost marine formation of the Late Cretaceous sedimentary cycle in the south-central Pyrenees. It consists mainly of quartz sandstone that was deposited as a regressive barrier complex. The sandstone is, overlain, by continental red shale and fluvial sandstone, the so-called << Garumnian » , an d is underlain by marine shale which, in its turn, was deposited on top of a thick turbidite sequence. Both the marine shale and the underlying turbidite sediments are referred to as Vallcarga Formation in the literature.
Results of our sedimentological and stratigraphic investigations are summarized on the cross sections of Table l.
(*) Lavoro eseguito con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Programma Speciale per la Conservazione del Suolo, Contratti n . 71.02175.28 e 72.00976.28.
(* *) Istituto di Geologia, Paleontologia e Geografia Fisica, Palazzo Carignano, 10123 Torino.
(***) Università Autonoma di Barcellona, Dipartimento di Geologia, Bellaterra (Barcellona).
An old paper when HCS was still called "truncated wave-ripple laminae"
498 G. GHIBAUDO - E. MUTTI - J. ROSELL
Table I A illustrates the generai stratigraphic relationships oh the Aren Sandstone in the study area. The formation can be Iocally subdivided into two informai units. The lower unit (unità inferiore) consists of a thick tongue of nearshore sandstone passing westward into offshore siltstone and calcareous mudstone; the latter become increasingly folded and disrupted in a basinward direction. The folding appears to be clearly related to synsedimentary slumping. The upper unit (unità superiore) consists of mudstone grading upward into nearshore sandstone. The mudstone sequence includes thinbedded turbidite sandstone at its lower and westernmost part. The nearshore sandstone resting on top of the mudstone sequence comprises a typical regressive complex with eolian, beach. lagoonal , and tidal facies becoming progressively younger from east to west.
The marked seaward divergence of the lower unit within the Aren sequence, as shown on Table I A and figure 4, is interpreted here as the result of synsedimentary structural deformation. In particular, the present stratigraphic setting and facies distribution would reflect the synsedimentary tilting of a fault block as shown on Table I A. The area where the inferred fault would cut part of the Aren sequence is now covered by thick, post-tectonic alluvial conglomerates and sandstones of Late Eocene and Oligocene age. However, the above interpretation is supported by severa) lines of evidence: l) the geometry of the rock bodies within the Aren sequence; 2) stratigraphic expansions and slumps within the lower unit pointing to a marked, synsedimentary deepening o f the basin toward the west; 3) the occurrence of terraces cut by waves into the upper surface of the Iower unit at its e asternmost part; 4) tbc occurrence of similary oriented faults cutting into older Mesozoic rocks immediately north of the study area.
T1lting started just at the beginning of the deposition of the lower unit which shows abundant features related to both rapid stratigraphic expansion and slumping. Following this, rate of deposition prevailed on rate of structural subsidence at least in the eastern part; thus, a thick sequence of nearshore sandstone could accumulate (figs. 5 and 8). Fina! tilting of the lower unit took piace immediately after the deposition of the above sandstone. This resulted in large-scale slump features affecting the entire thickness of the lower unit west of Aren, and in uplift and subsequent terracing to the east. The large-scale slump structures are shown on figure 9; wave-cut terraces are shown on both cross sections of Table l. Terraces of similar origin hava also been reported and illustrated by GHIBAUDO et al. (1973 b) from the Aren sequence in the Orcau area, east of Tremp.
Table I B shows in detail the facies distribution within the upper unit of the Aren Sandstone in the area of the Noguera Ribagorzana valley, i.e. at the type-locality of the formation . The cross section details in particular the regressive beach complex in the uppermost part of the Aren, just below the << Garumnian » red beds. The beach sediments display a depositional setting which is basically not unlike that described by CAMPBELL (1971) for the Upper Cretaceous Gallup Sandstone, New Mexico. Such a setting consists of landward embricated, progressively younger depositional units each of which is made up, from land to sea, of these facies:
l ) backshore, 2) foreshore. 3) shoreface, 4) offshore-heach transition , and 5) offshore siltstone and mudstone. In our particular case, the backshore deposits were either originally poorly developed or are characterized by sedimentary features which are not always clearly distinctive. For the above reasons, they have been represented on the cross section of Table I B together with dune sandstone with which they appear to be associated in most cases. Beach, eolian, tidal and lagoonal deposits occurring in the upper unit of the Aren Sandstone are dealt with in some detail in the part of the paper entitled Descrizione delle jacies; ali photographs illustrating these facies bave also an english caption.
Turbidites within the upper unit were deposited in the deepest part of a structural depression originated by tilting of a fault block (Table I A). They consist of thin-bedded finegrainec.l current-laminated quartz sandstone with predominant mudstone interbeds. This association is like that described by MUTTI & RICCI LUCCHI (1972) for their facies 0 turbidites. Paleocurrent directions indicate that the quartz sand was derived from the time-equivalent nearshore deposits to the east. The lack òf coarse-grained channel-fill facies suggests that the sand was transported into the basin by unconfined sheet-like turbulent suspensions that probably originated either by storm-wave activity or by slumps of unconsolidated materia!. As shown on figure 7 these turbidites could represent offlapping events related to the nearshore regression. At least at the beginning of their deposition, these turbidites were laid down at a water depth on the conservative arder of 500 meters.
RESUMEN
El presente trabajo resurne los resultados de las investigaciones • realizadas entre los aiios 1972 y 1973 sobre los depésitos litorales y sedimentos a estos asociados del Cretacico supcrior de la zona centrai sur-pirenaica. Las investigaciones, pertenecientes a un programa interdisciplinario promovido y financiado por el C. N .R. dentro del Programa Especial por la Conservaci6n del Suelo, tenian como fin principal definir las caracteristicas y los esquemas evolutivos de tipos de playas f6siles. Los resultados obtenidos muestran en la parte superior de las Areniscas de Arén, las caracteristicas internas y la geometria de una sucesi6n de ciclos de playa. Dichos ciclos estan comprendidos dentro de un complejo sistema deposicional regresivo en el qual, debido a fallas sinsedirnentarias, asociaciones de facies litorales pasan a dep6-sitos turbiditicos en una distancia muy corta. Las relaciones de facies entre los sedimentos litorales y turbiditicos han sido comprobadas mediante correlaciones directas de las superficies deposicionales. Los ciclos de playa propriamente dichos estan compuestos por facies de backshore, foreshore y shoreface. Hacia el mar abierto los dep6sitos de shoreface pasan gradualmente, a travé& de facies de transici6n, a pelitas y limolitas de plataforma. Tierra adentro, los sedirnentos de playa estan sustituidos por facies e61icas 6 lagunares. Debido a los excelentes afloramientos de la zona estudiada, las relaciones entrc estas diferentes facies pueden ser comprobadas tanto verticalmente como lateralmente.
LE SPIAGGE FOSSILI DELLE ARENARIE DJ AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 499
l. INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO
Promosso e finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del Programma Speciale per la « Conservazione del Suolo », fu avviato nel 1969 un programma di ricerche interdisciplinari sul regime e sulla conservazione dei litorali. Scopi ed impostazione esecutiva del programma sono stati ampiamente illustrati nel rapporto che ha fatto seguito al seminario tenutosi nel 1970 sul tema: «Criteri sedimentologici teorici e pratici per impostare un programma di ricerche per la conservazione dei litorali sabbiosi italiani » (BRAMBATI et al., 1972).
Tra le ricerche di base che si ritennero utili ai fini del programma suddetto venne incluso lo studio evolutivo di alcuni esempi di spiagge fossili. La ragione di questo studio fu precisata nell'opportunità di ottenere modelli di facies tridimensionali indicanti caratteristiche interne (litologia, tipo di stratificazione e di strutture deposizionali, granulometria) e geometria dei corpi sabbiosi depostisi in ambiente di spiaggia.
Lo studio venne affidato all'unità operativa facente capo all ' Istituto di Geologia dell'Università di Torino (Contratti C.N.R. n. 71.02175.28 e 72.00976.28) e le ricerche relative vennero effettuate tra il 1972 e il 1973, in collaborazione con il Dipartimento di Geologia dell 'Università Autonoma di Barcellona, su sedimenti litorali tardo-cretacei, noti nella letteratura come « Arenarie di Aren », ubicati nel settore centro-meridionale dei Pirenei. La scelta di questa regione venne suggerì ta dalle eccellenti condizioni di affioramento di tutto un complesso di spiagge fossili regressive già come tali individuate da due degli scriventi (E. MuTTI & J. RosELL) a seguito di studi preliminari su scala regionale.
I primi risultati ottenuti dallo studio di dettaglio di questi depositi sono stati pubblicati in due brevi note, sostanzialmente identiche, apparse rispettivamente su Acta Geologica Hispanica (GHIBAUDO et al., 197 3 a) e sul Bollettino della Società Geologica Italiana (GHIIJAUDO et al., 1973 b) .
La presente memoria compendia i risultati delle ricerche sino ad ora condotte sulle Arenarie di Aren . Essa è suddivisa in due parti. la prima tratta, dopo un breve cenno storico, metodi di studio e risultati acquisiti circa la stratigrafia e l'interpretazione ambientale delle Arenarie di Aren. Dati ed interpretazione sono rappresentati quasi interamente in forma grafica onde facilitarne la discussione. La seconda parte, che in certo qual modo può essere considerata come un'ap-
pendice, riguarda la descrizione dettagliata delle varie fades e la loro illustrazione fotografica . Un ulteriore contributo alla conoscenza di questi stessi depositi verrà fornito attraverso la prossima pubblicazione di un atlante fotografico inteso ad illustrare le strutture sedimentarie pitl caratteristiche dei sedimenti fluviali, deltizii e litorali del Cretacico superiore e del Paleogene della regione sud-pirenaica dei dintorni di Tremp (MUTTI & RICCI LuccHI, in preparazione).
Questo lavoro non avrebbe potuto essere condotto a termine senza il sostanziale aiuto di molte persone che qui desideriamo ringraziare cordialmente. J. FERRER, R. LEHMANN e H . P. LUTERBACHER hanno fornito i dati relativi alla biostratigrafia oltrecché utili informazioni sul significato paleoecologico di varie associazioni di foraminiferi. E. MoRELLI, A. 0BRADOR, J. M. PoNs e M. RAMAsco ci hanno assistito in varie fasi del lavoro' di terreno. Con F. RICCI LuccHr abbiamo avuto occasione di discutere a più riprese, nel corso di comuni escursioni, il significato di molte facies. Un particolare ringraziamento è qui infine rivolto a C. V. CAMPBELL, dal quale uno degli scriventi (E. M.) fu introdotto parecchi anni addietro allo studio dei sedimenti terrigeni di piattaforma attraverso un'indimenticabile escursione sulla Gallup Sandstone nel Nuovo Messico; con lo stesso C. V. CAMPBELL abbiamo inoltre rivisitato molti degli affioramenti delle Arenarie di Aren discussi nel presente lavoro ed abbiamo ottenuto P.reziosi suggerimenti al riguardo di non pochi problemi.
2. STRATIGRAFIA ED INTERPRETAZIONE AMBIENTALE
2.1. Studi precedenti ed inquadramento geologico
Le Arenarie di Aren, definite formalmente come unità litostratigrafica da MEY et al. (1968), costituiscono la formazione sommitale di una successione di sedimenti marini , d 'età tardo-cretacica, affioranti estesamente lungo tutta la regione sud-pirenaica tra le valli del Segre, ad est, e dell'Esera ad ovest. Questi sedimenti costituiscono, nel loro insieme, un ben definito ciclo sedimentario trasgressivo-regressivo.
La stratigrafia e l'assetto strutturale di tutti questi depositi sono noti nella letteratura attraverso numerosi ]avori (DALLONI, 1910; 1930; MISCH, 1934; ROSELL, 1967; SOUQUET, 1967; MEY et al., 1968; SEGURET, 1970; VAN HOORN, 1970; MUTTI & ROSELL, 1969;
500 G. GHIBAUDO - E. MUTTI - J. ROSELL
ROSELL et al., 1972; GARRIDO & RIOS, 1972; GARRIDO, 1973; etc.). Quasi tutti questi Autori concordano sul carattere regressivo, di « fine-ciclo », delle Arenarie di Aren e sulla loro età tardo-maastrichtiana a suo tempo proposta da DALLONI (1930) .
L'interesse per le Arenarie di Aren sotto un profilo sedimentologico è del tutto recente e limitato, per ora, all'area compresa tra Isona e la Valle Noguera Ribagorzana (NAGTEGAAL, 1972; GHIBAUDO et al., 1973 a ; 1973 b); altrettanto recente è l'inizio di una revisione biostratigrafica, basata su criteri moderni di studio di questi stessi depositi (LIEBAU, 1973) .
NAGTEGAAL (1972) riconosce l'inomogeneità litologica delle Arenarie di Aren secondo la definizione di MEY et al. (1968) e suddivide pertanto questa formazione in due sottounità informali: quella « inferiore » costituita da marne e calcareniti, e quella « superiore », o Arenarie di Aren s.s, costituita da calcareniti a tenore variabile di quarzo. Dell'unità « superiore» l'Autore mette in evidenza la complessa differenziazione in associazioni di facies nell'ambito di ambienti litorali e neritici. Egli riconosce depositi di cordoni litorali (coastal barriers) e di spiaggia nelle sezioni di Orcau e del Noguera Ribagorzana, depositi eolici nella valle Nog1,.1era Ribagorzana, e sedimenti di marea nei pressi di Isona (NAGTEGAAL, 1972, p. 266).
A conclusioni assai simili circa il significato delle Arenarie di Aren giungono GHIBAUDO et al. (1973 a, 1973 b) nelle loro conclusioni preliminari. Questi Autori mettono in particolare evidenza il carattere diacrono dei limiti litologici delle Arenarie di Aren ed il controllo della tettonica sinsedimentaria sulla distribuzione delle facies. Non ci dilungheremo su queste conclusioni dal momento che esse saranno riprese più estesamente, con eventuali modifiche ove necessario, nelle pagine seguenti.
Di particolare interesse ai fini di questo lavoro sono i risultati delle ricerche condotte da LIEBAU (1973) sui depositi « garumniani » della regione di Isona. Questo Autore, in una profonda revisione strat igrafica dei sedimenti al limite tra Cretacico e Paleocene della cosiddetta « Conca di Tremp », riconosce l'età eo-maastrichtiana della base della locale successione del « Garumniano » (ovvero del tetto delle Arenarie di Aren) ed il carattere diacrono dei limiti formazionali introdotti da MEY et al. (1968). LIEBAU (op . cit.) sottolinea inoltre il carattere transizionale tra le facies marine delle Arenarie di Aren ed i sovrastanti depositi prevalentemente lagunari del « Garumniano »
e, per conseguenza, la par$le equivalenza laterale tra le due unità.
L'area da noi studiata è ubicata nei prepirenei meridionali, a cavallo tra le provincie di Lerida e Huesca, grosso modo delimitata dal Noguera Pallaresa ad est e dal rio Isabena ad ovest. La situazione geologica locale e l'area di affioramento delle Arenarie di Aren sono mostrate schematicamente nella fig. l. Strutturalmente, tutta la zona fa parte della cosiddetta « Unità di Tremp » che GARRIDO (1973) distingue entro la «falda del Montsec ». L'« Unità di Tremp » costituisce, nella zona in esame, un'ampia sinclinale, ad asse pirenaico, con nucleo rappresentato da sedimenti paleogenici di cui è stato fatto argomento in altra sede (MUTTI et al., 1972). Il Cretacico superiore cui fa riferimento la presente memoria è parte del fianco settentrionale della struttura predetta. Esso è rappresentato da una successione di sedimenti marini costituenti un ben definito ciclo sedimentario e deposti in un settore di un bacino pirenaico più ampio i cui caratteri generali , morfologici e strutturali, sono stati accennati da HENRY et al. (1971), e MATTAUER & SEGURET (1971). L'inizio di questo ciclo sedimentario, nella zona esaminata, è ritenuto di età tardo-cretatica (SOUQUET, 1967; VAN HoORN, 1970; GARRIDO, 1973). 1 sedimenti di « base-ciclo», ossia i depositi trasgressivi basali, sono generalmente poco manifesti ; grande sviluppo prendono invece quelli torbiditici, ovvero .la Formazione di Vallcarga di VAN HooRN (1970), il cui spessore è localmente superiore a 2000 metri; al tetto di queste torbiditi si instaura gradualmente una evoluzione regressiva di cui le Arenarie di Aren, con il loro carattere generalmente litorale, rappresentano l'ultimo episodio. Al tetto di questi ultimi depositi si rinvengono le facies continentali, a « red beds », del cosiddetto « Garumniano » le quali, a loro volta, formano il substrato sul quale si instaura la fase iniziale trasgressiva del successivo ciclo sedimentario rappresentato dal Paleogene della zona centrale sudpirenaica (cf. MuTTI et al., 1972).
2.2. Metodi di studio
I risultati di questo studio derivano principalmente da osservazioni stratigrafico-sedimentologiche fatte nel corso del lavoro di terreno.
Alla base di queste osservazioni stanno i ben noti criteri della analisi stratigrafica e di quella di
LE SPIAGGE FOSS I LI DELLE ARENAR IE DI AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. SOl
CO NGLOME RATI ~TERZIAR I O D "GARUMNIA o .. DI COLLEGATS PRETETTONICO (CRETAC ICO 5 UP.-
...__,c....><.-"'--'"-' (OLIGOCENEl (PALEOCENE·EOCENE, PALEOCENEl
N
CD o
M ADRID
o LE RIDA
BA ELONA
ARENARI E DI
(CRETAC ICO 5Uf' l
FORMAZIO NE
DI VALLCARGA (CRETACICO 5UP. l
M ESO ZOICO DE L 'ANTICLINALE
'--'---'--'---'--'--'--'--' DI S. C O RNE LI
A--1'\: UBICAZ IONE DELLE SEZ ION I D I TAVOLA I
O 1 2 3 4 5 km
fig. T - Carta geologica schematica dell 'area studiata e traocia dello spaocato stratigrafìco della Tavola I A.
Geologie sketch map of the study area and location of the cross section of Table l A.
facies fondati sulla sovrapposizione, in continuità stratigrafica, di facies ed associazioni di facies che debbono necessariamente riflettere analoghe condizioni di equivalenza laterale al tempo della deposizione. In altre parole il tutte è basato sulla classica legge di WALTHER.
Entro la zona compresa tra Sapeira e la Val Isabena abbiamo misurato 16 sezioni stratigrafiche ciascuna delle quali è stata suddivisa in livelli, ossia in gruppi di strati con caratteri di facies similari. Ogni livello è quindi una litofacies, ossia un gruppo di strati con caratteri analoghi in termini di litologia e tessitura, tipo di stratificazione e strutture deposizionali ; si può presumere, di conseguenza, che questi strati siano stati verosimilmente deposti attraverso un unico processo o insieme di processi sedimentari con caratteri sensibilmente costanti nel tempo.
L'individuazione di queste litofacies e l'organizzazione verticale delle stesse in cicli deposizionali sono alla base delle interpretazioni paleoambientali presentate in questo lavoro. Il concetto di ciclo deposizionale
è noto 1;\ttraverso innumerevoli lavori che non varrebbe qui neppure la pena di citare. Tra quelli più conosciuti ricorderemo il lavoro di VISHER (1965) e il compendio di SELLEY (1970).
Il rilievo di dettaglio di sezioni stratigrafico-sedimentologiche entro le Arenarie di Aren ha permesso di individuare un certo numero di facies ricorrenti in successione verticale costante. 11 risultante ciclo deposizionale è sostanzialmente confrontabile a quello che si può desumere dal lavoro di CAMPBELL (1971) per le spiagge fossili del Cretaceo superiore della Gallup Sandstone nel Nuovo Messico e da altri lavori su analoghi sedimenti fossili e recenti (vedasi REINECK & SINGH, 1973, cum bibl.).
In accordo con il modello deposizionale di CAMPBELL (op . cit.), i depositi di spiaggia possono essere suddivisi in tre principali sottofacies corrispondenti alla deposizione in altrettanti sottoambienti naturali. Tali facies minori appaiono giustapposte, in ogni ciclo di spiaggia, nel seguente ordine da terra verso mare: 1) facies di retrospiaggia (backshore), 2) di
502 G. GH!BAUDO - E. M UTTl - J. ROSE LL
battigia (foreshore) e 3) di spiaggia esterna (shoreface). Corrispondenti verso terra di questi depositi possono essere indifferentemente facies palustri, lagunari e eoliche, mentre gli equivalenti laterali verso il mare aperto sono rappresentati dalle peliti e siltiti di piattaforma (ojfshore mudstone and siltstone) a cui questi depositi passano gradualmente tramite una zona di transizione (of f shore-beach t ransition di CAMPBELL, 1971). Le strutture sedimentarie, unitamente ai caratteri della stratificazione, litologia e tessitura ed alla posizione stratigrafica relativa all'interno di ciascun ciclo deposizionale, costituiscono i principali elementi diagnostici per il riconoscimento e la differenziazione delle varie facies. Per una completa descrizione di tali elementi si rimanda al succitato lavoro di CAMPBELL nonché ai dati più recenti forniti da REINECK & SINGH {1973) .
In successione verticale ed in sequenze regressive, i depositi dei vari sottoambienti di cui sopra si sovrappongono a costituire dei cicli deposizionali del tipo coarsening-upward; un esempio di tale tipo di cicli, basato sui caratteri sedimentari riscontrabili nei depositi di spiaggia delle Arenarie di Aren, è esemplificato in fig. 2.
Dati gli eccellenti affioramenti, almeno per quanto r iguarda il tipo e la geometria delle superfici di stratificazione ed i rapporti laterali tra le varie facies, il ciclo deposizionale suddetto può essere verificato lateralmente. In altre parole, le singole facies componenti che si rivengono sovrapposte entro ciascun ciclo, appaiono anche in relazione di equivalenza laterale tracciando strati o gruppi di strati lungo la loro direzione.
Le varie sezioni sono state correlate tra loro direttamente sul terreno per mezzo di strati o gruppi di strati tracciati lateralmente, in continuità fisica, tra sezioni contigue. In ragione dei cambiamenti di facies, molti gruppi di strati perdono i loro caratteri anche nel breve spazio tra tali sezioni, vale a dire che strati di una certa facies possono essere tracciati lateralmente in strati di una facies diversa nella sezione immediatamente vicina.
Le superfici di strato, o delimitanti gruppi di strati costituenti una litofacies nel senso suddetto, sono qui ritenute come linee o superfici tempo strettamente coeve. A scala locale, e per il tipo di sedimenti qui esaminati, queste superfici permettono pertanto corre-
!azioni di gran lunga più preoise rispetto a quelle eventualmente ottenibili per mezzo della biostratigrafia.
Per la parte di laboratorio ci siamo limitati ad esaminare un certo numero di sezioni sottili per controllare le descrizioni di terreno relative alla composizione delle arenarie, e numerose sezioni lucide per meglio definire certi tipi di strutture deposizionali a piccola scala. Sono state inoltre eseguite 23 analisi granulometriche allo scopo di verificare la possibilità di distinguere, attraverso parametri tessiturali, le varie facies riconosciute. I risultati di queste analisi si sono dimostrati del tutto inadeguati per lo scopo suddetto e, per conseguenza, essi non forniranno argomento di ulteriore trattazione nel presente lavoro.
2.3. Risultati e conclusioni
2. 3. 1. PREMESSA
La corretta comprensione della paleogeografia delle Arenarie di Aren è certamente di grande importanza per stabilire le modalità attraverso le quali si chiuse il ciclo marino tardo-cretacico nella zona prepirenaica. A grandi linee, questa paleogeografia è stata ricostruita da vari Autori (e.g., SououET, 1967; HENRY et al., 1971), ma la mancanza di studi stratigrafici e sedimentologici basati su criteri moderni ha impedito sinora di delineare un coerente assetto deposizionale.
Sulla base delle nostre attuali conoscenze sulle Arenarie di Aren ci è difficile inquadrare a scala regionale le conclusioni raggiunte in questo studio di carattere sostanzialmente locale. In effetti non sappiamo in quale preciso contesto le facies litorali da noi studiate si colleghino, nello spazio e nel tempo, con quelle omologhe affioranti ad esempio sul fianco nord della struttura del Montsec o con quelle di marea che NAGTEGAAL (1972) riporta per la zona di Isona e che noi riteniamo almeno in parte come facies di estuario.
Per le ragioni suesposte, e dato lo scopo particolare delle nostre ricerche, ci limiteremo pertanto a riportare, qui di seguito, dati e conclusioni relativi soltanto alla nostra area di studio, senza alcuna pretesa di generalizzazione neppure per le aree immediatamente limitrofe. La sola eccezione a ciò sarà rappresentata da certe conclusioni circa i rapporti stratigrafici tra le Arenarie di Aren ed i depositi sottostanti che, sulla base dei nostri risultati , ci sembrano intera-
fig. 2 - Oiclo d eposizionale regressivo in d epositi di spiaggia ricostruito sulla base di osservazioni dirette sulle Arenarie di Aren e di c riteri forni,ti dalla 'letteratura.
LE SPIAGGE FOSS I LI DELLE ARENARIE DI AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 503
CICLO DEPOSIZIONALE REGRESSIVO DI FACIES DI SPIAGGIA
FACIES ALLUVIONALI
FACIES EOLICA
FACIES DI RETROSPIAGGIA
(BACKSHORE)
~§@~~~~Sff FACIES DI BATTIGIA ~F:.?=8§~~~~§ _ (FORESHORE)
...
. · .· .• .. ·• - ,• '~ ,..'''; y
:· .. :··.)::>·::::· .. · .. ·.···· ... ·.·.::x':".'.:·:: ·: ·. ...
. ..... . : . . . . . . . . . . . . .
.::::::.::==· : ··:· ..... .
FACIES DI SPIAGGIA
ESTERNA (SHOREFACE)
A WAVE RIPPLES TRONCATI
O BIOTURBATA
FACIES DI TRANSIZIONE
4m PELITI E SILTITI DI
PIATTAFORMA CON 2
o
OCCASIONALI «STORM
SAND LA YERS»
fig. 2
504 G. GH I BAUDO- E. MUTTI - J. ROSELL
mente da rivedere, rispetto a quanto r iporta to nella letteratura, almento dalla Valle del Segre alla Valle Isabena.
In questa parte del lavoro descriviamo dapprima il quadro stratigrafico-deposizionale ricostruito localmente per le Arenarie di Aren tra Sapeira e Serraduy, e , successivamente, l'assetto deposizionale di dettaglio dei depositi litorali d i questa stessa formazione limitatamente ad un settore specifico dell'area stud iata.
2 . .J . 2. Q UADRO STRAT IGRAF ICO-DEPOSI Z IO ALE
ell'ambito della zona da noi studiata, il quadro stratigrafico-deposizionale entro il quale si inseriscono
le Arenarie di Aren tra Sapei.ra, nella Valle Noguera Ribagorzana, e Serraduy, in Val Isabena, è mostrato schematicamente nella Tav. I A.
La figura suddetta rappresenta uno spaccato stratigrafico (stratigraphic cross section) ricostruito a partire da sei sezioni complete, misurate dalla base al tetto delle Arenarie di Aren , e da altre dieci sezion i, omesse in questa Tavola ma rappresentate in quella I B relative a spessori pa rziali della stessa formazione.
La linea orizzontale delimitante verso l 'alto la successione delle Arenarie di Aren rappresenta il tetto della medesima formazione, ovvero la traccia della superficie limite con le sovrastanti facies lagunari e continentali del « Garumniano » non mostrate in figura. La orizzontalità di questa superficie non è sol-
fìg. 3 - Veduta panoramica deUe Arenarie di Aren nella valle del Rio Nogue ra Ribagorzana. li punto di vista è grosso modo da ovest. Si notino la terminazione a cuneo verso est della « unità superiore» e la marcata obUquità, rispetto al tetto della formazione, dei sedimenti costituen ti !'« un ità inferiore>> (UI). SuJio sfon do, i conglomera ti terziari post-tettonici (C) riposanti in di scordanza sul « Garumniano » (G) e sulle Arenarie di Aren. La freccia indica la zona mos·trata in dettaglio dalla fotografia di figura 4.
Generai v iew of the Aren Sandstone in the oguera Ribagorzana valley. ote the marked basinward (westward) divergence og the lower uni t (U l) w ith res.pect t o the ta p of the upper uni t (US) . Tertiary post-tectonic conglomerates (C) are overlying bot h the « Garumnian » (G) and the Aren on the background. The black arrow indicates the area shown in more detail on fi g. 4.
LE SP IAGGE FOSS I LI DELLE ARE ARIE DI ARE (CRETACICO SUPER IORE) ECC. 505
tanto un artificio grafico ma riflette, in questo caso specifico, una reale configurazione fisiografica al tempo della deposizione. Essa rappresenta, in effetti , una pianura costiera grosso modo orizzontale che si accre-ceva frontalmente, verso il mare, attraverso depositi
litora li regressivi, via via più recenti da est ad ovest. Consegue da quanto sopra che l'obl iquità delle superfici sottostanti al tetto delle Arenarie di Aren deve essere spiegata come un fenomeno deposizionale, topografico o strutturale contemporaneo alla deposizione della formazione.
Come risul ta dalla Tav. l A e da lle figg. 3, 4 e 5 le Arenarie di Aren s. i., intese cioè nel senso formazionale di MEY et al. (1968), sono in effetti costituite, localmente, da due distinte unità litologico-deposizionali
che abbiamo informalmente 'denominato « unità superiore » ed « unità inferiore » rispettivamente. Queste unità sono soltanto in parte confrontabili con le omonime unità d istinte da NAGTGAAL (1972).
« L'unità superiore » ha una sezione all'incirca a forma di cuneo con marcato assottigliamento, fino a totale scomparsa verso est. Dal basso verso l 'alto, essa è costituita, ad oriente della faglia che abbiamo rappresentato tra le sezioni di I se\ es e di Serraduy, da una spessa successione di peliti con sottili intercalazioni torbiditiche cui seguono peliti omogenee ed in fine i depositi arenacei litorali costituenti le Arenarie di Aren s.s secondo la definizione di AGTEGAAL (1972).
Verso est, lo spessore delle facies torbiditiche decresce rapidamente e l 'intera successione di questi de-
fig. 4 - Estremità orientale del cuneo sedimenta rio ·della « unità superiore» (US). Quest'ultima si assottiglia verso il fondo fi no a scomparire. Dell'<< unità superiore» sono preservate, in primo p iano, anche le facies pelitiche basa li; sul fondo, l'~mi•tà è ormai soltanto rappresentata dalle facies arenacee sommitali.
Easternmost outcrop area of the sedimentary wedge comprising the << upper uni i » (US). On the foregrou nd, the unit is stiU composed of a lower mudstone sequence overlain by nearshore and eolian sandstone. On the background , the lower unit is remarkably thinner and only made of sandstone deposits.
506 G. GH IBAUDO- E. MUTT I - J. ROSELL
c
fìg. 5 - Veduta generale della successione rratigrafìca delle Arenarie di Aren nella valle del Rio oguera Ribagorzana subito ad est di Aren. La formazione mostra qui chiaramente ·le due unità che ·la costituiscono. L'<< unità inferiore>> riposa su peliti della Formazione di Vallcarga non visibili nella fotografia. Sullo sfondo, a destra, sono parzialmente visibili il << Garumniano >> ed i conglomerati terziari post-tettonici. Il significato delle varie unità è discusso nel testo. Si notino le transizioni laterali, entro la parte sommi tale delle Arena rie di Aren, tra facies di battigia (B) e di spiaggia esterna (SE) messe in evidenza dall 'erosione differenziale. U l : unità inferiore; US: unità superiore; PAC: peli ti di p iattaforma, argilloso-calcaree, dell'<< uni tà inferiore>>; AL: arenarie litorali dell'<< unità inferiore >> ; PSP: peliti e siltiti di piattaforma, con intercalazioni di pacchi di arenarie litorali, dell '<< unità superiore>>: AS: arenarie di spiaggia ed eoliche dell'<< unità superiore>> .
Generai view of the stratigraphic sequence of the Aren Sandstone in the Noguera R ibagorzana valley, immediately east of Aren. The formation consists locally of two units. From base to top (left to right in the picture), the lower unit (UI) is made of ofTshore siltstone and calcareous mudstone (PAC), and nearshore sandstone (AL); the upper uni t (US) is made of a lower portion consisting of prevailing offshore mudstone and siltstone with intercalations of nearshore sandstone (PSP), and an upper portion compnsed by beach and dune sandstone (AS) . Distinct latera] facies ·changes can be seen in the beach and dune sandstone where foreshore ~B) deposits can be traced into shoreface (SE) facies in a seaward direction, i.e. from right to left on the photo. Tertiary post-tectontc conglomerates (C) and << Garumnian >> deposits (G) are visible on the background.
posi ti è sostituita lateralmente da peliti di piattaforma. Q ueste ultime, a loro volta, fanno passaggio laterale, sempre verso oriente, alle Arenarie di Aren s.s.
I sedimenti litorali, le associate facies eoliche ed i depositi pelitici di piattaforma dell'« unità superiore» sono mostrati in dettaglio, relativamente alla zona del Rio Noguera Ribagorzana, nello spaccato stratigrafico della Tav. I B. Questi sedimenti sono discussi estesamente nel paragrafo successivo e, in particolare, saranno dettagliatamente descritti nella seconda parte di questo lavoro.
L'« unità inferiore» riposa sulla Formazione di Vallcarga, localmente rappresentata da peliti, livelli caotici ed arenarie torbiditiche (vedasi VAN HooRN, 1970 per una dettagliata descrizione di questi depositi), attraverso un contatto strati grafico spesso disturbato da fenomeni di slwnping. Essa è formata da sed imenti pelitici, calcareo-argillosi, e pelitico-siltosi, cui si sovrappongono, limitatamente alla zona orientale, depositi arenacei litorali direttamente innestati entro il corpo principale delle Arenarie di Aren s.s.
L'« unità inferiore » si assottiglia marcatamente
verso oVest ove viene ad essere rappresentata da spessori sempre più ridotti di depositi pelitici, calcareoargillosi e spesso con aspetto nodulare, intensamente ripiegati e disgiunti da fenomeni di slumping a piccola e a grande scala.
Circa l 'età dei sedimenti cui si è fatto cenno in precedenza, essa è stata sempre considerata nella letteratura come tardo-maastrichtiana sulla base delle classiche ricerche stratigrafiche di DALLONI (1930); i risultati preliminari forniti dallo studio dei foraminiferi planctonici contenuti nei campioni da noi raccolti in questi depositi indicano una età tardo-maastrichtiana soltanto per l'« unità superiore »: le microfaune contenute nei sedimenti dell'unità sottostante appaiono in effetti già indicative del Maastichtiano inferiore (J. FERRER, R . LEHMANN, H. P. LuTERBACHER, comunicazione personale). Gli elenchi deiie forme determinate sono i seguenti:
a) « unità superiore »
Sezione 14: Globotruncana stuarti, Globotruncana fal-
LE SPIAGGE FOSS ILI DELLE ARENARI E DJ AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 507
sostuarti, Globotruncana gansseri, Globotruncana stuartiformis, Globotruncana cf. tricarinata, Globotruncana arca, Globotruncana rosetta, Globotruncana contusa, Globotruncana petaloidea, Pseudotextularia elegans, Racemiguembelina powelli, forme di transizione tra P. elegans e R. powelli, Planoglobulina brazoensis, Globigerinelloides volutus volutus, Heterohelix striata, Heterohelix glabrans. Sezione 7: Globlotruncana stuarti, Globotruncana falsostuarti, Globotruncana contusa, Globotruncana tricarinata, Globotruncana caliciformis, Globotruncana stuartiformis, Globotruncana arca, Globotruncana rosetta, Globotruncana intermedia, Globotruncana cf. bolii, Globigerinelloides volutus volutus, Heterohelix striata, Racemiguembelina powelli, Pseudotextularia elegans, Pseudotextularia deformis.
b) « unità inferiore »
Sezione l (base Arenarie di Aren s.s.) : Globotruncana contusa, Globotruncana arca, Globotruncana tricarinata, Globotruncana cf. canaliculata, Globotruncana stuarti, Globotruncana falsostuarfi, Globotruncana stuartiformis, Globotruncana cf. rosetta, Globotruncana marginata, Globotruncanella petaloidea, Glonigerinelloides volutus volutus, Globigerinelloides volutus pinguis, Heterohelix striata.
Questi risultati confermano la netta diacronia dei limiti formazionali delle Arenarie di Aren, nella definizione di MEY et al. (1968), già postulata sulla base di osservazioni stratigrafico-sedimentologiche di terreno da GH IBAUDO et al. (1973 a, 1973 b) e di studi paleontologico-stratigrafici da LIEBAU (1973).
Sulla base di quanto esposto in precedenza lo schema della Tav. I A si presta a considerazioni di un certo interesse in relazione all'evoluzione sedimentaria locale.
L'esame delle facies costituenti l'« unità infer iore » porta a concludere che i depositi di spiaggia che si rinvengono entro questa unità nel suo settore orientale passano lateralmente, verso ovest, a depositi di transizione e, successivamente, a facies pelitiche, calcareo-argillose, di piattaforma. Queste ultime sono certamente depositi indicativi di una profondità superiore a quella del livello di base del moto ondoso e mostrano soltanto occasionali intercalazioni di siltiti , in strati sottili e molto sottili, verosimilmente legate all'effetto di onde e correnti di tempesta (vedansi i depositi pelitici di piattaforma nella seconda parte del presente lavoro per una piì:t estesa discussione di questo
tipo di deposizione). Normalmente, queste peliti calcareo-argillose mostrano soltanto una diffusa e delicata bioturbazione, sono in strati sottili e medio-sottili delimitat i da superfici piano-parallele (fig. 6 A), e possono contenere, occasionalmente, sottili e mal definite lamine parallele di incerta interpretazione. Assai spesso, questi strati sono interessati da una diffusa struttura nodulare che sembra avere avuto un origine diagenetica precoce (fig. 6 B). Il tetto dell'« unità inferiore» corrisponde certamente ad una superficie deposizionale poiché è sempre parallela alle sottostanti superfici di stratificazione. Nonostante questi caratteri generali di sedimenti di piattaforma, l'« unità inferiore» occupa una posizione geometrica nei confronti del tetto delle Arenarie di Aren che indica, ad iniziare dalla sezione 13 e procedendo verso ovest, una batimetria dell'ordine delle centinaia di metri. Tale batimetria, come è mostrato in fig. 7, può essere facilmente desunta punto per punto, ed in via del tutto prudenziale poiché non tiene conto della compattazione dei sedimenti argillosi alla base dell'« unità superiore », attraverso l 'assunzione, in precedenza comprovata, del carattere deposizionale del tetto dell'« unità inferiore » e considerando la distanza verticale tra l'orizzontale tracciata a partire dalla zona di terrazzamento da moto ondoso (cf. paragrafo successivo) e la superficie suddetta. Come risulta dalla figura suddetta, le facies litorali dell'unità inferiore nella sezione 13 verrebbero già ad essere deposte a. profondità superiori ai 50 metri e le peliti calcareo-argillose della stessa unità in corrispondenza della sezione 14 a profondità dell'ordine di almeno 500 metri. Il pendio deposizionale del tetto dell'unità in questione ha un gradiente di circa 50 metri per Km., gradiente ovviamente eccessivo per ogni tipo di piattaforma sia questa fossile che recente.
La sola conseguenza che si possa trarre dalle considerazioni precedenti è che l 'intera « unità inferiore »
sia stata ruotata strutturalmente durante o immediatamente dopo la sua deposizione ed abbia acquisito, attraverso tale dislocazione, l 'abnorme gradiente attuale.
Noi riteniamo che l '« unità inferiore» rappresenti in effetti il primo episodio regressivo del locale ciclo sedimentario tardo-cretacico e che questo episodio sia stato reso complesso e successivamente annullato, per un riapprofondimento del bacino, a causa di un eccesso di subsidenza rispetto alla velocità di sed imentazione. L'eccesso di subsidenza è da noi ricollegato alla rotazione di cui sopra, ovvero al basculamento (tilting) sinsedimentario di un blocco di faglia. Questo basculamento ha come risultato quello di approfondire il ba-
508 G. GH IBAUDO - E. MUTTI - J. ROSELL
fig. 6 - A: Aspetto delle peli ti argH!oso-calcaree di piattaforma dd! ' << unità inferiore». B: Dettaglio dei sedimenti di cui sopra mostrante l' incipiente struttura nodulare.
A: Bedding pattern of the ofTshore calcareous mudstone of the lower tlnit. B: Close-up of the same sediments showing irregular and nodular bedding.
LE SPIAGGE FOSSI LI DELLE ARENARI E DI AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 509
E
SAPEIRA l
TE :TERRAZZO EROSO DAL MOTO ONDOSO
a -a: SUPERFICE DEPOSIZIONALE ISOCRONA
a - b : PROFONDI TA MINIMA DI DEPOSIZIONE
DELLE TORSI DITI AL TEMP O a
w
SERRADUY l
··'::: . . : · .. ·. _:_ ....... :~· · ...... ~·.·· .. ·_ .... : ... · .. .:: ... ::··: ..... · ...... :··.· .. .:·_: . ·.·~.:-.· ... · .. ·._::: .·::· . ... ·.·.
<{
a:: <{ 1-z w 2 o w Vl z Vl
. . ..... · ·
fig. 7 - Schema interpretativo dei rapporti deposizionali tra sedi 11enti torbiditici e litorali all ' interno dell'<< un ità superiore >> delle Arenarie di Aren.
l nferred depositional relationship between turbidite sediments an d time-equivalent nearshore facies within the upper uni t of the Aren Sandstone. TE: ten·ace cut by wave action ; a-a: time-equivaJent deposi tional surface (top of the lower unit); b-a: min imum water depth a t the beginning of turbidite deposition.
cino ad ovest e di innalzarlo ad est di un asse di rotazione orientato all'incirca nord-sud e grosso modo localizzabile tra le sezioni l e 4, alla giunzione dei depositi litorali, o Arenarie di Aren s.s., delle unità inferiore e superiore.
U blocco basculato era immerso sensibilmente verso ovest. Ciò è comprovato non soltanto dai rapporti geometrici tra l'« unità inferiore » e quella « superiore » discussi in precedenza, quanto, e soprattutto, dalle proprietà direzionali delle strutture da slumping e da ispessimento stratigrafico (stratigraphic expansion) che si osservano entro i depositi della prima unità. Esempi di tali strutture sono mostrati nella fig. 8.
Il basculamento ha certamente inizio sin dalla prima deposizione delle facies pelitiche dell'« unità inferiore », pressocché ovunque caratterizzate da strutture da slumping a piccola e grande scala; viene poi equilibrato dalla deposizione, almeno localmente, come risulta dallo spessore fino a 100 metri di facies arenacee costantemente litorali nella zona ad est di Aren (cf. sezioni 4 e 7 della Tav. I A); determina infine un approfondimento generale assai accentuato messo in evidenza dal franamento in massa di tutto lo spessore dell'« unità inferiore », come si osserva chiaramente
sul terreno tra le sezioni 13 e 14 (v ed asi anche fig. 9). E' probabile che nel corso di questa ultima fase di basculamento, ed in corrispondenza di locali zone di rotazione, abbiano preso sviluppo i fenomeni di terrazzamento da moto ondoso osservabili tra le sezioni 4 e 7 (cf. paragrafi successivi). Questi ultimi non rappresentano un fatto isolato entro la successione delle Arenarie di Aren. Come è stato dimostrato da GHI
BAUDO et al. (1973 b), terrazzamenti ancor più vistosi caratterizzano la stessa formazione nella zona di Orcau, mostrando in tal modo che il controllo tettonico sulla deposizione di questi sedimenti prese inizio anche assai prima di quanto osservabile tra Sapeira e Serraduy, e che, per conseguenza, tale controllo ha un carattere almeno non strettamente locale.
Riteniamo che la faglia responsabile dell'assetto deposizionale discusso in precedenza fosse all'incirca orientata NNE-SSW e sia ubicabile, nella sezione qui considerata, tra Iscles e la Val Isabena, verosimilmente al di sotto della spessa ed estesa copertura di conglomerati paleogenici post-tettonici. Ciò è suggerito dalle rimarchevoli differenze di spessore e di facies che mostrano le successioni delle Arenarie di Aren a Iscles ed a Serraduy e dalla presenza di faglie
510 G. CHI BAUDO - E. M UTTI - ). ROSE LL
fig. 8 - Dettaglio della figura 5 mostrante la transizione verticale tra le peliti argilloso-<:alcaree di piattaforma (PAC) e le sovrastanti arenarie litorali (AL) dell'<< unità inferiore». Si notino le strutture da slumping (S) e da rapido ispessimento stratigrafico (E). Vedasi la figura 5 per gli altri simboli.
Detail of figure 5 showing the vertical transition between offshore calcareous mudstone (PAC) and overlying nearshore sandstone (AL) within the lower unit. Observe the slump (S) in the nearshore deposits and the small-scale expansion features in the underlying oiTshore, finer-graine sed iments.
con pressocché analoga orientazione direttamente rilevabi li entro i depositi calcarei mesozoici affioranti subito a nord dell'area studiata (ROSELL, dati inediti).
E' possibile infine, anche se al riguardo non disponiamo di dali precisi, che la stessa locale discordanza che si osserva entro la successione di Serraduy, discordanza che noi abbiamo generalizzato in Tav. I A, sia legata a questa attività tettonica sinsedimentaria. Detta discordanza pone a contatto i sedimenti calcareo-marnosi nodulari costituenti le « marne a Echinocorys » Auctt. C) con le torbiditi della Formazione di Vallcarga localmente deformate. Tale discordanza potrebbe in effetti rappresentare il reinnesto della se-
dimentazione normale al di sopra di depositi deformati e parzialmente denudati da franamenti in massa verso l'adiacente depressione creatasi strutturalmente.
Se le conclusioni precedenti sono sostanzialmente valide, risulta da esse che le facies torbiditiche dell'« unità superiore » possono essere collocate in un quadro batimetrico e deposizionale assai preciso. Esse furono deposte a profondità dell'ordine di almeno 500 metri e risultano essere stretti equivalenti laterali di
(l) Questi depositi corrispondono grosso modo ai sedimenti argi lloso-calcarei di piattaforma della nostra <<unità inferiore>>.
LE SPIAGGE FOSS ILI DELLE ARE AR I E DI AREN (CRETACICO SU PERIORE) ECC. 511
fig . 9 - Pieghe da slumping entro le peliti calcareo-argillose della « unità inferiore >> tra la valle Noguera Ribagorzana ed lscles. Q ueste pieghe coinvolgono localmente l'i ntero spessore dell'<< unità inferiore >> e sono qui interpretate come il risulta to di scivolamen ti in massa per e!Tetto del basculamento tettonico (vedasi testo) che interruppe la deposizione di quest'unità e ne modificò sosta nzialmente l'assetto geometrico (cf. Tav. l A) .
Slump folds alfecting the entite thickness of the lower unit between the Noguera Ribagorzana vaJl ey and Iscles. The folds are interpreted as the result o f large-scale slumping which occurred during the fina! tilting of the unit (see TabJe I A and english summary) .
depositi di spiaggia ubicati lungo una linea di costa ad una distanza dell'ordine di l O chilometri (fig. 7) .
Questi sedimenti torbiditici, i cui caratteri di facies sono discussi in maggior dettaglio nella seconda parte di questo lavoro, possono rappresentare un eccellente esempio di riempimento di una depressione strutturale di natura sinsed imentaria .
La loro origine è qui postulata secondo lo schema della fig. 7. ossia alla base di disposti vi di offlapping determinatisi nel corso della generale regressione sulla p iattaforma e come risultato di onde e correnti di tempesta in zone litorali o neritiche, con messa in sospensione di sabbie fini e silts successivamente trasportati al largo da correnti turbolente e diluite. Il gradiente del pendio deposizionale appare del tutto adeguato per tale meccanismo, anche supponendo, come
necessario, che il valore iniziale di 50 metri per chilometro sia venuto col tempo a diminuire.
Al limite può divenire assai sottile la distinzione tra questi meccanismi e quelli proposti da HAYES
(1967), R EI ECK & SINGH (1972) , e GOLDRING
& BRIOGES (1973) per i cosiddetti« storm sand layers » .
In effetti , laddove esistono condizioni fisiografico-batimetriche come quelle del caso da noi esaminato, la distinzione non ha forse più senso dal momento che il gradiente del pendio è sufficiente ad accelerare le sospensioni su brevi distanze e a determinarne la loro rapida evoluzione in vere e proprie correnti torbide.
l n favore dello schema della fig. 7 stanno da un lato le strutture deposizionali degli strati torbiditici, dall'altro le direzioni delle paleocorrenti (da ENE a ESE), le brusche terminazioni degli strati verso oriente,
512 G. GHJBAUDO - E. MUTTI - f. ROSELL
geometrie di offlapping a piccola scala, ed infine la mancanza di ogni altro elemento che possa far configurare un differente assetto deposizionale.
Sulla base di quanto sopra, e ricordando i dati biostratigrafici riportati e discussi più sopra, ci sembra assa i probabile che tutto l'intero quadro deposizionale tardo-cretacico, tra le valli del Segre e delI'Esera, possa sostanzialmente riflettere condizioni simultanee di regressione in aree di piattaforma (Arenarie di Aren) e di offlapping nelle zone più profonde del bacino (Formazione di Vallcarga), con graduale riempimento di quest'ultimo da est verso ovest.
Questi processi, in un contesto complicato dalla tettonica sinsedimentaria, avrebbero determinato la sostanziale equivalenza nel tempo tra porzioni di sedimenti litorali e torbiditici appartenenti a formazioni ed a eventi sedimentari sinora ritenuti nettamente distinti nel tempo. Questa ipotesi non può tuttavia essere verificata al presente in ragione della mancanza di adeguati studi biostratigrafici e di facies per i sedimenti in questione.
2. 3. 3. I DEPOS ITI LITORALI DELLE ARENARIE DI AREN
s.s.
L'organ izzazione laterale e verticale delle varie facies componenti i depositi di spiaggia dell'« unità superiore » (Arenarie di Aren s.s.), costituenti il principale interesse di questo lavoro, è mostrata in Tav. I B. Tale tavola rappresenta uno spaccato stratigrafico di estremo dettaglio ottenuto, come accennato in precedenza, attraverso la correlazione strato per strato, o per gruppi di strati, di sezioni stratigrafico-sedimentologiche opportunamente spaziate; queste sezioni sono ubicate a cavallo del Rio oguera Ribagorzana, pressocché in corrispondenza alla chiusura del cuneo sedimentario dell'« unità superiore ».
Tale spaccato permette la visualizzazione delle effettive relazioni spazio-temporali tra le varie facies che compongono ciascun ciclo di spiaggia, nonché tra i cicli medesimi, e di trarre, per conseguenza, utili indicazioni sugli originari pendii deposizionali e sulla geometria dei depositi, sui meccanismi genetici dei cicli stessi ed infine sull 'evoluzione complessiva di queste spiagge tardo-cretaciche. Come dati di riferimento per la restituzione grafica dello spaccato predetto sono stati scelti i tetti d i livelli interpretati come piccoli delta di marea la cui originaria superficie deposizionale è supposta orizzontale. Questa scelta ha permesso una ricostruzione sufficientemente verosimile delle rela-
zioni di facies all'interno di questi sedimenti. Come è stato fatto presente nel paragrafo introduttivo, la descrizione dei caratteri sedimentari delle varie facies riconosciute è rimandata alla seconda parte di questo lavoro: argomento di questo paragrafo sarà pertanto l'analisi dei rapporti stratigrafici tra queste ultime.
Come mostrato in Tav. I B, prescindendo dai sedimenti lagunari e di marea a diretto contatto con il tetto dell'« unità inferiore» e le cui relazioni di facies saranno trattate nelle pagine successive, la parte stratigraficamente più alta dell '« unità superiore» appare sostanzialmente costituita da tre tipi di associazioni di facies rispettivamente riferibili a depositi eolici, di spiaggia e di piattaforma. A tali sedimenti si associano, localmente, p iccoli delta di marea. Per ciò che concerne le relazioni spaziali tra i vari cicli di spiaggia e tra questi ed i sovrastanti depositi eolici la figura in esame appare sufficientemente chiara così da non richiedere una discussione troppo approfondita.
Ciascun ciclo di spiaggia costituisce un corpo sedimentario grosso modo tabulare la cui inclinazione riflette quella dell'originaria superficie deposizionale. Da tale inclinazione primaria delle superfici deposizionaJi conseguono le relazioni diacrone delle linee tempo, materializzate da singole superfici di stratificazione, rispetto alla geometria dell'intero corpo arenaceo litorale; quest'ultimo infatti, osservato nel suo insieme, acquista una geometria anch'essa approssimativan}.ente tabulare ma, a differenza dei singoli corpi sedimentari che lo costituiscono, risulta orizzontale o sub-orizzontale.
Sebbene ciascuna superficie di strato o ciascun singolo strato della successione sedimentaria materializzi in effetti una linea tempo, in Tav. I B sono messe in risalto quelle linee tempo espresse dalle superfici deposizionali che limitano verso l'alto ogni ciclo di spiaggia. Tali superfici deposizionali di fine-ciclo acquistano particolare interesse poiché permettono la suddivisione dei singoli cicli nonché l 'osservazione delle loro reciproche relazioni spaziali. A proposito di queste ultime è possibile osservare come ciascun ciclo di spiaggia risulti progressivamente pii:t spostato verso il mare aperto, e più alto stratigraficamente, rispetto al precedente, così da definire un tipico assetto embricato riflettente un 'effettiva generale regressione della linea di costa attraverso una successione di singoli eventi costruttivi delle spiagge stesse (fig. 10). Analogamente, i sedimenti eolici associati al sistema di spiagge regressive sormontano queste ultin1e attraverso un contatto erosionale via via più alto stratigraficamente nel senso
fig. IO - Veduta grosso modo est-ovest della parte superiore dell'<< unità superiore » delle Arenarie di Aren subito ad ovest del Rio oguera Ribagorzana (cf. T av. I B). La fotografia mostra la transizione sia verticale che laterale tra peliti e siltiti di piattaforma e arenarie di spiaggia. Queste ultime costitu iscono livelli sempre più spessi, dal basso verso l'alto, entro le peliti di piatt•aforma alle quali p assano inoltre lateralmente, verso ovest, ossia verso destra nelola fotografia, in direzione del mare aperto. Il tetto delle arenarie di spiaggia (S) è interamente costituito da deposi ti eolici (E) discordanti lungo tutta la parte destra dell'affioramento mostrato in figura.
East-west view of the upper part of the upper unit immediately wcst of the oguera Ribagorzana river (see fig. 38). The picture shows both vertical and latera! transition from ofTshore siltstone and muclstone into beach s nel t ne. The Jatter occurs a increasinglv thickcr levels from base to to : these levcls thin ou sea a ·d.
r
"' "' "O
> C'l C'l
"' .., o "' "' E: c m r r
"'
514 G. GHJBAUDO - E. MUTTI - J, ROSELL
della direzione generale di regressione, ovvero da oriente ad occidente.
Di particolare interesse, ai fini di una migliore comprensione delle modalità regressive di questa linea di costa tardo-cretacica e della dinamica costruttiva delle singole spiagge, è infine l'osservazione della posizione spaziale relativa tra i vari cicli. L'osservazione della Tav. I B mostra infatti come, pur nell 'ambito di un generale schema regressivo, i singoli cicli di spiaggia contraggano sovente rapporti trasgressivi gli uni rispetto agli altri. In conseguenza di tali rapporti, facies di piattaforma e di transizione di un determinato ciclo vengono così a sovrapporsi, sovente, su depositi di transizione c di spiaggia esterna del ciclo sottostante o, al limite, su parte degli stessi depositi di battigia. Successivamente a tale iniziale trasgressione, si instaura, in ogni spiaggia, una tendenza regressiva attraverso la quale si determina l'effettivo avanzamento della costa verso il largo.
Queste considerazioni permettono due deduzioni significative: l) la generale regressione della linea di costa avveniva attraverso una successione di minori eventi trasgressivo-regressivi; 2) ogni singolo ciclo di spiaggia si individua tramite una rapida, seppur modesta, trasgressione iniziale seguita da una più lenta fase regressiva.
Entrambi i punti suddetti non appaiono esclusivi della linea di costa delle Arenarie di Aren ma sembrano piuttosto caratteri generali di gran parte delle regressioni legate a coste basse e piatte. Esempi di coste regressive fossili del tutto confrontabili sotto questi aspetti con quella delle Arenarie di Aren sono forniti da YOUNG (1957), WEIMER (1961), HOLLENSHEAD & PRITCHARD (1961) e CAMPBELL (1971). In accordo con questi Autori, tali episodi trasgressivo-regressivi, che stanno alla base dell'aspetto ciclico di questi sedimenti, sono riferibili, con ogni probabilità, al perenne mutare del delicato equilibrio tra velocità di sedimentazione e di subsidenza.
Le conclusioni di cui sopra mettono infine in risalto come, almeno nella dinamica regressiva dei depositi litorali qui presi in considerazione, siano da escludere abbassamenti o innalzamenti del livello marino legati a fenomeni più generali quali potrebbero essere, ad esempio, eventuali effetti eustatici. Anche nel caso più improbabile che effetti di tal genere abbiano avuto una certa importanza, essi risultano oscurati nei sedimenti in questione dai meccanismi suaccennati e, pertanto, di impossibile precisazione.
Una discussione sulla interpretazione del complesso di spiagge regressive dell'« unità superiore » in un
quadro ambientale più ampio non può prescindere dalle seguenti osservazioni (cf. Tav. I):
t) Associazione costante dei depositi di spiaggia, almeno in tutta l'area compresa tra Sapeira ed i dintorni di Aren, con sedimenti eolici.
2) Presenza, alla base dei depositi di spiaggia, di grandi corpi arenacei canalizzati interpretati come sedimenti di bocca di marea (cf. Tav. I A e paragrafi successivi).
3) Innesto del complesso spiagge-dune eoliche dell'« unità superiore» sui depositi di spiaggia dell'« unità inferiore » nei pressi di Sapeira.
4) Caratteri dei depositi « garumniani » sovrastanti, direttamente a contatto con le Arenarie di Aren s.s. Questi sedimenti, di cui non è stato fatto alcun cenno in precedenza, possono essere così brevemente delineati: facies marnoso-calcaree con presenza di macrofaune indicative di acque salmastre al tetto della sezione di Sapeira; facies di pianura inondabile costiera nell'area compresa tra Sapeira ed Iscles; facies calcareo-marnose lacustri a oogoni di Caracee al tetto della sezione di Iscles. Inoltre, ad est dell'area studiata, nella vicina Valle Noguera Pallaresa, facies lagunari costituiscono infine gran parte dei sedimenti « garumniani » sviluppati al tetto delle Arenarie di Aren ivi affioranti (LIEBAU, 1973).
L'associazione di depositi di spiaggia con sedimenti di bocca di marea, eolici e lagunari, nonché con facies deposte in specchi d'acqua dolce o salmastra, costituisce il carattere più significativo di quei sedimenti depostisi in corrispondenza di coste contraddistinte da una relativamente complessa differenziazione ambientale (barrier complex) in pianure alluvionali costiere, lagune e specchi d'acqua protetti e cordoni litorali (MASTER, 1967; SHELTON, 1967; CURRAY, 1969; DICKINSON et al., 1972; etc.).
Il complesso di spiagge regressive dell'« unità superiore », unitamente ai depositi eolici associati, viene pertanto qui interpretato, sulla base delle precisazioni stratigrafiche e sedimentologiche precedenti, come un cordone litorale in via di progressivo avanzamento verso il largo. Tale cordone litorale proteggeva localmente specchi d'acqua dolce e salmastra e più vaste aree lagunari sviluppate ad est, e probabilmente nordest, dell'area studiata, attualmente solo in parte rappresentati entro la locale successione sedimentaria del « Garumniano ».
Di particolare interesse speculativo, ai fini di
LE SPIAGGE FOSSILI DELLE ARENARIE DI AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 515
questa discussione, appare infine l'innesto del complesso di spiagge e dune eoliche del cordone litorale suddetto al tetto dell'« unità inferiore » nei pressi di Sapeira. E' possibile in tal caso supporre che una qualche irregolarità fisiografica nella primitiva linea di costa abbia innescato una prima freccia litorale (spit) dal cui progressivo sviluppo prese origine il cordone litorale suaccennato. Tale originaria irregolarità è probabilmente ricollegabile al basculamento del blocco di faglia discusso in precedenza ed il cui asse di rotazione è in effetti ubicabile all'incirca nella stessa area in cui l'innesto s'effettua.
L'accrezione ed il progressivo avanzamento verso il mare delle spiagge tardo-cretaciche delle Arenarie di Aren sembra infine da ascriversi almeno localmente, come nella maggior parte di analoghi depositi recenti, <tl continuo trasporto sottocosta di sabbie e silts da parte di correnti litorali e costiere. Sulla base dei dati attualmente a nostra disposizione sarebbe prematuro localizzare l'area di provenienza e la direzione di trasporto di questi materiali.
3. DESCRIZIONE DELLE FACIES
3.1. Depositi di spiaggia ed associati sedimenti eolici
3. l. 1. D E POSITI EOLICI E DI RETROSPIAGGIA
Sedimenti eolici e di retrospiaggia sono sviluppati nella porzione sommitale delle Arenarie di Aren lungo tutta l'area di affioramento compresa tra Sapeira ed i dintorni del paese di Aren. Essi verranno descritti ·congiuntamente poiché, in questo caso specifico, la più meno intensa rielaborazione eolica anche dei depositi di retrospiaggia rende problematica sul terreno una netta distinzione dei sedimenti appartenenti a ·questi due ambienti.
Nel loro insieme i depositi eolici costituiscono un -corpo sedimentario limitato da superfici inferiore e -superiore irregolari, che si estende in direzione est-ovest per circa 6 chilometri con una potenza media di 30-40 metri. In successione verticale i depositi eolici appaiono inquadrati superiormente dai sedimenti continentali del « Garumniano » e, inferiormente, dal ·complesso di spiagge regressive dell'« unità superiore » su cui poggiano in discordanza, e, talora, con un netto contatto erosionale (Tav. I B e fig. 11 A). Come mostrato in Tav. I B questi sedimenti possono sormontare indifferentemente, tramite il loro contatto inferiore erosionale, facies di battigia o di spiaggia esterna. I depositi di questa facies risultano costituiti da
quarzareniti bianche pressocché pure ed a cemento calcitico, ben pulite e classate, la cui granulometria più frequente rientra nel campo delle sabbie mediofini e medie. Solo localmente sono presenti concentrazioni dì materiale più grossolano, rappresentato da sabbie da grossolane a mìcroconglomeratìche, in livelletti mìllimetrìci allineati lungo superfici di lamine.
La stratificazione di queste arenarie è per lo più di difficile definizione. Dove le strutture interne sono meglio visibili le arenarie eoliche consistono di un complesso di strati, da 15-20 centimetri fino a 3-4 metri di spessore, limitati da superfici curve e non parallele tra loro (fig. 12). Le strutture interne, in questo caso, sono costituite da gruppi di lamine oblique a grande scala concave verso l'alto, che, intersecandosi, costituiscono la tipica struttura a festoni (festoon cross bedding~. In tagli paralleli alla direzione del vento le medesime arenarie mostrano gruppi di lamine oblique unidirezionali sia di tipo tabulare che cuneiforme (fig. 13 A).
Sebbene le direzioni di immersione delle lamine presentino un'ampia dispersione, esse immergono predominantemente, con inclinazioni comprese tra 20° e 30°, verso il quadrante nord-orientale. Altrove, la stratificazione è di più difficile risoluzione e solo localmente si rilevano superfici principali debolmente curve a grande scala che si intersecano e separano livelli internamente laminati o senza strutture visibili.
Tali depositi appaiono virtualmente privi di fossili e solo nella loro porzione stratigraficamente più alta, al passaggio con i soprastanti sedimenti continentali « garumniani », si rinvengono macrofaune a gasteropodi polmonati (Lychnus sp.) e frammenti di uova di dinosauro (fig. 13 B). Questi giacimenti, localizzati rispettivamente sulla vecchia mulattiera di Sapeira e nei pressi di Orrit, erano già stati in precedenza segnalati da RosELL (1967).
Intercalati nei depositi descritti sono relativamente frequenti dei livelli discontinui, spessi fino a 70-80 centimetri, di arenarie estremamente mal classate, generalmente bruno rossastre chiare sia in patina che in frattura. che presentano caratteristiche concentrazioni e passate di granuli più grossolani (fino ad oltre l centimetro) e di frammenti di fossili marini sovente totalmente ricristallizzati (fig. 11 B). Tali livelli sono qui interpretati come il prodotto della parziale rielaborazione eolica di originari depositi di retrospiaggia, dove i gusci di organismi spiaggiati durante le tempeste ed i materiali più grossolani sarebbero concentrati come materiale residuale dall'azione di cernita del vento in aree di deflazione.
516 G. GHIBA U DO • E. MUTTI • ). ROSELL
fig. 11 - A: Discordanza angolare (D) per erosione tra sedimen ti eolici (E) e sottostanti facies di spiaggia costituite in prevalenza da depositi di battigia (B). B: Particolare di sedimenti di retrospiaggia. Si noti lo scarso grado di classazione dell 'arenaria e l'abbondanza di gusci di molluschi spiaggia ti. Questi ultimi sono totalmente ricristallizzati .
A : Dune sandstone (E) resting unconformably on top of foreshore deposits (B). B: Detail of backshore deposits. Note the very poor sorting of the sandstone and the abundance of recrystallized shells.
LE SPIAGGE FOSS ILI DELLE ARENARIE DI AREN (CRETACI CO SU PER IORE) ECC. 517
fig. 12 - A: Depositi eolici (E), mostranti gruppi di lamine oblique a grande scala limi tati da supenfici curve e non parallele tra loro (festoon cross bedding), a tetto di sedimenti di retrospi•aggia (R). II taglio de].]'affioramento è grosso modo parallelo aJ.Ia direzione del vento. B: Stru ttura a festoni in depositi eolici in un taglio all 'incirca normale rispetto alla direzione del vento.
A: Festoon cross bedding in dune sandstone (E) resting on top of backshore deposits (R). The exposure is oriented roughly parallel to wind direction. 8: Festoon cross bedding in dune sandstone in a cut roughly perpendicular to wind direction.
518 G. GH IBAUDO- E. MUTTI - j . ROSELL
[i.g. 13 - Depositi eolici. A: Gruppi di lamine oblique unidirezionali e Mngenziali, limitati da superfici piane (tabular cross bedding) in un taglio parallelo a1la direzione d el vento. B: Gasteropodi polmonati (Lychnus sp.) entro depositi eolici.
Dune sandstone facies. A: Tabular sets of unidirectional, tangential cross laminae in a cut parallel to winwd direction. B: Terrestrial gastropodes ( Lychnus sp.}.
LE SPIAGGE FOSSILI DELLE ARENARIE DI AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 519
L' interpretazione di tutti questi sedimenti come depositi eolici appare giustificata dalla loro posizione stratigrafica e dalle strutture e tessiture che li caratterizzano. l caratteri tessiturali e le strutture interne di vari tipi di dune eoliche costiere recenti sono stati descritti da Mc KEE (1957), Mc BRIDE & HAYES (1962, LAND (1964), YAALON (1967), BIGARELLA et al. (1969). Lavori a carattere riassuntivo sui depositi eolici in generale sono forniti da Mc KEE (1966), GLENNIE (1970) e BIGARELLA (1972).
Sezioni in arenarie di dune costiere paragonabili per geometria, dimensioni delle strutture e tessitura dei sedimenti a quelle descritte per le Arenarie di Aren sono mostrate in particolare da Mc KEE (1957 , fig. 22), Mc BRIDE & HAYES (1962, fig, 2) e BIGARELLA et al. (1969, fig. 9). Nel loro dettagliato studio sulle dune costiere recenti del Paranà (Brasile) BIGARELLA et al. ( 1969) mostrano inoltre la diretta sovrapposizione, in successione verticale, delle sabbie di duna sui depositi di spiaggia. Analoga situazione è documentata da CAM PBELL (1971) per i sedimenti eolici associati a i depositi di spiaggia nella Gallup Sandstone del Cretacico superiore del Nuovo Messico.
3 . l. 2. DEPOS ITI DI BATTIGIA
I caratteri della stratificazione e le strutture sedimenarie dei depositi di battigia sono ben noti nella letteratura concernente i sedimenti di spiaggia recenti (THOMPSON, 1937; Mc KEE, 1957; LOGVINENKO & REMIZOV, 1964; SOLIMAN, 1964; ERVIN, 1964; CLIFTON, 1969; CLIFTON et al., 1971 DICKINSON et al., 1972; REINECK & SINGH, 1973); esempi simili sono descritti in sedimenti fossili da VISHER (1965), SHELTON (1967), MASTERS (1967), CAMPBELL (1971), HOWARD (1972) e CuFTON (1973). Tutti questi Autori concordano sostanzialmente nella descrizione dei caratteri dei depositi di battigia che appaiono sempre costituiti da arenarie generalmente ben classate, caratterizzate tipicamente da lamh1e parallele, più o meno inclinate verso mare.
I sedimenti delle Arenarie di Aren riferibili a questa facies sono costituiti sostanzialmente da arenarie fini e medie, moderatamente ben classate; più raramente sono presenti arenarie grossolane o molto grossolane per lo più concentrate in lamine singole o in gruppi di lamine di limitato spessore. Composizionalmente, la quasi totalità di questi sedimenti è riconducibile a quarzareniti a cemento calcitico con trascurabili quantità granuli carbonatici, in prevalenza
bioclasti. Solo localmente, ~·ella parte bassa della sezione di Sapeira (cf. sez. l, Tav. [ A), la componente carbonatica diventa rilevante ed in alcuni casi prevalente. Gli strati all'interno di questa facies sono in prevalenza da medio-sottili a spessi, più raramente massicci, e caratterizzati da superfici di stratificazione piane e parallele. Le strutture intrastratali sono rappresentate da lamine parallele e debolmente inclinate l o - 3° unidirezionalmente verso mare rispetto alle superfici di stratificazione oppure, come nel caso pitt comune, in apparenza parallele e concordanti con le superfici di stratificazione in relazione ali 'orientazione dei tagli naturali (fig. 14). In alcuni casi uno strato può mostrare locali intersezionj tra gruppi di lamine parallele che, pur conservando la medesima direzione di immersione, hanno differente inclinazione .
Questi sedimenti risultano inoltre privi di fossili; una qualche attività organica è testimoniata solo di rado dalla presenza di piccole gallerie cilindriche di organismi limivori per lo più verticali e di incerta attribuzione. Ripple marks, rill marks e altre strutture minori segnalate in analoghi sedimenti recenti non sono state osservate nelle Arenarie di Aren.
Stratigraficamente, questi depositi appaiono infine inquadrati lateralmente da facies di spiaggia esterna verso mare e da facies eoliche verso terra. Analogamente, in successione verticale, essi riposano sui medesimi sedimenti di spiaggia esterna e, in un ciclo regressivo complero, sono sormontati in discordanza e con un contatto erosionale dalle facies eoliche (fig. 11 A).
3 . l. 3. DEPOSITI DI SPIAGGIA ESTERNA
I sedimenti assimilati alla facies di spiaggia esterna sono costituiti da quarzareniti fini e medie prevalenti, subordinatamente molto fini , generalmente con buona o moderata classazione, in strati, da sottili a spessi, limitati da superfici di stratificazione sia piano-parallele che ondulate (wave parallel bedding di CAMPBELL, 1 96 7). Solo nelle spiagge esterne, associate a battige calcarenitiche, come in parte della sezione di Sapeira, questi depositi sono costituiti da biocalcareniti con granuli di quarzo sparsi ed in proporzioni variabili.
Due tipi di strutture interne caratterizzano gli strati di questa facies. Nel caso più generale, le strutture primarie all'interno degli strati di spiaggia esterna sono completamente obliterate dall'azione di bitoturbazione di organismi bentonici (fig. 15); in questo caso gli strati acquistano struttura omogenea e le superfici di stratificazione divengono indistinte (fig. 16 A).
520 G. GHIBAUDO - E. MUTT! - J. ROSEll
fig. 14 - Depositi di spiaggia. A: Arenarie <li battigia. Parte alta di un ciclo di spiaggia regressivo. Passaggio verticale tra depositi di spiaggia esterna (SE) , totalmente bioturbati , a snvrastan ti sedimenti di battigia (B) a lamine piane e paraUele. B: Arenarie di battigia mostranti le tipiche lamine piano-parallele.
Foreshore sandstone facies. A: Foreshore sandstone (B) resting on top of entirely bioturbated shoreface deposits (SE). B: Close-up of parallel laminated f01·eshore sandstone.
LE SPIAGGE FOSS I LI DELLE ARENARIE DI ARE (CRETACICO SUPER IORE) ECC. 521
fig. 15 - Sedimenti di spiaggia esterna. A: Strati spessi e massicci di arenarie totalmente bioturbate. B: Particolare del grado di bioturbazione.
Shoreface deposits. A: Thick to massive sandstone beds completely bioturbated. B: Close-up of bioturbation features.
fig. 16 - Depositi di spiaggia esterna. A: Megasequenza negativa (coarsening-upward cyc/e) in un ciclo di spiaggia regressivo, costituito, dal basso verso l'alto, da peliti siltose di piattaforma (P), arenarie e siltiti siltose di transizione (T) ed arenarie di spiaggia esterna (S). Notare la completa bioturbazione di tutti i sedimenti e la conseguente, parziale amalgamazione degli strati. B: Lamine oblique a grande scala legate a ripples da onda. Si noti la conformazione esterna simmetrica dei ripp/es preservata e la geometria delle lamine che si adatta a quest'ultima.
Shoreface deposi,ts . A: Regressive, coarsening-upward sequence including, from base to top, the following facies: offshore mudstone and siltstone (P), oiJshore-beach transition (T), and shoreface sandstone (S). B: Truncated wave-ripple laminae, or wave ripple bedding, in shoreface sandstone.
LE SPIAGGE FOSSILI DELLE ARENARIE DI AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 523
Tale bioturbazione appare come uno degli attributi peculiari dei sedimenti di spiaggia esterna e di transizione di alcuni tipi di depositi litorali fossili (SHEL TON,
1967; CAMPBELL. 1971; DICKINSON et al., 1972; How ARD, 1972); esempi di analoghi depositi recenti caratterizzati da intensa bioturbazione sono noti nella letteratura concernente l'argomento (REINECK & SINGH, 1973, cum bibl.).
Solo raramente la bioturbazione di questi sedimenti preserva parzialmente gruppi di lamine oblique a grande e piccola scala, limitati da superfici curve e non parallele, che possono rappresentare resti della particolare laminazione costituente il secondo tipo di struttura presente in questa facies. Quest'ultima è costituita da gruppi di lamine oblique a grande e piccola scala, la cui geometria ripete parte della conformazione e sterna di ripples da onda, che si ritagliano e troncano tra loro (fig. 16 B). Questi ripples variano in lunghezza d'onda da 30-40 centimetri fino ad l metro e in altezza da pochi centimetri fino a 10-15 centimetri. Quando la forma esterna ondulata dei ripples da oscillazione è preservata, i gruppi di lamine, in corrispondenza delle creste possono ritagliarsi nettamente o, come nel caso più generale, vi può essere parziale sovrapposizione di un gruppo sull'altro. Questa struttura, descritta per la prima volta da CAMPBELL (1966) , e denominata con il termine di « truncated wave-ripple laminae » è stata attribuita da questo stesso Autore alla migrazione e sovrapposizione di ripples da onda sul fondo. La stessa struttura è stata descritta da REINECK & SINGH (1973), pag. 89 come wave-ripple bedding.
Le arenarie di spiaggia esterna possono inoltre mostrare, localmente, lamine oblique da corrente, a piccola e grande scala, legate alla migrazione di ripples ·e dune di vario tipo e con differente orientazione, analogamente a quanto segnalato per corrispondenti sedimenti recenti. Piccoli ripples da oscillazione e da corrente sono infine comunemente rappresentati al tetto di molti strati di questa facies.
Molto abbondanti nelle arenarie di spiaggia esterna sono le tracce fossili rappresentate da semplici gallerie cilindriche (common tubes) sia verticali che orizzontali, che, più raramente da Ophiomorpha e Asterosoma (fig .17). Ad eccezione delle gallerie cilindriche semplici, che sono ripartite in tutti i sedimenti di questa facies, le altre tracce fossili appaiono distribuite pressocché unicamente nei depositi totalmente bioturbati e solo di rado in quelli con strutture primarie ancora ben preservate.
Le relazioni di facies laterali e verticali dei sedi-
menti di spiaggia esterna sono mostrati in Tav. I B. Questi depositi sono inquadrati lateralmente da facies di transizione verso il mare aperto e da facies di battigia verso terra. Verticalmente, essi sono limitati da facies di transizione verso il basso e da facies di battigia verso l'alto in successioni regressive; quando trasgrediti questi sedimenti sono direttamente ricoperti da facies di transizione o di piattaforma (offshore).
3. 1. 4. fACIES DI TRANSIZIONE
La facies di transizione è caratterizzata da strati da sottili a medio sottili, alternativamente consistenti e friabili, di arenarie fini e medio fini. Siltiti e peliti siltose si intercalano sovente con le arenarie e localmente possono essere dominanti (fig. 18).
Gli strati . sono limitati da superfici di stratificazione prevalentemente piane e parallele o, più di rado, ondulate. Tali superfici non sono tuttavia ovunque chiaramente distinguibili causa l 'intensa bioturbazione cui questi sedimenti sono andati soggetti : per conseguenza, interi pacchi di strati appaiono sovente totalmente omogeneizzati e acquistano una stratificazione pressocché indistinta. Le arenarie di questa facies, a differenza di quelle di battigia e di spiaggia esterna, sono più ricche in contenuto pelitico e contengono, talora in abbondanza, mica e piccoli frustoli carboniosi. Questi ultimi hanno in genere dimensioni inferiori a 2-3 millimetri; frammenti centimetrici non sono tuttavia rari.
Leggere differenze nella granulometria, nel contenuto in matrice pelitica e nel grado di bioturbazione controllano il differente grado di consistenza degli strati che caratterizzano questa facies. I depositi maggiormente bioturbati risaltano particolarmente nella morfologia in ragione di una migliore classazione, un basso contenuto in matrice pelitica ed una migliore cementazione.
Le strutture interne primarie non sono quasi mai preservate in questa facies la cui caratteristica principale è la pressocché completa bioturbazione dei sedimenti; la struttura omogenea appare pertanto dominante. Nei rari casi in cui le strutture siano parzialmente preservate, esse sono rappresentate da lamine da ripples da onda troncate, a piccola scala o, più raramente, da lamine oblique a piccola scala da corrente. Le tracce fossili presenti in questa facies sono costituite unicamente da semplici e piccole gallerie cilindriche, sia verticali che orizzontali, e da rare Ophiomorpha.
524 G. GHIBAUDO - E. MUTTI - J. ROSELL
fig. 17 - Strutture biogene in sedimenti arenacei di spiaggia esterna. A: Ophiomorpha. B: Asterosoma von OTTO, 1954 (non GRUBE, 1867) (cf. HANTZSCHEL, 1962).
Biogenic structures in shoreface sediments. A: Ophiomorpha. B: Asterosoma.
LE SPIAGGE FOSS ILI DELLE ARENARIE DJ AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 525
fig. 18 - Deposi ti di transizione (offshore-beach transition) . A: Strati sottili e medio-sottili di arenarie fini alternati a peliti siltose. B: Par tcolare dei depositi di transizione. Si noti la completa obliterazione delle strutture sedimentarie primarie ad opera della bioturbazione.
OITshore-beach transition deposits. A: Alternating thin beds of fi ne sandstone and si lty mudstone. B: Detail of burrowed sediments.
526 G. GHIBAUDO - E. MUTTI - J. ROSELL
Le relazioni laterali e verticali di facies dei sedimenti di transizione sono mostrati in Tav. I B. Lateralmente essi passano a depositi di spiaggia esterna verso terra e a peliti e siltiti di piattaforma verso il largo. In cicli regressivi completi essi appaiono inoltre inquadrati, in successione verticale, tra facies peliticosiltose di piattaforma inferiormente e facies di spiaggia esterna superiormente. Quando trasgrediti essi fanno passaggio direttamente verso l'alto alle facies pelitiche di piattaforma.
Sebbene tali depositi mostrino caratteri simili a quelli di spiaggia esterna, la stratificazione più sottile, la granulometria più fine e l'intercalazione di siltiti argillose, unitamente alla loro posizione stratigrafica, permettono di interpretare questa facies come la naturale transizione delle arenarie di spiaggia ai depositi pelitico-siltosi di piattaforma. Questi caratteri generali sono particolarmente simili alle facies di « offshorebeach transition » della Gallup Sandstone descritta da CAMPBELL (1971).
Questi depositi sono in generale interpretabili come il risultato di una deposizione al di sotto del livello di base del moto ondoso. Le intercalazioni pelitiche sarebbero in questo caso depositi da decantazione e gli straterelli arenacei il prodotto di locali sospensioni generate da onde e correnti di tempesta . I caratteri genetici di questi depositi saranno discussi più in dettaglio nel paragrafo successivo.
3.2. Depositi pelitico-siltosi di piattaforma
A questa facies vengono riferiti i depositi peliticosiltosi che costituiscono i diretti equivalenti laterali verso il mare aperto delle arenarie di spiaggia dell'« uunità superiore » (cf. Tav. I B).
Tali sedimenti sono caratterizzati dall'alternanza di peliti marnose, più o meno siltose, con straterelli di siltiti o, di raro, di arenarie molto fini e fini (fig. 19). Le peliti marnose sono di solito nettamente prevalenti rispetto alle siltiti e sovente rappresentano la quasi totalità dei depositi di questa facies. Altrove i sedimenti di piattaforma sono viceversa costituiti, anche per spessori rilevanti, da siltiti argillose omogenee, totalmente bioturbate.
Gli straterelli siltosi intercalati nelle peliti sono da molto sottili a sottili e presentano, come caratteristica costante, un contatto di base sempre netto e ben marcato. Le superfici di stratificazione che limitano questi strati sono di regola piane e parallele; superfici inferiormente piane e superiormente ondulate non sono
tuttavia infrequenti. Internamente questi strati possono mostrare sia struttura omogenea dovuta a bioturbazione che lamine oblique a piccola scala associate o meno a lamine parallele che, in tal caso, sono sviluppate prevalentemente nella porzione inferiore degli strati. Data la più o meno intesa obliterazione delle strutture interne da parte dell'attività di organismi limivori è difficile, nella maggior parte dei casi, stabilire se le lamine oblique di cui sopra siano dovute a ripples da onda o da corrente. Laddove interamente preservate, le lamine oblique da corrente appaiono tuttavia nettamente prevalenti.
Tutti questi depositi hanno, nel loro insieme, caratteri sedimentari perfettamente confrontabili con quelli di analoghi depositi di piattaforma sia recenti che fossili {HAYES, 1967; CAMPBELL, 1971; REI ECK & SINGH, 1972, 1973; GOLDRI NG & BRIDGES, 1973). In accordo con tali Autori l 'interpretazione più attendibile per la genesi di questi depositi è legata all'alternanza di lunghi periodi di bassa energia ambientale durante i quali decantano i sedimenti pelitici più fini, con periodi di alta energia conseguenti a onde e correnti di tempesta. Durante questi ultimi periodi, notevoli quantità di materiale fine sono erose e poste in sospensione nella zona litorale dall'elevata energia del moto ondoso e sono trasportate successivamente al largo, durante la fase di recessione delle tempeste, con il ritorno verso il mare aperto di ingenti masse d'acqua in eccesso sulla costa (HAYES, 1967). Tali veloci correnti di ritorno, ricche di sedimenti in sospensione, permetterebbero il trasporto di silts e sabbie anche a notevoli distanze dalla costa e gli straterelli arenacei, prodotti dalla loro deposizione, sono noti nella letteratura come depositi di tempesta (storm sand layers di REI NF.CK & SINGH, 1972). Per una discussione più approfondita sulla genesi di tali depositi vedasi REINECK & SINGH, 1973 e GOLDRINGH & BRIDGES, 1973.
Stratigraficamente questi sedimenti costituiscono ovunque i corrispondenti laterali verso il largo delle facies di spiaggia (cf. Tav. l) e la loro posizione nella successione stratigrafica appare in stretta relazione con i fenomeni trasgressivo-regressivi sia maggiori che minori riscontrabili nell'area in studio. In successione verticale essi marcano infatti gli eventi trasgressivi sovrapponendosi direttamente alle facies descritte nei paragrafi precedenti o ad altre facies di piattaforma e vengono gradualmente ricoperti, durante le fasi regressive, da depositi di transizione e di spiaggia. Considerati nel loro insieme i depositi pelitico-siltosi costituiscono un corpo grosso modo cuneiforme (cf. Tav. I A)
LE S I' IACCE FOSSILI DELLE ARE ARIE DI ARE (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 527
fig. 19 - Peliti e silti ti ·di piattarorma. A: Alternanza di prevalenti peliti con strati sotti li e molto sottili di arenarie fini e si.Jtiti. B: Particolare dei sedimenti mostrati nella precedente fotografia.
Offshore si ltstone an d mudstone. A : Thin an d very-thin beds of finesandstone an d si ltstone bounded by even or wavy p aralie! surrace, alternating with prevailing mudstone. B: Close-up of the same exposu re.
528 G. GHIBAUDO - E. MUTT! - J. ROSELL
inquadrato inferiormente da facies relativamente più profonde e superiormente dalle facies litorali delle Arenarie di Aren s.s a cui fanno naturale transizione. I particolari rapporti tempo-stratigrafici conseguenti a fenomeni di off/apping che questi sedimenti contraggono in particolare con le facies torbiditiche sviluppate nella porzione occidentale dell'area in studio sono mostrate in fig . 7 e discusse nella prima parte del lavoro.
3.3. Depositi lagunari
Depositi Jagunari sono sviluppati ad est di Orrit, nella parte orientale dell'area studiata, in corrispondenza della chiusura del cuneo sedimentario costituente l '« unità superiore » (Tav. I B). Questi sedimenti sono costituiti da una fitta alternanza di marne siltose grige, localmente siltiti, con straterelli giall<:>bruni di arenarie fini e molti fini (fig. 20 A).
Gli strati arenacei sono da molto sottili a sottili limitati da superfici di stratificazione piane e parallele. Superfici inferiori piane e superiori ondulate sono ugualmente frequenti. Il contatto di base di tali strati è sempre netto ben marcato e le superfici corrispondenti risultano a volte caratterizzate dalla presenza di piccole strutture da corrente riferibili a scour e tool marks. Le strutture interne sono viceversa raramente riconoscibili causa l'intensa bioturbazione che contraddistingue tutti i depositi di questa facies. Quando preservate, esse risultano costituite da lamine oblique a piccola scala da corrente e in misura minore da lamine pianparallele. Relativamente frequente è il caso di straterelli che, pur presentando lamine oblique da corrente al loro interno, mostrano la superficie superiore sagomata da piccoli ripples simmetrici, denotando in tal modo una azione di rielaborazione di questi sedimenti da parte del moto ondoso.
Intercalate agli strati descritti sono marne siltose o siltiti molto fini anch'esse per lo più intensamente rielaborate dall'azione di organismi limivori e senza strutture visibili. Associati a questi depositi si rinvengono infine, nella loro parte superiore, livelli qui interpretati come piccoli canali di marea. Questi ultimi sono rappresentati da strati medio-sottili e spessi di arenarie molto grossolane, a geometria esterna pianoconvessa verso il basso e lenticolare su medie distanze; essi sono inoltre caratterizzati dalla presenza di abbondanti inclusi pelitici (clay chips) e, più di rado, da piccoli frammenti di lamellibranchi.
I sedimenti descritti h~nno una potenza media dell 'ordine dei 10-20 metri ed appaiono inquadrati inferiormente dai depositi di spiaggia dell'« unità inferiore » mentre, verso l'alto, sono sormontati da sedimenti intertidali nella loro porzione occidentale e direttamente dalle facies di spiaggia dell'« unità superiore » nella loro porzione più orientale. Queste relazioni di facies sono illustrate in Tav. I B. Come mostrato in tale figura , il contatto inferiore di questi depositi è riflesso, per un certo tratto, da una superficie inclinata ed erosionale che marca un gradino nella superficie di deposizione dei sedimenti dell'« unità inferiore », qui rappresentati interamente da facies di spiaggia esterna. Questo salto morfologico è interpretato come l'espressione di un terrazzo eroso dal moto ondoso nelle facies di spiaggia sottostanti , prima della deposizione di quelle lagunari. Su tale superficie inclinata queste ultime si sarebbero deposte contraendo con le facies sottostanti rapporti di lieve discordanza stratigrafica (Tav. I B) . Superiormente e lateralmente, verso ovest, le medesime facies lagunari appaiono invece troncate da sedimenti di offshore e intertidali, trasgressivi.
3.4. Depositi di marea
Tre tipi di facies rappresentanti i prodotti sedimentati di ambienti infuenzati dall'azione delle maree sono presenti nelle Arenarie di Aren della Valle Noguera Ribagorzana. Esse sono riferite precisamente a facies intertidali e subtidali, di delta di marea (tidal delta) e di bocca di marea (tidal in/et).
3. 4 . l. DEPOSITI lNTERTIDALl E SUBTIDALl
Facies intertidali e subtidali sono sviluppate nei pressi di Orrit al tetto dei depositi lagunari descritti in precedenza (cf. Tav. I B) . La loro interpretazione è basata sia su caratteri sedimentari direttamente confrontabili con quelli di analoghi depositi recenti che sulla base delle loro relazioni stratigrafiche laterali e verticali.
La fisiografia ed i caratteri diagnostici degli ambienti di marea attuali sono conosciuti soprattutto dagli studi sulle piane di marea che bordano diversi tratti di costa del mare del Nord e sulle aree intertidali della Nuova Scozia (cf. VAN STRAATEN, 1954; EVANS, 1965; KLEIN, 1970; DE RAAF & BOERSMA, 1971; TERWINDT, 1971). Brevi compendi sulle caratteristiche generali di
fig. 20 - A: Depositi lagunari. Strati sottili di arenarie fini e peliti si ltose intensamente bioturbate. Si notino i contatti inferiori molto netti delle intercalazioni arenacee. B: Arenarie di delta di marea. Livello interpretato come delta di marea (DM) , costituito da arenarie medio-grossolane, a tetto di depositi di transizione (T). Si notino la continuità laterale, la base netta ed il tetto transizionale del livello di delta di marea.
A: Thin bedded, burrowed sandstone ancl si lty mudstone, jnterpreted as lagoonal deposits. Note the sharp basai contaot of sandstone beds. Internai structures have been largely destroyed by burrowing. B: Sandstone unit interpreted as tidal delta (DM). It rests on top of offshore-beach transition facies (T). Note the latera! continuity of the tidal delta unit, its flat and sharp base and the transitional upper contact.
530 G. GHIBAUDO - E. M UTTI - J. ROSELL
tali ambienti ed ampi riferimenti bibliografici sugli stessi sono forniti da REINECK (1972) e REINECK & StNGH (1973). Da questi lavori emerge una suddivisione ambientale delle aree a sedimentazione controllata dalle maree in tre sottoambienti principali comprendenti le zone supratidali, intertidali e subtidali. Causa la scarsità di dati concernenti in particolare le aree subtidali odierne, la differenziazione tra depositi intertidali e subtidali appare a tutt'oggi problematica e difficoltosa (DE R.AAF & BOERSMA, 1971). Per questa ragione l'interpretazione dei depositi subtidali relativa a parte dei sedimenti di marea discussi in questo paragrafo è legata sostanzialmente alle relazioni stratigrafiche laterali che essi contraggono con depositi intertidali e di piattaforma adiacenti. Facies supratidali non sono rappresentate o non sono da noi riconosciute in questa porzione delle Arenarie di Aren.
a) Facies intertidali
Questa facies è rappresentata da arenarie fini e medio fini in strati da molto sottili a medio sottili. Tali strati presentano contatti basali netti e piani ed appaiono lenticolari su distanze dell'ordine dei metri o della decina di metri. Carattere localmente dominante di questi depositi è la · più o meno intensa rielaborazione da parte di organismi limivori e la completa obliterazione delle strutture primarie. Negli altri casi, tuttavia , le strutture interne sono rappresentate da gruppi di lamine oblique a piccola e grande scala mostranti la tipica bimodalità direzionale (herringbone structure) che caratterizza i depositi intertidali e direttamente confrontabili con le cosiddette strutture SS e LS di DE RAAF & BoERSMA (1971). Allineamenti di piccoli frammentini pelitici (clay chips) sottolineano di sovente tali lamine mentre a tetto degli strati possono essere preservati ripples simmetrici a cresta spianata (capped-off ripples). Altrove gli strati, pur mantenendo la stessa geometria lenticolare, non mostrano strutture chiaramente interpretabili e sembrano all'apparenza omogenei o presentano lamine parallele o oblique unidirezionali mal definite. Altri caratteri sedimentari come le flaser e lens structures, superfici di riattivazione, etc., presenti in depositi intertidali descritti nella letteratura, non sono stati rinvenuti nei sedimenti di questa facies. Questi depositi non mostrano infine alcun tipo di organizzazione ciclica al loro interno sia per quanto riguarda lo spessore degli strati che per l'organizzazione verticale e la scala delle strutture sedimentarie.
I caratteri descritti ed., in particolare la discontinuità della stratificazione, la presenza di strutture tipo herringbone e di ripples marks spianati, e l'assenza di ciclicità appaiono elementi sufficienti per ritenere che la deposizione di questi sedimenti sia stata controllata almeno parzialmente dall'azione delle maree. I dati disponibili e soprattutto l'assenza di strutture deposizionali a grande scala del tipo descritto da KLEIN
(1970), fanno tuttavia ritenere che queste ultime fossero caratterizzate da escursioni di marea di modesta entità.
b) Facies subtidali
I depositi ascritti a questa facies sviluppano una geometria esterna tabulare e risultano inquadrati lateralmente da facies intertidali verso terra e dalle peliti e siltiti di piattaforma verso il mare aperto (vedi Tav. I B); in successione verticale essi passano verso l 'alto bruscamente a facies trasgressive di piattaforma, da cui sono trasgrediti mentre inferiormente sormontano le stesse con un passaggio transizionale. L'inquadramento stratigrafico di questi sedimenti appare pertanto indicativo di una deposizione avvenuta in un'area subtidale situata pitt al largo ed a profondità maggiore rispetto alle facies intertidali e passante, verso il mare aperto, alle peliti e siltiti di piattaforma.
I sedimenti subtidali sono contraddistinti da strati sottili é subordinatamente molto sottili di arenarie fini e medio fini. Carattere peculiare di tali depositi è la totale rielaborazione da parte di organismi limivori e la conseguente completa assenza di strutture sedimentarie intrastratali. Sovente, interi gruppi di strati risultano tra loro amalgamati in conseguenza dell'azione di bioturbazione determinando livelli compositi, spessi fino a 70-80 centimetri, all'interno dei quali la stratificazione diviene indistinta e di difficile definizione. Altrove, gli strati presentano superfici di stratificazione inferiori piane e superiori ondulate oppure piane e parallele; in ogni caso i contatti di base degli strati di questa facies risultano sempre netti e ben marcati. Tale elemento lascia supporre che analogamente a quanto avviene per altri sedimenti subtidali (vedi i paragrafi relativi ai depositi di transizione e di piattaforma) l 'individuazione di queste superfici inferiori nette sia ricollegabile agli effetti della elevata energia ambientale durante periodi di tempesta.
Questi depositi sono inoltre caratterizzati da una estrema abbondanza di tracce fossili rappresentate, in particolare, dai generi Ophiomorpha, Asterosoma e da
LE SPIAGGE FOSSILI DELLE ARENARIE DI AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 531
gallerie cilindriche sia verticali che orizzontali di incerta attribuzione.
Verso ovest, infine, le facies descritte fanno transizione ai depositi pelitico-siltosi di piattaforma attraverso una graduale perdita di strati arenacei a favore di intercalazioni progressivamente più numerose e più spesse di interstrati pelitico-siltosi e pelitici.
3. 4. 2 . DEPOSITl DI DELTA DI MAREA
A questa facies vengono assimiliati due corpi sabbiosi, di estensione laterale relativamente grande e di limitata potenza, presenti nella successione sedimentaria dell'« unità superiore » nei pressi di Are n. Essi risultano inquadrati in senso verticale da sedimenti -di spiaggia (transizione) e di piattaforma (vedi Tav. I B).
I dettagli della stratificazione e delle strutture sedimentarie che caratterizzano i delta di marea recenti non sono a tutt'oggi conosciuti; sulla base della loro posizione stratigrafica e degli elementi forniti dai caratteri sedimentati dei corpi suaccennati circa il loro meccanismo di deposizione, essi vengono tuttavia da noi interpretati come delta di marea a piccola scala. Tali corpi costituiti da arenarie medie e grossolane, risultano infatti caratterizzati da una geometria esterna lenticolare piano-convessa verso l'alto e da contatti di base estremamente netti e ben marcati (fig. 20 B). I contatti superiori con i sedimenti che li ricoprono appaiono invece transizionali.
Le strutture interne sono per lo più obliterate da fenomeni di bioturbazione o, altrove, questi sedimenti risultano omogenei e senza strutture visibili; solo localmente, nella parte alta di ciascun livello, si riscontrano accenni a lamine parallele o ondulate e, talora, gruppi di lamine oblique unidirezionali e mal definite.
Tutti gli elementi suddetti suggeriscono un'accrezione vert icale di questi corpi legata a trasporto e deposizione di sabbie da parte di correnti trattive ad elevata energia come potrebbero sussistere in vicinanza di bocche di marea nelle aree di costruzione dei delta di marea stessi. Un'ipotesi alternativa per la genesi di questi corpi a contatto basale netto e geometria piano-convessa verso l'alto è la possibilità che essi derivino dallo smantellamento improvviso, ad opera di onde e correnti generate durante periodi di tempesta, di barre di offshore o di secche effimere in via di costruzione al largo.
3. 4. 3. DEPOSITl DI BOCCA Dr> MAREA
Come depositi di bocca di marea sono qui interpretati, sulla base della loro geometria esterna e delle relazioni laterali e verticali di facies, alcuni corpi sabbiosi, canalizzati a grande scala, presenti nella parte stratigraficamente più bassa delle spiagge fossili della «unità superiore» nei dintorni di Iscles (vedi Tav. I A). Nella sezione corrispondente a tale località, l'« unità superiore » presenta infatti nei 20 metri basali della successione di spiagge, alcuni corpi arenacei soprapposti a marcata geometria lenticolare piano-convessa verso il basso (fig. 21 A).
Questi corpi, aventi spessore variabile tra 3 e 8 metri ed estensione laterale fino a 300-400 metri, mostrano sempre un contatto di base erosionale e risultano inquadr.ati lateralmente da facies di spiaggia esterna e separati da modesti spessori (0,5-1 metro) di arenarie totalmente bioturbate del tutto simili a quelle di spiaggia esterna ad essi laterali. Verso l'alto, l'intera successione canalizzata risulta sormontata da una alternanza di facies di spiaggia esterna e di battigia prevalenti.
Solo i depositi di bocca di marea stratigraficamente più bassi appaiono marcatamente erosionali direttamente sulle facies pelitico-siltose di piattaforma sottostanti. In quest'ultimo caso il contatto inferiore erosionale è sottolineato dalla presenza di numerosi flute casts di ]lotevoli dimensioni, (fig. 21 B) indicanti un senso delle correnti da sud. Le arenarie costituenti tali corpi sono medie o medio-fini e possono mostrare, nella loro porzione inferiore, sia lamine parallele che gruppi di lamine oblique a grande scala concave verso l'alto e separate da superfici curve e non parallele (festoon cross bedding) . Nel caso più generale non sono tuttavia visibili strutture interne. Nella parte alta di tali livelli non di rado sono invece presenti lamine oblique a piccola scala da corrente unidirezionale e piccoli inclusi pelitici (clay chips) .
Come discusso nei paragrafi precedenti, l'intera successione di spiagge e di depositi eolici associati costituenti la sommità dell'« unità superiore » è riferibile, nel suo insieme alla progressiva accrezione di un cordone litorale verso il mare aperto. In tale contesto i depositi canalizzati descritti , inquadrati lateralmente e verticalmente da facies di spiaggia, devono necessariamente essere assimilati a sedimenti di bocca di marea. La sovrapposizione di corpi canalizzati separati da facies di spiaggia esterna suggerisce, inoltre, che tale bocca di marea doveva essere tenuta compie-
i>• ...... ,. ....
fig. 21 - Depositi di bocca di marea. A: Corpo arenaceo canalizzato alla base dei sedimenti litorali dell'<< unità superiore ». Si noti il contatto inferiore marcatamente erosionale entro peliti e si lti ti di piattaforma. L'affioramento è ubicato nella prima incisione ad ovest di -Isoles. B: Grandi f/ute casts alla base di arenarie canalizzate di bocca di marea.
Tidal inlet deposits. A: Channelized sediments with lower erosional surface cut into ofTshore siltstone and mudstone. These channelized sediments at the very base of the nearshore sediments comprising the upper part of the upper unit, immediately west of l scles. B: Large-scale flute casts at the base of tidal inlet sandstone.
{tg. 22 - Depositi torbiditici en tro la parte bassa dell'« unità su periore>> nell a zona di lscles. La geometria esterna della stratifìcazione, apparentemente espressa da superfici piano-parallele nella fotografia A, è in effetti assai meno regolare nel dettaglio (vedasi fo to B) a causa di fenomeni di Jenticolarità e discontinui tà laterale degli strati arenacei. Si noti il basso rapporto sabbia : peli te in entrambi gli affioramenti .
Turbidite sediments in the lower part of the upper unit in the l scles area. The generai bedding pa ttern is given by thin , even parallel beds of turbidite sandstone a.Jternating with prevailing mudstone. In detai l, the sandstone beds have often irregular shape due to wedging and lensing (see photo B).
534 G. GHIBAUDO- E. MUTTI - J. ROSELL
fig. 23 - Strutture minori entro i depositi torbiditici del·l'<< unità superiore». A : Sotti·le strato d i arenaria torbid itica mos trante sottili lamine da corrente parallele, ondulate ed oblique. B: Prod cast alla base di uno strato torbiditico.
Minor sed imentary structures of turbidite sediments in the l scles area. A: Thin current laminae in a thin-bedded turbidite sandstone. B: Prod cast at the base of a turbidite bed.
LE SPIAGGE FOSSILI DELLE ARENARIE DI AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 535
tamente aperta solo intermittentemente in occasione di periodi di maggior energia delle correnti di marea.
L'assetto deposizionale sopra descritto è seguibile, tramite una progressiva giustapposizione di corpi canalizzati , per circa 2-3 chilometri ad ovest di Iscles. Ciò lascia supporre che la bocca di marea che interrompeva in questa zona il cordone litorale abbia migrato verso ovest prima di essere gradualmente ostruita. Tale migrazione deve essere avvenuta, probabilmente, in risposta ad un intenso trasporto di sedimenti sottocosta ad opera di correnti costiere analogamente a quanto si verifica in numerosi esempi recenti.
3.5. Depositi torbiditici
Sedimenti interpretati come depositi torbiditici costituiscono gran parte della successione sedimentaria dell'« unità superiore » nella sua area di affioramento più occidentale (cf. Tav. l A). Nella sezione di Jscles essi sviluppano una potenza di circa 400 metri e sono inquadrati inferiormente dalle facies pelitiche dell '« unità inferiore» mentre verso l'alto passano gradualmente, per progressiva perdita di strati arenacei, a facies di piattaforma pressocché interamente pelitiche, legate al complesso di spiagge regressive soprastanti.
Tali depositi sono rappresentati da un'alternanza di marne grige e arenarie fini e molto fini in strati molto sottili, subordinatamente sottili (fig. 22). Le marne sono nettamente prevalenti ed il rapporto sabbia/argiiJa risulta pertanto estremamente basso e compreso tra O, l e 0 ,5. Le strutture intrastratali comprendono esclusivamente lamine parallele e oblique a picçola scala organizzate in sequenze di BouMA (1962) di tipo Te/e, Td-e, Tb-c/e (fig. 23 A); ben sviluppate risultano anche le strutture infrastratali rappresentate da vari tipi di piccoli scour e tool marks indicanti provenienze da est-nord-est e da est-sud-est (fig. 23 B).
l depositi torbiditici descritti possono essere assimilati per i loro caratteri sedimentari alla facies D di MUTTJ & RICCI LuccHI (1972); nel contesto sedimentario locale essi vengono interpretati come depositi legati a sospensioni diluite di limitato volume originatesi, probabilmente, in seguito a risospensione di sedimenti sulle aree di piattaforma situate ad oriente. Tali nuvole torbide, scorrendo verso ovest lungo il pendio deposizionale, depositavano il loro carico nella parte più profonda del bacino determinandone il graduale riempimento.
Manoscritto ricevuto il 12 luglio 1974.
Ultime bozze restituite il 13 gennaio 1975.
4. BIBLIOGRAFIA
BIGARELLA j. j., BECKER R. D. & DUARTE G. M. (1969) -Coastal dune structures /rom Paranà (Brazil). Marine Geo!., 7, 5-55.
BIGARELLA j . j. (1972) - Eolian environmenls: their characleristics, recognition, and impor/ance. In: RIGBY J. K., HAMBLIN W. K. (editors): Recognition oj ancienl sedimenlary environments. Soc. Econ. Pal. Min. Spec. Pubi., 16, 12-62.
BoUMA A. H. ( 1962) - Sedimentology oj some flysch deposi/s. Elsevier, Amsterdam, 168 pp.
8RAMBATI A., FIERRO G., GAZZI P., GNACCOLINI M., MUTTI E. & PAGANELLI L. (1972) - Seminario sul tema : Criteri sedimentologici teorici e pratici per impostare un programma di ricerche per la conservazione dei litorali sabbiosi italiani. Cooperativa Libraria Universitaria, Bologna, 121 pp.
CAMPBELL C. V. (1966) - Truncated wave-ripple laminae. jour. Sed. Petr., 41: 825-828.
CAMPBELL C. V. (1967) - Laminae, laminasel, bed and bedsel. Sedimentology, 8, 7-26.
CAMPBELL C. V. (1971) - Depositional model-Vpper Cretaceous Gallup beach shoreline, Ship Rock Area. Northwestern New Mexico. )our. Sed. Petr., 41 , 395-409.
CLIFTON H. E. (1969) - Beach lamination: nature and origin. Marine Geo!., 7, 553-559.
Cu FTON H. E. ( 1973) - Marine-non marine facies change in middle Miocene rocks, Southeastern Calien/e Range, California. In : Sedimentary facies changes in Tertiary rocksCalifornia transverse and southern coast ranges. SEPM Trip 2, 1973 Annua! Meeting AAPG, SEPM, SEG, 55-57.
CuFTON H·. E., HuNTER R. E. & PHILLIPS R. L. (1971) - Depositional slruc/ures and processes in the non-barred highenergy nearshore. jour. Sed. Petr., 41, 651-670.
CuRRAY j . R. (1969) - Shore zone sand bodies: barriers, cheniers and beach ridges. In: STANLEY D.). (editor): The New Concep/s on Continenlal Margin Sedimenlation. Am. Geo!. lnst., Washington, JC-11-1-18.
DALLONI M. (1910) - Elude géologique des Pyrénées de l'Aragon. Anna! Fac. Sci. Marseille, 444 pp.
DALLO 1 M. (1930) - Elude géologique des Pyrénées Catalanes. Ann. Fac. Sci. Marseille, 26, 365 pp.
DICKINSON K. A., BERRYHILL H. L. jR. & HOLMES C. W. (1972) - Criterio for recognizing ancient barrier islands. In: RIGBY J. K., HAMBLIN W. K. (editors): Recognition of ancient sedimenlary environmenls. Soc. Econ. Pal. Min. Spec. Pubi., 16, 192-2 14.
ERVIN G. O . (1964) - Observalion oj beach cusps and beach ridge jormation on the Long Jsland Sound. jour. Sed. Petr., 34, 554-560.
EvANS G. ( 1965) - l nterdital flat sedimenls and their environments oj deposition in the Wash. Geo!. Soc. London Quar. Jour. , 121, 209-245.
GARRIDO M. A. (1973) - Estudio geologico y relacion entre tectonica y sedimentacion del Secundario y Terciario de la vertiente meridiana/ pirenaica en su zona centrai (pro-
536 G. GHIBAUDO - E. MUTTI - J. ROSELL
vincias de Huesca y Lerida). Tesis doctoral. Universidad de Granada.
GARRIDO M. A. & R1os L. A. (1972) - Sintesis Geologica del Secundario y Terciario entre /os rìos Cinca y Segre (Pirineo Centra/ de 'la vertiente surpirenaica, provincias de Huesca y Lerida) . Bol. Geol. y Min., 58, 1-47.
GHIBAUDO G., MORELLI E., MUTTI E., 0BRADOR A., PONS J., RAM Asco M. & RoSE LL J. ( 1973 a) - Facies y paleogeografia de la << Arenisca de Aren >> (Nota preliminar) . Acta Geol. Hispanica, l , 13-15.
GHIBAUDO G., MORELLI E., MUTTI E., 0BRADOR A., PONS J., RAMASCO M. & RoSELL r. (1973 b) - Osservazioni sedimentologiche preliminari sulle Arenarie di Aren (Cretacico superiore) tra / sona e il Rio Noguera Ribagorzana (Prepirenei spagnoli). Boli. Soc. Geol. lt., 92, 529-540.
GLENN IE K. W. (1970) - Desert sedimentary environments. Elsevier, Amsterdam, 222 pp.
GoLDRI G R. & BRIDGES P. (1973) - Sublitoral sheet sandstone. Jour. Sed. Petr., 43, 736-747.
HAYES M. O. (1967) - Hurricanes as geologica[ agents, south Texas coast. Am. Assoc. Petroleum Geol. Buti., 51, 937-942.
HOLLENSHEAD C. T. & PRITCHARD R. L. (1961) - Geometry of producing mesaverde .sandstones, San fuan Basin. In : PETERSON J. A., 0SMOND J. C. (editors): Geometry of sandstone bodies. Am. Ass. Petroleum Geol., Tulsa, Oklahoma, 98-118.
HANTZSCHEL W. (1962) - Trace fossils and problematica. In: MuoRE R. C. (editor): Treatise on invertebrate paleontology, p. W, Miscellanea, 177-245.
H ENRY J., LAN USSE R. & VILLANOVA M. (1971) - Evo/ution du domaine marin pyrénéen du Sénonien supérieur à l'Eocène inférieur. In : DEBYSER L., LE PICHON X., MoNTADERT L. (editors): Histoire structurale du Goffe de Gascogne, pp. IV, 7-1 ; VI , 7-7, Edit. Technip., Paris.
HooRN (VAN) B. ( 1970) - Sedimento/ogy and pa/eogeography oj an Upper Cretaceous turbidite basin in the south-central Pyrenees, Spain. Leidse Geol. Mededelingen, 45, 73-154.
HowARD J. D. ( 1972) - Trace fossils as criteria jor recognizing shorelines in stratigraphic record. In: RIGBY J. K., HAMLI N W. K. (editors): Recognition of ancient sedimentary environments. Soc. Econ. Pal. Min. Spec. Pubi., 16, 192-214.
KLEIN G. DE V. (1970) - Depositional and dispersa[ dynamics of intertidal sand bars. )our. Sed. Petr., 40, 1095-1127.
LAND L. S. (1964) - Eolian cross-bedding in the beach dune environment, Sape/o I.sland, Georgia. Jour. Sed. Petr., 34, 389-394.
LIEBAU A. ( 1973) - El Maastrichtiense lagunar (Garumniense) de /sona. Libro guida Xli i Coloquio Europeo de Micropaleontologia, 87-112.
LocviNENKO N. V. & REMIZOV I. N. (1964) - Sedimentology of beaches on the north coast of the sea of A zov. In: STRAATEN (VAN) L. M. f . U. (editor): Del/aie and shallow marine deposits. Elsevier, Amsterdam, 245-252.
MASTERS C. D. (1967) - Use of sedimentary structures in de-
termination of depositional tmvironments. Mesaverde Formation, W illiam Fork Mountains, Colorado. Am. Assoc. Petroleum Geo!. Bull., 51, 2033-2043.
MATTAUER M. & SEGURET M. (1971) - Les rélations entre la chaine des Pyrénées et le Goffe de Gascogne. In: DEBYSER L., LE PICHON X., MONTADERT L. (editors): Histoire structurale du Golfe de Gascogne, pp; IV, 4-1 ; IV, 4-24. Edit. Technip., Paris.
Mc BRIDE E. T . & HAYES O. M. ( 1962) - Dune cross-bedding on Mustang Island, Texas. Am. Assoc. Petroleum Geol. Buti., 46, 546-551.
Mc KEE E. D. ( 1957) - Primary structures in some recent sediments. Am. Assoc. Petroleum Geol. Bull., 41, 1704-1747.
Mc KEE E. D. ( 1966) - Structures of dunes a t White Sands National Monument, New Mexico (and comparison with structurale du Goffe de Gascogne, p, IV, 4-1 ; IV, 4-24. tology, 7, 1-69.
MEY P. H. W., NAGTEGAAL P. J. c., ROBERT K. G. & ARTEVELT J. J.A. (1968) - Lithostratigraphic subdivision of post-Her· cynian deposits in the south-central Pyrenees, Spain. Leidse Geo!. Mededelingen, 41, 221-228.
MI SCH P. (1934) - Der bau der mittleren Sudpyrenaen. Abb. Gesell s. Wiss. Gottingen Math. Phys. Kl., t. 111, 12, 1597-1764.
M UTTI E. & RosELL J. ( 1969) - Osservazioni sedimentologiche sul F/ysch senoniano dei dintorni di Pobla de Segur (Prov. di Lerida, Spagna). Boli. Soc. Geol. Tt., 88, 453-467.
MuTTI E., LUTERBACHER H. P., FERRER J. & ROSELL J. (1972) - Schema stratigrafico e lineamenti di facies del Paleogene marino della Zona Centrale Sudpirenaica tra Tremp (Catalogna) e Pamplona (Navarra) . Mem. Soc. Geo!. It., Il, 39t-416.
MuTn E. & RI CCI LucCHI F. (1972) - Le torbiditi dell'Appennino settentrionale: introduzione all'analisi di facies . Mem. Soc. Geol. lt., 11, 161-199.
NAGTEGAAL P. J. C. (1972) - Depositional history and c/ay minerals of the upper Cretaceous basin in the south-central Pyrenees, Spain. Leidse Geo!. Mededelingen, 47, 251-275.
RAAF (DE)J. F. M. & BOERSMA J. R . ( 1971) - Tidal deposits and their sedimentary structures (seven examples from Western Europe). Geol. Mijnbouw, 50, 479-504.
REINECK H. E. (1972) - Tidal flats. In: RIGBY J. K., HAMBLIN W. K. (editors): Recognition of ancient sedimentary enviromnents. Soc. Econ. Pal. Min. Spec. Pubi., 16, 146-159.
REI NECK H. E. & SINGH l. B. (1972) - Genesis of lamina/ed and graded rhythmites in storm-sand layers of shelf mud. Sedimentology, 18, 123-128.
REINECK H. E. & SI NGH l. B. (1973) - Depositional sedimentary environments. Springer-Verlag, Heidelberg, New York , 439 pp.
RosELL J. ( 1967) - Estudio geologico del sector del Prepirineo comprendido entre los rios Segre y Noguera Ribagorzana (Prov. de Lerida). Pirineos, 75-78, 9-214.
ROSELL f ., 0BRADOR A. & PoNs J. M. ( 1972) - Significacion .sedimento/ogica y paleogeografica del nivei arcilloso con corales del Senoniense superior de los alrededores de Pob/a
LE SPIAGGE FOSSILI DELLE ARENARIE DI AREN (CRETACICO SUPERIORE) ECC. 537
de Segur (Prov. de Lerida) . Acta Geo!. Hispanica, t. VII (I), 7-11.
SEGURET M. (1970) - Etude tectonique des nappes et senes décollées de la partie centrale du versant sud des Pyrénées. Tesis inedita. Fac. Sci. Montpellier.
SELLEY R. C. ( 1970) - Ancient sedimentary environment s. C HA PMAN & HALL, Ltd. London, 237 pp.
SHELTON ) . W. ( 1967) - Stratigraphic models and generai criterion jor recognition of al/uviai, barrier bar, and turbidity-currents sand deposi/s. Am. Assoc. Petroleum Geo!. Bull., 51, 2441-2461.
SOLI MA M. S. (1964) - Primary structures in a part of the N ile delta sand beach. In: STRAATEN (VAN) L. M. J. U. (editor): Deltaic and shal/ow marine deposi/s. Elsevier Amsterdam, 379-387.
SououET P. (1967) - Le Crétacé supérieur Sud-pyrénéen en Catalogne, Aragon et Navarre. Thèse Fac. Sci. Toulouse, 529 pp.
STRAATEN (VA ) L. M. J. U. (1954) - Composition and structure
of recent marine sediments iiJ the Netherlands. Leidse Geo l. Mededelingen, 19, 1-11 O.
TERWINDT ). H. J. (1971) - Litho-facies on inshore estuarine and tidal iniets deposi/s. Geo!. Mijnbouw, 50, 515-525.
THOMPSON W. O . (1937) - Originai structures of beaches, bars, and dunes. Am. Assoc. Petroleum Geol. Bull., 48, 723-752.
VISHER G. S. (1965) - Use oj verticai pro/ile in environmentai reconstruction. Am. Ass. Petroleum Geol. Bull., 49, 41-61.
WEIMER R. J. (1961) - Spatiai dimensions of upper Cretaceous sandstone, Rocky Mountain Area. In : PETERSON J. A., OsMOND J. C. (editors): Geometry of sandstone bodies. Am. Ass. Petroleum Geo!., Tulsa Oklahoma, 82-97.
YAALON D. H. (1967) - Factors affecting the lithification of eo/ianite on interpretation of its environmental significance in the coastal plain oj l srael. Jour. Sed. Petr., 37, 1189-1 199.
YouNG R. G. (1957) - Late Cretaceous cyc/ic deposits, Book C/iffs, Eastern Utah. Am. Assoc. Petroleum Geo!. Bull., 41. 1760-1774.
-..... ..
Mem. Soc. Geo!. lt., 13
G. GHmAuoo, E. MuTTI, J. RossEL
E SEZIONE DI DETTAGLIO NEl DEPOSITI DI SPIAGGIA DELL'UNITA SUPERIORE
100 200 300m
E SCHEMA
TE TERRAZZO
BM DEPOSITI DI BOCGA DI MAREA
CD® SEZIONI MISURATE
--/2. : PIEGHE DA SLUM PING
STRATIGRAFICO - DEPOSIZIONALE GENERALE w
r -, L. · . ..J
ISCLES l
· .· .... ·_. :_· ·.- · . . · ... SERRAqUY
:·.·_::_.:: :: <::_< .. · .. ·:.':· : ~ ' . . - . . .. ... : . . .
-;:_ ~ :.::.~ -~::':- : . . ·: .: ·-· ·. -.· : _ ..... _ ...... :._·.·.·::::::: · -· .·. ·. , , ·:_._·:::: ·::
. . .... : ::: .. : _:' -~-:: : : .' .. ·:.- .
PELITI E SILTITI DI S PIATTAFORMA E SCARPATA
Up ~ ~, .. :: ::::::::::::::: :·.: :::::::::::::: ::: ::::::::: g r
?. .~E'.:: :: : : ::::: : :: : ::::::: :::::: : ::: :::: :: ::: : :::::·. g
c:::._BM
~ ............ .. .. .. .... PELI TI CON SOTTILI .. .. .. .. o
.. ....... .. .... STRATI TORB IDITICI .... .... ~ z .. ...... .. .... .. .. ...... .... .... . .. ...... .... (/)
..... ' ' . . . . . . _· ... : ._ ..... .. -~-::: ... _:: . : . . .. · . ' .
DISCORDANZA
FORMA Z IONE DI VALLCARGA
200m
100
2
®
3km
A
A: Schema stratigrafi.co-deposizionale generale. B: Sezione di det taglio nei d epositi di spiaggia ,deJ,l'unità suoper.iore.
A: Generai ·Stratigraphic cross section. B: Detailed c ross section showi.ng in detail the faci es distribution within the upper unit.
NOGUERA RIBAGORZANA r.;"\ @1
~ --~~~-~~~~----r--~~~--~-----------r
L E
ARENARiE EOLICHE
E DI RETROSPIAGGIA
( Eofl~ f b&LA{r:,/w~~
ARENARI E DI BATTIGIA
(~o 'te siwze. ~
ARENARIE DI SPIAGG IA
ESTERNA (, s/u;.ve~ ~
ARENARI E, SILTITI E
PELITI DI TRANSIZIONE J.
( s~·~ -offskot~ "1'fWA11'T!.JJI.f.~
G E
-~
PELITI E SILTITI
DI PIATTAFORMA
( eJ H>L?e-_')
PELI TI E ARENARIE
LAGUNARI
CANALI DI MAREA
ARENARIE INTERTI DALI 0-®
ARENARIE SUBTIDALI
ARENARIE, SILTIT I E PELITI
SUBTIDALI DI TRANSIZIONE
ARENARIE DI DELTA
DI MAREA
CONTATTI EROS IONALI
SEZIONI. MISURATE
TAVOLA l.
w
B
ERRATA CORRIGE
Nella memoria di G. GHIBAUDO, E. MUTTI e J. RosELL (Le spiagge fossili delle Arenarie di Aren (Cretacico superiore) nella valle Noguera Ribagorzana (Pirenei centro meridionali, province di Lerida e Huesca, Spagna)
pag. col. riga
506 fig. 5 14
530 a 16
532 fig. 21 5
536 b 15 e seg.
Vol. XIII (4) (1974) delle Memorie della Soc. Geo!. It.:
ERRATA
from right to left
non sono da noi riconosciute
These channelized sediments at the very base
Mc KEE E. D. 09.66) · Structures of dunes at White Sands National Monument, New Mexico (and comparison with structurale du Golfe de Gasgogne, p, IV, 4·1; IV, 4-24. tology, 7, 1·69.
CORRIGE
from left to right
non sono state da noi riconosciute
These channelized sediments occur at the very base
Mc KEE E. D. (1966) · Structures of dunes at White Sands National Monument, New Mexico (and a Comparison with Structures of dunes from other se· lected areas). Sedimentology, 7, 1-69.