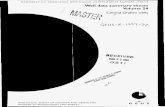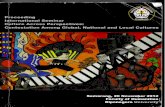Lo Alluvione. Un racconto tra paura, penitenza collettiva e perdono, in G. FOSCARI, E. ESPOSITO, S....
Transcript of Lo Alluvione. Un racconto tra paura, penitenza collettiva e perdono, in G. FOSCARI, E. ESPOSITO, S....
Indice
Introduzione
Frane ed alluuioni nel Salernitano e a Caua de, Tirreni ...di S Porfido, E,. Esposito, S. Mazzola, C. Violante, G. Sanroro,
E. Spiga
Caua ne/ Settecento: dspetti della uita po/itica ed economica...........di S. Sciarrotta
Lo Alluvion e. (Jn racconto trd paurd, penitenza, co/lettiua e perdonodiuino
di G. Foscari
schede analitiche delle rocalita colpite dall'ailuuione del nouembre1773...........
di E. Esposito, S. Porfido, G. Sanroro, C. Volante
,, )3
(Jn a rifes s i o ne s u I /e fo nti s to ri c h e........ .
di F, Alaia
Documenti
,59
u79
llye_s? gnloglco dell'area di Caua de'Tirreni... ), 89di F. Molisso, M. Sacchi, C. Violante, S. Mazzola
contesto meteo-climatico e pruuiometrico deil'euento alluuiona/edell'l l-lZ nouembre 1773 ........., , 157
di G. Thanfaglia, E. Esposito, S. porfido, C. Violante, S. Mazzola
Gli ffitti indotti dall'alluuione sur contesto urbano e territoriale... , 167di E. Esposito, S. Porfido, S. Mazzola, C. Violante, G. Sanroro,E. Spiga
P"g. 7
,9
u 183,, 797
5
Fonti archiuistiche " 293
Bibliografa ' 295
Inclice d.egli autori.. ' 303
Ind.ice dei luoghi.... ' 305
Autori d.ei sagi...... ) 311
Innoduzione
Questo libro nasce dal felice connubio di studiosi con esperienze diverse,capaci di trovare una mediazione tra la sensibilità storica e il tecnicismoilluminato dei geologi. Oggetto di studio è un evento rimosso dalla storiae dalle coscienze, ma che suona, una volta ricostruito e riportato alla luce,come un nuovo autentico monito per quanti hanno la responsabilità politicae civile nella conduzione di una città. Più in generale è un ammonimentoper ricordarci che I'Italia intera è continuamente esposta ai rischi del dissestoidrogeologico.
Lintuizione è stata quella di correlare ricerche parallele condotte e pro-mosse dal Centro Studi Storia ed Ecologia del Tèrritorio e il lavoro di geologidel CNR-IAMC di Napoli.
Il Centro Studi, responsabile dell'intero progerto, svolge da anni un'arri-vità mirata alla ricostruzione di una banca-dati dei casi di dissesto geologicoe idrico (frane e alluvioni) relativo alla provincia di Salerno nel corso del XIXsecolo, questo volume costituisce Ia naturale prosecuzione di un progetto cheha già trovato riscontro in unulteriore recenre pubblicazionel. Lobiettivodi fondo è proprio quello di "rimuovere la rimozione" ossia impedire che
scenda il silenzio sui casi passati di dissesto, dimenticati in maniera piii omeno involontaria, rispetto ai quali occorrerebbero, come anche l'Europaammonisce, una grande attenzione ed una maggiore sensibilità. Non c'è
silenzio della storia più assordante di questo, quando cioè intere zone sonodistrutte, quando Ie forze della natura e I'incuria dell'uomo porrano lutti e
scempi vari, quando addirittura scompare un intero casale come nel caso inesame. Lasciare che quei silenzi restino tali sarebbe responsabilità altrettantograve per chi svolge funzioni di stimolo culturale a beneficio della società.
La ricostruzione è stata inserita nel pieno del quadro socio-economico
I G. Foscenr-S. Scrennorre, Il dissestonella Valle dell'Irno (1800-1860), Salerno,
idrogeologico nella Costiera Amalftana e
Edisud. 2011.
della città de la Caua nel corso del Settecento, affinché sia sempre chiaro
che l'evento che si riporta in luce sia appieno riposizionato dentro il suo
stesso tempo, contestualizzandolo. Una lezione imprescindibile per chi fa
della storia la propria disciplina di vita.
Accanto al compito più propriamenre storico, mediante I'uso delle
sresse fonti, c'è stato il febbrile lavorio di valenti geologi (giir, a loro volta,
ampiamente impegnati nello studio di queste temadche) che hanno fornito
tutte le notizie tecniche necessarie perché di tale evento accaduto circa250
anni fa si potesse ottenere una ricostruzione dettagliata con meticolose
localizzazioni geografiche sulla base dei toponimi e con una descrizione
dei danni riportati.Il tutto Jarricchito da ulteriori informazioni relative ai maggiori episodi
di calamità naturali e da informazioni inerenti al contesto meteo-climatico e
pluviometrico dell'evento alluvionale dell'11-12 novembre lTT3.I|prodottohn"i., oggetro della nostra analisi, frutto anche di un piacevole sodalizio
umano, risponde, dunque, ad un esigenza di dialogo multidisciplinare
in un'ottica dichiaratamente sistemica, come richiesto dalla natura stessa
dell'evento e dalla metodologia tipica della scienza ecologica.
Tuttavia il dialogo rra marerie che hanno percezioni, linguaggi e codici
interpretativi differenti, non è mai semplice ed è stato affidato ad una me-
diazione culturale in cui non sono mancati momenti di contaminazione,
pur nelf identitir delle due discipiine-cardine, ossia la stofia e la geologia.
Il 1773 è I'annus horribilis di una media quanto produttiva città del
Mezzogiorno, il racconro con cui sono state ricostruite le fasi critiche dell'al-
luvione è stato affidato ad un'accurata ricostruzione archivistica ed a fonti
coeve piìi o meno dirette dalle quali si può evincere la portata del nubifragio,
causa scarenante dell'alluvione-frana, che alcuni uomini del tempo, con un
linguaggio oramai per noi desueto, definirono lo allwuione. Di qui il titolo
d"to "Ílibto .h. sin dalle prime battute ha inteso rispettare il gergo più
o meno diffuso alla fine del XWII secolo e provare anche a ricostruire le
percezioni, le paure e le ingenue forme di richiesta della misericordia divina.
prof. Giuseppe Foscart
Fisciano, otnbre 2013
Lo alluvione.
(Jn raccont\ trd paura, penitenza collettiua e perdono diuino
GruselpB Foscent
Il racconto di questa terribile calamità, che ha avuto come suo eplcentro
catastrofico Cava, - ma con un raggio d'azione ben più ampio in quanto
ha interessato altri centri del Principato citeriore -, si snoda per varie fasi
che non si possono certo considt'"tt "t'o-ale o del tutto nuove nella
storia delle comunità cittadine, soPrattutto in etìL moderna' quando esse
venivano toccare da ar,rrenimenti così drammatici. Tali fasi riproducono gli
stati d,animo di una popolazione provata da un accidente rmpreYedibile e
devastante e vanno d"ilo ,gorn.n,o p., l'evento in sé alla penitenza collettiva
dettata dalla devozior. ,.li"gior", dai'impotenzaallaconsapevolezzadeifatti'
alla reazione e ai tentativi delle istituzioni locali e nazionali di portare un
consistenre risroro a quanti erano stati colpiti direttamente dall'alluvione'
Levento ha un oriiine narurale ed è determinato dalle forti e persistenti
piogge che a Cava h"ri.to ",r.,,o
la punta massima tra le due e mezzadi notte
à.1liorr.di 11 novembre e l'alba dello stesso giorno' Ma non si possono certo
traslurare le responsabilità degli uomini, che sarebbero state comprese piìr
avanti negli anni, quando d" l,rel versante di Cava sarebbero arrivati altri
segnali di".rt ..orirtema da tempo diventato precario- ed insicuro'"D,"lrr"
parte, il diboscamento in atto in piir parti del Mezzogiorno, spesso
del tutto irragionevole e senza i necessari controlli, - anche in virtìr di una
normativa foi.rt"l. non ancora ben codificatal -, una scarsa capacità di saper
contenere e convogliare le acque provenienti dalla montagna, valloni poco
curati e intasati dall'occlusion. do,rrr," a materiale vario trasportato e dagli
alberi, I'abbondante accumulo di ceneri e lapilli provenienti dalle eruzioni
del Vesuvio per le aree poste nelle sue vicinanze' con una intrinseca franosità
del terreno porto in declivio, la messa a coltura dei terreni scoscesi' sono
t s"1" ,"1 18 26, grazieall'opera delf infaticabile carlo Alan de Rivera sarebbe stata pro-
-rtg"oi"'r..r..r" l.g"g. for..t"là che avrebbe posto dei vincoli molto ferrei al diboscamento
.d "1"1"
-"rr" " .oltii" delle terre poste in pendio'
59
(ìrusp-ppr- Foscnni
fattori che hanno inciso in molti dissesti geologi ed idrici soprattutto nelle
aree a nord del Salernitano.Seguiamo, dunque, le fasi della disgrazia, disposte sulla base della se-
quenza temporale:
I fase: il tempo tragico della catastrofe, che si combina con l'impotenzadi coloro che la subiscono ed è caratterizzato dalla paura colletti-va per I'evento in sé e dal timore di una sua possibile reiterazione;
II fase: la spasmodica e irrinunciabile ricerca del perdono divino, atti-vando i più abituali rituali di celebrazione religiosa e di preghiera;
III fase: la piena e matura consapevolezza del disastro, la penosa conta
dei morti, la rassegnazione per i danni umani e materiali subitie le comunicazioni ufficiali;
IVfase: la ricerca della normalízzazíone.
La ricostruzione della catastrofe è affidata a numerose fonti coeve: docu-
menti notarili stilati nei giorni immediatamente successivi e memoriali redat-
ti alcuni anni dopo. Lattendibilità" di queste informazioni è data dalla credibi-
lità in sé dei testimoni oculari dell'alluvione e anche dalla comparazione con
altre notizie, sicché il quadro ci appare sviscerato con sufficiente chiarezza.
La percezione che se ne ricava, a distanza di circa due secoli e mezzo,
è che non fu compresa subito la portata devastante dell'evento, se non da
quelli che lo patirono in prima persona e riuscirono a salvarsi, subendo luttiin famiglia o distruzioni patrimoniali. Pertanto, solo con il passare delle ore
e con le notizie che iniziarono a trapelare per tutta la città, ci si rese contodawero di ciò che era accaduto.
I fase: il tempo tragico della catastrofe
A metà dell'anno 1773 poco o niente facevapresagire lo sconquasso che
qualche mese dopo si sarebbe registrato. Anzi, agiudicare dalle attente anno-
tazioni riportate dal notaio Giovanni Manniello, - che rogava a Cava e che
con una certa meticolosità" aveva registrato a mo' di diario sulle prime pagine
del protocollo notarile gli eventi susseguitisi in città -, il raccolto di grano
in giugno era stato dal'vero abbondante e si era diffuso un comprensibile
compiacimento tra la popolazione2. Il grano era owiamente imprescindibile
2 Ancnryio Dr Srero Dr SerBnNo (da ora ASSA), Protocolli Notarili, N. V, notaioGiovanni Manniello, b. 1407 a. 1773, Cava, annotazione dei notaio riportata nelle primepagine non numerate del Protocollo.
60
Lo alluvione. LIn ft1ccont/ trd ?aurd, Penitenza coJlettiua e perdono diuìna
per l'alimentazione e la paura della non certo lontana carestia del 1764
(in fondo non erano passari ancora dieci anni) aleggiava come uno spettro
terribile, anche per ragioni di ordine pubblico, per il malcelato pericolo di
tumulti e ribellioni3.Aila più che sufficiente disponibilità di grano e, dunque, di farina,
corrispondeva analoga copiosità delle altre vettovaglie. Insomma, si poteva
stare ;bbastanza tranquilli. Non c'era da pensare di poter patire la fame.
certo, 20 carlini, owero, 2 ducati al tomolo (all'incirca 40 Kg) erano un
prezzo alquanto eccessivo per il grano, come gli B carlini e mezzo necessari
p.t p"g".. un tomolo e mezzo di granodinir, ossia di granone, come veniva
"bi*"l-.n,e chiamato. Ma l'onda lunga psicologica della carestia non si
era ancora arrestata e quando c'era penuria di grano o anche solo il timore
che esso scarseggiasse , i prezzi aumentavano, come da legge economica o'
forse, più .or.r.a"-.ntà, come da astuzia dei commercianti, le cui sottili
speculazioni erano alquanto note in città.
I mesi a seguire erano stati piuttosto capricciosi, soprattutto sul piano
meteorologico.vanno considerati, infatti, con parricolare attenzione tre fattori:
Il primo, I'esrate era stara alquanto fredda, tanto che nel mese di agosto,
,..orào quanto annotava il notaio Manniello <si sentiva tal freddo, che
pareva essere il mese di dicembre con continue piogge fredde'a'^
Il secondo, verso la fine dello stesso agosro il tempo si era finalmente
messo al bello e ciò era durato per i successivi due mesi, con caldo eccessivo
e senza pioggia5.
Sfuggiva atta conoscenza dei contemporanei il fatto che I'alternanza dí
-rrt"-àti delle condizioni atmosferiche non dipendesse da strani capricci
-=-, Snni,o aaie tradizionali cuccagne a Carnevale per esorcizzare il pericolodelle sedizioni
popolari, si veda D. ScaEocr-ro, Il gàco della cuccagna. Spreco e ruyullifes,riuldllla carestia del'17i4
a Napoti, Cava de' Tirreni, Àvagliano, 200 1 . Piìr in generale. si veda E. .LB
Rov Leou-
*tz,Tr*pirliTrrtrl,tempotlicarestia.Storiadelclimadall'annomille,Torino,Einaudi, 1982.
4 AS'SA, Protoc\lli Notaril1, N. v., notaio Giovanni Manniell0, b. 1407 a.7773' cit.5 La differenza tra rempo metereologico e clima è dawero fondamentale. Qui non par-
liamo di tempo metereologico, ossia della risultante di molti fattori (umidità, temperatura,
pressione, pricipitazioni, ienti, nuvolosità, ecc...) riferita ad un area deflnita in un tempo
breve o brevissimo o in un determinato inter-vallo di tempo; ma parliamo piuttosto di clima'
con riferimento alf insieme delle condizioni atmosferiche sopra indicate che caratterizzano
una determinata afea o regione geografica, otrenure da rilevazioni omogenee dei dati per
lunghi periodi di tempo, "'í-.no",rà,'"nni. Infatti, occorre considerare che tra il XVI e il
iif ,.i"f. I'Europa iu , r^tt rit" ta dalla 'piccola era glaciale' con._inve rni. rigidissimi che
,i,,r.r.grrir"r-ro "d
ir-r,r.rr-ri miti, ed.rtati.àn piogge intens.e ed alluvionaÌi' con evidenti
fluttuazìoni climatiche che incidevano sulla compattezza dei terre'i.
61
Grusspps Foscenr
del tempo o dal solito castigo divino, come frequentemente si era abituatia pensare, ma era il frutto di quella piccola era glaciale che dal XV stava
caÍatterizzando I'intera Europa (e che sarebbe durata fino al XIX secolo),
creando condizioni di profonda instabilità. Senza alcun dubbio, si trattavadi due condizioni atipiche, che, componendosi tra loro, avevano minato lastabilità e la compattezza dei terreni un po' ovunque.
Ma c'era un terzo fattore in agguato: l'ulteriore instabilità meteorologica.Il30 ottobre erano iniziati i temporali, abbondanti, che erano proseguiti
per tre giorni fino al 1o novembre. Larsura e I'aridità dei terreni, la siccitànei campi erano ora improwisamente e tumultuosamente scompaginate da
queste copiose e vigorose piogge.
Nel giorno della commemorazione dei defunti pochissimi riuscironoad andare a Messa per il tempo dal'vero inclemente, ma la pioggia era stata
anelata e benedetta da molti, in particolar modo dai viticoltori, i quali, ap-
pena il tempo si rimise al bello, come a\.venne per alcuni giorni di seguito, si
dedicarono, come sempre, a quell'occasione irripetibile di coesione familiaree di festa che era la vendemmia.
Essa risultò generosa, come annotava Manniello, tanto che uil vino perla grande abbondanza non si è saputo dove riponerlo avendo avanzato cia-scheduna massaria il doppio degli altri anni che è stato necessario a molti diriponerlo nelle tine, e sobbottoni, la vendemia durò sino alla fine di ottobre,e parte di Novembrer6. Insomma, la pioggia precipitata nel momento adattoaveva ben agevolato la produzione e, a ragione, tutti pensavano che anche
un buon vino avrebbe potuto accompagnare la tavola delle famiglie.La mattina del 9 novembre ricominciò a piovere a dirotto, tanto che non
si poté uscire di casa. Si stava reiterando, cioè, laterza nefasta condizione:
dopo i sessanta giorni di siccità, la pioggia di fine ottobre-inizio novembre ed
una brevissima tregua di bel tempo, iniziò a riversarsi acqua senza soluzionedi continuità. E per due giorni di seguito.
Il giovedì seguente, 11 novembre, giorno di S. Martino, i rovesci cessa-
rono per pochi momenti; la tregua prima del disastro, perché unel giornopoi seguitorno dirottissimamente le acque sino alle tre ore di notterT.
Ore di pioggia battente e incessante, poi, alle 2 e mezza della notte, unrumore cupo e sordo: una frana dalla potente carica distruttiva si staccò da
uno dei versanti del Monte Finestra, nella parte in cui esso giganteggia suivillaggi di Passiano e S. Arcangelo, e si riversò con tufta la sua furia veemente
6ASSA,
"- rocolli Notarili, N. V., notaio Giovanni Manniello, b. 1407a. 1773, cit.
7 lbirJem.
62
Lo alluvionc. Un tacconto trd ?/1uft7, peniteTtza co/lettìua e perdono liuino
su un piccolo casale posizionato tra i due agglomerari più grandi: Casalonga,(tanto che - annotava il notaio - spiantarono moltissime partite di boschi,e selve delle Montagne sopra il Casale di Passiano, che s'unirono al Vallonedetto del Vargarallo, e non bastandoli il letto di detto Vallone, che era pro-fondissimo, e largo superavano le acque che seco conducevano smisuratepietre, ceppe, alberi grossissimi, ed arene superorno, ed arrivarono sopra le
Massarie, devastandole d'alberi, e riempiendole di pietre e brecciara, in talmodo che parte le univa al Vallone, ed altre le ridusse inabili a coldura, e
giungendo nel ponte della Regia Strada detto dell'Epitaffio, non potendodetto ponte ricevere il torrente e smisuratissimi sassi alberi, ceppe, ed altroche seco l'acqua conduceva, superorno, ed avanzarono per sopra detto Pontediroccandone le sue murars.
Dalla relazione emerge che la portara violenta di acqua e terra aveva
trasportato con sé anche pietre ed alberi di notevole dimensione ed aveva
come sbriciolato i boschi adiacenti; la gigantesca massa si era riversata nelvallone del Gargarallo (Vargarallo nel documento), andando ben oltre lasua portata e la sua tracimazione con acqua, fango e detriti aveva sommersole masserie lì presenti; da lì era conrinuaro il suo percorso di devastazionesino ad arrivare al ponte dell'Epitaffio, demolito in più punri.
Non è solo la morte di innumerevoli persone, colte nel sonno, ma è
la fine di un casale, viene cancellato un toponimo e, con esso, per un po'di tempo, una storia di insediamento che sarebbe rimasta viva solo nellamemoria delle generazioni più avanti negli anni.
La narrazione a posteriori è affidata alle parole dello storico ed eruditocavese Andrea Carraturo, testimone oculare e sopralvissuto alla tragedia, ilquale, poco piìr di dieci anni dopo, nel 1784, così avrebbe ricordato I'evento,ancora vivido nella sua mente:
nTra i uari alluuioni piìi o meno funesri di cui si ha memoria e t/i cui si uede
ancora qualche uestigio, è assai rimarcheuole l'ultimo della sera d.el giouedì 11 dinouembre clell'anno 1773, allorché sulle ore due e mezza di notte, Jia larghissime
piogge, perdé forse per uwt della accennare cagioni r1ualche nube il suo equilibrio,e si sciolse in un uasto ed improuuiso uolume di acque alle falde del monte Finestra,
al di sopra del uilkggio detto Casalonga, che spiantò boschi, selue ed annose pianre,
e dirigendo il suo corso contro il detto ui/lagio atterrò quante case ebbe a fronte,arrenò campi e poderi, si spaziò sulle pianure di S. Vito e si antlò a perdere uerso
Nocera. Da circa 160 persone perirono in tal disastro, ef.no in Nocera stetst ne
giunsero dei cadaueri. Il danno fu aalutato per moltissimi migliaia di scurli. La
I lbidem
bJ
CrusEppr Foscanr
mirt casd prtternll, cl,re adesso ha L'onore di accogliere il lodato cau. Filangieri' ed è
situata in un'ltmen/t c/impagnLt chiamata i/ Gaudio Piccolo, trouassi allorrt nella
stessd linea della direzione della gran piena, ma fortunatamente fu I'unica che
campò t/al generale deuastamento. Patì nond.imeno de'grauissimi danni nelle sue
adiacenze, e caddero motte fabbriche esteriori nell'atto che il gran facasso ten€utl
turti sbalorditi, qudnti erduamo dl di dentro, inconsapeuoli della cagione che in
quel buio ttgiua cln tanta uiolenza al di fuori,e.
La testimonianzadelCarraturo rende ragione della gravità del fenomeno
e ci conferma come la zonainteressata fosse caratte tizzatada poderi e campi
coltivati. Egli ci porta a conoscenza di uno soltanto dei versanti dell'allu-
vione, che, invece, aveva toccato in modo altrettanto roYinoso anche il lato
a sud, verso Molina, Vietri e Salerno.
D'altra parte, lo stesso fronte meteorologico si rivela molto ampio, avendo
implicato Maiori, san severino, coperchia, dunque, la valle dell'Irno, la
Costiera Amalfitana (o buona parte di essa), la valle di Cava sino al Capo-
luogo, Salerno, passando per Molina e Vietri.La colata di fango aveva colpito indisdntamente modeste abitazioni e case
appartenenti a famiglie facoltose, devastato piccoli appezzamenti e qualche
.r*r" proprietà, ma è indubitabile che si rivelò un'occasione di ulteriore
dramma soprattutto per il ceto popolare e contadino che occupava, in gran
parte, l'area del casale dí casalonga, spazzato via dal gigantesco ammasso
di terra e acqua.
Il sobborgo, come larga parte del territorio cittadino, era caratteîizzato'
infatti, da un" diffusa rete di piccoli contadini-proprietari, ricca di terre
coltivate di modesta estensione e con un abbondante pfesenza del bosco. Lì,
a Casalonga,anche se in relazione alle più limitate esigenze di insediamento
antropico che si registravano nel corso del Settecento, le famiglie presenti
erano comunque numerose, per lo più costituite da analfabeti, braccia dedite
al faticoso l",roro nella terra, coloni resi insicuri dalle incertezze dell'attivrtà'
agricola.
Gli effetti del disastro non possono certo prescindere da questa precaria
trama sociale né da qualche incauto intervento dell'uomo, che, soprattutto
più a monte, aveya probabilmente operaro più di un dissennato taglio. Ilàibor."-.rrto resta una delle concause dell'evento, anche se occorre in-
trecciare più fattori che avevano compromesso la tenuta del territorio per
accertare le reali cause del fenomeno.
e cfr. A. c.q.nnrruno, Lo '\tato attuale" de/la città (1784), a cura di S. Mrr-.cNo, cava de
Tirreni, Avagliano, 1986, pp. 45-46 in nora.
64
Lo alluvione. LIn racconto ttr.t ?aara, penitenza co/lettiurt e perrlono tliuino
La straordinaria testimo nianzadel noraio Giovanni Manniello, uno d.eisupersdti cha ha lasciato traccia scritta del drammatico momento vissuto,resta la più fedele ricostruzione dell'evento eva apprezzata nella sua jnterczza:(erano deme acque in abbondanza che la sua
^ltiu^arrivò sino alli colli dellequercie della mia Massaria, siccome s'osservò dall'impressione del loto cheivi rimase, ed inoltrandosi verso la casa tutto ciò che si ritrovava d,alberili spiantava con averne anche spiantate e portate via re mura der cortile, edaprendo con gran empito le porte delle caie entrò in esse una gran quantitàdi loto pietre ceppe, e brecciara, sorro delle quali mi ritrovai"sommerso, esuffogato, per essere calato casualmente nelli bassi di detta casa, e nel mentregià era morro e fuor d'indendimento srando sotto grossi ceppi, e roto più dipalmi 4 vz, pawe di vedermi da forzasuperiore, . d"" pi.tor" -ano sollevatoincominciando asvilupparmi da rotto l. c.ppe loro, .d
"rrr. ord.egne di casa
cadutemi sopra mi rampicai sopra il m.rrà n.l mezzo della casa, e srandosbalordito sopra di quello ,.nr",p.r"nza di sopravivere facendo continuiatti di contrizione invocando la mia Alvocata, e Gran protretrice Mariadell'olmo, e le Anime Sante del purgatorio non sapendo per dove sarvarmimentre in un punto viddi due lampi che mi ferno rr.d.r.là porta deila casa,ed alcuni tavoloni, che andavano nuotando per d.entro di queila, sopra dequali-appoggiando li piedi andai dentro la grada, . gi,r.rà neila cameranon fui conosciuto per uomo ma mosrro diloto qui. imm.diatamentes'intromise sino alle carni, ma per la dio grazia sano, e libero d.a ogni male,onde per quanro potei mi risrorai, cambiandomi tutte le vesti che con granstento mi levai da dosso.
La Massaria non solo da capo a piedi inondata d'arene, pietre brecciara,e ceppe' ma ben anche ne staccò circa moggia quatrro, e fanoli vallone,siccome s'osserva dagl'Alberi rimasti intorno h q".tt".
talascio per ora il nostro lacrimevole ."ro, . passo a descrivere tuttotremante il stupendo, sanguinoso, e dolente alluvione del casale detto dicasa Longa, quale ne fìr da quello roralmenre spiantato senza lasciarvenesegno, o vestigia di detto casale, che appena si poteva conoscere dove erastata la sua situazione le case, .h. .r"no .irconvicine furono tutte empite diloto, con gran srenro non perirono gl'abbitatori di quelle, et oltrepassandola lava portando smisurati alberi di quercie assieme colle ."r. ,pi"rr,",., .quantità di cadaveri la maggior parre ne rimasero nelle piane di s. vi,onella cupa di Priato, ed altri luoghi convicini, ed altri r. frro.ro trovati allecammarelle, siccome furono benissimo conosciuti, che fattosi il computodi detti cadaveri ritrovati ascesero al numero di [mancal] .
Lestenzione della lava fu dalla massaria delri magnifici Francesco e
65
Grusr'r'Pl Fosc'ru
Fratelli de Iulis sino al palazzo nuovo, la Regia strada. non.si conosceva
dove era stata per d.,," t"t"'ione' tutte le d'elte massarie si riempirono di
mobili, pezze dif".,ro'lt""i'ed ordegne di case' ma per quello si sentì dire
che le genti Ia stessa notte andav""o pigli"t-tdo le dette robbe' non ostante
tal orribile Flaggello, delle Case di Caraturo molto ne staccò di fabrica ma
vi rimase la parte pr;i;; ;,er graziadi Maria Santissima dell'olmo in
quella stava dipinta. , , r-,.,^^^ -:^i^-^ ti .,Tutte Ie massarie per dove passò detta lava furono ripiene di varie sorte
di arene, cioè rapilloi";';"i^;;:'pietre dove tre due' e quattro palmi di
detta robba, che vi otJo"t'o pi') anni per ridurle al pristino stato' tutti si
empirono di legni ,';;i, t chiancarollt di Case da sotto detto Casale sino
alla terra di Mascolo'
La casa di Arlto"io Avagliano ne fu buttata da detta lava assieme colle
persone che vi .,""t Jt"t?o' e ritrovandosi inferma la moglie di Pietro
Avagliano .hi"-","'i''-tìt"ì"i""gfi"no figlia d'Alessio che giacendo in letto
facendo atti di contrizione assieme con un altra sua parente' -e
quattro figli'
sopraleCameredidettaCasa,volendoprendereilcrocefissodacapoilmurodel letto si vidde po""'ui" e smorzare ii lt'me' e sbalordita si ritrovò assieme
con detta ,,," p",.'o nella detta massaria delli Signori Julis all,ignuda, ma
con una figliola d.''tt'o la Conola' che per g'^"il.di Maria Santissima del
carmine fu salvata d" prr*I. Milione .À. "rid",r,
la stessa notte ritrovando
la moglie, che stimava avernela anche portata la lava che asserì essere stata
liberata per l'intercessione di Maria Santissima del Carmine della quale
;;;;;;; ldorro il suo abbetino' quale trovò senza essere stato in menoma
;;;;;;;;"to lo che da tutti non poteva capirsi.come uscire della Camera
dove stava r"nr" pt'ì'J, i., gfi dissi che l"Vt'gi''" l'aveva presa per li cappelli
e condotta sana' e salva in detto luogo'
La parte del Castello fu anche daÀeggiata' che calatain giìr la lava ruinò
molte massarie, ed anche pericular potevanopiìr.persone del Casale di Priato'
ma per speciale p'ott'io"t del Glorioso S' Ncola nessuno periculo' siccome
la notte furono "td;;i;; i"ti"
"ttt"''i lumi' che calavano' ed oscendevano
dallapartediPriatello,chepoilicongetturòesserstatoilSantoprotettore'.h. fórr. andato dilatando le acqueor''
Il racconto, sull'ond'a di una legittima commozione' conserva rntatta
la capacitàL di ,ipo't""i "i *o-t"ii drammatici della tragedia' Il notaio
si ritrova q""r, ttt"ì-t";;;;;ttt".dal fango' dalle p.ietre' dai ceppi di
alberi sradicati, quasi un metro e venti centimletri di melma e fanghiglia' e
66
ilnssa. lrr, colli Notarili,N' v', notaio Giovanni Manniello' b' l4o7 a' 1773' ctt
Lo arlluvione. fJn rdcconto tra Paurd, penitenzd co//ettiua e perdono diuino
viene salvato da una mano amica, provando subito a trovare una sicura via
di fuga. lIfl.agel/0, seguendo lo svolgimento del resoconto, aveva toccato,
come detto, Casalonga, era proseguito verso la piana di S. Vito ed era arrivato
sino al casale di Pregiato, posto sulla direzione della frana ma non certo a
corta distanza. Di lì, verso Nocera, il tratto non è affatto breve, ma la gittata
del fango, la massa, la velocit2L acquistata nel lungo percorso in discesa dal
Monte Finestra, avevano creato le condizioni per trascinare tutto con sé,
fino alla vicina cittadina dell'agro, già piìi volte e in piìr punti devastata dalle
esondazioni del torrente Cavaiola.
II fase: la ricerca del perdoruo diuino.
Erano oramai trascorsi pochissimi giorni dall'alluvione. La situazione era
nelle mani del clero che non aveva perso certo l'occasione per tenere viva
nella gente la paura per il Dio castigatore e vendicativo che aveva scatenato
leforze della natura al solo fine di infliggere una dura punizione agli uominiper le loro colpe e malefatte. Lo spavento, lo smarrimento e la devozione
facevano il resto.
Il clero esortava a pregare e a chiedere la misericordia divina e si affrettò
ad organizzare una solenne processione.
La pioggia non aveva ancora cessato di tenere desta la gente' Il boato
della frana rovinosa €ra ancora vivo e si sapeva che tanti erano morti, sepolti
dal fango e trasportati lontano. La confusione regnava sovrana. Anche Pre-
giato, S. Lucia, il corso del torrente Bonea nella parte a valle che procede
verso Vietri, erano segnati dal luttuoso tragitto del fango e delle acqu€' ma
le notizie che arrivavano erano ancora piuttosto discontinue ed incerte. Si
parlava, sgomenti, dei cadaveri ritrovati a Nocera, versante nord della frana,
a varie miglia dal disastro.
La processione doveva servire a ricomporre il quadro sociale, a cementare
la comunità, a dare speranza a tutti che il peggio fosse passato e che occorresse
solo placare l'ira del Signore, espiando i peccati. Si rimarcava a dovere ilvalore terapeutico di quella funzione religiosa pubblica. Erano passati poco
più di cento anni dalla peste del 1656 cheproprio una processione, almeno
nell'immaginario collettivo e nell'interessata comunicazione mediatica del
clero, aveva bloccato il morbo a Cava. Ciò aweniva in una società intrisa
di ingenua credulità e di una altrettanto possente devozione, in cui alla
trasmissione orale della paura e dei rituali del perdono si sommava un alto
tasso di ignoranza dovuto all'analfabetismo, e in cui, la genuina semplicità
contadina era l'abituale veste delle relazioni umane, soprattutto nel delicato
67
Gtusr.r,rr Fosceru
ed impari rapporto con i poreri forti (patriziato, istituzioni, parroci, ricchi
mercanti ecc..).
Ma questo fondamentale momento di catarsi comunitaria non si prefi-
g.rr" .oÀ. un atto di resa o di impotenza. Esso scandiva il senso della par-
Iecipazione popolare, era il segnale indiscutibile di una venerazione sentita
come propria, profonda e, altresì, condivisa. Non possiamo trascurare certo
.h. l" Chi.r" i"ppr.r.nrasse un'imporranre ed autorevole rete connettiva
della comunità rneridionale e, dunque, cavese. Lo era sempre stata. Il suo
magistero era affidato a parroci che sapevano toccare le corde giuste del po-
poló, .o' efficacia e persuasione, usando anche prediche ammonitrici circa
i. ,.rponr"bilità da attribuire ai comportamenti e ai peccati degli uomini,
ch. l-ron lasciavano insensibili, non potevano lasciare insensibili.
Ma il timore di un Dio giustamente cdttigrltorr (così come appariva agli
uomini e alle donne del tempo o come veniva loro presentato) compare
finanche in un atto ufficiale del Parlamento cittadino, dal quale emerge in
tutta eviden za chela calamitir e le miserie nnelle quali per giusta jra di Dio
siam cadutirll dipendessero dagli indegni comportamenti degli uomini.
Istituzione politica e clero, assieme, rafforzavano l'idea di una gigantesca
colpa colleitiva, aprendo una stagione di espiazioni-che sarebbe andata
dalia confesrion. "ll" preghiera, alla comunione, alle forme di beneficenza
ed ai lasciti in punto Ji r"or,. a favore della parrocchia, della chiesa o della
confraternita alle quali si apparteneva.
E così, inevitabilmen,., .-.rg.r,a I'altra faccia dell'operato della chiesa,
quella che puntava proprio sulla paura del Dio castigatore per rendere il
proprio magirt.ro ., ,opr",,,r,,o, il controllo sociale più praticabili' pun-
,"rrào -olto sulla credulità. popolare. Si trattava, inoltre, di tenere sempre
vivo quell'armamenrario ritu"l. per plasmare continuamente gli individui,
sul piano pedagogico e su quello spirituale'
òia .i ,ping".,-di .onr.g,.r.tr", "
,agio,,"" in breve su quale fosse la fun-
zione della r.$ion. nella societàr settecentescar2, che passava dalla cura delle
anime, alla capacità di alleviare le sofferenze nella vita terrena' da un dovere
prettamente umanitario e cristiano, a strumento di disciplina collettiva' e
.h.,r.d.,r" nel sacerdote la figura adatta ad ammonire la folla ed educarla alla
paura in Dio. E non dobbiaÀo cefto dimenticare che proprio il XVTII secolo
"bbi".ortitrrito un primo significativo momento di riflessione sui possibili
- tt a*.* Sroruco cor,ruNars or ceva (da oraACC), Classe II, sez. II, n' 13 (1772'
1796), delibera del 29 novembrc 1773, cc. 9r'-i0r'12 Cfr. M. Rosl', Settecento religioso. Politica della ragione e religione deL cuore, Venezia,
Marsilio, 1999.
6B
Lo alluvione. LJn racconîo tra ?dura, Pmitenza collettiua e Perdono diùno
eccessi della devozione, che doveva tuttavia tener conto della sensibilità reli-
giosa popolare, affettiva e sentimentale, erede della pietà barocca, che reagiva
ai processi di laicizzazione della società. Dunque, la società settecentesca
era caratterizzata dall'intreccio tra la piùr generale funzione civilizzatrice e
socializzatrice della religione, la devozionalità affettiva e collettiva, con i suoi
simboli, le sue rappresentazioni sceniche (di cui, ad esempio, la processione
era strumento nodale), ma anche le esuberanze della venerazione.
Accanto al clero, proprio le confraternite, con tutto il bagaglio di rituali,gesti e genufessioni per rendere ancora più liberatoria e partecipata la pre-
ghiera collettiva ed acuire la solennità di quei momenti. Esse abbondavano
ed erano un altra anima pulsante della cittadina, cui era stato affidato da
tempo il compito di radicare il seme della solidarietà, di rinsaldare lo spirito
della fraternità cristiana e, per questo, funzionavano quasi da ammortizza'
tori sociali, per il loro impegno a favore anche dei marginali, contenendo
il rischio delle possibili ribellioni sociali. Ma avevano anche obiettivi pir)
articolati e, direi, subdoli: accrescere la suggestione collettiva con i loro
rituali mistici e formali e accentuare implicitamente il controllo dei ceti
piìr potenti e ricchi, che nelle confraternite avevano un ruolo di spicco, sul
resto della popolazione.Larciconfraternita del SS. Nome di Dio e di S. Maria Incoronata dell'Ol-
mo aveva una storia documentata che risaliva alla metàr del Quattrocento.Tha i suoi compiti precipui c'erano la diffusione della devozione contro I'uso
della bestemmia dilagante, opere di pietà di varia natura, la costruzione diun ospedale, la necessità di assicurare benefici ai confratelli in caso di morte,
e I'importante custodia dell'immagine di Santa Maria dell'Olmol3. Tocca-
va, ora, proprio a questa Congregazione I'onere di organizzare e sostenere
la processione, portando in giro per la città la sacra immagine della Beata
Vergine Incoronata, la protettric e speciale di Cava.
D'altra parte, la processione era stata richiesta espressamente dal Vesco-
vo e caldeggiata anche dal Capitolo e da numerosi cittadini; si era dunque
diffusa I'idea di una doverosa penitenza collettiva e la processione rappre-
sentava il momento emblematico del raccoglimento e della preghiera, di
riflessione sulla caducità della vita e sulla necessità di essere in sintonia con
i dettami del cristianesimo, ma era anche una testimo nianzadella religiosità
popolare al seguito di un immagine devozionale, con il suo tradizionale ed
apprezzato rituale.
r3 Cfr. A. INpnaNzi, Le Confaternite della Diocesi di Caua e i loro luoghi, Cava de'Tirreni,Di Mauro editore, 1999, pp. 227-238.
69
GrusEPpP- Fosclnr
I governatori della Congregaziottl D' Carlo Abbenante' D' Giuseppe
Galise, D. Giuseppe Stt"di'do e D' Gennaro de Marinis ebbero I'onere di
*"rf"r."r. l" S"à," Immagine della À4adonna dalla chiesa dell'Incoronata
Maria dell,olmo alla chilsa cattedrale, attraversando in sosranza buona
p"t,. a.i ..nrro urbano della cittàr' uper ivi porgerli umili suppliche per
la desiderata ,.r.niti, .t ft' tt'i'"tt li gravi i"t,,ti tht a questo pubblico
;;;; ;""sati dalle .ottitt" pretipito" e gravi pi"glt"^^lcona della
Madonna, attorno "ll" q""lt 'i
t'" '"dit"t" """ credenza popolare ed un
racconto misterioso e im}aginifico che ne celebravano le virtù e le qualità
taumaturgict . . .","r.in., l"..bb. stata affidata alla custodia del Capitolo
della Chiesa C",,"a,"it, per d'ieci-quindici giorni' a.decorrere dal 14 no-
vembre. Tlascorsi i quali, l'immagine sacra larebbe dovuta ritornare nella
chiesa di san Francesco d.i Paola, dove essa era custodita'
Lobiettivo,.o-.,p..ificamentedelineatonell,attonotarileredattoperuffrcializzareil,.-po,l"to passaggio di consegne dell'icona'1:t1' tt" quello
d,i <sodisfare alla vehemerrà pi""J.,rorione di turta questa Città>'5 per un
tempo ritenuto ragionevole e necessario'
Sentiamo ,".",;, ; ;roposito' il meticoloso racconto del notaio
Manniello: ul-a mattina ben per tempo tutta la Città fe ricorso alla nostra
Protrettrice e Miracolos" Vt'gi"t Coron"t" dell'Olmo' la quale fu esposta
con apparato' . .o,.tio 'op'i I'Alt're MaggrorS della sua Chesa di San
Francesco di paola, .or, .orr.orro di tutta h Òittl, con incessanti lagrime, e
preghiereditutti,edattidiringraziamentodinonaversubbissatol'intieracittà, siccome dovea essere,.i".."d.r. per li miei gran peccati, si tenne
cosìespostaindettaChiesaladettaBeatissimaVerginesinoallaDomenicamattina, che poi verso l'ora tardi' coll'intervento Ji tt"tt le processioni di
questa Città, Clero, pJt Conventuali' -e
Reverendissimo Capitolo della
catredale, la detta Beatissima vergine dell'olmo fìr sollendemente portata
alla detta Chiesa Catredale ed il giorno si aprì la. Santa Missione O: f*:l
Ji ln.r," nostra Città, con incessanti preci' e penitenze continue con vlsrte
di tntt. le dette Processioni, con atti di mortificazioni'
La detta S""o'ftlittio* d"'a per lo spazio di giorni quattordici in
detta Catred"l., .t-" it' sino al Sabtato la st'a' la mattina Domenica an-
che verso l',ora tardi fìr sollendemente portata la detta Beatissima vergine
dell,OlmoalsuoluogoconinterventoancofadelledetteprocessioniClero,
- '' ASSAJ- tocolli Notarili, notaio Nicola Maria Adinolfi' b' 2222 a' 1773' Cava' 14
novembre 1773,c'344v't5 Ibidem.
70
Lo alluvione. (Jn racconto tra Pdur/1, Penitenzd col.lettiua e perdono tliuino
e Padri di questa Città, con averla anche portata processionalmente sino
alPalazzo nuovo>r16.
Il minuzioso racconto del salvataggio del notaio ci permette di ribadire
taluni aspetti già sin qui emersi ed altri nuovi dar,vero rilevanti: 1) almeno
nei pressi della sua abitazione la portata del fango aveva superato abbon-
dantemente il metro e 20 cm, ma in altri punti della sua masseria aveva
raggiunto urialtezza anche più rilevante, come testimoniato dal fatto che
la melma aveva coperto le querce almeno fino al punto in cui iniziavano
i rami e le loro biforcazioni dal tronco principale; 2) nel fango che aveva
spazzato via le case e gli alberi si notavano anche sabbia, breccia, ceppi dialberi, lapillo e pozzolana. che avevano reso tutta la massa, che proveniva
dall'alto ad una certa velocità, scorrevole e ponderosa nel medesimo tempo;
3) si registrarono fenomeni di sciacallaggio nelle ore successive al disastro,
con persone che si aggiravano per prelevare vestiti, utensili di casa e mobilitrasportabili.
Scene che tristemente si ripetevano in eventi del genere, gettando piìi diun'ombra sulle intrinseche qualità della società locale, sulla robustezza della
solidarietà di cui la Chiesa era interprete ed emblema, ma anche il segno diun'evidente disgregazione sociale che trovava nelle incertezze economiche,
chepenalizzavano soprattutto i pit) disagiati, Ia sua principale ragion d'essere.
III fase: La cottsapeuolezza dell'euento e dei danni. Le comunicazioni ufficiali
Napoli non fu tenuta all'oscuro della vicenda. Nei giorni successivi alla
tragedia si susseguirono infatti le comunicazioni ufficiali alla Camera della
Sommaria e al Sovrano, per informarli della gravità dell'evento e per otte-
nere misure appropriate. Il re, appena informato della sciagura' predispose
che si fornisse qualunque"prouuidenza" ai sudditi di Cava e che egli fosse
ragguagliato sia sui rimedi proposti dall'organo di governo cittadino sia sul
più generale andamento della situazione.
Le relazioni, che sintetizzano tutti i vari momenti della ragedia, appaiono
piuttosto dettagliate e meticolose. Il timore che le autorità potessero riscon-
trafe una qualche responsabilità o omissione rendeva tutti attenti a seguire ilfilo logico di un ragguaglio minuzioso. Inoltre, si volevano toccare le corde
del paternalismo monarchico.La Regia lJdienza di Salerno, con la sua figura più importante, il Preside,
unitamente all'Uditore che apparteneva alla medesima struttura, al Com-
t(' Iui, notaio Giovanni Manniello, N. V., b. 1407 a. 1773, cit
71
Grusspps Foscanr
missario di Campagna, che aveva specifiche competenze di tutela dell'ordinepubblico ed al Governatore di Cava, già dal 12 novembre avevano iniziato
una tambureggiante comunicazione con la Capitale, proseguita nei giornia seguire.
Il 12 novembre pervennero due lettere, a breve intervallo di tempo tra
loro, una scritta dal Commissario di campagna, I'altra dal Governatore diCava, e destinate al Re. In esse si ponevano in evidenza la violenza dell'allu-
vione, la rovina di case poderi e beni, I'interruzione dei traffici commerciali
ed il possibile rischio che nei giorni successivi si potesse registrare un indebita
appropriazione dei beni dei defund a danno dei legittimi eredi.
Si era organizzata repentinamente una riunione straordinaria presso ilpalazzo del Preside a Salerno nella quale si era stabilito che f indomani sa-
rebbero partiti per Cava un Caporuota con numerosi soldati per assicurare
i beni dei sudditi colpiti dalla sciagura, per dare sepoltura ai morti, per
constatare i danni prodotti e per provare a rendere agibile la strada princi-pale, il Regio Caminol7, che risultava, invero, allagataed inagibile in moltipunti dalla píazza di Nocera fino a Vietri, con la conseguente inondazione
delle campagne. Il controllo era stato esteso, poi, a tutte le strade interne
di Cava e dei molti quartieri situati alle falde delle circostanti montagne.
Il Commissario di Campagna, Biagio Sanseverino, nel rapporto del 15
novembre, ribadiva tale situazione, rassicurando sulla rovina certa della
zona interessata, anche perché osserudtA in modo diretto dal Commissario.
Ciò ci fa naturalmente pensare che in piìr di un'occasione si fosse esagerato
nel racconto di un alluvione, per sollecitare interventi e risorse; invece le
circostanze ricorrenti a Cava non creavano dubbio alcuno ed erano state
toccati molti casali della città, e, nel fondo della valle, il Vescovado, la Regia
Corte, il palazzo del Reggimento, luogo dell'amministrazione comunale, ilmercato, Ia negoziazione, le strade. Inoltre, il Commissario, argutamente,
poneva l'attenzione sul fatto che si dovesse riattare in maniera celere I'area
toccata dalla frana, perché, considerate le falde ripide, c'era il rischio con-
creto di nuovi danni, che avrebbero condizionato pesantemente la vita della
popolazione, già toccata dalla sciagura.
La Camera della Sommaria di Napoli si riuniva il22 novembre per
esaminare le relazioni pervenute e per esprimere il proprio parere. Innanzi-
tutto, essa esprimeva Lln plauso all'Udienza Provinciale di Salerno per aver
subito inviato il Caporuota e i soldati per il controllo del territorio e per
r7 Ancrrrvro oI Srero or Neporr (da ora ASNA), Sommaria, Consuhationum, vol. 322,
22 novembre \773, ff.204v-209v.
72
Lo alluvione. Un rrtcconto trd ?aur/l, pen;tenza co/lzttiud e perdono liuino
portare la necessaria assistenza alla popolazione colpita dall'alluvione, inoltreriteneva necessario che questo lavoro continuasse, ma coglieva l'occasioneper ribadire le responsabilità e le comperenze degli organi oramai investitidella vicenda. Toccava, in effetti, al Preside ed alla Regia Udienza di Salernocoordinare gli interventi e decidere il da farsi, senza che il Commissario diCampagna o altre figure si intromettessero indebitamente nelle decisioni. LaCamera della Sommaria, inoltre, era del parere che si dovesse inviare aCavaI'ingegnere regio Felice Bottiglieri con il compito di un esatta valutazionedei danni subiti dalle strade ed iniziare anche ad awiare le prime r.attazioni.
Il 17 dicembre la Camera della Sommaria di Napoli, si riuniva ancora peraffiontare l'emergenza a Caval8. Intanto appariva chiaro a tutti che il frontedella calamità fosse alquanto vasto, perch é aveva riguardato le Università diCava, Nocera Soprana, Tiamonti, Scala, Salerno e i suoi casali, e qualche ca-
sale di San Severino, con moltissimi morti e causando danni ingentissimi. Per
questo motivo, il Percettore delle tasse di Salerno aveva deciso di non infieriresu queste zone sollecitando il pagamento delle imposizioni dovute. La Som-maria ribadiva che non si dovevano inviare i Commissari, temutissimi dallapopolazioni e dalle amministrazioni locali, in quanto incuranti delle difficoltàeconomiche della gente e fortemente oppressivi. La prepotenza di queste be-cere figure era molto risaputa e già nel corso del XVII secolo si erano infittitele lamentele di sudditi, sindaci, parroci, per mitigarne il ruolo e la funzionere.
Essi erano I'anello spietato del sistema impositivo, già poco amato dallepopolazioni, ed in aggiunta, in quanto privati a cui era affidata la funzionedi far pagare i morosi, badavano solo ai propri interessi, incuranti dellesciagure o delle difficoltà economiche insorte e non esitavano ad appro-priarsi di tutto ciò che potesse ayere un valore di mercato, pur di saziare lapropria ingordigia. Erano voci non infondate quelle relative alla voracitàdei Commissari, che si spostavano per bande, stazionavano per giorni nelleUniversità a spese delle comunità locali, provocando ulteriori danni finan-ziari, sottraevano danaro dalle casse comunali o addirittura capi di bestiame,
ovini, caprini e quant'altro.La Sommaria, che ben conosceva la situazione, provava giustamente a
frenare i possibili abusi.
Due settimane prima, anche i governanti di Cava si erano attivati, pro-ponendo tre tipi di interventi:
tB lui, vol. 324, 17 dicembre I773, ff . 3r-3v.1e Cfr. G. Foscaru, Stato, politicafscale e contribuenti nel Regno di Napoli (1610-1648),
Soveria Mannelli, Rubettino, 2006.
73
GrussplE Fosclru
' in primo luogo, una misura di carattere fiscale, ossia, I'abolizione della
tassa catastale, ula quale - si legge nel documento - se per I'addietro è stata
sempre un p€so insostituibile per la scarsezza e poco frutto de territorij di
questa città e per altri molti riflessi oggi è divenuto del tutto impossibile,
ed importabile per la mancanza de' corpi o distrutti o estremafitente
danneggiatir2o;. in secondo luogo, dare la possibilità di tagliare quei boschi e selve rima-sti
in piedi, per utllizzate il legname per la ricostruzione delle case, delle
fabbriche e per riedificare i territori devastati;. infine, ed è il terzo punto proposto, di oftenere un ristoro dalla pubblica
Amministrazione con una somma corrispondente al bisogno ed ai danni
subiti. Nella fattispecie, i governanti locali, retti dal sindaco SimoneTajani,
si richiamavano ad un analogo prolvedimento che era stato già accordato
a Cetara, casale di Cava, nell'alluvione che l'aveva colpito nel 1762.
Se il primo ed il terzo punto avevano una loro plausibilità, perché cercava-
no di evitare che al danno fisico e materiale si aggiungessero anche le abituali
tasse che non avrebbero potuto essere corrisposte a seguito dell'indubitabiledifficoltà. determinata dall'alluvione, e cercavano, altresì, di ottenere dallo
Stato un finanziamento che rimettesse in piedi l'economia dell'area colpita,
il secondo rimedio ci appare piìr frutto di un arguzia dei possidenti che una
reale misura d'intervento.A dire il vero, già provare ad abolire la tassa catastale era I'ennesima prova
di forza dei benestanti di Cava, che, si può dire, non avevano accettato da
secoli il significato di una tassa patrimoniale, sia per I'oggettiva limitazione
del territorio cavese che non assicurava una copiosa tassazione, sia, - e questo
evidentemente contava anche di piùr -, perché i maggiorenti della città preferi-
vano esentare le loro terre da una patrimoniale e spingere la tassazione verso la
gabelle sui beni di consumo, sicuramente più redditizie, ma che essi riuscivano
a non corrispondere in quanto produttori delle principali derrate agricole.
Ad ogni buon conto, che molte terre fossero state oramai danneggiate era
palese, per cui un azione contro la tassazione su terreni divenuti improduttiviaveva, come detto, una sua ragionevolezza.
La misura sui boschi, invece, ci appare del tutto impropria. Con il pretesto
dell'urgente ricostruzione e della necessità di reperire sul posto la materia
prima (il legname), si completava lo sfascio del territorio, rendendo ancora
più esposta e soggetta ad ulteriori devastazioni lazona appena sconquassata'
privandola dei residui alberi soprar,vissuti.
74
']o ACC, Classe II, sez. II, n' 13 (1772-1796), delibera de1 29 novembre 1773, cc.9t-10t.
l-o :rlluvione. Un raccottto trd ?dut/1, peniteilzd tolbttiua e perdono dirìno
Nelle settimane e nei mesi a seguire, proseguì in modo incessante lastima dei danni. A santa Lucia, popoloso casale di cava, si erano riuniti ibenestanti del posto per valutare con atenzione le condizioni del mulino,che era stato in gran parre sepolto dall'arena ed appariva del tutto inser-vibile. occorreva rimuovere fango e sabbia, così come rendere agibile ilcuraturo dove si biancheggiavano le tele21. Le persone più facoltose avevanodato mandato ai deputati del casale di far eseguire i lavori e di prendereil danaro necessario anche in prestiro, potendo conrare sulla disponibilitàdei più abbienti.
oltre ai guasti che ayevano subito le abitazioni sepolte nella zona cloudell'alluvione, olrre al blocco dei trasporti e, di conseguenza, dell'economia,si erano avuti anche altri problemi: impossibilità di dare in fitto masserieinvase da fango, detriti e sabbia, e quesro anche in posti non vicini all'epi-centro dello alluuione, inconvenienti nel reperire danaro per gli interventidi ripristino del territorio, scompuri chiesti dagli appaltatori del mulinodi santa Lucia, insomma, un elenco di conseguenze che aggravavano lepossibilità di ripresa dell'economia cittadina22.
Ma nelle vicinanze non è che le cose fossero andate per il meglio.A Vietri, il più grande casale di Cava, un gruppo di faenzari che da
decenni aveva imparato quel mestiere e lavorava nei pressi della marina,attestava nel gennaio del r774 che due dei tre piccoli mulini necessari per<macinare colori di faienza, erano srari distrutti, gli archi del ponte vicinoad alcuni magazzini di deposito erano srari invasi da grossi alberi trasportatidall'alluvione, gli strumenti di lavoro ed il legname trascinati via23.
A San Severino, e precisamente nel casale della Piazza, alcuni giornidopo I'alluvione, vari testimoni artestano che tutte le strade risultavanoampiamente distrurre, al punto di impedire completamente il traffico dellemerci e soprattutto del grano al passo dell'ospizio, dove si esigevano lecorrispondenti gabelle, da parte del Principe di Avellino. Erano oramaidieci giorni che non si vedevano passare carretre, né animali carichi dibeni alimentari, creando evidenti problemi di approwigionamento allapopolazione2a.
un gruppo di negozianti di grano e farina artesta altresì che quasi tutti imulini macinanti ad acqua dello Stato di Sanseverino erano stati inondati,
':r ASSA, Protocolli Notdrili, N. V., notaio Gofilo Salzano, b. 1351 a. 1774, Cava,26febbraio 1774.
22 Iui, Cava,24 maggio 1774.23 lui, notaio Nicola Maria Adinolfi, b.2222 a. 1774, Cava, 1 7 gennaio 1774.)a Iui, notaio Biagio Iacuzio, b. 6121 a. 1773, Sar.r Severino, 10 dicembre 1773, cc.2l\rlv.
75
GruseppP Foscanr
per cui essi non avevano poruto rrtlizzarli per macinare per oltre un mese'
e ribadendo che a questa già palese difficoltà si era accompagnata la grave
devastazione di tutie l. sir"de, sicché neanche alla dogana del Grano di
sanseverino quanro nei principali passi della medesima università si era
potuto praticare il commercio del grano'5.
A Maiori, sempre a seguito dell'alluvione, si registrano guasti notevo-
lissimi a tutte le cartiere dell'Università, in particolar modo quella tenuta
in fitto dal reverendo don Angelo Crisconio e da suo nipote Nicola, una
cartiera di 13 pile, come si evince dal documenro, situata nel luogo di Santa
Maria delle irazie26. Risultava completamente divelta la porta principale
della fabbrica, si erano introdotti smiswrati sassi all'tnterno, per un'altezza
di g palmi (2 metri e mezzo circa), menrre il fango e la sabbia avevano
,r"rpàr,",o con sé la materia prima per ottenere la pregiata carta, che viene
detàgliatamente specificara. Inoltre, risultavano completamente crollati tre
^ glrrin ,con la conseguenre perdita di tutta la merce. Il rischio paventato
è .È. pe, un lungo periodo di tempo non si potesse lavorare con gravissime
conseguenze, e con gravi difficoltà nel corrispondere la catapania, ossia la
corrispondente tassa2-.
il capomastro fabbricatore Francesco catino, - del quale è stata recen-
temenr; ricostruita la notevole ed apprezzara attività nel Capoluogo, lui
che proveniva da cava ma viveva oramai a salerno da tempo2s-, attesta che
nelllprile del1774 aveva ricevuto 55 ducati in acconto dall'arcivescovo
di SaÈrno, a saldo dei 105 ducati convenuti fra Catino e l'arcivesco per /a
spurgo, ossia lo svuoramenro di due territori appartenenti alla Mensa Arci-
,r.r..-orril. di salerno e situati nella città di Nocera, completamente interrati
da arena e breccia2e.
E danni ingenti si riscontrano anche a coperchia, dove ancora la Men-
sa Arcivescoviie di Salerno possedeva diversi mulini ad acqua' con alcuni
territori adiacenti adibiti "
or.o, del tutto distrutti dalla furia delle acque3O'
Anche a Salerno risulta distrutto una parte dell'acquedotto' a causa della
piena del torrente calcedonia, e per questo il già citato mastro fabbricatore
-.t
1r1,noti-EttoreAlfano,b.6095 a. l773,SanSeverino,21 dicembre 1773,cc.296r1v.)6 hti, notaio Giacomo Cito, b. 3187 a. 1773,Maiori, minuta del 24 novembre1773'
cafte non numefate.11 Ibidem.2s cfr. S. ScraRnorre,,4 rtigiani. La rete d.e i mestieri e I'organizzazione del lauoro a salerno
(1734-1764), Salerno, Edisud, 2011, passim.' ,, ASSA, protocolli Notdriii, notaió Carlo Barone, b.5376 a. 1774, Salerno, 16 aprile
l/ /4, cc. olr-oJV.30 1al, Salerno, 30 aprile 1774' cc.70v-90v'
76
Lo alluvione. [Jn racconîo tftt ?dur/1' ?enitenza col/ettiua e perdono dìuino
Francesco Catino viene chiamato per la riattazione necessaria' con una spesa
di poco superiore ai 500 ducati31.
IVfase: la ricerca della normalizzazione
La normalizzazione risulta lenta, e non poteva che essere così. Ripri-
srinare lo stato dei territori, delle masserie, delle colture, dei mulini, delle
cartiere, delle fabbriche distrutte o gravemente colpite richiede energie e
vigore fisico, risorse materiali e spirito di ricostruzione. C'è un problema di
capitali disponibili, e solo i più abbienti possono disporre delle necessarie
somme per alwiare con una cerra rapidità le riattazioni o una vera e propria
ricostruzione. La normalizzazione per i piccoli proprietari, per i coloni, i
contadini, necessita di un tempo largamente prolungato, stenti ulteriori e
spesso la necessità, soprattutto a Cava, nelle zone piir colpite, di lasciare
addirittura la terra per cercare altrove fortuna.
La normalizt rion passa anche per qualche furba azione di qualche
scaltro attore, che utihzzail proprio sagace spirito imprenditoriale e sfrutta
il bisogno assoluto di chi non ha pir) come vivere ed è disperato' o anche di
chi non intende vivere là" dove sono periti i familiari più cari, per allungare
le mani sui terreni ancora lordati ed oramai improduttivi'Don Mattia Armenante di cava, - un canonico! - è il protagonista di
rapide quanro dubbie operazioni notarili. È stupefacente come a meno
di venti giorni dalla tragedia riesca ad essere iperattivo e a portare davanti
al notaio Nicodemo Piasapia, Aniello e Baldassarre cuomo, zio e nipote.
Baldassarre ha un'età tra i 14 ed i 17 anni, nell'alluvione ha perso il padre
Gabriele (fratello di Aniello), la madre, i fratelli e le sorelle, e si è salvato,
con lo zio, solo perché al momento della tragedia non si tfovavano nella casa
che era stata spizzata via dalla furia delle acque e dal fango. Occorrerebbero
500 ducati pei ricostruire la casa, una cifra enorme, impossibile per Aniello,
neanche a pensarci per il niPote.
Entra in azionedon Mattia, che partecipa ad un'asta pubblica, e si aggiu-
dica la terra e quanto rimasto per 55 ducati. Un decimo di ciò che risultava
necessario per la ricostruzione della casa32.
Solo pochi giorni e don MattiaArmenante si attiva nuovamente. Questa
,rolt" ,ono Pasquale ed Emanuela siani, zio e nipotina di età. tra i 14 ed r
17. Emanueh e figlia di Aniello. Possiede con lo zio un pezzo dt terra ora
Jr lui, cc.90v-94r.3. 1zi, notaio Nicodemo Pisapi a,b.2347 a.. 1773, Cava, 30 novembre 1773, cc.159r-180v
77
GrusnPPr' Fosc'\nr
divenuto sterile, senza più alcuna pianta' né alberi fruttiferi' tutti distrutti'
un rerreno oramai ,i.op.rto di ceppe e pietre, dove prima campeggiavano
due case rerrane, ,orr;:;;ì; i'ri"?,1'r".i'lle acque e dal flango' Non avendo
danarobastevoleperricostruireeripiantart"lbt'i'essideliberanodivenderea don Mattia Armenante per la somma di 9 ducati33!
E appena due giorni dopo' il 4 dicembre' don Mattia si mostra ancora
una volta prodigo (riJ ;;i";;" con i fratelli Antonio e Pasquale Senatore
la vendita del terreno oramai sterile per 25 ducati3a'
Il 7 dicembr. ,...""" l"rluale pailadino del casale di S. Michele Arcan-
gelo, propri.,"rio p'il" itú"["uiotte di una casa terrana a travi' con un
Focolare ed un piccolo forno' e due camere situate al piano superiore' con
un terreno' dapprima vitato e fruttato ora divenuto sterile e improduttivo'
completament. ,itoft'to di ceppi' arena e pietre' Don Mattia acquista il
tutto per 82 ducatir'' rratrava di un mucchio di pietre
C"ìitl cristiana, si dirà' perché oramai si
abbandonat. . qt'A*"o "tl"bbt dovuto intervenire' Se non lo avesse fatto
don Mattia "t.,i "t"ttUtro
probabilmente agito allo stesso modo' Fa specie
pensare e verificare che sia stato un canonico'"e si può anche pensare - perché
no? _ che don Mattia abbia racimolato tutto il Janaro possibile per aiutare
persone oramai senza sPeranza'
Caritir cristiana, si diràr'
Forse, però, " q"t*o si riferiva il Preside della Regia Udienza quando
aveva deciso di i"";;i-r"ia",ip.. impedire speculazioni ed appropriazioni
di qualunque sorta'
)i lui, Cava' 2 dicembreta Iui, Cava,4 dicembre3t lui, Ca'ta.,7 dicembre
1773, cc.202rlv'1773, cc.202v-206v'1773, cc.207v-212v'
7B