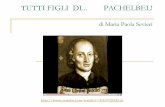L'USO DI INTERNET IN FAMIGLIE CON FIGLI ADOLESCENTI Visioni, strategie e problematiche educative
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L'USO DI INTERNET IN FAMIGLIE CON FIGLI ADOLESCENTI Visioni, strategie e problematiche educative
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONAFACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di Laurea inScienze dell’Educazione
Elaborato finale
L’USO DI INTERNET IN FAMIGLIECON FIGLI ADOLESCENTI
VISIONI, STRATEGIE E PROBLEMATICHE EDUCATIVE
Relatore Candidato
Prof.ssa Chiara SITÁSusan TONINI
INDICE
INTRODUZIONE 7
1. USO DI INTERNET IN FAMIGLIA: RIFERIMENTI
TEORICI E RICERCHE SUL TEMA 91.1 Riferimenti teorici sull’utilizzo di
Internet e del computer in famiglia 91.1.1 Internet come superamento della televisione? 91.1.2 Media Education e vita famigliare 11
1.2 Alcune ricerche nazionali ed europee
sull’uso del computer in famiglia 141.2.1 Il computer nella vita quotidiana dei bambini
italiani
14
1.2.2 Analisi europea sui comportamenti dei bambini
nel web
17
1.3 Le questioni educative 18
2. LA RICERCA EMPIRICA IN AMBITO EDUCATIVO 212.1 Il metodo fenomenologico - eidetico 22
2.1.1 La cultura ecologica 222.1.2 L’oggetto del metodo fenomenologico di ricerca 232.1.3 Le fasi del metodo 242.1.4 L’analisi delle descrizioni 25
2.2 L’intervista semistrutturata 262.2.1 Tipologie d’intervista 26
5
2.2.2 Caratteristiche dell’intervista semistrutturata 28
3. LE FASI DELLA RICERCA 313.1 Costruzione della traccia 313.2 Il campionamento 34
3.3 La trascrizione delle interviste 35
3.4 L’analisi delle interviste 37
4. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 414.1 L’uso di Internet 41
4.1.1 Capacità d’uso del PC 414.1.2 Tempi di utilizzo 43
4.1.3 Uso sociale 444.1.4 Uso ludico 454.1.5 Uso informativo e scolastico 47
4.2 Gestione “famigliare” del computer e
consapevolezza dei genitori
49
4.2.1 Governo etero diretto 49
4.2.2 Gestione mediata 51
4.2.3 Libero utilizzo 53
4.3 Opinioni sulla rete 544.3.1 Internet come una piazza o come una perdita di
tempo
54
4.3.2 L’utilità di Internet 56
4.3.3 Internet come supporto ad altri strumenti 57
4.3.4 Preoccupazioni sull’utilizzo di Internet 59
4.4 Considerazioni sull’utilizzo del computer 60
6
in famiglia
CONCLUSIONI 63
RINGRAZIAMENTI 65
BIBIOGRAFIA 67
APPENDICE SU CD terza di
copertina
INTRODUZIONE
L’idea di questa ricerca nasce da alcuni elementi
molto diversi fra loro e che hanno avuto pesi
differenti nella stesura del disegno di ricerca.
Il primo di questi sono la new addictions, o nuove
dipendenze, che mi hanno proiettata all’interno del
vasto mondo dei media e delle questioni educative ad
7
essi legate. È da sottolineare che con il termine
nuove dipendenze non si intende solo quella da
Internet e computer, ma anche quelle da lavoro, da
sesso, da shopping compulsivo, etc. La parte
interessante di questo tema non sono le dipendenze in
sé, ma piuttosto il fatto che all’interno della
letteratura iniziano ad essere presenti dei testi in
cui c’è la consapevolezza che sempre più persone
passano molto tempo davanti a uno schermo.
Nell’ottica di queste nuove dipendenze è entrato in
gioco il secondo elemento. Da una diretta osservazione
della mia famiglia e dei ragazzi che frequentavano il
centro dove ho svolto il tirocinio, mi sono resa conto
di come gli adolescenti fossero degli esperti della
rete e di come vi passassero molto tempo
“indisturbati”. La scelta di questo termine non vuole
indicare che i ragazzi vi passavano un’enorme quantità
di tempo senza che nessuno li interrompa, ma sta
proprio a individuare quelle situazioni in cui loro
stanno davanti al computer senza preoccuparsi che
qualcuno alle loro spalle li osservi, poiché sono ben
consapevoli dell’ignoranza dei genitori nell’ambito
virtuale.
Il terzo fattore che mi ha portata alla scelta di
questo tema come definitivo per la stesura del mio
elaborato è derivato dalla letteratura. Nel leggere
8
numerose monografie di autori che vengono considerati
degli esperi nell’ambito dei media, quali Rivoltella,
Masterman e Popper, ho potuto notare come la tematica
dell’utilizzo della rete in famiglia sia stata solo
accennata e come si siano concentrati, invece, sul
rapporto educazione - televisione.
Da qui nasce l’interesse di provare ad approfondire
questo argomento, seppur con una ricerca dalle
dimensioni ridotte, che non ha sicuramente le pretese
di generare delle soluzioni al problema largamente
applicabili, ma che può far luce su una piccola parte
di quest’ampia tematica.
Risulta altresì importante chiarire il contesto in
cui la ricerca si è svolta, perchè solo attraverso
questo passaggio è possibile comprendere appieno
alcune affermazioni e comportamenti degli intervistati
e delle rispettive famiglie.
Le interviste sono state svolte in una valle
composta da numerosi comuni, ognuno dei quali conta un
numero assai esiguo di abitanti, che va da un minimo
di 600 ad un massimo di 4000. A casa dei pochi
abitanti della zona, è naturale che le persone si
conoscano più o meno tutte; questo avviene anche per i
ragazzi ed è accentuato dal fatto che tutti
frequentano lo stesso complesso scolastico e gli
stessi luoghi di aggregazione. In questa zona,
9
infatti, c’è un solo istituto scolastico superiore
diviso su due sedi, ma notevolmente legate fra loro
perché molte attività vengono svolte in maniera
congiunta: un esempio è il ballo di fine anno.
Inoltre, non esiste un’ampia scelta di locali serali e
notturni e conseguentemente tutti i ragazzi di una
stessa fascia d’età si ritrovano all’interno dello
stesso. Come mi ha fatto notare un genitore, i ragazzi
che vivono in questa zona hanno una maggiore libertà
di uscire rispetto ai loro coetanei che vivono in una
grande città: questo è un fattore da non
sottovalutare, perché con gli amici si possono
incontrare in ogni momento e quindi necessitano meno
di strumenti per rimanervi in contatto.
1. USO DI INTERNET IN FAMIGLIA:
RIFERIMENTI TEORICI E RICERCHE SUL TEMA
10
Quando si parla di mass media, sono numerosi i
lavori al riguardo, sia che si tratti di monografie,
che di saggi o di rapporti di ricerca. È da
sottolineare che gran parte della letteratura presente
sull’argomento si occupa, però, del rapporto fra media
e scuola, e più specificatamente di quello fra la
televisione e l’istituzione scolastica. A questo
proposito è da sottolineare che per la stesura di
questo capitolo sono stati presi in considerazione
numerosi lavori, alcuni dei quali esprimono giudizi
notevolmente estremisti – a parer mio –
sull’argomento, poiché non esiste una cospicua
letteratura sul tema da me indagato.
1.1 Ri fer imenti teor ici sul l ’ut i l i zzo di Internet e del
computer in famigl ia
1.1 .1 Internet come superamento del la te lev i s ione?
11
La televisione è sicuramente il media più presente e
utilizzato nelle famiglie italiane: un’indagine ISTAT
del 2009 afferma che il 93,6% delle persone con più di
tre anni guarda e utilizza questo strumento. Questo è
un dato eclatante, che ci fa rendere conto di come la
tecnologia, e più in generale i media, facciano parte
della nostra vita quotidiana: già nel 1995 la vita
senza televisione non era più concepibile (Bionda et al.
1995).
Nonostante questo c’è chi afferma che «la
televisione è già dichiarata obsoleta» (Sartori, 2000:
29) e che il futuro è Internet. Ciò che sta alla base
di questa affermazione è che il televisore si presenta
come uno strumento monovalente, perchè riceve immagini
che lo spettatore deve solo guardare. Questa
caratteristica rende il fruitore un fruitore passivo,
a differenza del mondo multimediale che è per sua
stessa definizione interattivo e polivalente e crea,
quindi, degli utenti attivi (Sartori, 2000). È da
ricordare, però, che nessun media “del passato” è mai
stato totalmente soppiantato dalla novità tecnologica
presente sul mercato: degli esempi possono sicuramente
essere i quotidiani e la radio che, nonostante la
presenza della televisione, non sono andati sparendo.
Come la televisione anche Internet ha tre possibili
impieghi:
12
essere utilizzato per scopi strettamente
pratici, come la ricerca di servizi;
essere una fonte di svago;
essere uno strumento educativo – culturale
(Sartori, 2000).
Se si mette l’utilizzo del computer sul piano del
puro divertimento non è scontato che la televisione ne
esca battuta, poiché i due diversi strumenti puntano a
target di spettatori differenti, infatti
«la televisione andrà a vincere tra i “pigri” o gli
affaticati che preferiscono stare a guardare, mentre
Internet andrà a vincere tra gli “attivi”, tra coloro
che amano dialogare e cercare» (Sartori, 2000: 30)
Sartori (2000) afferma anche Internet ha delle
potenzialità infinite, sia nel bene che nel male, ma
questo potenziale può essere prevalentemente positivo
solo se i fruitori utilizzano la rete come strumento
per acquisire informazioni e conoscenze. Questo
risulta alquanto utopistico, poiché la maggior parte
degli utenti non è di questo tipo.
In conclusione, la televisione resterà il media
principale delle famiglie italiane, poiché il vedere
passivo è molto più comodo e facile del vedere attivo
che ci passa le rete; senza contare che la TV «ci fa
13
vedere un reale che ci tocca davvero, mentre il
cibermondo ci fa vedere immagini immaginarie»
(Sartori, 2000: 35).
1.1 .2 Media Education e v i ta famigl iare
Il termine Media Education viene coniato per la prima
volta nel 1973 dal Conseil International du Cinéma de
la Télévision (CICT), un organismo legato all’UNESCO,
e sta a indicare «lo studio, l’insegnamento e
l’apprendimento dei moderni mezzi di comunicazione ed
espressione considerati come specifica ed autonoma
disciplina nell’ambito della teoria e della pratica
pedagogiche, in opposizione all’uso di questi mezzi
come sussidi didattici per le aree consuete del
sapere». In Italia quest’espressione indica «quel
particolare ambito delle Scienze dell’educazione e del
lavoro educativo che consiste nel produrre riflessione
e strategie operative in ordine ai media intesi come
risorsa integrale per l’intervento formativo»
(Rivoltella, 2001a: 37). Nonostante questo termine sia
nato per dare un nome a quel movimento pedagogico che
si occupa dell’integrazione curricolare dei media
nella scuola (Masterman, 1997); negli ultimi anni la
Media Education ha voluto esprimersi anche per quanto
14
riguarda l’utilizzo e l’educazione a questi strumenti
in ambito famigliare.
Innanzitutto è bene fare un quadro generale di
quello che risulta essere il controllo parentale in
riferimento all’utilizzo dei media. Rivoltella (2006)
afferma che il controllo dei genitori risulta essere
molto blando, poiché le famiglie posseggono molti
media e alcuni dei quali sono collocati nella stanza
dei figli. a seguito di quest’affermazione non bisogna
pensare solo con riferimento alla televisione, poiché
essa ha perso il suo ruolo di medium principale. I
ragazzi, infatti, hanno una «dieta multimediale […]
più equilibrata, fatta anche di musica, Internet,
videogames, cinema» (Rivoltella, 2006: 50). A
complicare ulteriormente la situazione sono i numerosi
punti di accesso ai media di cui essi dispongono:
Internet non è più fruibile solo da casa, ma è
possibile accedervi anche attraverso reti wireless e
cellulari di ultima generazione. La casa, quindi, non
risulta più essere il luogo di consumo principale,
perché esistono strumenti mobili per rimanere sempre
connessi.
È in quest’ottica che gli studiosi hanno ritenuto
importante estendere la Media Education all’ambito
famigliare, ma calibrando gli interventi in relazione
all’età dei figli. Vengono a crearsi così due
15
categorie: la prima è quella che fa riferimento
all’infanzia e alla preadolescenza (4-14 anni), la cui
questione principale risulta essere legata al governo
del rapporto con i media; la seconda si occupa
dell’adolescenza e della giovinezza (14-25 anni), il
cui compito è quello di capire se un consumo più
autonomo dei media corrisponde a un consumo più
critico.
Un problema che nasce nell’esportazione della Media
Education in famiglia deriva, però, dal fatto che questo
movimento pedagogico è coniato su misura per
l’ambiente scolastico, dove l’educazione assume un
aspetto formale. Questa formalità non è sicuramente
presente in famiglia e risulta impensabile
«l’educazione al consumo critico dei media […] secondo
il modello della lezione o dell’esercitazione»
(Rivoltella, 2006: 55). Un modo per svincolare a
questo problema potrebbe essere quello di affermare
che la Media Education debba svolgersi esclusivamente a
scuola o nei contesti di educazione formale e che, di
conseguenza, la famiglia non se ne debba occupare.
Questa appare una soluzione alquanto banale e
semplicistica, visto che i ragazzi consumano i media
prevalentemente nel loro tempo libero e non a scuola.
In riferimento a questo nasce anche una profonda
contraddizione, poiché
16
«da una parte la famiglia si presta come contesto
ideale per la Media Education, dall’altra non si potrà mai
chiede a un genitore di disporre delle stesse
competenze di cui dispone l’insegnante» (Rivoltella,
2006: 56)
La domanda che ci si pone appare allora chiara: come
è possibile fare Media Education in famiglia? Questo è un
quesito ancora aperto, ma a cui numerosi studiosi
hanno tentato di rispondere
La prima soluzione individuata è quella di formare i
genitori, ma questo non significa che il genitore deve
divenire un esperto media educator. Questa posizione
sarebbe profondamente sbagliata perché caricherebbe il
genitore di una responsabilità eccessiva. Formare i
genitori non significa nemmeno dare una lista di
“istruzioni per l’uso”, perché il più delle volte si
trasformerebbero in consigli estremamente moralistici.
Inoltre, la ricerca ha fornito dei risultati
contradditori su questa tematica, considerando che è
emerso come
«risultino più capaci di educare ai media genitori
senza una particolare istruzione, che agiscono sulla
base del loro buon senso pedagogico, o come genitori
molto informati sui rischi educativi dei media
17
finiscano per esaurire la loro presenza educativa nella
verbalizzazione della loro preoccupazione senza
tradurla fattivamente nel governo dei media»
(Rivoltella, 2006: 57)
La seconda soluzione fornita dagli esperti è stata
quella di fissare dei modelli di intervento educativo
(Rivoltella, 2002), che però rischiano di produrre più
problemi che vantaggi proprio dal punto di vista
educativo. I modelli elaborati dagli studiosi sono
tre:
modello-dieta, che consiste nel ridurre la
quantità di consumo dei media da parte del
ragazzo attraverso forme di negoziazione;
modello-censura, dove vengono eliminati tutti o
almeno parte dei media presenti nella vita del
ragazzo, anche attraverso la proposta forzata di
alternative al consumo mediale;
modello-filtro, in cui ha una funzione di
tutore nei confronti del consumo mediale
(Rivoltella, 2006).
Come detto sopra, questa della Media Education in
ambito famigliare è una questione ancora aperta, ma a
cui si stanno cercando delle soluzioni. Una di queste,
a cui si sta lavorando attualmente, è quella di creare
una rete di genitori ed esperti per aprire uno spazio
18
di confronto sul tema dei media. Solo in questa
maniera le “istruzioni dell’uso” non saranno mera
morale, ma utili informazioni contestualizzate e
aderenti al piano educativo.
1.2 Alcune r icerche nazional i ed europee sul l ’uso del
computer in famigl ia
È da sottolineare che nonostante queste ricerche
siano molto recenti possono apparire superate, perchè
nel corso di questi ultimi anni sono cambiate molte
cose nell’ambito della tecnologia: basti pensare alla
nascita dei primi dispositivi di navigazione in
mobilità, come ad esempio le Internet Key, o
all’avvento degli smartphone.
Un esempio di quanto detto sopra può essere la
ricerca disegnata nel 1999 dal Centre des Liaisons
pour l’Education aux Médias et à l’Information (CLEMI)
di Parigi che ha coinvolto anche l’attuale Centro di
Ricerca sull’Educazione ai Media all’Informazione e
alla Tecnologia (CREMIT) dell’Università Cattolica di
Milano, per lo svolgimento della parte italiana.
Quest’indagine venne poi pubblicata da Rivoltella,
referente italiano per la ricerca, nel libro dal
titolo “I r@gazzi del web” (2001b). Questo lavoro
19
offre notevoli spunti sul tema del rapporto che i
ragazzi hanno con Internet, ma molti passaggi
risultano ormai superati, poiché dal 2001 al 2009 si è
avuto un aumento pari a quasi il 20% delle famiglie
che possiedono un computer e sono raddoppiate quelle
che dispongono di un accesso a Internet (ISTAT, 2010).
1.2 .1 I l computer ne l la v i ta quot id iana dei bambini
i ta l iani
Si tratta di un’indagine ISTAT svoltasi nei primi
mesi del 2005, dal titolo “Indagine multiscopo sulle
famiglie. Aspetti della vita quotidiana” (ISTAT,
2007). Questa ricerca è stata fatta su circa 20˙000
famiglie, per un totale di circa 55˙000 persone.
Dai dati raccolti risulta che le famiglie “più
tecnologiche” risultano essere quelle al cui interno è
presente almeno un minorenne: è proprio in queste
famiglie che si ha la maggiore crescita di possesso di
beni tecnologici. Il 67,6% delle famiglie possiede un
personal computer (PC) e il 51% dispone anche di un
accesso a Internet. Rispetto al 1997 c’è stato un
notevole incremento, poiché in quell’anno solo il
24,9% e il 3% possedevano rispettivamente un PC e una
connessione alla rete.
20
È interessante notare la presenza di alcune
differenze riguardanti il genere nell’utilizzo del
computer e di Internet. Queste differenze sembrano
essere, però influenzate dall’età. In linea generale
sono i maschi i maggiori fruitori della tecnologia,
visto che il 45,3% della popolazione maschile dai tre
anni in su utilizza il computer, contro il 34,7% delle
femmine. Questa tendenza s’inverte, però, nella fascia
fra i sei e i dieci anni dove il 54,5% delle bambine
utilizza il PC rispetto al 51,9% dei bambini. Alla
luce di questi dati si può ipotizzare che il limitato
impiego delle nuove tecnologie alla scuola
dell’infanzia sia dovuto proprio ad un uso minore del
PC da parte delle donne, che detengono la quota di
maggioranza all’interno del personale educativo di
questa istituzione.
All’interno di questa ricerca vengono anche
approfondite le tipologie di attività svolte dagli
utenti della rete. I dati ci dicono che l’attività
principale svolta da chi naviga in Internet è quella
di comunicare (77,4%), a cui segue quella di cercare
informazioni sanitarie e su merci e servizi (64,4%).
Le altre categorie individuate nel corso dell’indagine
coinvolgono meno della metà della popolazione, come ad
esempio usare servizi online che è stato scelto solo
dal 47,3% degli intervistati. Questi dati si
21
riferiscono a tutto il campione preso in esame e non
solo ai bambini. In riferimento a quest’ultimi, in età
compresa fra i sei e i dieci anni, sono state
individuate solo quattro categorie:
giocare o scaricare giochi, immagini e musica
(73,5%)
mandare o ricevere e-mail (16,1%)
leggere o scaricare giornali, news e riviste
(11%)
cercare informazioni su merci e servizi (10,7%)
Da queste informazioni è possibile ricavare la
conclusione che Internet e il computer più in generale
vengono visti dai bambini soprattutto come un gioco,
piuttosto che come uno strumento di conoscenza e
informazione.
All’interno della stessa indagine è stata stilato un
elenco dei giochi che i bambini fanno con la mamma e
con il papà. In questa lista sono stati divisi i
maschi e le femmine ed è stata fatta un’ulteriore
scomposizione per fasce d’età: la prima è quella che
va dai tre ai cinque anni, mentre la seconda è quella
dai sei ai dieci anni. In riferimento ai giochi fatti
con la mamma, emerge che i maschi della prima fascia
principalmente disegnano, mentre i giochi virtuali
sono solo al nono posto; le femmine della stessa età
la pensano in maniera uguale per quanto riguarda la
22
prima posizione, ma fanno slittare al decimo posto i
giochi con il computer. La prima posizione, occupata
dal disegnare, rimane invariata anche per la seconda
fascia, sia maschile che femminile; invece, la pratica
di giochi virtuali assieme alla mamma guadagna alcune
posizioni passando al sesto posto per i maschi e al
nono per le femmine.
Diversa risulta essere la situazione che riguarda i
giochi con il papà. Per i maschi fra i tre e i cinque
anni la prima posizione è occupata dai giochi di
movimento e i giochi online si collocano al quinto
posto; totalmente diverso è per le femmine della
stessa fascia d’età, che principalmente disegnano e
mettono all’ottavo posto i giochi virtuali. La
situazione cambia ulteriormente per la seconda fascia
d’età: i maschi mantengono al primo posto i giochi di
movimento, ma già al secondo posto sono presenti i
videogiochi e i giochi al computer; anche le femmine
mettono al primo posto i giochi di movimento, ma
lasciano i giochi online al quarto posto.
Questa parte della ricerca mette in luce i diversi
ruoli che hanno i genitori in relazione all’utilizzo
del computer. Come appare dai dati sopraesposti, si
può dedurre che il papà abbia una maggior tolleranza
del PC, ma che allo stesso tempo condivida con i figli
23
i momenti in cui questo dispositivo viene utilizzato
come strumento di svago.
1.2 .2 Anal i s i europea sui comportament i de i bambini nel
web
Questa ricerca si è svolta su un campione di 4˙800
ragazzi fra i due e i tredici anni in quattro Paesi
diversi: Italia, Francia, Regno Unito e Germania.
L’indagine è stata commissionata dal Ministero per
l’Innovazione e le Tecnologie (MIT) e affidata alla
Nielsen//NetRatings. I risultati sono poi stati
presentati in occasione del convegno organizzato dallo
stesso MIT nel maggio del 2002, dal titolo “Chi ha
paura della rete? Per un uso consapevole di Internet”.
Per osservare il comportamento durante la navigazione
è stato installato sul computer dei partecipanti un
software specifico che vi è rimasto per tutto il primo
trimestre del 2002 (Nielsen//NetRatings, 2002).
Durante il periodo di osservazioni si è potuto
notare che il 35% dei bambini italiani era
potenzialmente connesso alla rete, ma che vi
navigavano attivamente solo il 14%. Questo dato si
colloca in una posizione intermedia rispetto agli
altri Paesi presi in analisi, poiché la Francia
24
risulta essere lo Stato con meno piccoli navigatori
(solo il 25% è potenzialmente connesso e il 9% lo è
effettivamente) e il Regno Unito si pone al primo
posto con ben il 56% di navigatori passivi e un 29% di
navigatori attivi. La situazione tedesca non è molto
diversa da quella inglese e si differenzia solo per
pochi punti percentuali: sono il 54% i bambini
potenzialmente connessi e il 20% quelli che navigano
attivamente.
Da questa ricerca emerge anche che
«le differenze di genere tra i bambini e i ragazzi
italiani navigatori sono molto meno accentuate a favore
dei maschi in confronto alla popolazione adulta che
frequenta Internet» (Mantovani e Ferri, 2006: 111-112).
È anche importante sottolineare che la maggior parte
della navigazione avviene nelle ore serali o nel fine
settimana e che per i bambini delle scuole elementari
è prevalentemente assistita dai fratelli maggiori o
dai genitori. Diversa è la situazione per i ragazzi
che frequentano la scuola media, la cui navigazione
avviene principalmente in maniera autonoma. Uno dei
motivi di quest’autonomia può essere ricondotto alle
competenze che hanno questi ragazzi, perché il più
delle volte superano quelle che posseggono i genitori.
25
Dal punto di vista di quest’ultimi Internet risulta
essere importante, se non quasi indispensabile, ma è
al tempo stesso pericolosa.
1.3 Le questioni educative
Dalla letteratura fin qui analizzata emergono
chiaramente alcune questioni educative che hanno
sostenuto l’elaborazione delle domande di ricerca.
Il primo di questi quesiti riguarda il controllo dei
genitori nei confronti dei figli a proposito dei
media; Rivoltella (2006) afferma che in molti casi
risulta essere blando, ma è necessario indagare quanto
il governo parentale è realmente limitato. È
altrettanto importante comprendere in che modo viene
esercitato questo tipo di controllo e se si estende a
tutti gli aspetti che riguardano l’utilizzo del
computer e di Internet o se è circoscritto soltanto ad
alcune aree. Per poter analizzare questo punto è
importante porsi prima la questione di quanto i
genitori conoscano e sappiano utilizzare la rete,
soprattutto in riferimento a quanto la sanno usare i
loro figli. È fondamentale, infatti, comprendere chi
detiene le redini della socializzazione a questo
mezzo; e soprattutto è importante capire se sono
26
presenti dei legami fra l’ambito professionale o lo
status socio-economico del genitore e la sua
dimestichezza nell’utilizzo di questi nuovi strumenti.
Alcuni studiosi (Di Maggio et al. 2004) affermano che
certe persone utilizzano Internet più di altre e sono
per lo più rappresentanti dei segmenti sociali che
hanno un miglior accesso all’istruzione, redditi più
elevati e altre risorse che facilitano l’adozione
dello strumento. Anche Van Dijk (2005) si è occupato
delle disuguaglianze di competenze digitali,
affermando che alcune caratteristiche ascritte come
l’età, il genere e la famiglia d’origine influenzano
notevolmente il tipo di capacità che avrà la persona
avrà nei confronti della rete. È altresì importante
sottolineare come queste differenze si annullino nella
fascia d’età che va dai 12 ai 25 anni (Gui, 2009).
Il secondo interrogativo che nasce risulta essere
legato al tema del rapporto fra scuola e media. Più
precisamente è necessario indagare se e in che misura
la scuola richieda agli studenti di utilizzare questi
strumenti. Molti studiosi, infatti, si sono
concentrati su quell’ambito della Media Education che
esplora il tipo di educazione ai media che viene fatta
all’interno del contesto scolastico, ma un numero
assai esiguo di loro si è concentrato su come e quanto
27
la scuola richieda l’utilizzo della tecnologia in
ambito domestico.
Un’ulteriore questione che emerge leggendo i lavori
degli esperti, e che viene presa in considerazioni
anche da Rivoltella (2006), è quella della nascita di
numerosi strumenti tecnologici che permettono di
restare sempre connessi, di essere sempre in rete. Il
problema che ci si pone riguarda proprio questo
aspetto: l’essere sempre connessi. Viene naturale
chiedersi se questa perenne connessione sia dovuta ad
un grande bisogno di informazione o a un grande
bisogno di comunicazione (e quindi di relazione). I
due temi non si escludono uno con l’altro, ma è
importante capire quale sia la priorità nel momento in
cui si accede alla rete.
Un ultimo quesito riguarda la concezione che si ha
del computer e più precisamente di Internet. Sartori
(2000) afferma che il PC non sostituirà mai la
televisione, ma è fondamentale comprendere se questi
due strumenti sono visti come interscambiabili o se il
computer risulta essere un ripiego quando alla tv non
trasmettono niente di interessante.
Da tutte queste questioni aperte o poco indagate
emerse dalla letteratura , è possibile prendere spunto
per realizzare quella che è la domanda di ricerca. Il
tema da indagare risulta sicuramente essere quello
28
dell’utilizzo dei media in famiglia, analizzato
soprattutto dal punto di vista delle strategie che i
genitori mettono in atto nei confronti dei figli, e
delle opinioni che essi hanno a proposito della rete.
29
LA RICERCA EMPIRICA IN AMBITO EDUCATIVO
La ricerca empirica in ambito educativo è
fondamentale per la costruzione del sapere in questo
campo: solo da essa è realmente possibile ricavare le
indicazioni per orientare al meglio la pratica. Appare
chiaro che nessuna ricerca scientifica sarebbe in
grado di produrre dati con la valenza di regole
generali per l’azione (Mortari, 2007). È necessario
tenere conto del presupposto che «nessuna conclusione
di una ricerca scientifica si può convertire
immediatamente in una norma dell’arte dell’educazione»
(Dewey, 1984: 11), ma che i dati che da essa ne
derivano possono solo essere considerati in maniera
ipotetica e di conseguenza ci forniscono soltanto
delle linee guida che vengono in aiuto per comprendere
i casi specifici. La ricerca di formule generali non
solo è utopistica, poiché in educazione tutto è
provvisorio e sempre aperto, ma degenera nell’arco di
poco tempo «in vuote generalizzazioni» (Arendt, 1987:
294).
31
La ricerca empirica, quindi, viene concepita come
indagine sul campo. Dewey sostiene che il mondo
dell’educazione deve basarsi sui contributi
provenienti dalla ricerca sul campo, perché ne
derivano elementi importanti che non sarebbero
raggiungibili in altri modi (Dewey, 1993). Questo non
significa che in ambito educativo è possibile svolgere
solo ricerche di tipo empirico, ma evidenzia il fatto
che questo tipo ricerca deve essere strettamente
correlata con la quella di tipo teoretico, affinché si
crei una continua rimodulazione delle due «nella forma
di una reciprocazione evolutiva» (Mortari, 2007: 12).
In quest’ottica si pensa alla ricerca empirica come
a quel tipo di ricerca che inserisce nel contesto
qualcosa di nuovo: è chiaro che l’essenza di questo
tipo d’indagine porta a concepirla come una ricerca di
tipo trasformativo. Risulta altresì importante la
ricerca constatativa, che mira a comprendere come si
presentano le cose all’interno del contesto (Mortari,
2007). Nell’indagine presentata nei capitoli
successivi si è fatto ricorso a questo secondo tipo di
ricerca.
2.1 I l metodo fenomenologico – eidetico
32
2.1 .1 La cul tura ecologica
La cultura ecologica è la cornice entro cui si
inserisce il metodo fenomenologico – eidetico, che non
è l’unico che contraddistingue questo paradigma, ma ne
fanno parte anche la grounded theory e la narrative inquiry.
Della cultura ecologica non fanno parte solo i
diversi metodi, che ci danno le informazioni sulla
raccolta e sull’analisi dei dati, ma anche:
l’epistemologia, cioè le regole generali che
guidano l’indagine. Nello specifico della cultura
ecologica si parla di epistemologia naturalista;
la filosofia di ricerca, per dare una direzione
di senso all’intero lavoro. In questo caso sono
più di una quelle che caratterizzano il paradigma
e si parla di fenomenologica, critica,
partecipativa, ermeneutica;
le strategie, che danno istruzioni su come
procedere. Caratterizzanti della cultura
ecologica sono la ricerca-azione, l’etnografia e
l’etnometodologia.
le tecniche d’indagine, utili per la raccolta
pratica dei dati (Mortari, 2007).
Il metodo fenomenologico - eidetico prende
ispirazione dalla filosofia fenomenologia di E.
33
Husserl (1859 – 1938) e va di pari passo con l’omonima
filosofia di ricerca. Una delle peculiarità di questo
metodo sta proprio nella flessibilità delle procedure
dello stesso: basti pensare che i ricercatori che si
affidano alla filosofia di ricerca fenomenologica
sottolineano che andrebbero evitati tutti quei
processi che la irrigidiscono, perché impediscono di
vedere la vera essenza del fenomeno (Van Kaam, 1966).
Questo tipo di metodo richiede che l’attenzione del
ricercatore sia focalizzata sull’oggetto e non sul
metodo stesso, perché solo in questo modo si mantiene
intatta la particolarità che esso ha di essere
«particolarmente apprezzabile nel contesto delle
scienze umane» (Mortari, 2007: 169).
2.1 .2 L ’oggetto de l metodo fenomenologico d i r i cerca
Secondo il metodo fenomenologico - eidetico,
l’oggetto della ricerca è il fenomeno studiato
prendendo in considerazione il significato che ha
avuto nell’esperienza vissuta dei partecipanti. Per
indagare questo aspetto è necessario che coloro che
partecipano alla ricerca descrivano la loro
esperienza, in modo che il ricercatore possa
analizzarla per descrivere il fenomeno «così come si
34
manifesta nella sua percepita immediatezza» (Van Kaam,
1966: 15). L’analisi che il ricercatore fa sulle
descrizioni fornite dai partecipanti viene chiamata
dagli esperti analisi strutturale e consiste nel
«determinare le “strutture sottostanti”» (Mortari,
2007: 170), che in altre parole vuol dire cogliere il
significato fondamentale che il partecipante ha voluto
dare a quella precisa esperienza. Le strutture che si
vanno ad analizzare risultano essere «costruzioni
quanto più fedeli del fenomeno» (Mortari, 2007: 170).
Proprio da quest’ultima frase è possibile ricavare il
criterio di validità di una ricerca fenomenologica: il
paradosso della costruzione fedele da vita a questo
principio. Da questo punto di vista la vera essenza di
una fenomeno è quella qualità che risulta essere
comune a tutte le descrizioni.
Come ho già detto nella parte iniziale del capitolo,
dalle ricerche in abito educativo non è possibile
ricavare una tesi di valore universale. Questo non
pensabile perché ogni descrizione del fenomeno che ci
viene fornita dai partecipanti viene inevitabilmente
mediata dall’esperienza degli stessi. Conseguentemente
a ciò non si deve pretendere di giungere a dei
risultati dal valore universale, ma che abbiano la
maggior valenza possibile.
35
2.1 .3 Le fasi de l metodo
Il metodo di ricerca fenomenologico - eidetico è
composta da diverse fasi. Sicuramente la prima, e
anche la più importante, è l’individuazione
dell’oggetto di ricerca. Riguardo a questo punto
esistono due differenti scuole di pensiero: la prima
afferma che il fenomeno da indagare debba essere
rilevante dal punto di vista scientifico; la seconda,
sostenuta principalmente da Moustakas, sostiene invece
che l’oggetto della ricerca deve avere un particolare
significato soprattutto per il ricercatore. Una volta
che si è individuato il fenomeno, è necessario
indagare il significato che gli viene attribuito dai
partecipanti.
Il secondo passo sono proprio i partecipanti. È
chiaramente indispensabile cercare delle persone «che
abbiano o abbiano avuto esperienza diretta del
fenomeno» (Mortari, 2007: 171). Una peculiarità della
ricerca fenomenologica riguardo a questo punto è che i
partecipanti a questo tipo d’indagine sono
relativamente pochi.
La terza fase del metodo fenomenologico - eidetico
riguarda la raccolta dei dati, che solitamente sono
delle descrizioni che il partecipante da del fenomeno.
36
La tecnica più utilizzata è sicuramente l’intervista.
Questa parte verrà approfondita nel paragrafo
seguente.
Un elemento essenziale di questo tipo di ricerca è
sicuramente l’epoché: proprio da essa, il cui concetto
fu elaborato dal padre della fenomenologia Husserl,
prende il nome il metodo sopradescritto. Con il
termine epoché si indica l'astensione dal dare un
determinato giudizio o valutazione, qualora non
risultino disponibili sufficienti elementi per
formulare il giudizio stesso. Poiché gli studiosi si
sono occupati raramente di questo aspetto del metodo,
è stata individuata una soluzione alquanto
semplicistica per fare in modo che le riflessioni
personali del ricercatore non influiscano all’interno
del setting di ricerca: «praticare interviste non
strutturate che escludono qualsiasi domanda
preformulata» (Mortari, 2007: 172). Questo tipo
d’intervista prende il nome di «intervista libera da
presupposizioni» (Ray, 1994: 129), ma in realtà è più
probabile che emergano inconsciamente i giudizi del
ricercatore quando si lascia trasportare dal libero
flusso del discorso.
Mortari (2007) afferma che il vero metodo
fenomenologico - eidetico si realizza nell’intervista
semistrutturata, dove sono presenti solamente i nuclei
37
tematici da trattare. In questa maniera è possibile
mantenere il setting conversazionale molto libero, ma
allo stesso tempo «consente al ricercatore di vigilare
meglio sulle sue convinzioni rispetto ai temi da
trattare» (Mortari, 2007: 172-173). Nonostante questo,
la principale e fondamentale operazione eidetica di
questo metodo rimane la descrizione richiesta ai
partecipanti. Questo aspetto non si esprime solo
attraverso una mera descrizione delle esperienze
vissute, ma anche attraverso l’esplicitazione del modo
in cui si è giunti alla definizione di quest’ultime.
2.1 .4 L ’anal i s i de l le descr iz ioni
Le descrizioni fornite dai partecipanti non possono
essere utilizzate in forma grezza, ma devono essere
analizzate attentamente. L’analisi si compone di
diverse fasi, più semplici e meno tecnicistiche di
quelle previste dalla grounded theory. Con il termine
semplice non s’intende che l’analisi viene fatta in
maniera superficiale, ma che la tecnica è più snella e
fornisce una sorta di valore aggiunto al metodo
eidetico.
La prima fase è quelle di leggere attentamente tutte
le descrizioni e di individuare le parti inerenti
38
all’argomento preso in esame. Questo passaggio viene
chiamato «orizzontalizzazione» (Mortari, 2007: 173),
perché si riesce ad avere un orizzonte completo dei
significato che i partecipanti danno all’argomento. Il
passo successivo è quello di creare dei “contenitori”
in cui raggruppare tutte le unità di significato che
riguardano uno stesso aspetto del tema trattato.
Solo al termine di questi due passaggi il
ricercatore può iniziare ad elaborare una descrizione
abbastanza generale dell’oggetto di studio. La
definizione si basa su due diversi tipi di
descrizioni: una che riguarda in che cosa consiste la
qualità del fenomeno; e l’altra che si occupa di
«“come” viene vissuto il fenomeno» (Mortari, 2007:
173). Poiché la definizione generale dell’oggetto sia
completa, è necessario individuare ciò che è comune a
tutte le descrizioni e che risulta quindi ricorrente.
Moustakas (1994: 58) definisce la descrizione
fenomenologica come quella che «si mantiene quanto più
vicina possibile alla tessitura strutturale delle
cose, alle loro fenomeniche qualità e proprietà
materiali».
A questo riguardo esistono due scuole di pensiero:
il Duquesne Method e l’Heuristic Research. La seconda è una
variazione del primo metodo elaborata da Moustakas. La
differenza fra la prima e la seconda sta
39
principalmente nell’interpretazione delle azioni
epistemiche, come ad esempio un continuo confronto con
i partecipanti «per verificare insieme l’attendibilità
dei dati così come sono stati configurati dal
ricercatore» (Mortari, 2007: 175-176). La differenza
più evidente è sicuramente quella che riguarda le
descrizioni; infatti, l’Heuristic Research non si basa
solo su quest’ultime, ma anche su numerosi altri
documenti come poesie, diari etc. In conclusione, nei
due metodi differisce il livello di generalità a cui
ciascuno punta, poiché il metodo elaborato da
Moustakas agli inizi degli anni Novanta rimane legato
agli aspetti più individuali dei singoli.
2.2 L ’ interv ista semistrutturata
2.2 .1 Tipologie d ’ interv i s ta
L’intervista qualitativa è una tecnica per la
racconta dei dati ed è sicuramente lo strumento più
usato per le ricerche in ambito educativo. Con il
termine intervista s’intende
40
«una conversazione sollecitata e orientata
dall’intervistatore, che opera sulla base di uno schema
flessibile e non standardizzato di nuclei tematici che
s’intende indagare» (Milani e Pegoraro, 2011: 13).
L’intervista può assumere numerose forme diverse, in
base agli obiettivi, al disegno di ricerca e allo
status dei soggetti. Bichi (2007) è il primo a
raggruppare tutte le diverse configurazioni di
interviste in tre macrotipologie, che differiscono fra
loro sulla base di due caratteristiche: la
standardizzazione e la direttività. La
standardizzazione è quel principio che misura il
livello di pre-definizione di un’intervista, che in
altre parole significa valutare se l’intervistatore ha
scelto anticipatamente i temi, l’ordine delle domande
e le varie possibilità di risposta. La direttività,
invece, è lo strumento attraverso cui valutare il tipo
di conduzione che l’intervistatore adotta. Tale
principio si può misurare su una scala che va
dall’intervista non direttiva, dove i partecipanti
possono condurre il discorso in maniera libera e
autonoma, ad un massimo di intervista totalmente
direttiva, in cui «la conversazione segue la direzione
che le è impressa dall’intervistatore» (Sità, 2009:
4).
41
Le tre tipologie di interviste individuate da Bichi
sono le seguenti:
intervista standardizzata, conosciuta anche
come intervista strutturata o questionario. La
direttività e la standardizzazione raggiungono i
massimi livelli in questo tipo di colloquio, a
causa della «serie ben definita e articolata di
domande» (Milani e Pegoraro, 2011: 20);
intervista non-direttiva, o non strutturata. La
caratteristica principale di questa tipologia è
proprio quella di essere all’opposto rispetto a
quella sopradescritta, poiché i livelli di
standardizzazione e direttività sono molto bassi
in modo da mettere al centro della conversazione
l’esperienza dell’intervistato;
intervista semistrutturata, che si colloca a un
livello intermedio fra l’intervista
standardizzata e quella non-direttiva. Questa
tipologia verrà successivamente approfondita in
modo più completo.
Per costruire un’intervista sono necessari «tanti
piccoli passi che richiedono […] molta cura» (Milani e
Pegoraro, 2011: 14), come ad esempio costruire una
traccia, individuare i soggetti, contattarli e
convincerli ad accettare, raggiungerli per
42
intervistarli, registrare la conversazione,
trascriverla e analizzarla.
2.2 .2 Caratter i s t i che del l ’ interv i s ta semistrut turata
Mortari (2007) afferma che l’intervista
semistrutturata è la tecnica di ricerca che
maggiormente rispecchia i presupposti del metodo
fenomenologico – eidetico, poiché essa richiede
all’intervistatore di delineare all’interno di una
traccia i nuclei tematici da analizzare. Agendo in
questa maniera è possibile vigilare sulle proprie
convinzioni e sui propri giudizi; e fare in modo che
essi non contaminino il setting di ricerca.
La traccia è lo strumento principe che il
ricercatore ha a disposizione al momento del colloquio
con i partecipanti; e si compone di nodi tematici
«concatenati e interdipendenti» (Milani e Pegoraro,
2011: 20), in modo che la conversazione possa iniziare
da un punto qualsiasi della griglia e spostarsi
liberamente da un tema all’altro, senza che ci sia un
ordine prestabilito. Questa modalità di condurre
l’intervista concede un’ampia libertà sia al
ricercatore che all’intervistato, ma garantisce anche
che vengano trattati tutti i temi di interesse per la
ricerca. Naturalmente questo tipo di tecnica richiede
una buona capacità di comunicazione da parte
43
dell’intervistatore, che deve esplorare tutte le
questioni agganciandosi alla risposta alla domanda
precedente e non seguendo sistematicamente la griglia
(Milani e Pegoraro, 2011).
Nello svolgere un’intervista di questo tipo la
durata della stessa non è mai calcolabile, poiché si
può passare da interviste condotte in setting
estremamente freddi che si trasformano in «botta e
risposta» (Milani e Pegoraro, 2011: 34), a situazioni
diametralmente opposte, dove le narrazioni divengono
interminabili. Questi due contesti sono i casi limite,
che non dovrebbero mai verificarsi: la durata
“normale” di un’intervista di questo tipo va dalla
mezz’ora all’ora e mezza, soprattutto perché dopo tale
lasso di tempo l’attenzione dei due partecipanti
inizia a calare notevolmente.
L’intervista semistrutturata ha numerosi vantaggi,
come ad esempio quello di poter acquisire un gran
numero di informazioni e di poter chiarire subito
eventuali dubbi sorti nel corso della conversazione.
Questa caratteristica prende il nome di flessibilità,
che può essere sicuramente considerata un vantaggio
per i motivi sopradescritti, ma si presenta anche come
uno svantaggio «se diventa puro arbitrio
dell’intervistatore» (Milani e Pegoraro, 2011: 36). Un
altro vantaggio di questa tipologia di intervista è il
44
fatto che il ricercatore è presente mentre i
partecipanti rispondono alle domande e può, quindi,
osservarne le reazioni non verbali. L’intervista
strutturata incontra, però, un notevole ostacolo nel
tempo e nei costi di realizzazione: non è neanche
paragonabile il tipo di lavoro che si trova a fare
l’intervistatore per analizzare questo genere di
intervista rispetto a quello che farebbe per un
questionario.
Una questione fondamentale, da tenere sempre in
considerazione, è quella che l’intervistatore non ha
mai una visione diretta del fenomeno, ma la ricava dai
racconti e dai ricordi dell’intervistato (Gianturco,
2005). In questa maniera al ricercatore arriva
soltanto ciò che l’interlocutore vuol fare apparire,
una sorta di presunta verità, perché
«il soggetto nel ricordo, nel ri-vivere,
inevitabilmente deforma, cioè carica tutto ciò che è
interpretazione successiva, riflessione o sensazione o
cumulo di esperienze che fanno sì che quel dato diventi
un fatto costruito a posteriori» (Orlando, 1997: 100).
Alla luce di quanto detto sopra, questo tipo
d’intervista è da «considerare degno di fiducia, più
che “vero”» (Atkinson, 2002: 92). Nonostante questo, è
45
anche vero che il compito del ricercatore non è quello
di raccogliere il dato oggettivo, ma quello di
osservare la costruzione soggettiva della realtà e la
logica che vi sta alle spalle.
46
3. LE FASI DELLA RICERCA
3.1 Costruzione del la traccia
Come ho detto nel capitolo precedente, una
peculiarità dell’intervista semistrutturata è la non
rigidità della traccia: in questo modo il ricercatore
ha a disposizione una griglia di riferimento che non
deve essere utilizzata in modo prestabilito, ma che
può essere adattata alle condizioni che si creano in
ogni singola intervista.
Il primo passo per la costruzione della traccia è
stato quello di individuare all’interno dell’argomento
di ricerca dei temi su cui soffermarmi o indagare più
in profondità nel corso delle interviste. Come
suggerito dal manuale di Milani e Pegoraro, ho
predisposto uno schema circolare d’intervista, ovvero
«l’insieme tematico che punta a definire le domande e
garantisce l’elasticità nella conduzione» (Milani e
Pegoraro, 2011: 22). La FIGURA 1 si riferisce proprio
al suddetto schema. Come è possibile notare, i vari
nuclei tematici sono interdipendenti e collegati fra
di loro, in modo da consentire al ricercatore di
47
spostarsi liberamente da un tema all’altro senza
rispettare un preciso ordine.
Successivamente sono passata a stendere il vero e
proprio canovaccio delle domande dell’intervista. Nel
corso di questo procedimento era importante avere ben
presente in testa gli scopi dell’indagine,
l’importanza delle domande per l’intervistato e la
rilevanza delle domande rispetto alla ricerca stessa.
È anche importante che il ricercatore tenga sempre
presente che le domande da lui pensate potrebbero
risultare inadatte o che debbano essere rimodulate,
poiché non è concepibile prevedere la direzione che
prenderà la conversazione, cosa invece possibile nelle
interviste di tipo strutturato. Per arrivare alla
lista corretta delle possibili domande ho dovuto
stendere due volte il canovaccio: la prima volta,
infatti, avevo steso un elenco composto interamente da
domande chiuse o viziate, poiché orientavano la
risposta dell’intervistato. Solo in una successiva
rilettura di questo primo elenco mi sono resa conto
dell’errore e ho quindi riformulato l’intera bozza
cercando di limitare il più possibile le domande
chiuse per lasciare spazio a quelle aperte; ho,
inoltre, prestato particolare attenzione a non
inserire domande multiple, che disorientano
l’interlocutore.
48
FIGURA 1
Mappa circolare dei nuclei tematici
La traccia finale dell’intervista risulta essere
composta da sei nodi tematici, ognuno dei quali ha
degli obiettivi precisi e definiti; per ogni nucleo
Contestualizzazione
dell’intervista
Uso generale di computer e Internet in famiglia
Tempo di utilizzo del
computer
Internet per
comunicare
Filtri e controllo di
Internet
Scuola e utilizzo di Internet
49
sono state individuate delle possibile domande o
questioni da indagare. Di seguito (TABELLA 1) viene
riportata la traccia utilizzata per svolgere le
interviste inerenti a questa ricerca.
TABELLA 1
Traccia dell’intervista
PRIMO NUCLEO TEMATICO: Contestualizzazione
dell’intervista.OBIETTIVO: Inserire l’intervista in un chiaro contesto
in relazione ad alcune caratteristiche
dell’intervistato, come possono essere età, titolo di
studio, attuale occupazione ecc.TEMI TRATTATI: Età, titolo di studio, impegno
professionale, numero dei figli ed età degli stessi,
numero di computer e tipo di connessione alla reteSECONDO NUCLEO TEMATICO: L’uso che generalmente viene
fatto del computer e Internet in famiglia.OBIETTIVO: Far emergere da una libera esposizione
dell’intervistato l’uso che si fa, a grandi linee, del
computer a casa sua.TEMI TRATTATI: Uso generale del computer e di Internet
in famiglia e da parte dei diversi membri, descrizione
delle attività svolte davanti allo schermo
TERZO NUCLEO TEMATICO: Tempo di utilizzo del computer.OBIETTIVO: Individuare i diversi usi di Internet e del
50
computer in famiglia anche in relazione al tempo che
ognuno vi dedica.TEMI TRATTATI: Numero di ore al giorno o alla
settimana che si utilizzano il PC
QUARTO NUCLEO TEMATICO: Internet per comunicare.OBIETTIVO: Determinare se Internet viene visto anche
(o soprattutto) come un mezzo di comunicazione e di
scambio.TEMI TRATTATI: Presenza di iscrizioni al social
network in famiglia, presenza di indirizzi e-mail,
utilizzo di software di comunicazione (es. Skype)
QUINTO NUCLEO TEMATICO: Chi filtra e controlla
l’utilizzo del computer e di Internet.OBIETTIVO: Far emergere le dinamiche presenti
all’interno della famiglia riguardo i filtri e il
controllo dell’accesso a Internet.TEMI TRATTATI: Creazione di diversi profili per i
diversi membri della famiglia, creazione di password o
limitazioni orarie, posizione del computer in casa,
possibilità di fare acquisti onlineSESTO NUCLEO TEMATICO: La scuola e l’utilizzo del
computer e di InternetOBIETTIVO: Comprendere se e come la scuola richieda
l’utilizzo di questo strumento tecnologico fuori
dall’orario di lezione.TEMI TRATTATI: Richieste degli insegnanti riguardo al
51
computer, consapevolezza dei genitori riguardo ad un
utilizzo scolastico del PC
3.2 I l campionamento
Il primo problema pratico che si è presentato è
stato quello del campionamento, ovvero del chi
intervistare. Nella fase di campionamento non è
richiesta una procedura rigidamente formalizzata, ma
deve essere garantita una certa casualità.
Innanzitutto è importante definire il target di
questa ricerca, poiché solo dopo aver fatto questo
passo si può passare alla scelta vera e propria di
partecipanti. Dopo un’attenta analisi dei temi da
analizzare, si è giunti alla conclusione che i
partecipanti alla ricerca dovessero avere come
requisito fondamentale quello di essere genitori di
almeno un figlio adolescente, in età compresa fra i
sedici e i diciotto anni. La scelta di prendere in
considerazione proprio questa fascia d’età è stata
dettata dal fatto che i ragazzi che na fanno parte
hanno, nella maggior parte dei casi, una buona
conoscenza dello strumento e una certa indipendenza
nell’utilizzo dello stesso. In questo modo è stato
possibile indagare le dinamiche che si creano attorno
52
all’utilizzo della rete all’interno di famiglie che
possiedono, almeno in linea teorica, i “mezzi” per
poter utilizzarla al pieno delle sue funzionalità. Con
il termine “mezzi” intendo indicare, come già detto
sopra, la vasta competenza che hanno i ragazzi in
merito al computer e a Internet, competenza che supera
molte quella degli stessi genitori.
Per creare il campione utile a questa ricerca ho
deciso di utilizzare un procedimento a palla di neve.
La peculiarità di questo processo è quella per cui
«vengono intervistate persone via via contattate su
indicazione delle persone precedentemente intervistate.
Questo metodo agevola l’individuazione degli
interlocutori, ma comporta il rischio di permanere
all’interno di gruppi di persone affini» (Loda, 2008:
194)
Per aggirare il rischio esposto da Loda (2008) ho
deciso di utilizzare una doppia linea di contatti, in
modo da non focalizzarmi solo su un gruppo di persone.
In questo modo c’era si il rischio che mi venissero
indicate persone con caratteristiche simili, ma
seguendo due linee di indicazioni è stato possibile
individuare un gruppo abbastanza eterogeneo di
partecipanti.
53
3.3 La trascr iz ione del le interv iste
Un passo fondamentale all’interno della ricerca
risulta essere quello della trascrizione delle
interviste. È buona pratica, se la persona
intervistata lo concede, quella di registrare o
videoregistrare tutte le interviste. In questa maniera
il ricercatore non perde neanche un passaggio della
conversazione e può osservare in modo accurato quella
che è la comunicazione non verbale dell’interlocutore,
cosa che non sarebbe possibile se fosse impegnato a
prendere appunti.
Tutte le interviste da me svolte sono state
registrate e poi trascritte. È importante avere
l’accortezza di non lasciar passare troppo tempo fra
lo svolgimento del colloquio e la sbobinatura, in modo
che il ricordo di tutti i particolari sia ancora vivo
nella mente dell’intervistatore. Alcuni manuali, come
ad esempio quello di Milani e Pegoraro (2011), mettono
i ricercatori davanti a un bivio: se trascrivere solo
le parti strettamente inerenti al contenuto o se
traslitterare il testo integrale della conversazione.
Per questa ricerca, visto l’esiguo numero di
interviste, si è scelto di trascrivere tutto il testo.
54
La trascrizione dei colloqui risulta essere il
passaggio più dispendioso in termini di tempo della
ricerca, poiché il testo scritto deve essere la copia
perfetta della registrazione audio. È fondamentale che
tutto venga trascritto nei minimi dettagli, comprese
le pause, le incertezze e gli errori (sia grammaticali
che di sintassi), per fare in modo che chi legge possa
comprendere il clima dell’intervista.
Come si è detto prima, la trascrizione richiede
molto tempo, ma è necessario che venga fatta dalla
persona che ha svolto l’intervista, perché
«ha avuto un contatto diretto con l’intervistato e può
[…] fornire un quadro più articolato e completo
possibile degli aspetti verbali e non verbali del
colloquio» (Milani e Pegoraro, 2011: 72)
Sul mercato esistono dei programmi che possono
aiutare nel corso di questo lavoro ma non sostituire
la mano del ricercatore, poiché quest’ultimo deve
comunque integrare le informazioni orali con quelle
non verbali.
La trascrizione delle interviste è stata inserita
all’interno di tabelle strutturate in modo tale da
rendere il lavoro di analisi più snello e chiaro anche
55
a chi non ha partecipato attivamente alla ricerca. Un
esempio è presente nella TABELLA 2.
TABELLA 2
Esempio di griglia per la trascrizione
Nr
.
Inizi
ale
Testo intervista Analisi
1
Analisi
235.
S. E… che tipo di uso… di usodi Internet fate qui? Perlavoro, per scuola, perFacebook, per giochi… più omeno da dir… da descrivermiun po’…
36.
H. Allora guarda… l’uso che nefaccio io a casa è minimo,perché lavorando tutto ilgiorno… tutta la mattina,naturalmente, sul computer…poi, cioè, non c’ho proprio…voglia... di venire a casa eriaccendere…
56
3.4 L ’anal is i del le interv iste
Il passaggio più importante e impegnativo di un
lavoro di ricerca risulta sicuramente essere quello
dell’analisi. Questo procedimento richiede al
ricercatore di conoscere bene il disegno di ricerca e
di avere ben presente quali sono i temi da indagare,
poiché deve trarre dalle interviste le informazioni
utili per rispondere in maniera esauriente a quella
che è la domanda di ricerca.
Il primo passo è sicuramente quello di leggere e
rileggere i testi delle interviste, in modo da
comprendere appieno le informazioni forniteci
dell’intervistato. Questa lettura approfondita serve
al ricercatore anche per individuare all’interno del
testo le affermazioni significative rispetto al
fenomeno (Mortari, 2007).
Una volta che si sono individuate e sottolineate nel
testo le unità significative è necessario fare un
riassunto delle stesse, in modo da renderne chiaro il
contenuto senza dover cercarlo nelle parole
dell’interlocutore. Questo tipo di lavoro prende il
nome di “analisi 1”. Un esempio è riportato nella
TABELLA 3.
TABELLA 3
57
Esempio di analisi 1
Nr
.
Inizi
ale
Testo intervista Analisi
1
Analisi
235. S. E… che tipo di uso… di uso
di Internet fate qui? Perlavoro, per scuola, perFacebook, per giochi… più omeno da dir… da descrivermiun po’…
36. H. Allora guarda… l’uso che nefaccio io a casa è minimo,perché lavorando tutto ilgiorno… tutta la mattina,naturalmente, sul computer…poi, cioè, non c’ho proprio…voglia... di venire a casa eriaccendere…
Uso minimoperchéutilizzatomolto allavoro
37. S. Decisamente…38. H. Quindi… addirittura non
guardo neanche le mail e èmio marito che mi dice:“Guarda che ti è arrivatauna mail”… magari, poi, dopoquindici giorni vado avedere… ehm… però… ecco, ioveramente minimo, insomma…lo uso per tenere un po’ lacontabilità, così di… di miomarito che c’ha un’aziendaartigianale.. però, proprio…ecco… essendo anche proprio…eh… anche questa gestionecontabile è abbastanzaminima… lo userò ‘na volta…insomma, ogni quindicigiorni anche per lui…
Il maritoricorda dicontrollarela mail.Contabilità
Il passaggio successivo è quello di raggruppare le
unità con contenuto simile in grappoli di significato.
Solitamente questi “macro-contenitori” fanno
riferimento ai vari nuclei tematici della traccia e
servono al ricercatore per creare ordine all’interno
58
dei colloqui e per capire quanto siano state
approfondite le varie tematiche da lui indagate. Nella
TABELLA 4 è riportato un esempio della prima parte
dell’analisi 2.
TABELLA 4
Esempio della prima parte di analisi 2
Nr
.
Inizi
ale
Testo intervista Analisi
1
Analisi
235. S. E… che tipo di uso… di uso
di Internet fate qui? Perlavoro, per scuola, perFacebook, per giochi… più omeno da dir… da descrivermiun po’…
36. H. Allora guarda… l’uso che nefaccio io a casa è minimo,perché lavorando tutto ilgiorno… tutta la mattina,naturalmente, sul computer…poi, cioè, non c’ho proprio…voglia... di venire a casa eriaccendere…
Uso minimoperchéutilizzatomolto allavoro
Uso delPC / genitori
37. S. Decisamente…38. H. Quindi… addirittura non
guardo neanche le mail e èmio marito che mi dice:“Guarda che ti è arrivatauna mail”… magari, poi, dopoquindici giorni vado avedere… ehm… però… ecco, ioveramente minimo, insomma…lo uso per tenere un po’ lacontabilità, così di… di miomarito che c’ha un’aziendaartigianale.. però, proprio…ecco… essendo anche proprio…eh… anche questa gestionecontabile è abbastanzaminima… lo userò ‘na volta…insomma, ogni quindicigiorni anche per lui…
Il maritoricorda dicontrollarela mail.Contabilità
Uso delPC / genitori
59
L’ultimo passaggio da svolgere all’interno del
processo di analisi delle interviste è quello di
qualificare la macro-categorie di significato, in modo
da creare delle sotto-categorie. Quest’azione ha lo
scopo di creare una prima ossatura utile alla
restituzione dei risultati, ma anche quello di
approfondire il contenuto delle macro-categorie: è una
sorta di via di mezzo fra l’analisi 1 e la prima parte
dell’analisi 2. Al ricercatore è molto utile
quest’ultima fase, poiché si può fare una chiara idea
di quelli che sono i contenuti e può subito
comprendere se ha individuato tutte le informazioni
necessarie per rispondere alla domanda di ricerca.
Nella TABELLA 5 è riportato un esempio della seconda
parte dell’analisi 2.
TABELLA 5
Esempio della seconda parte di analisi 2
Nr
.
Inizi
ale
Testo intervista Analisi
1
Analisi
235. S. E… che tipo di uso… di uso
di Internet fate qui? Perlavoro, per scuola, perFacebook, per giochi… più omeno da dir… da descrivermiun po’…
36. H. Allora guarda… l’uso che nefaccio io a casa è minimo,perché lavorando tutto il
Uso minimoperchéutilizzato
Usolimitatodel PC /
60
giorno… tutta la mattina,naturalmente, sul computer…poi, cioè, non c’ho proprio…voglia... di venire a casa eriaccendere…
molto allavoro
genitori
37. S. Decisamente…38. H. Quindi… addirittura non
guardo neanche le mail e èmio marito che mi dice:“Guarda che ti è arrivatauna mail”… magari, poi, dopoquindici giorni vado avedere… ehm… però… ecco, ioveramente minimo, insomma…lo uso per tenere un po’ lacontabilità, così di… di miomarito che c’ha un’aziendaartigianale.. però, proprio…ecco… essendo anche proprio…eh… anche questa gestionecontabile è abbastanzaminima… lo userò ‘na volta…insomma, ogni quindicigiorni anche per lui…
Il maritoricorda dicontrollarela mail.Contabilità
Usolimitatodel PC /
genitoriUso
lavorativodel PC /
genitori
Solo al termine del lungo processo di analisi è
possibile individuare se ci sono delle strutture
invariate e ricorrenti e procedere quindi con la
presentazione dei risultati, che dovrebbero dare una
risposta (o almeno aprire delle nuove questioni)
riguardo alla domanda di ricerca.
61
4. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
4.1 Uso di Internet
Dall’analisi delle interviste emerge che indagare il
tipo di utilizzo di Internet che viene fatto in
famiglia è fondamentale per comprendere al meglio
tutti gli altri aspetti della ricerca, come ad esempio
il tema del governo del PC o quello delle opinioni
sullo stesso.
4.1 .1 Capaci tà d i uso de l PC
Per iniziare a dare un senso ai dati emersi
dall’analisi, è importante puntualizzare i livelli di
competenza che possiedono sia i genitori che i figli
in merito al computer.
Innanzitutto, si può notare come dalle interviste
affiorino dei livelli di capacità molto differenti fra
loro, soprattutto in riferimento agli adulti. Come
accennato nel primo capitolo (§ 1.3), queste
63
discrepanze possono essere dovute al diverso status
socio-economico dell’intervistato oppure al diverso
livello di istruzione. Una dimostrazione di questo è
possibile ricavarla dalle informazioni fornitemi
all’inizio di ogni intervista: nel piccolo campione
intervistato, il direttore di banca possiede delle
competenze nettamente superiori a quelle della
casalinga o a quelle dell’esercente. Questa differenza
a livello di abilità è riscontrabile anche all’interno
delle famiglie stesse, dove un genitore è esperto e
l’altro quasi totalmente privo di esperienza: proprio
il direttore di banca afferma che la figlia di sette
anni naviga in Internet meglio della mamma. Questa
conclusione non può sicuramente essere generalizzata,
perché ho potuto rilevare che anche delle semplici
impiegate possiedono delle buone capacità
informatiche.
In ogni caso appare chiaro che in sei famiglie su
sette sono i figli i maggiori esperti in ambito
informatico. Le competenze dei ragazzi non si fermano
solo al saper fare e gestire le funzionalità di base,
ma utilizzano il computer e la rete in modo esperto.
Genitore 2: Il G. ieri mi diceva: “Guarda che ho aperto
il server di questo gioco”… cioè, non… non passano più
64
per… come dirti, tecnicamente… per una serie di computer,
ma accedono direttamente al server principale.
Genitore 4: R. è bravo perché comunque ha fatto già
quattro esami per il passaporto europeo…
Un ulteriore punto su cui soffermare l’attenzione è
quello relativo al grado di competenze dei figli in
relazione a quello dei genitori. È possibile
osservare, infatti, che nelle famiglie in cui i
genitori hanno buone competenze informatiche, i
ragazzi possiedono delle capacità superiori a quelle
dei coetanei. Anche questa informazione è ricavabile
da un’analisi approfondita delle interviste: infatti,
comparando il titolo di studio e l’ambito lavorativo
dei genitori alle competenze dei figli risulta chiara
la correlazioni fra questi due aspetti. Il genitore
che fa il direttore di banca e usa in maniera esperta
il PC, ha un figlio che riesce ad accedere
direttamente ai server dei giochi e programmare delle
pagine in html; la mamma che fa la casalinga e usa il
computer in modo grossolano ha una figlia che lo usa
solo per operazioni molto semplici. Questa
peculiarità, può essere dovuta al tipo di
socializzazione al computer che essi hanno avuto.
Quando il genitore è competente risulta essere in
65
primo luogo egli stesso a introdurre il computer nella
vita famigliare, cosa che invece non avviene quando i
genitori non possiedono le abilità adatte.
Genitore 3: Io ero negatissima… non avevo mai fatto un
corso di informatica in vita mia e quindi… abbiam detto:
“Lo userai tu”… poi, chiaramente devi adeguarti…
Genitore 2: … il primo che ha insegnato son stato io…
4.1 .2 Tempi d ’ut i l i zzo
Conoscere quanto tempo le persone passano davanti
allo schermo è importante per capire che genere di
rapporto hanno con le strumento.
È scontato che la categoria che lo utilizza
maggiormente è quella dei ragazzi, ma fanno
un’eccezione quei genitori che utilizzano questo
apparecchio come mezzo principale per il loro lavoro
(es. impiegate). Dalle interviste emergono, però,
delle notevoli differenze, poiché si va da un minimo
di un’ora al giorno ad un massimo di più di quattro
ore. Come è possibile notare dall’analisi, i figli
maschi risultano essere coloro che fanno un uso più
frequente della rete e per periodi più prolungati.
66
È importante analizzare anche il tempo che i
genitori passando davanti al computer, poiché anche in
questa categoria ci sono numerose differenze.
Escludendo dall’osservazioni il tempo che vi passano
obbligatoriamente per questioni lavorative, emergono
due aspetti abbastanza esplicativi. Il primo è quello
che se una persona svolge la sua attività lavorativa
prevalentemente con il PC, quando arriva a casa ha un
vero e proprio rifiuto per tale strumento
Genitore 2: io sul lavoro lo uso tantissimo [il
computer], per motivi di lavoro… e casa ho un po’
un’ostilità ad accendere il computer…
Genitore 4: io, guarda… ne ho già abbastanza… fra lavoro,
perché io comunque lavoro sul computer… eh…
Il secondo aspetto riguarda i tempi di utilizzo veri
e propri. È possibile notare dall’analisi delle
interviste che i genitori che utilizzano di più la
rete in ambito domestico sono quelli che hanno
imparato in maniera autonoma ad utilizzare lo
strumento. Bisogna, inoltre, sottolineare che le
motivazioni che stanno alle spalle di questo
sperimentarsi sono legate soprattutto all’informazione
su temi di interesse, come ad esempio la ricerca di
67
gare sportive, oppure alla voglia di contatti che si
esplicita con l’utilizzo di alcuni social network.
4.1 .3 Uso soc iale
Quando parlo di uso sociale del computer e della
rete, intendo raggruppare in questa categoria tutti i
diversi utilizzi legati alla comunicazione virtuale
(sia sincrona che asincrona) e alla ricerca di
contatti, sia attraverso l’indirizzo di posta
elettronica che attraverso l’utilizzo di social
network quali Facebook e Twitter.
Quest’ultimo fenomeno risulta essere molto esteso,
poiché in tutte le famiglie che ho intervistato esiste
un accesso alla piattaforma Facebook. Bisogna
sottolineare che in una di esse, la connessione non
avveniva tramite un profilo personale, ma attraverso
quello di un amico che aveva fornito la password. È
lecito pensare che gli iscritti a questo social
network siano principalmente i ragazzi, ma questa
credenza si è rivelata sbagliata, poiché in quattro
famiglie su sette i maggiori utilizzatori di Facebook
si sono rivelati i genitori.
68
Genitore 2: Io lo uso [Facebook] perché avendo a che faretanto coi ragazzi, ehm… è abbastanza normale…
Genitore 2: Mia moglie non ha un accesso a Facebook ma
entra con il mio [profilo]…
Genitore 6: Anch’io vedo che ci son stati all’inizio…
all’inizio anch’io andavo spesso [su Facebook]…
Alcuni genitori che possiedono un profilo personale
hanno affermato che utilizzano questo strumento per
controllare i figli, per vedere cosa pubblicano e che
genere di amicizie hanno. Facebook risulta essere il
social network che riscuote più successo, perchè solo
in due famiglie risultano essere attive delle
iscrizioni ad altri social come Twitter e Google+ e in
un caso non è ancora stato capito appieno il loro
funzionamento.
Un altro strumento di comunicazione presente
praticamente in tutte le famiglie risulta essere l’e-
mail; molte volte all’interno dello stesso nucleo è
presente più di un indirizzo. Solo in un caso
l’intervistato mi ha detto che la sua famiglia non
possedeva un recapito di posta elettronica, ma ha poi
affermato che entrambi i figli erano iscritti a
Facebook, social in cui è necessario possedere una
casella e-mail. La mail viene usata per le cose più
69
svariate, come ad esempio per scambiarsi i compiti,
per questioni lavorative, per scambiare informazioni
con gli altri membri di un gruppo, per ricevere delle
newsletter o per iscriversi a dei siti Internet.
Un ultimo mezzo di comunicazione virtuale è Skype.
Questo software risulta essere molto conosciuto da
quelle persone che devono mantenere dei contatti con
l’estero, perché permette di chiamare in maniera
gratuita. Viene utilizzato principalmente dai ragazzi,
ma dall’analisi delle interviste non risulta avere
grande diffusione, se non in quelle famiglie che
possiedono già delle alte competenze informatiche.
4.1 .4 Uso ludico
Con il termine uso ludico si vuole indicare quella
categoria di attività che vengono svolte davanti al
computer per puro divertimento o passatempo. Questo
genere di attività risulta essere quello svolto
maggiormente in tutte le famiglie da me intervistate.
I giochi, sia online che non, sono l’attività più
svolta in assoluto dai ragazzi. Dalle interviste è
emerso che i giochi svolti al PC sono numerosi e
differenti in relazione all’età dei soggetti e al
genere.
70
I maschi in età adolescenziale risultano essere
orientati maggiormente verso i giochi di ruolo che
trattano di guerra, come ad esempio “Call of Duty” o
“Habbo”, o verso le versioni online dei giochi che
svolgono abitualmente nelle realtà, come ad esempio
“Pokemon”. In molti casi questi giochi richiedono la
presenza sincrona di molti utenti, poiché per
combattere o per giocare una partita devono esserci
almeno due partecipanti connessi tramite due computer
diversi.
Genitore 2: Gioca in compagnia, della sua classe in
realtà… della scuola… si trovano, magari ‘na volta al
mese nelle case di… di… fra di loro… Si trovano anche
fuori dalla rete, però si collegano [per giocare]…
Genitore 5: Giocano con la Playstation su Internet,
perché si collegano con i suoi compagni…
Diversa è la situazione per le ragazze della stessa
età, che non sembrano interessate a questo aspetto
della rete, se non per dei giochi promossi da
Facebook, come “Cityville” o “Fruit Ninja”.
La differenza di genere si annulla nei giochi svolti
dai ragazzi che frequentano medie ed elementari,
poiché non ci sono grandi differenze fra maschi e
femmine di quest’età. Le attività ludiche che svolgono
71
davanti allo schermo sono legate soprattutto alla
cucina virtuale, al colorare online e al completare
percorsi in stile “Pacman”.
I passatempi online dei genitori risultano essere
legati soprattutto alle passioni degli stessi, come ad
esempio ricercare ricette, visitare pagine di cantanti
o confrontare i prezzi di capi d’abbigliamento e
oggettistica. Altre attività svolte davanti allo
schermo sono legate ad alcune attività che prima
venivano fatte in maniera manuale, come archiviare e
sistemare foto.
Un aspetto che mi è stato difficile indagare è
quello relativo al download di film e musica dalla
rete, poiché essendo considerata un’azione illegale
non mi veniva fornite informazioni in merito. Solo una
famiglia ha affermato che il figlio fa questo uso del
computer, mentre un’altra ha affermato che le figlie
non scaricano assolutamente nulla, perché si fanno
passare film e musica da un amico. Inoltre, un
genitore ha espresso un’opinione contraria a questi
tipo di pratiche.Genitore 2: La mia rabbia è che scaricano programmi su
programmi…
Un’ultima attività che ho catalogato come ludica è
quella degli acquisti online. Questo è risultato un
72
aspetto molto importante da indagare, poiché fornisce
delle informazioni su delle credenze implicite degli
intervistati. Innanzitutto sapere se una persona fa
degli acquisti online ci fa comprendere il grado di
fiducia che ha della rete e dall’analisi appare chiaro
che chi possiede delle competenze informatiche
migliori è anche colui che effettua maggiormente
acquisti da Internet. Inoltre, la possibilità o meno
dei figli di compiere questo genere di acquisti ci da
delle indicazioni sul tipo di controllo che i genitori
hanno nei confronti della rete, ma questa tematica
verrà approfondita successivamente (§ 4.2). È
importante, però, spiegare che questa attività è stata
classificata come ludica perché lo shopping, virtuale
o reale che sia, rimane in ogni caso un’operazione
divertente. Dalle interviste risulta che quasi tutte
le famiglie hanno effettuato almeno un acquisto dalla
rete e nella maggior parte dei casi se ne sono
occupati i genitori. L’unica famiglia che non ha
effettuato compere online si è però informata su come
funziona e ha visitato i siti che svolgono questo
servizio per confrontare i prezzi.
4.1 .5 Uso informativo e scolast i co
73
Ulteriori utilizzi che vengono fatti del computer
sono strettamente legati alle richieste scolastiche,
alla voglia di informazione e allo svolgimento
dell’attività lavorativa.
La scuola richiede l’utilizzo del computer e della
rete, ma in misura molto ridotta. L’attività più
richiesta è sicuramente quella di fare delle ricerche
riguardo ad alcuni argomenti trattati in classe o per
approfondirli. Molti genitori mi hanno sottolineato
come la scuola chieda sempre meno di utilizzare il PC,
al punto da non svolgere nemmeno le ore curricolari di
informatica.
Genitore 1: Perché, addirittura, la C. l’anno scorso alle
medie mi diceva che… non mi ricordo chi era il prof., se
era la… la RS. o chi era… che comunque, diceva che aveva
computer, ma che comunque non l’avevano fatto, allora
aveva dato un voto anche così, senza…
Genitore 2: Forse col VZ. quando era a scuola lo
chiedevano di più… eh, su G., un po’ forse perché si sono
accorti che è un po’ togliere, ehm… stimoli, perchè poi
fanno proprio taglia-incolla di brutto, ecco…
Intervistatrice: E… li hai mai visti usare Internet per
scuola oltre che per la patente, come mi hai detto…
Genitore 5: No…
74
Solo una scuola media richiede un utilizzo costante
della rete, poiché i compiti per casa vengono inviati
tramite mail.
Il computer diviene fondamentale quando si passa ai
gradi di istruzione universitaria, dove l’accesso alla
rete è indispensabile perché la maggior parte delle
informazioni e del materiale sono disponibili solo
online.
È importante notare come la maggior parte delle
persone intervistate ha affermato di aver acquistato
il computer perché la scuola lo richiedeva, ma come in
realtà l’uso per questioni scolastiche sia nettamente
limitato.
Un’attività comune a molti genitori, invece, è
quella di ricercare informazioni su temi di loro
interesse, cosa che risulta inesistente nell’utilizzo
dei ragazzi. I temi più indagati sono quelli relativi
allo sport, al gossip o a informazioni sanitarie.
Genitore 1: Due anni fa mi era venuto il male alla
cervicale, allora sai là, ti trovi a cercare ernia, ti
viene fuori di tutto…
Genitore 6: [I marito visita siti che riguardano] varie
gare di alpinismo piuttosto che… d’estate, insomma, di
mountain bike… e poi, va bè, i siti… noi siamo
75
appassionati di moto da strada… quindi i siti, comunque,
che parlano di moto…
Molti adulti, inoltre, utilizzano il computer per
leggere quotidiani o cercare delle notizie. Una
particolarità di questa attività è che viene svolta
anche da persone che sono alla prime armi con il PC.
Un genitore afferma che il figlio inizia a
interessarsi alla lettura di quotidiani online, ma è
l’unico caso rilevato nel corso delle interviste.
4.2 Gestione “famigl iare” del computer e
consapevolezza dei genitori
Dall’analisi delle interviste sono emersi diversi
stili di controllo che i genitori adottano nei
confronti dei figli relativamente all’utilizzo del
computer. L’ obiettivo di questo paragrafo non è
quello di cercare di individuare quale sia lo stile
migliore da adottare, ma è quello di comprendere le
motivazioni dei diversi approcci anche in relazione
alle competenze informatiche dei genitori.
4.2 .1 Governo etero d i ret to
76
Ho scelto di raggruppare nella categoria del governo
etero diretto tutte quelle situazioni in cui è il
genitore a dettare le regole riguardo ai tempi e modi
di utilizzo del computer e della rete da parte dei
figli.
In tutte le famiglie a cui ho rivolto l’intervista
erano presenti due o più figli di età diverse. Il tipo
di controllo relativo alla rete che i genitori mettono
in atto varia al variare dell’età dei figli.
Genitore 7: Posso programmarlo [il computer] per il EF.
in un modo, per esempio, che è più grande, per la FG. in
un altro…
Le strategie adottate dai genitori sono le più
svariate. Il metodo più utilizzato è quello di non
posizionare il computer in camera dei figli, ma di
metterlo in una stanza facilmente controllabile, come
il salotto o la stanza da stiro. È da notare come le
strategie siano più elaborate se il genitore ha una
buona padronanza del mezzo.
Genitore 7: C’è un programmino proprio apposta dove io
posso decidere in quali orari loro possono connettersi,
perciò ho evitato le ore del po-meriggio dove devono
studiare…
77
Questo non significa che un genitore che ha delle
buona abilità relative al computer automaticamente
controlla il figlio e chi non è in grado di utilizzare
questo strumento lascia i figli liberi di navigare a
loro piacimento. La dimostrazione di questo si ha in
un’intervista in cui mi è stato detto che quando il
tecnico ha installato il PC, si è chiesto a lui di
creare il sistema dei profili con diversi accessi a
Internet, perché lei e il marito non sapevano farlo.
Genitore 1: Ognuno la sua casella, così… allora la più
piccola, naturalmente, si va sul suo che non bisogna
andare su Internet… quando ci han messo il computer io hosottolineato “Guarda, per favore, ecco… se hai la
possibilità di.. di fare qualcosa”. Ecco, allora hanno
fatto la password…
I metodi adottati dai genitori non sono sempre
accettati in maniera incontrastata dai figli. Facebook
e i social network sono l’argomento principale su cui
si hanno delle visioni molto diverse. Un esempio
riguarda proprio le richieste da parte dei ragazzi che
frequentano le scuole medie di poter avere un proprio
profilo su Facebook, a cui i genitori si oppongono
categoricamente. Un’ulteriore contrasto riguarda una
tecnologia che ha preso piede nell’ultimo anno: gli
78
smartphone. Alcuni genitori si sono resi conto di come
i figli utilizzino la rete sul cellulare e diventino,
quindi, difficilmente controllabili. Una delle
soluzioni per aggirare questo problema è quello di
ritirare il cellulare in determinati momenti della
giornata.
In conclusione un controllo di tipo etero diretto
deriva principalmente dalla paura che i figli si
imbattano in siti non adatti alla loro età o che vi
passino troppo tempo in maniera incontrollata. Questa
paura è derivata sicuramente dalle numerose notizie
che ci forniscono al riguardo altri media come la
televisione; e i genitori vedono come unica soluzione
a questa problematica quella di controllare in maniera
costante i propri figli.
Genitore 7: Puoi anche escludere tutto quello che riguarda…
che ne so… pornografia, piuttosto che…
Genitore 1: È un buon metodo secondo me, anche per… per
evitare spiacevoli…
4.2 .2 Gest ione mediata
79
Per gestione mediata del computer s’intende quella
strategia di controllo attraverso cui i genitori
patteggiano con i figli i tempi e modi di utilizzo. Le
persone che si affidano a questo tipo di metodo sono
quelle che hanno maggior fiducia nella rete, ma che
hanno sicuramente anche un buon rapporto con i figli.
Un altro elemento importante in questo tipo di governo
riguarda anche le competenze informatiche dei
genitori, poiché si tratta di lasciare ai figli una
sorta di libertà vigilata. È naturale che questo tipo
di controllo viene messo in atto soprattutto con i
figli più grandi, perché si ritiene abbiano una
capacità di discernimento maggiore. Un esempio di
quanto detto è riscontrabile proprio nelle parole di
un’intervistata.
Genitore 1: Mia figlia potrebbe, che ne so, in quella due
ore che io manco, potrebbe fare di tutto e di più, che io
non so niente, perché non so, poi, entrare nella sua…
però, ecco, nei confronti appunto della ragazza grande ho
la massima fiducia, e comunque non ha neanche Facebook…
Questo tipo di strategia non si compone di regole
ferree, ma è fatta di accordi fra le idee dei genitori
e quelle dei ragazzi.
80
Genitore 2: Continuo a dire, casa mia abbiam sempre
cercato di dire ‘sta roba… responsabilità e libertà… cioè
se tu dimostri che le cose che fai le fai con un po’ de
responsabilità, per me puoi anche star su fino alle
undici di sera a giocare sul computer e bon… purché i
risultati alla fine vengano…
Genitore 3: Di solito mi chiedono [di usare il computer]…
anche il grande… No, non mi chiede [il figlio maggiore]…
fa: “Và che vado al computer”, ecco… almeno ti informa…
Un ulteriore elemento importante di questo metodo
riguarda il controllo diretto, che occasionalmente i
genitori mettono in atto.
Genitore 2: A casa mia la regola l’è che ogni tanto io
son lì con lei che navigo… se lei è su Facebook io vedo…
per quanto poco sia, però tuo figlio e tua figlia sa che,
comunque, i tuoi genitori…… qualcosa sanno…
Genitore 6: Anche su Facebook, eh… sono spesso… io ogni
tanto le controllo, perché… c’è J. in linea oppure
spenta…
Nonostante la grande apertura dei genitori che si
affidano a questa strategia, rimangono ancora dei
punti su cui le due parti si trovano in contrasto e
molto spesso riguardano proprio il controllo diretto.
81
Un genitore mi ha riportato l’esempio del figlio che
aveva impostato numerose password all’interno della
rete e poi gli aveva lanciato una sfida.
Genitore 2: Con mio figlio più grande, il VZ… era ben a
15, 16 anni… mi aveva sfidato, perché mi diceva che tanto
io non sarei mai riuscito a beccargli la sua password… …
allora, se uno è un po’ pratico… e io ho degli amici che
sono molto più pratici di me perché fanno gli informatici
di professione, ci sono dei programmi che recuperano le
password… gli ho detto: “La prossima volta la password te
la trovi cambiata”…
Lo stesso genitore mi riporta un altro esempio
relativo all’altro figlio, che ogni volta che utilizza
il computer cancella la cronologia.Genitore 2: Gli dico sempre: “Perché cancelli la
cronologia? Se non hai fatto niente di male, non hai
problemi d cancellarla... Se la cancelli è perchè non ti
fidi di me o perchè hai combinato qualcosa”...
Questo dimostra che, nonostante il fatto che i
ragazzi i cui genitori adottano questa strategia
possono utilizzare il computer in maniera abbastanza
libera, il leggero controllo cui sono sottoposti a
volte può apparire soffocante agli occhi degli stessi,
poiché hanno comunque delle regole-guida a cui
attenersi.
82
4.2 .3 Libero ut i l i zzo
Un ultimo tipo di controllo relativo al computer è
quello libero, in cui i ragazzi possono gestire in
maniera autonoma sia i tempi che i modi di utilizzo.
Nella maggior parte dei casi la scelta di questa
strategia è una scelta obbligata, dovuta alla mancanza
di competenze per controllare i figli quando sono
connessi alla rete. Anche in questo caso non sto
affermando che tutti coloro che non sanno utilizzare
il computer non diano delle regole in merito
all’utilizzo dello stesso.
Dall’analisi delle interviste appaiono due diverse
motivazioni alla scelta di questo tipo di metodo. La
prima è la seguente, riportata con le parole dell’
intervistata.
Genitore 4: Per fortuna che studia… no… per fortuna va a
scuola e lavora, che così non è sempre sul computer…
Intervistatrice: E per fortuna va bene a scuola e quindi
non si può dirgli niente…
Genitore 4: Eh si… eh… effettivamente no… eh… no…
83
La seconda, invece, è proprio il caso a cui facevo
riferimento prima. I genitori non possiedono delle
competenze adeguate a comprendere cosa fanno i figli
al computer. A questa situazione si aggiunge il fatto
che il computer fisso è situato nella camera da letto
dei ragazzi e quest’ultimi non concedono ai genitori
di vedere i siti a cui sono connessi.
Un aspetto sicuramente importante che emerge dalla
due interviste in questione è che in queste due
famiglie ci sono solo figli maschi. Questo fattore può
apparire irrilevante, ma se si analizzano le dinamiche
famigliari anche fuori dalla rete e relative ad altri
aspetti della vita, come per esempio uscire la sera,
si noterà facilmente che ai figli maschi si tende a
concedere una maggiore libertà perché danno l’idea di
essere più autonomi.
All’interno di questa strategia i genitori non sono
partecipi di quello che fanno i figli davanti allo
schermo, se non relativamente a qualche sporadico
racconto relativo a barzellette o a questioni
scolastiche.
Genitore 5: Mi chiama: “Mamma, mamma… vieni a vedere,
vieni a vedere e guarda”… magari c’è una barzelletta…
leggo quella… “Ecco… adesso vai”…
84
4.3 Opinioni sul la rete
Come è possibile vedere dalla traccia di ricerca,
non era stato pensato nessun nucleo tematico relativo
alle opinioni degli intervistati riguardo alla rete o
più in generale, riguardo al computer. Nonostante
questo tutti i partecipanti mi hanno fornito i loro
giudizi al riguardo e mi sembrava fondamentale darvi
peso nell’analisi dei dati, poiché da queste opinioni
è possibile comprendere appieno sia l’uso che viene
fatto dello strumento, sia le motivazioni della
strategia educativa adottata.
4.3 .1 Internet come una piazza o come una perdi ta di
tempo
Dalle interviste emerge che la maggior parte delle
persone ha dei giudizi negativi riguardo al computer e
a Internet.
Molte persone considerano Internet come una piazza,
poiché si riesce a reperire quasi ogni tipo di
informazione. A mio parere, questa idea della rete è
molto legata ai social network, dove sempre più
85
persone pubblicano informazioni riservate della
propria vita privata.Genitore 1: Io vedo anche le mie amiche, così, si mettono
su le foto dei suoi bambini appena nati… a me proprio non
mi piace… che tutti vedono…
Genitore 1: Si sa di tutto, di tutto… perché tu ti trovi,
comunque, a scuriosare i discorsi che fa un'altra…
Genitore 2: Facebook era un po’ la fiera, no? Cioè era un
po’ la piazza…
Genitore 3: Al computer non è che vedi la personalità…
Genitore 6: Tu scrivi una cosa e viene interpretata in
tutta un’altra maniera…
Un secondo modo di vedere Internet in maniera
negativa è legato al fatto che sia una perdita di
tempo. La pensano in questo modo soprattutto le
persone che vi devono passare molto tempo per
questioni lavorative.
Genitore 4: Facebook è soltanto una perdita di tempo…
cioè, può essere una cosa utile… però, io, guarda… ne ho
già abbastanza…
Le opinioni sfavorevoli riguardo al computer e alla
rete variano al variare del tempo che i vari membri
86
della famiglia passano davanti allo schermo. Durante
un colloquio in cui è emerso che le figlie usavano il
PC relativamente poco, per esempio, una partecipante
ha espresso il giudizio che segue riguardo all’uso di
Internet per troppo tempo
Genitore 1: Certo che diventa una dipendenza dopo…
diventa una vera dipendenza…
Un elemento che ha una forte influenza sulla nascita
di queste opinioni è sicuramente il titolo di studio o
l’ambito lavorativo degli intervistati.
Genitore 7 (diploma artistico): [Quando i ragazzi usano
il computer] sono limitati, poi, nel fare le altre cose…
Genitore 4 (impiegata): … per me [il computer] è il
lavoro e mi vien da vomitare…
Un opinione comune che è emersa da quasi tutte le
interviste riguarda l’affidabilità della rete in
riferimento agli acquisti online. Nella metà delle
famiglie intervistate i primi a sperimentarsi negli
acquisti virtuali sono stati i figli e nonostante sia
andato tutto per il meglio, i genitori hanno mantenuto
le loro opinioni negative al riguardo.
87
Genitore 6: A me non piace tanto comprare su Internet…
Genitore 5: No, io non son tanto propensa per ‘sti
acquisti su Internet… non mi fido tanto…
Genitore 4: I ragazzi [hanno comperato] le figurine… le
carte dei Pokemon… loro si… io no perché non mi fido…
In conclusione, è da notare come in quelle famiglie
dove viene adottato uno stile educativo piuttosto
rigido riguardo ai media, e soprattutto al computer,
ci siano delle visioni maggiormente negative di questi
strumenti.
4.3 .2 L ’ut i l i tà d i Internet
Dall’analisi delle interviste non emergono solo
giudizi negativi, poiché Internet e il computer
vengono descritti anche come degli strumenti utili,
soprattutto per quanto riguarda la ricerca di
informazioni, sia scolastiche che legate al tempo
libero.
Genitore 1: Poi anche cose interessanti è, però…
88
Genitore 2: Tante citazioni di studiosi di economia… le
prendi da lì, ma perché è più comodo, senza scriverteli a
mano…
Genitore 4: Per quello è ben comodo…
Genitore 6: In un attimo è fatta una ricerca e anche,
magari, bellina... aggiungendo le im... tutte le immagini
che vuoi...
Come è possibile notare dagli spezzoni di interviste
sopra riportati, all’interno delle stesse
conversazioni ci sono sia opinioni negative che
positive sull’utilizzo del computer. A parer mio,
queste discrepanze non sono dovute al fatto che gli
intervistati non conoscono l’argomento su cui sono
chiamati a esprimersi o sono indecisi al riguardo,
bensì la colpa è di alcuni errati collegamenti di
idee. Il più delle volte, infatti, si collega
involontariamente Internet alle chat, ai social
network o ai giochi online. In questa maniera è più
facile che il commento in merito alla rete sia
negativo. Se però si parla di computer in riferimento
all’ambito scolastico o alla ricerca di notizie, i
giudizi saranno il più delle volte favorevoli verso
questo tipo di utilizzo. Quanto appena detto è
89
riscontrabile anche negli stralci di interviste che ho
riportato sopra.
Bisogna inoltre sottolineare che i giudizi
favorevoli all’uso di Internet sono relativamente
pochi, anche da parte di quelle persona che sostengono
l’utilizzo di questo strumento in famiglia. Questo può
essere dovuto al fatto che solitamente ci si sofferma
sugli aspetti negativi delle cose, perdendo di vista
ciò che può essere un punto di forza della cosa
stessa.
4.3 .3 Internet come supporto ad a l t r i s t rument i
Un aspetto importante da sottolineare riguarda la
visione del computer in relazione ad altri strumenti e
mezzi di comunicazione. Molti dei partecipanti alla
ricerca hanno effettuato un confronto fra il computer
e gli altri dispositivi, mettendo l’accento
soprattutto sulla questione legata al superamento dei
mezzi precedenti. Come afferma Sartori (2000),
l’avvento di una nuova tecnologia non sta a
significare che inevitabilmente quella precedente
andrà a scomparire; e sono di quest’idea anche la
maggior parte delle persone da me intervistate.
90
Genitore 2: Dicevano: “Saranno eliminate le carte”[…]
però… eh… alla fine, qualsiasi documentazione che tu devi
avere, la devi avere o in cartaceo o sul… Devi aver
sempre un supporto…
Genitore 2: Il computer ti fa fare un casino di robe in
più, però alla fine devi comunque avere… anche il vecchio
non lo devi buttar via…
Genitore 3: E poi salvare le fotografie… eh… è importante
il computer… io ti dico… se mi va… io le stampo sempre…
le più belle me le stampo… ho l’album… son proprio
tradizionalista, no?
Genitore 4: Ma è comodo [mandare un SMS]… so che arriva…
e poi mi rispondono e lo vedo subito… per cui, man mano…
perché anche la posta elettronica… è meno comoda che un
SMS, sinceramente…
Come si può notare dagli spezzoni di interviste che
ho riportato sopra, alcune persone affermano che è
giusto affidarsi alla tecnologia più nuova, ma senza
lasciare in disparte o eliminare totalmente quella
precedente. È importante chiedersi, però, se questo
tipo di pensiero è dettato da una vera consapevolezza
verso la questione o se invece deriva da delle scarse
competenze informatiche. A parer mio, sono pochi i
genitori che hanno delle abilità e una conoscenza tale
da poter aver un quadro chiaro in merito a questa
91
situazione, senza cadere nella superficialità di
riportare solo affermazioni sentite da altre fonti.
Un ulteriore aspetto che è emerso da alcune
interviste è l’ampio uso del cellulare da parte dei
ragazzi. Molti genitori lamentano un utilizzo
spropositato di questo strumento, ma non appare chiaro
se sia solo un uso legato all’invio di messaggi o
anche alla navigazione in Internet. Di questa
conoscenza generica dei genitori riguardo
all’argomento ne è presente un esempio in una delle
interviste analizzate. Come si può vedere, la mamma
circoscrive l’utilizzo del cellulare ad un uso di sola
messaggistica, mentre la figlia introduce nel discorso
la tematica della navigazione in rete.
Genitore 1: La più grande usa il cellulare che è una roba
mostruosa… ce l’ha sempre in mano, sempre in mano…
Messaggi, sti famosi messaggi…
Figlia 1: Alla fine hai Internet sul telefono… se vuoi lo
cerchi…
Come detto prima (§ 4.2.1), la questione della
navigazione dal cellulare risulta essere una delle
tematiche su cui i genitori si sentono esclusi, perché
non riescono ad avere un controllo totale dei figli su
questo aspetto.
92
In conclusione il computer viene considerato molte
volte uno strumento di supporto, comodo per svolgere
alcune funzioni, come ad esempio archiviare foto o
gestire dei documenti, ma su cui non bisogna
riversare troppe aspettative.
4.3 .4 Preoccupaz ioni sul l ’u t i l i zzo d i Internet
Riguardo all’utilizzo della rete emergono anche
numerose preoccupazioni da parte dei genitori, per i
motivi più diversi.
Il primo motivo di queste preoccupazioni risulta
sicuramente essere legato alla presenza in rete di
numerosi siti non adatti ai ragazzi.
Genitore 7: Puoi anche escludere tutto quello che
riguarda… che ne so… pornografia, piuttosto che… perciò
gli ho escluso tutti quei nomi un po’… anche perché
capita che il DE., il piccolino, arriva…
In secondo luogo, molti genitori esprimono delle
ansie relative alla loro capacità di controllo, poiché
il più delle volte sono i figli i maggiori esperti di
Internet in famiglia. A sostenere questa affermazione
c’è la questione legata al tipo di socializzazione che
93
è avvenuta riguardo all’uso del computer. Il più delle
volte sono stati i figli i primi a sperimentarsi con
questo nuovo strumento, per poi trasmettere le
competenze apprese ai genitori: una vera e propria
socializzazione alla rovescia (Mead, 1966).
Genitore 1: È più la piccola che insegna al papà
Genitore 4: No, poi ogni tanto… [il marito] parecchio
chiede a R. come fare… se deve fare anche lui… perché,
non so… l’iscrizione alle gare dei pompieri o così… se ha
bisogno, allora chiede a R…
L’ultima motivazione delle preoccupazioni espresse
dai genitori durante le interviste riguarda i figli
più piccoli. Un genitore afferma di essere angosciato
perché la figlia minore vede il computer come la
normalità, poiché tutti in casa lo usano sia per
lavoro che per svago.
Genitore 2: io ho paura per quella più piccolina, invece,
perché, eh… vede già tutto fatto, no?
Per concludere Internet è uno degli elementi che
crea preoccupazione all’interno del nucleo famigliare,
soprattutto in relazione alle limitate competenze
94
informatiche di cui dispongono i genitori per
controllare efficacemente i figli.
4.4 Considerazioni sul l ’ut i l i zzo del computer in
famigl ia
Nel corso delle interviste, molti dei partecipanti
hanno espresso delle considerazioni sull’uso del
computer e della rete all’interno della loro famiglia.
Mi sembra importante dedicarvi un paragrafo, in modo
da avere un quadro completo di quello che è il punto
di vista degli intervistati in riferimento a questo
nuovo strumento che è entrano nella vita quotidiana
della maggior parte delle persone.
Genitore 1: Non siamo una famiglia di… di modernizzati
sul computer... né mamma, né papà, né... né...
Genitore 1: Ecco, puoi dire “L’ho trovata una famiglia
che non lo usa tanto”...
Genitore 2: “Ma… ma abbiamo veramente bisogno di tutte
‘ste… ‘ste connessioni?”… la mia paura è che dopo a forza
di connetterci con tutti, cioè, non ti parli neanche col…
Genitore 2: Quindi c’è preoccupazione… nello stesso tempo
c’è anche un po’, cioè… il mondo va avanti di questo…
95
chiudere le porte, tenerli fuori da questo mondo,
blindare gli accessi a Internet, essere troppo oppressivi
alla fine rischi di creare un emarginato…
Genitore 7: E lei, in queste quattro settimane [senza
computer e cellulare] ha fatto tante di quelle cose che
altrimenti non avrebbe fatto…
Da queste riflessioni emerge che concedere ai
ragazzi di usare Internet è fondamentale affinché si
inseriscano in maniera corretta all’interno del gruppo
dei pari, ma il più delle volte i genitori vedono la
rete come limitante, sia per loro che per i ragazzi
stessi. Questa considerazione deriva dal fatto che il
più delle volte si prende del materiale dalla rete
senza leggerlo in maniera critica e giudicandolo
attendibile a priori, solo perché ce l’ha fornito
Google.
Genitore 7: Se uno lo fa con un certo sentimento va bene…
EF. che prendeva e faceva copia-incolla… non serve a
niente…
Genitore 2: [I professori non affidano più ricerche da
fare in Internet perché] si sono accorti che è un po’
togliere, ehm… stimoli, perchè poi fanno proprio taglia-
incolla di brutto, ecco…
96
Concludendo, alla luce di tutti i dati emersi
dall’analisi delle interviste, il computer viene
considerato uno strumento sicuramente utile e che può
facilitare molti aspetti della vita, ma solo se
utilizzato in maniera critica e responsabile. Un uso
sconsiderato dello stesso porta, secondo i
partecipanti, ad avere una visione distorta sia del
mondo virtuale che di quello fuori dallo schermo.
97
CONCLUSIONI
Leggendo i risultati di questa ricerca, si può
notare come ad alcune tematiche non si è avuta una
risposta chiara, ma come la questione sia invece
rimasta aperta. A parer mio non esiste una soluzione
precisa a queste domande, poiché trattandosi di
tematiche legate al mondo dell’educazione non è
possibile trovare delle leggi generali che regolano il
fenomeno (Mortari, 2007).
Una tematica attualmente aperta è sicuramente quella
relativa alla gestione famigliare del PC. Come si può
notare dall’analisi dei risultati, si possono
individuare i diversi stili di governance, ma non è
assolutamente possibile prevedere come e da parte di
chi verranno messi in atto. Ogni famiglia ha uno suo
modo unico di gestire il rapporto fra i ragazzi e i
media, che fa sicuramente riferimento alla linea
educativa generale adottata con i figli.
Una seconda questione non ancora risolta riguarda
l’utilizzo della rete per adempiere alle richieste
fatte dalla scuola. In quasi tutte le interviste
99
appare che la motivazione principe che ha portato
all’acquisto del computer è che quest’ultimo veniva
espressamente richiesto dell’istituzione scolastica.
Nel momento in cui, però, si va ad approfondire quali
siano le richieste effettive di professori e docenti,
emerge che esse sono relativamente poche, se non
totalmente nulle, e limitate a qualche ricerca di
approfondimento. La domanda che è lecito porsi e a cui
non è stata trovata una risposta è questa: la scuola
ha davvero sollecitato le famiglie, alla fine degli
anni Novanta, ad essere all’avanguardia sul piano
tecnologico? O c’è stata piuttosto un’interpretazione
errata da parte dei genitori di quelle che erano le
reali richieste dei docenti, anche in relazione alla
numerosa pubblicità sull’argomento fatta in quegli
anni?
Un ultimo quesito riguarda il tempo che i ragazzi
passano davanti allo schermo. Ogniqualvolta si parla
con un genitore quest’ultimo si lamenta della grande
quantità di tempo che il figlio passa davanti ai
media, computer o televisione che sia. Anche il questo
caso, se si esamina la questione in profondità si può
vedere che i ragazzi che passano molte ore in rete
sono relativamente pochi e sempre più in diminuzione.
La questione, che è ancora aperta, è la seguente: i
ragazzi passano davvero sempre meno tempo davanti al
100
computer? O questa riduzione in termini di tempo è
dovuta all’avvento dei nuovi cellulari che permettono
di navigare in mobilità, senza essere sottoposti al
diretto controllo dei genitori?
Come si può notare le questioni su cui resta ancora
da discutere sono molte. Appare chiaro, però, che non
mi è possibile determinare una risposta a suddetti
quesiti in questa sede, lasciando quindi ad altri il
piacere di approfondire le tematiche ancora aperte.
101
RINGRAZIAMENTI
Ringrazio l’Università degli Studi di Verona e in
particolar modo la Facoltà di Scienze della
Formazione, che mi ha permesso di acquisire tutte le
competenze necessarie alla stesura di questo lavoro.
Ringrazio di cuore la professoressa Chiara Sità, che
con i suoi consigli, le sue spiegazioni e le sue
correzioni mi ha sostenuta durante tutto il lavoro di
ricerca e di composizione di questo elaborato.
Ringrazio Alessia, che con le sue lezioni e la sua
passione per la materia ha fatto appassionare anche me
alla ricerca qualitativa in ambito educativo.
Ringrazio tutte le persone che hanno dato la loro
disponibilità ad essere intervistate e si sono
prestate ai fini di questa ricerca.
Infine ringrazio tutte quelle persone che con il
loro sostegno, sia morale che economico, hanno fatto
in modo che riuscissi a completare questo percorso di
studi nel migliore dei modi.
102
BIBLIOGRAFIA
ARENDT H. (1987), La vita della mente, Bologna: il Mulino
(ed. or. The life of the Mind, 1978, New York – London:
Harcout Brace Jovanovich)
ATKINSON R. (2002), L’intervista narrativa. Raccontare di sé nella
ricerca formativa, organizzativa, sociale, Milano: Raffaello
Cortina (ed. or. The life story interview. Qualitative Research
Methods, 1998, Thousand Oaks: Sage)
BICHI R. (2007), La conduzione delle interviste nella ricerca sociale,
Roma: Carocci
BIONDA M. L. et al. (1995), I media e la famiglia, in CASETTI
F. (a cura di) (1995), L’ospite fisso. Televisione e mass media
nelle famiglie italiane, Milano: San Paolo
DEWEY J. (1984), Le fonti di una scienza dell’educazione,
Firenze: La Nuova Italia (ed. or. The Sources of a Science of
Education, 1929, New York: Livering Publishing
Corporation)
DEWEY J. (1993), Esperienza ed educazione, Firenze: La Nuova
Italia (ed. or. Experience and Education, 1938, New York:
Macmillan)
105
DI MAGGIO et al. (2004), From Unequal Access to Differentiated Use:
A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality, in
NECKERMAN K. (a cura di) (2004), Social Inequality, New
York: Russel Sage Found
GIANTURCO G. (2005), L’intervista qualitativa. Dal discorso al testo
scritto, Milano: Guerini Scientifica
GUERRESCHI C. (2005), New addictions. Le nuove dipendenze,
Milano: San Paolo Edizioni
GUI M. (2009), Le “competenze digitali”. Le complesse capacità d’uso
dei nuovi media e le disparità nel loro possesso, Napoli: ScriptaWeb
ISTAT (2005), La vita quotidiana dei bambini, Roma: ISTAT
ISTAT (2007), La vita quotidiana nel 2005. Indagine multiscopo
annuale sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana. Anno 2005, Roma:
ISTAT
ISTAT (2010), La vita quotidiana nel 2009. Indagine multiscopo
annuale sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana. Anno 2009, Roma:
ISTAT
LODA M. (2008), Geografia sociale. Storia, teoria e metodi di ricerca;
Roma: Carocci
106
MEAD G. H. (1966), Mente, Sé e Società, Firenze: Giunti
Barbera (ed. or. Mind, Sefl and Society, 1934, Chicago:
University of Chicago Press)
MASTERMAN L. (1997), A scuola di media. Educazione, media e
democrazia nell’Europa degli anni ’90, a cura di RIVOLTELLA P.
C., Brescia: La Scuola
MANTOVANI S., FERRI P. (2006), Bambini e computer. Alla
scoperta delle nuove tecnologie a scuola e in famiglia, Milano: Etas
MILANI P., PEGORARO E. (2011), L’intervista nei contesti socio-
educativi: una guida pratica, Roma: Carocci editore
MORTARI L. (2007), Cultura della ricerca e pedagogia. Prospettive
epistemologiche, Roma: Carocci
MOUSTAKAS C. (1994), Phenomenological Research Methods,
Thousand Oaks: Sage
NIELSEN//NETRATINGS (2002), Il viaggio del bambino in Rete:
itinerari, esperienze, attese. La prima analisi europea sui comportamenti
dei bambini nel web
ORLANDO D. (1997), Metodologia della ricerca pedagogica,
Brescia: La Scuola
POPPER K. (2002), Cattiva maestra televisione, a cura di
BOSETTI G., Venezia: Marsilio
107
RAY M. A. (1994), The Richness of Phenomenology: Philosophic,
Theoretic, and Methodological Concerns, in MORSE J. M. (1994),
Qualitative Research Methods, Thousand Oaks: Sage, pp. 117-
133
RIVOLTELLA P. C. (2001a), Media Education. Modelli, esperienze,
profilo disciplinare, Roma: Carocci
RIVOLTELLA P. C. (2001b), I r@gazzi del web. I preadolescenti e
Internet: una ricerca, Milano: Vita e Pensiero
RIVOLTELLA P. C. (2002), Televisione ed educazione familiare,
in GOZZOLI C. (a cura di) (2002), Linguaggi televisivi e realtà
familiari. Quali spazi d’incontro?, Milano: Unicopli, pp. 195-199
RIVOLTELLA P. C. (2006), Genitori, Media Education, vita
familiare, in «La Famiglia», 238, pp. 49-60
SARTORI G. (2000), Homo videns, Roma: Editori Laterza
SITÁ C. (2009), L’intervista. Dispensa del corso di ricerca educativa,
Verona
TAROZZI M. (a cura di ) (2007), Il governo della tv. Etnografie
del consumo televisivo in contesti domestici, Milano: Franco Angeli
VAN DIJK J. (2005), The deepening divide. Inequality in the
Information Society, London: Sage
108