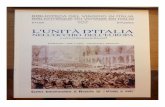Adolescenti stranieri e politiche formative. Pratiche di cittadinanza tra formazione e lavoro -...
Transcript of Adolescenti stranieri e politiche formative. Pratiche di cittadinanza tra formazione e lavoro -...
Adolescenti stranieri e politiche formative. Pratiche di cittadinanza tra formazione e lavoro Mariagrazia Santagati Docente a contratto di Sociologia dell’educazione Università Cattolica di Milano, [email protected] - [email protected] Tel. +39-02-7234-2346) Parole chiave: adolescenti stranieri; politiche formative; formazione professionale; processi di inclusione; educazione alla cittadinanza; transizione al lavoro Abstract La partecipazione al sistema formativo degli allievi stranieri costituisce il presupposto della cittadinanza, ma pone la società italiana di fronte alla necessità di elaborare nuove regole per l’attribuzione dei diritti alle nuove generazioni. In questi ultimi anni, numerose sono state le indagini sociologiche sugli adolescenti stranieri inseriti nel sistema di istruzione, che hanno messo in luce una serie di nodi problematici rispetto all’esperienza formativa, tuttavia, è rimasta ancora limitata l’attenzione della ricerca rispetto alla formazione professionale, sempre più strategica in quanto laboratorio di integrazione e canale per l’assolvimento dell’obbligo formativo, connessa alla fruizione dei diritti sociali di cittadinanza.
A tal proposito, nel paper si presentano i risultati delle attività di indagine (sviluppate grazie ad un assegno di ricerca presso l’Università di Torino) relative ai percorsi degli adolescenti stranieri inseriti nel sistema della formazione professionale della Provincia di Torino: dalla ricerca emergono fragilità degli allievi stranieri, da cui possono derivare rischi di esclusione, e potenzialità di una formazione che riesce a tutelare e promuovere i giovani nei contesti lavorativi, ma soprattutto è funzionale a percorsi di cittadinanza, di assunzione di responsabilità, di scoperta di diritti e doveri da esercitare nel mondo del lavoro e, più in generale, nel contesto sociale. Dal punto di vista delle politiche, si evidenzia il ruolo centrale delle istituzioni formative nel percorso di cittadinizzazione dei giovani stranieri, impegnate nel costruire spazi di cittadinanza, in particolare nel tutelare il diritto allo studio dei giovani stranieri, nel garantire l’accesso alla formazione, nel supportare al raggiungimento di esiti positivi e nell’accompagnare nel delicato passaggio dalla formazione al lavoro.
2
1. Oggetto del contributo. La formazione, presupposto per la cittadinanza delle nuove generazioni Nel contesto attuale, è difficile pensare al significato della cittadinanza senza confrontarsi con il tema delle migrazioni internazionali: se la cittadinanza è definibile come piena appartenenza ad una comunità socio-politica (Marshall, 2002), l’immigrazione mette in discussione il criterio della nazionalità, che non può più essere considerato il filtro esclusivo o più adeguato per definire la titolarità dei diritti di cittadinanza (Zanfrini, 2007). Nel dibattito sul tema, in effetti, la proposta di sganciare i diritti di cittadinanza da un cittadinanza nazionale acquista sempre maggiore rilevanza negli apporti teorici (Kymlicka, 1999; Beck, 2003; Besozzi, 2009).
La presenza di allievi con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico e formativo del nostro paese può essere considerata un’occasione nella direzione dell’investimento nella formazione alla cittadinanza locale/globale dei giovani, ponendo la società italiana di fronte alla necessità di elaborare nuove regole per l’attribuzione dei diritti sociali, civili, politici, in un contesto in cui la legge rende difficile diventare cittadino per chi è nato o ha studiato in Italia sin da bambino (Zincone, 2006). Banks (2008) sostiene, in tal senso, che l’immigrazione comporta un ripensamento della cittadinanza e dell’educazione alla cittadinanza e mette in discussione la concezione assimilazionista, liberale, universale di cittadinanza: l’autore propone di introdurre, a partire dai sistemi di istruzione/formazione, un’idea di “cittadinanza trasformativa e profonda” che aiuti gli studenti ad acquisire prospettive e valori cosmopoliti, conoscenze ed abilità necessarie per promuovere l’uguaglianza e la giustizia sociale, sviluppando una riflessività attorno alle appartenenze culturali, regionali, nazionali e globali, attraverso il confronto tra pari di differenti provenienze culturali.
La formazione costituisce, senza dubbio, un ambito strategico dei processi di inclusione sociale. Per gli adulti può rappresentare un’occasione di riqualificazione e nuova collocazione professionale, assumendo un doppio significato – di tutela e difesa dei diritti in professioni poco qualificate, a garanzia contro lo sfruttamento dei datori di lavoro; ma anche di mezzo di promozione sociale per il miglioramento della qualità e delle condizioni del lavoro (Santagati, 2007) 1 . La cittadinanza può
1 Un’attenzione specifica alla formazione si rileva nel “Piano per l’integrazione nella sicurezza. Identità e incontro” del 10.06.2010, presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Interno e il Miur; nonché nell’“Accordo di integrazione” tra lo straniero e lo Stato, un sistema di regole che consentirà a chi arriva in Italia, rispettando le leggi, un percorso di integrazione a partire dal gennaio 2011. Si tratta di un meccanismo di crediti e punti che potranno essere incrementati nei primi due anni di permanenza in Italia e che poi verranno poi vagliati al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: i crediti potranno
3
funzionare, quindi, come criterio di inclusione in una comunità nazionale, in chiave sia politica che sociale, ma nello stesso tempo, nel caso degli immigrati, appare funzionare come criterio di esclusione, quando si cerca di limitarne o addirittura precluderne l’accesso: ciò accade, soprattutto, in Italia, uno dei paesi europei più restrittivi nella concessione della cittadinanza (Procacci, 2008)2.
Molto rilevanti, dunque, per la fruizione dei diritti possono essere le reali opportunità che la società di accoglienza offre soprattutto alle nuove generazioni: in tempi di crisi economica e di riduzione delle opportunità occupazionali per tutti, diviene ancora più centrale per i giovani stranieri il ruolo della formazione, vero e proprio presupposto di una piena cittadinanza. Per i più giovani, la formazione è la premessa necessaria ed indispensabile per l’inclusione sociale, poiché offre sia opportunità di socializzazione e di sviluppo di capitale sociale, sia occasioni di apprendimento e riuscita (con la maturazione di un proprio capitale culturale), rappresentando la principale chance di mobilità sociale per sé e per la propria famiglia.
D’altro canto, le ricerche e gli studi sugli adolescenti stranieri presenti nel nostro paese mettono in luce una serie di nodi problematici rispetto all’esperienza formativa, quali (Besozzi, Colombo, Santagati, 2009; Colombo E., 2010; Giovannini, 2010; Ricucci, 2010): - l’eterogeneità e la complessità dei percorsi degli adolescenti, in costante aumento nei sistemi di istruzione e formazione, tra cui prevalgono ancora giovani con un’esperienza diretta di migrazione e quindi di migranti di prima generazione; - l’investimento in istruzione da parte degli studenti stranieri, ma anche le notevoli carenze di risorse materiali e relazionali (ad es. lo scarso aiuto e supporto nello studio) nel portare avanti la scelta di conseguire un diploma e di trovare un lavoro adeguato; - l’orientamento verso percorsi brevi e professionalizzanti, anche in presenza di forti motivazioni verso lo studio, confermata dalle difficoltà di proseguire gli studi, concluso il ciclo dell’obbligo; - la canalizzazione formativa, attestata dalla concentrazione delle presenze negli istituti professionali e nella formazione professionale; - gli elevati tassi di ritardo e di abbandono, la notevole dispersione scolastico-formativa e le carriere irregolari; - una diffusa incertezza sul futuro formativo e professionale degli allievi stranieri, che aumentare attraverso l’acquisizione di conoscenze linguistiche e competenze civiche e lo svolgimento di attività come percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio. 2 Dalla comparazione delle politiche europee per l’integrazione, realizzata al fine di calcolare un indice complessivo di integrazione, emerge che l’Italia si colloca al terzultimo posto per i requisiti di idoneità richiesti agli immigrati, considerati particolarmente sfavorevoli (Niessen et al., 2007; Cesareo, 2009).
4
si esprime nel rischio di un’integrazione subalterna e di una segregazione in professioni poco qualificate sul modello dei genitori, cui consegue una mobilità socio-professionale sostanzialmente bloccata, aggravata da un accesso alla cittadinanza ancora limitato3. È opportuno sottolineare inoltre che, in questi ultimi anni, numerose sono state le indagini sociologiche sugli adolescenti stranieri inseriti nel sistema di istruzione (cfr. le più recenti, come ad es. Colombo, Domaneschi, Marchetti, 2009; Ravecca, 2009), tuttavia, è rimasta ancora limitata l’attenzione della ricerca rispetto al mondo della formazione professionale (Besozzi, Colombo, 2007; 2009; Malizia, Pieroni, Santos Fermino, 2008), sempre più strategico in quanto laboratorio di integrazione e canale per l’assolvimento dell’obbligo formativo, connessa alla fruizione dei diritti sociali di cittadinanza per gli stranieri (Ambrosini, 2000).
Tra l’altro, numerosi documenti dell’Unione europea degli ultimi decenni – a partire dal Libro Bianco di Delors (1993) e dal successivo Libro Bianco di Cresson con cui si è avviata la politica dell’istruzione e della formazione dell’Unione (1996) –, affermano la rilevanza dell’istruzione e della formazione, strategiche nella società della conoscenza, al fine di favorire crescita economica, coesione sociale e sviluppo personale, nonché nel consolidare il patrimonio valoriale e culturale alla base della cittadinanza europea. Di recente, la Commissione europea, con la comunicazione “un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020” del 9.6.2010, ha presentato le prospettive per il futuro dell’istruzione e formazione professionale – raccogliendo le riflessioni lanciate nel processo di Copenhagen avviato nel 2002, che ha sostenuto gli Stati membri nella modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale. Nel documento, si è ribadita la necessità di innalzare la qualità della formazione e offrire ai più giovani, con la formazione professionale iniziale, competenze direttamente spendibili nel mercato del lavoro, garantendo maggiori opportunità a gruppi particolarmente svantaggiati (tra cui vengono citati coloro che hanno origine immigrata). Per costruire l’Europa del 2020, la Commissione sostiene, inoltre, che sarà necessario perseguire la priorità di una “crescita intelligente”, sviluppando un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, e una “crescita inclusiva”, promuovendo equità, coesione sociale e cittadinanza attiva, combattendo ad esempio l’emarginazione sociale degli studenti provenienti da un contesto migratorio.
A proposito della questione dei percorsi degli adolescenti stranieri e delle politiche formative, che come sottolineato anche dall’Unione europea rappresentano soggetti
3 Per un approfondimento su tali problematiche, cfr. Nomisma, 2009; Miur, 2009; Santagati, 2009a; Canino, 2010.
5
e azioni strategiche per il futuro della società, si intendono presentare i risultati delle attività di ricerca (sviluppate grazie ad un assegno di ricerca presso l’Università di Torino cofinanziato dalla Provincia di Torino) sul sistema della formazione professionale della Provincia di Torino, nell’ambito dei percorsi della Direttiva Diritto-Dovere e Obbligo di Istruzione e Formazione Professionale, interessato negli ultimi anni dall’ingresso consistente di allievi stranieri. La situazione torinese, tra l’altro, non si discosta da quella nazionale e regionale, sia rispetto alla domanda di istruzione e formazione, sia dal versante dell’offerta formativa, che propone agli adolescenti stranieri e italiani corsi in cui assolvere al diritto-dovere/obbligo formativo, grazie al processo di riforma innescato a partire dalla legge 53/2003 (Scardigno, 2005). Gli ultimi dati del monitoraggio dell’Isfol (2009) riferiscono, per l’a.f. 2007/08, di circa 6.838 corsi di questo tipo, in cui sono stati coinvolti 130.431 giovani, concentrati in particolare in tre regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto), che hanno totalizzato il maggior numero di allievi (oltre il 50% del totale nazionale). Sebbene sia difficile monitorare con esattezza quanti e quali minori stranieri si siano avvicinati a questa proposta formativa, dalle stime dell’Isfol emerge che gli allievi stranieri della formazione professionale supererebbero nel nostro paese circa le 10.000 unità. I giovani stranieri nel sistema formativo della provincia di Torino
Il sistema della formazione professionale della Provincia di Torino, nell’ambito dei corsi per l’assolvimento dell’obbligo/diritto-dovere, è stato interessato da un progressivo aumento dell’utenza straniera.
In particolare, nell’analisi della domanda di formazione degli stranieri, in valori assoluti, gli iscritti alla formazione professionale si attestano su livelli quantitativi di molto inferiori al numero degli iscritti nel canale dell’istruzione: nell’a.f. 2007/08, in totale, il 6,8% dei 14-18enni della Provincia di Torino (ovvero 6035 allievi) e il 12,8% degli adolescenti stranieri (cioè 955 soggetti), inseriti in percorsi di istruzione o formazione, hanno frequentato la formazione professionale. Tuttavia, il tasso di incidenza percentuale degli stranieri, in questo ultimo ambito, è doppio se confrontato con quello riscontrato nelle scuole secondarie di II grado (15,1% nella formazione professionale versus 7,5% nella scuola)4.
4 Nell’a.f. 2008/09 gli allievi stranieri della formazione professionale sono 854 e rappresentano il 15,8% dei corsi dell’obbligo/diritto-dovere (7,3% nell’istruzione secondaria di II grado). La ricerca presentata nel paper è stata svolta nell’a.f. 2007/08 e 2008/09, per tale motivo i dati si riferiscono a tali anni formativi. Per un approfondimento sui dati relativi all’istruzione e agli studenti stranieri, cfr. Osservatorio Istruzione Piemonte, 2009. Tra le varie caratteristiche dell’utenza straniera, si evidenzia una maggiore connotazione al maschile della scelta della formazione professionale tra gli stranieri (il 72,8% sono maschi), mentre un maggior equilibrio di genere caratterizza l’istruzione. Particolarmente numerosi sono i giovani provenienti dalla Romania e dal
6
Tralasciando le differenze in termini di valori assoluti5, la seguente tabella propone
un confronto tra scuole secondarie di II grado e centri di formazione professionale (CFP) con la più alta incidenza percentuale di studenti stranieri: come si evince dai dati, nelle prime dieci scuole superiori sono stranieri circa 20-30 studenti ogni 100 frequentanti, mentre i centri di formazione oscillano da un massimo di incidenza percentuale del 76% ad un minimo del 22%. Tab. I: Classifica delle prime dieci scuole secondarie di II grado e dei CFP della Provincia di Torino per incidenza percentuale di allievi stranieri (a.s. / a.f. 2007/08) Scuole secondarie II grado Incidenza % CFP Incidenza % IPC Boselli (TO) 30,2 Casa di Carità - Città dei ragazzi (TO) 76 IPIA Plana (TO) 26,9 CNOS - Agnelli (TO) 53,0 IPIA Birago (TO) 26,4 IAL - Gheddo (TO) 50,0 IPIA Zerboni (TO) 24,8 CSEA - Mario Enrico (TO) 46,2 IPC Giulio (TO) 24,3 IAL - San Luca (TO) 27,9 ITC Arduino (TO) 23,2 San Carlo - Capello (TO) 26,6 ITC Sommeiller (TO) 21,0 CSEA - Giulio Pastore (TO) 23,38 ITI Avogadro (TO) 20,7 Immaginazione e lavoro - Fontanesi (TO) 23,36 ITI P. Levi (TO) 20,0 CIAC - Cinotto (Valperga Caluso) 22,8 ITC Luxemburg (TO) 19,2 CIOFS - Agnelli (TO) 22,3 Fonte: Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.
I dati confermano, pertanto, come la formazione professionale, dal punto di vista della domanda formativa, proprio per la presenza significativa di stranieri rispetto al totale degli iscritti, rappresenti un’importante opportunità per i giovani stranieri di iniziare e/o di proseguire il proprio percorso formativo in Italia.
Dal versante dell’offerta formativa, invece, è opportuno ricordare che il sistema educativo ridisegnato dal processo di riforma, innescato a partire dalla legge Marocco; si registra, invece, una presenza notevole di peruviani ed albanesi solo nell’istruzione. Piuttosto limitata è la presenza di giovani stranieri nati in Italia (3,7%). A livello di esiti (ammessi/non ammessi agli anni successivi di frequenza, meritevoli/non meritevoli nei corsi annuali con attestati di frequenza, idonei/ non idonei negli esami di qualifica) non vi sono particolari differenze tra italiani e stranieri. 5 In provincia di Torino, vi sono 96 istituti di istruzione secondaria di II grado (50 nella città di Torino e 46 in provincia) e in media ognuno ha circa 850 studenti; esistono anche 45 CFP (18 nel capoluogo e 27 nel resto della provincia), di cui ciascuno è frequentato in media da 140 studenti (nei corsi dell’obbligo). Inoltre, in valori assoluti, il numero più alto di stranieri concentrati nel medesimo istituto superiore è di 529 studenti, mentre la massima presenza numerica di stranieri in un unico centro di formazione professionale è di 69 allievi. Si ribadisce, tuttavia, che dal momento che le differenze quantitative sono determinate soprattutto dall’articolazione istituzionale dell’offerta d’istruzione e formazione, può essere interessante soffermarsi sull’incidenza percentuale degli stranieri nel sistema scolastico e formativo (ovvero sul numero di allievi migranti presenti rapportati al totale della popolazione di un istituto o centro).
7
53/2003, ha trasformato gradualmente la formazione professionale regionale. Attualmente, i corsi finanziati dalla Provincia di Torino dal bando Diritto/dovere all’Istruzione e Formazione Professionale e Obbligo di Istruzione e Formazione Professionale, si dividono nelle seguenti tipologie (cfr. Regione Piemonte, 2005): - percorsi triennali di qualifica, rivolti prioritariamente a quattordicenni in possesso di licenza media; - percorsi biennali, per giovani che abbiano frequentato almeno un anno di serale superiore o che siano in possesso di crediti formativi, maturati in esperienze diverse; - percorsi annuali con attestazione di frequenza, finalizzati al reingresso in un percorso della formazione professionale, dell’apprendistato o dell’istruzione secondaria di II grado.
Gli adolescenti, italiani e stranieri, possono quindi iscriversi a corsi con una durata che varia tra le 800 e le 3150 ore, che rappresentano un ambito in cui i ragazzi possono assolvere al diritto-dovere/obbligo formativo. I percorsi, finalizzati, tra l’altro, all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, sono particolarmente apprezzati dagli adolescenti stranieri, che frequentano i corsi proposti dalla provincia di Torino: la presenza di attività aggiuntive che prevedono sostegni individuali e laboratori di recupero, l’offerta di percorsi destrutturati con funzione di ri-motivazione e ri-orientamento scolastico e professionale, propedeutici al reingresso in contesti scolastico-formativi, l’attivazione di laboratori di lingua italiana e cittadinanza, fa sì che la formazione professionale rappresenti un ambito di accoglienza di adolescenti da poco giunti in Italia, ma che venga anche scelta dai minori stranieri che crescono nel nostro sistema scolastico.
Gli allievi stranieri, nel complesso, sono maggiormente presenti, rispetto agli italiani, nei corsi biennali e annuali di Introduzione ai processi produttivi (IAPP). Minore è la presenza nei percorsi di triennali, al punto che l’incidenza percentuale degli stranieri sale dall’11,2% dei triennali al 19,6% dei biennali al 22,8% dei corsi IAPP (a.f. 2008/09). Gli allievi stranieri sono piuttosto numerosi, a livello di valori assoluti, nei corsi per operatore meccanico ed operatore elettrico; a livello di incidenza percentuale, sono particolarmente presenti nei corsi per operatore dell’abbigliamento, operatore meccanico ed elettronico del moto/autoveicolo, operatore meccanico, operatore dell’alimentazione, operatore impiantista termoidraulico.
8
2. Alcune indicazioni per l’interpretazione dei processi di inclusione dei giovani stranieri in Italia
Prima di passare alla presentazione di alcuni risultati della ricerca, è opportuno precisare che si intende proporre nel paper un’interpretazione multidimensionale dei percorsi degli adolescenti stranieri, combinando fattori strutturali, etnico-culturali, di personal agency (Crul, Vermeulen, 2003)6. Si ritiene, infatti, che l’integrazione possa essere misurata dal livello di libertà di scelta dei figli dell’immigrazione nella formulazione di percorsi non totalmente predestinati, nonché dal grado di autonomia nell’elaborazione dei propri progetti rispetto alla famiglia e alla società di arrivo. Tale processo di integrazione, tra l’altro, non prevede solo le prospettive dell’assimilazionismo e del differenzialismo, dominanti nella letteratura sociologica internazionale, bensì può essere anche plurale, relazionale, aperto e negoziale, in grado di combinare differenze culturali e valori comuni tra migranti e società ricevente, così come emerge dalle ricerche sulle traiettorie degli adolescenti stranieri in Italia (Besozzi, Colombo, Santagati, 2009).
Le nuove generazioni di immigrati rappresentano, senza dubbio, una generazione strategica, i cui progetti possono sfidare modelli e destini predefiniti, sviluppando inconsuete strategie di inclusione, assimilazione o appartenenza multipla; ma si tratta anche una generazione di passaggio, che affronta le difficoltà derivanti dall’iniziale progetto migratorio familiare per consolidare il proprio inserimento nella società di arrivo, mettendo spesso in discussione le aspirazioni dei genitori e le capacità di accoglienza del contesto di immigrazione.
Per quanto riguarda il rapporto con la famiglia, infatti, le traiettorie dei figli si inseriscono all’interno dei progetti familiari sia per portarli a termine sia per contrastarli. La migrazione risulta essere un evento significativo, attorno al quale si ridefiniscono le scelte e i percorsi degli adolescenti, nonché il legame col paese d’origine e i processi d’inserimento nella società ricevente. Senza dubbio, nelle analisi, è necessario considerare la famiglia d’origine non solo come ostacolo all’integrazione ma come risorsa molteplice – di tipo economico, sociale, culturale, valoriale, ecc. – trasmessa dai genitori ai figli, premessa indispensabile per il buon esito dell’inclusione formativa, sociale e professionale, e non solo un’eredità cui ancorarsi, rappresentata da una rigida appartenenza etnica, spesso discriminante nel contesto di arrivo. La migrazione, talvolta, favorisce nei nuclei familiari la maturazione di uno specifico ethos, orientato al sacrificio, al riscatto e alla promozione sociale, tipico di una generazione “di mezzo” che spesso, di fronte al
6 Cfr. l’articolo di Colombo, Santagati (2010), in cui vengono esplicitate alcune indicazioni per ricerche che intendano comprendere e spiegare i processi di inclusione sociale dei giovani stranieri.
9
fallimento dei propri genitori, crede nell’impegno per giungere al successo del proprio progetto personale e familiare.
Oltre a sviluppare un’analisi multidimensionale dei percorsi dei giovani stranieri, si ritiene necessario sottolineare che è importante affrontare lo studio dei processi di inclusione dal punto di vista dei migranti, ma anche delle chance offerte dal sistema di opportunità, grazie a politiche locali e nazionali per l’istruzione, la formazione, il lavoro e la cittadinanza. Si tenga presente che, in Italia e in Europa, i percorsi di integrazione dei giovani immigrati vengono influenzati, in maniera rilevante, dalle politiche nazionali e locali, aspetti piuttosto trascurati dalle ricerche statunitensi che hanno maggiormente enfatizzato la comparazione tra i differenti gruppi etnici, dando per scontato il contesto istituzionale (Crul, Thomson, 2007). L’attenzione alle politiche di intervento in ambito europeo emerge con evidenza, ad. es., dal Green Paper. Migration and mobility: challenges and opportunities for EU Education Systems (Commission of the European Communities, 2008), ma anche da altri documenti recenti (Eurydice, 2009; Nusche, 2009).
Le strategie dei minori stranieri e delle loro famiglie in Italia si intersecano, dunque, con le opportunità di inclusione sociale presenti nei differenti contesti locali, veicolate da politiche finalizzate a rafforzare la coesione sociale e una piena cittadinanza per tutti. In Italia, tuttavia, non vi è né omogeneità né equità nelle possibilità per i giovani nelle diverse aree e settori economici del paese: per tale motivo, i percorsi di integrazione sono particolarmente differenziati e i loro esiti difficili da prevedere, anche se tutte le ricerche evidenziano il ruolo strategico assunto dalla famiglia e dalle istituzioni formative nei percorsi delle nuove generazioni, nonché l’incertezza della transizione tra formazione e lavoro.
Centrali sono, quindi, le opportunità che le istituzioni pubbliche offrono alle nuove generazioni a livello d’istruzione e formazione, nella transizione al mercato del lavoro ed, infine, nell’accesso alla cittadinanza: si ritiene che le dinamiche di inclusione ed esclusione delle nuove generazioni si giocheranno, in prima battuta, a partire dalle opportunità formative e lavorative offerte dal contesto italiano. Sarà anche necessario mettere in relazione la storia migratoria delle famiglie con la questione della cittadinanza, regolata in Italia dal principio dello ius sanguinis, considerando che tale acquisizione sarà una chance determinante per una piena e inclusiva partecipazione sociale e politica dei giovani stranieri.
3. Il percorso metodologico dell’indagine presentata Nell’ambito di questo frame teorico (analisi multidimensionale dei percorsi dei giovani stranieri; studio dei processi di inclusione dal punto di vista dei migranti e del sistema
10
di opportunità), si colloca l’indagine cui si fa riferimento in questo contributo, che si è articolata in due fasi.
In una prima fase, dal 2006 al 2008, è stata realizzata una ricerca di tipo qualitativo, che si è proposta di esplorare percorsi e scelte formative e di vita degli adolescenti stranieri, nell’ambito del sistema della formazione professionale della Provincia di Torino, luogo di passaggio cruciale tra la scuola e il lavoro. Lo scopo dell’indagine è consistito nell’individuare le specificità dell’utenza straniera, al fine di ricostruire le chance di vita (Dahrendorf, 1981), ovvero le reali possibilità dei soggetti di acquisire ciò cui attribuiscono un valore positivo, in relazione ai fattori economici, sociali e culturali che possono influire e orientare i loro processi di scelta. L’indagine ha utilizzato una metodologia di tipo qualitativo, comprendendo: - 36 interviste semi-strutturate con testimoni privilegiati e adulti significativi (responsabili delle agenzie e dei centri di formazione professionali, professori, tutor, genitori, ecc.); - 64 interviste rivolte a adolescenti stranieri residenti nella provincia di Torino e frequentanti i corsi della formazione professionale, differenziati per genere, età, nazionalità, ente di formazione e settore professionale del corso frequentato.
Le interviste si sono poste l’obiettivo di ricostruire il vissuto dei ragazzi, considerando che il loro percorso scolastico e formativo era profondamente intrecciato con l’esperienza migratoria, che ne condizionava la progettualità, le aspettative e le aspirazioni, nonché i percorsi d’inclusione. I temi di indagine hanno riguardato, pertanto, il passato dei giovani intervistati, ovvero il percorso migratorio, scolastico e formativo fino alla scelta della formazione professionale (l’esperienza migratoria, l’istruzione nella scuola italiana e non, le motivazioni della scelta formativa, l’orientamento e il supporto alla scelta, le attese personali e familiari); il presente, ovvero l’esperienza nella formazione professionale (la valutazione del percorso formativo, i significati della formazione/istruzione, le relazioni con compagni e professori); il futuro e, in particolare, le rappresentazioni del lavoro (i progetti, i significati e il valore del lavoro, le difficoltà, le prospettive migratorie).
Successivamente, in seconda fase – dal 2008 ad oggi –, l’itinerario d’indagine ha spostato il proprio focus d’attenzione sulle prassi del sistema formativo, con la realizzazione di un approfondimento sulle iniziative per gli allievi stranieri inseriti nei corsi dell’obbligo/diritto - dovere: attraverso la somministrazione di un questionario strutturato a tutti i centri di formazione della provincia, la ricerca si è focalizzata sulla rilevazione delle pratiche d’integrazione messe in campo dalle agenzie, a favore degli allievi migranti. In particolare, è stato realizzato, per due anni consecutivi, un censimento delle iniziative per allievi stranieri inseriti nei corsi dell’obbligo che, oltre a rilevare dati sulle caratteristiche degli allievi presenti nei corsi attivati da 16 enti e 45 CFP, ha rivolto un’attenzione specifica alle pratiche sviluppate in differenti aree di
11
intervento: l’accoglienza degli allievi stranieri (nell’orientamento in ingresso e all’avvio dei percorsi formativi attivati presso i centri), la relazione tra centri e famiglie straniere, i percorsi di accompagnamento nella transizione al lavoro, il ruolo degli operatori (cfr. Santagati, 2009b).
Dall’analisi dei risultati complessivi delle due fasi d’indagine (qualitativa e quantitativa – attraverso un’analisi del contenuto della documentazione empirica ricavata dalle interviste e un’elaborazione statistica con SPSS dei dati raccolti mediante questionario), sono emerse: alcune caratteristiche dei giovani stranieri inseriti nella formazione professionale, si tratta ovvero di fragilità e potenzialità che limitano o favoriscono il processo di inclusione sociale e la fruizione di diritti di cittadinanza; nonché alcune potenzialità, debolezze e sfide per il sistema formativo, in particolare nel tutelare il diritto allo studio dei giovani stranieri, nell’accesso alla formazione, nel raggiungimento di esiti positivi e nel delicato passaggio dalla formazione al lavoro 7.
4. Una sintesi dei principali risultati di ricerca La partecipazione formativa dei giovani stranieri: fragilità e potenzialità nei percorsi di cittadinizzazione
Nella ricostruzione dei percorsi degli allievi, le narrazioni dei giovani stranieri
inseriti in percorsi di formazione professionale evidenziano, da un lato, alcune fragilità che si possono tramutare in rischi di esclusione e impossibilità di godere appieno dei diritti di cittadinanza sociale connessi alla formazione; dall’altro lato, emergono alcuni punti di forza e potenzialità degli allievi stranieri, che possono rendere realmente la formazione il presupposto della cittadinanza.
Innanzitutto, tra gli stranieri sono presenti fragilità, fattori di debolezza e rischi di esclusione, simili a quelli degli allievi italiani che frequentano la formazione professionale, ma che sono aggravati dalla condizione migratoria di questi giovani e delle loro famiglie, ovvero da un’esperienza che ha ricadute in termini di instabilità e precarietà sulle traiettorie di vita dei giovani, a livello sociale, lavorativo, giuridico, ecc. Le fragilità emergono, in particolar modo: - dalla trasformazione dei centri formativi, in cui sempre più adolescenti stranieri, con molteplici problematiche (familiari, economiche, giuridiche, ecc.), convivono con
7 Nel paragrafo che segue sono riportate alcune riflessioni che saranno oggetto di un’analisi più approfondita durante l’ultima fase delle attività dell’assegno di ricerca (termine giugno 2010), in cui è prevista la pubblicazione di un volume che documenti gli esiti dell’itinerario di ricerca.
12
giovani italiani, definiti a rischio di esclusione, fragili, ribelli e poco motivati, con notevoli difficoltà nella transizione nella vita adulta (Luciano, 2004; 2005); Con i compagni qualche volta litighiamo, sai uno è invidioso dell’altro. Tipo c’è il gruppo di marocchini, c’è gruppo di italiani e io sto con gli italiani, ma magari qualche marocchino viene e parliamo. Ma non siamo mai tutti insieme: il marocchino viene là e dice all’italiano “tu sei così, tu sei così e lo prende in giro”. Stiamo per i fatti nostri e nessuno ascolta gli altri (Albania, M). Io non sono il tipo che va in classe e fa casino. Sono i rumeni in classe da me che fanno casino, parlano in rumeno, fanno sclerare. Abbiamo anche un po’ cioccato, ma siamo amici adesso. Ci vuole solo un po’ per capire come siamo fatti, però poi va bene. A parte che si sono attaccati pure tra loro, due rumeni, come dire non è che sono tanto intelligenti. Perché noi arabi, quando vediamo altri arabi che si attaccano, noi non ci attacchiamo quasi mai tra di noi. Invece i rumeni mi hanno detto che quando vedono un rumeno e un italiano che si picchiano, picchiano il rumeno. Cioè da noi questa cosa qua non esiste: cioè se vediamo due che si picchiano, stiamo dalla parte del nostro paese, capito? I rumeni sono da una parte e gli italiani dall’altra: è che parlano lingue diverse (Tunisia, M). Ho avuto un po’ di problemi qua a scuola. Avevo problemi con marocchini e italiani che mi hanno anche minacciato con i coltelli. Loro se la prendevano con me, anche se stavo tranquillo, anche se non parlavo, mi tiravano pugni e calci. Così ho cambiato scuola. Qua non è come dall’altra parte, ci sono anche più regole. Quando mi sono picchiato fuori da scuola, mi volevano buttare fuori. Poi il direttore ha detto “lasciamolo ancora un po’, vediamo come si comporta”. Ha visto come mi comportavo bene con tutti, ha detto “è migliorato, lo lasciamo in scuola”. Mi ha detto “se succede ancora, è finita”. Speriamo che non succede… Non sono io che voglio fare casino, sono gli altri che mi provocano. Ci sono anche i miei amici che ho fuori che hanno detto “se hai problemi non ti lasciamo” (Romania, M).
- dall’esperienza recente di migrazione vissuta dalla maggioranza degli allievi. Molti tra i giovani sono arrivati in Italia tra la preadolescenza e l’adolescenza, in seguito a ricongiungimenti familiari o da soli, e si sono inseriti negli ultimi anni della scuola media o direttamente nella formazione professionale; In Romania sono arrivato a fare il professionale, un anno fatto e poi sono venuto qua. Qui ho dovuto rifarlo (Romania, M).
Sono in questa scuola soltanto da un mese. In Albania facevo seconda liceo, qui prima biennio… All’inizio è stato difficile, ma adesso va meglio. Un po' già sapevo la lingua (Albania, M). In Colombia, ho fatto fino alle superiori, fino al terzo anno. Prima per l’età e poi perché volevo fare la segretaria… sono venuta qua… Sapevo che quando arrivavo qua, finivo i due anni e poi cercavo un lavoro (Colombia, F). Quando sono arrivato sono stato in una comunità per minori e mi hanno trovato loro questa scuola. Sono da solo: io volevo continuare a studiare, ma loro mi hanno detto che se sei in comunità, devi imparare qualche mestiere, poi quando compi 18 devi continuare la tua vita (Afghanistan, M).
13
- dalle condizioni economiche particolarmente svantaggiate di cui soffrono gli allievi stranieri, cui consegue la necessità di un rapido inserimento nel mondo del lavoro per i giovani (appartengono, infatti, a famiglie monoreddito e/o monoparentali);
La scuola dura solo tre anni e poi mio figlio va subito a lavorare. La vita a Torino è faticosa, spendiamo tutto quello che guadagniamo… e poi noi siamo in 6, lavora solo mio marito (34, madre). Mia mamma già conosceva questa scuola e non aveva neanche soldi per mandarmi in un’altra scuola, mi aveva detto “A te cosa piacerebbe fare?”, dico “A me la barista”, Allora andiamo in quella scuola perché tanto conosco la scuola, so che si studia bene e vai là”. Dopo una settimana che sono arrivata in Italia, sono già entrata nella scuola. Al momento in cui sono arrivata non sapevo che scuole c’erano, ho fatto quello che al momento si poteva fare, però altre alternative non le conoscevo (Romania, F). - dal limitato utilizzo del capitale culturale della famiglia come risorsa per orientare i percorsi formativi dei figli. Anche quando i genitori possiedono titoli di studio alti o medio-alti, si manifesta la loro difficoltà, di persone scolarizzate e formate all’estero, di orientarsi nel sistema d’istruzione e formazione italiano, aspetto reso particolarmente problematico anche dalle scarse competenze nella lingua del paese d’accoglienza; I miei genitori non sanno che scuola sto facendo (Marocco, M). Mio padre non sapeva com’era lo studio in Italia. L’Italia non è come il Marocco, che devo fare la terza media e poi scegliere cosa seguire, invece in Marocco è un'altra cosa, lui non sapeva che era così. Poi gliel’ho detto che potevo andare in quella scuola, che l’altra è difficile per me. Ad esempio a mio fratello gli ha consigliato di andare all’elettrico perché ha capito che dopo la terza media devi scegliere cosa voler continuare (Marocco, M). Le famiglie dei ragazzi stranieri non possono aiutarli, perché è diverso quando tu hai un padre non so medico, che è italiano, già che conosce la situazione e allora ti può sedersi lì e ti aiuta. Quando invece i tuoi genitori non conoscono la società, non conoscono l’istruzione perché non hanno studiato qui, non ti possono aiutare. A volte cercano e ti fanno sbagliare, perché insomma scelgono le cose che vorrebbero loro per te, mentre tu non sei loro e gli insegnanti molte volte ti vedono straniero e ti mandano già ad istituti professionali subito. Tantissime volte ho conosciuto gente che adesso veramente è a dei livelli alti: c’è una ragazza che voleva fare il liceo scientifico, la professoressa fa “tu non lo fai perché non andrai mai bene, non sarà possibile”, l’ha scoraggiata tantissimo, alla fine non l’ha fatto quando poteva benissimo fare quelle cose lì. Poi il fatto che lei avesse comunque il velo, era straniera, ci sono insegnanti che veramente ci scoraggiano. E non c’è un ufficio, qualcosa dove vai e dici “io sono straniero, ho studiato qui, ho fatto questo, cosa potrebbe andarmi bene, dove vado il prossimo anno e cosa devo fare adesso” (Marocco, F).
- da un capitale sociale familiare debole, derivante principalmente dalle reti etniche e utile per percorsi migratori e inserimenti lavorativi in settori poco qualificati, ma non in grado di veicolare le informazioni necessarie per gli immigrati rispetto al sistema scolastico/formativo8.
8 La famiglia può comunque mitigare la perdita di capitale sociale secondario conseguente alla migrazione: alcuni studi hanno riscontrato che gli effetti negativi della migrazione familiare sono più significativi nelle
14
Conoscevano una persona, però diciamo che tutti promettono tutto, quando arrivi ti lasciano per strada e loro, dopo un mese, si sono trovati a Torino che non conoscevano nessuno. Sono stati duri, quasi due anni, finché comunque hanno cominciato a star bene, a sistemarsi (Romania, F). Sono arrivato qui a scuola tramite amici che venivano con me alla scuola media, poi visto che è venuto mio fratello sono venuto anch’io (Tunisia, M). Me l’ha detto un mio amico. Mi ha detto fai meccanica che è più bello di elettronica (Perù, M). Era già venuto mio fratello tre anni fà a fare un corso di elettricista, quindi sapevo che qua c’erano i corsi e sono venuto qua. Mi hanno aiutato mia madre, mio padre, mio fratello. In famiglia abbiam parlato e ho deciso di venir qua. È stato abbastanza facile perché avevo le idee già precise. Sapevo già cosa voglio fare. Son venuto qua e mi sono iscritto a meccanica auto (Romania, M).
Nel complesso, alcuni fattori strutturali (scarse risorse economiche, svalutazione del capitale culturale dei genitori, capitale sociale in prevalenza etnico, composizione della famiglia, ecc.) risultano rilevanti nell’influenzare percorsi di soggetti piuttosto vulnerabili e che andranno probabilmente ad occupare una posizione marginale nel contesto sociale di accoglienza. Anche negli studi sui giovani stranieri negli Stati Uniti (Portes, Fernandez-Kelly, Haller, 2009), ad esempio, l’assimilazione verso il basso – misurata con specifici indicatori (precoce abbandono scolastico, stato di disoccupazione, povertà, figli in adolescenza, arresti e incarcerazioni per crimini) – appare determinata da una forte influenza dello status socioeconomico e della struttura familiare, oltre che dagli effetti negativi dell’acculturazione intergenerazionale che sono riflessi nell’origine nazionale e dal ruolo del capitale culturale, inteso sia come forza motivazionale che restaura l’orgoglio e lo status della famiglia, trasmettendo alte aspirazioni, sia come know how posseduto da immigrati con alti livelli di istruzione.
Oltre all’influenza di fattori strutturali, i giovani stranieri si trovano a condividere nel loro percorso lo stesso spazio fisico e la stessa condizione con una parte svantaggiata della popolazione autoctona, nell’ambito delle istituzioni formative, in una situazione di prossimità spaziale e sociale. Lo spazio della coabitazione, talvolta, può diventare sinonimo di marginalità, in cui si verifica una dinamica di degrado materiale e sociale: in Europa (e in Italia), la concentrazione avviene, non tanto sulla base dell’origine etnica, quanto sull’origine
famiglie con genitori poco coinvolti nell’istruzione dei figli (Hagan, MacMillan, Wheaton, 1996). Inoltre, alcune recenti ricerche (Gilardoni, 2008; Ravecca, 2009) evidenziano il ruolo ambivalente del capitale sociale etnico, che ha una funzione positiva nelle prime fasi d’inserimento ma piuttosto limitata nel sostegno e nel miglioramento scolastico, formativo, sociale. Il valore che i genitori attribuiscono all’istruzione sembra variare non tanto a seconda del gruppo di appartenenza, ma più in base allo status, al capitale culturale familiare e al genere.
15
di classe, tra soggetti con cui si condivide un’esperienza di esclusione. I CFP rappresentano, in tale prospettiva, un ricettacolo di soggetti svantaggiati (italiani e stranieri), un canale di formazione di scarsa importanza e rilevanza, quasi una sorta di inevitabile preludio alla marginalità e alla impossibilità di partecipare dei diritti di cittadinanza attraverso l’istruzione e la formazione. Il nostro ente è nato per coprire le fasce deboli del mercato del lavoro… si tratta di marginali, di persone che non hanno diritti di cittadinanza (9, prof).
Le difficoltà nella fruizione di adeguate opportunità formative si colgono in dinamiche che limitano il diritto allo studio degli allievi stranieri, ad esempio negli ostacoli nell’accesso all’istruzione secondaria di II grado, negli esiti negativi che mostrano le carriere maggiormente irregolari ed interrotte degli stranieri rispetto agli italiani, nella transizione al lavoro in cui diminuiscono ulteriormente le opportunità.
Per quanto riguarda l’accesso all’istruzione, è opportuno ricordare che dal punto di vista giuridico, l’iscrizione scolastica dei minori stranieri e le prestazioni complementari al diritto all’istruzione (che rendono effettivo il diritto allo studio del minore, anche straniero) devono avvenire a parità di condizioni con i minori italiani sino al completamento del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, ovvero sino al conseguimento del titolo di studio di scuola superiore o di rilascio della qualifica professionale o di completamento dell’apprendistato, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dalla normativa vigente e non in contrasto con gli obblighi comunitari e internazionali assunti dallo Stato italiano (Asgi, 2009; Rozzi, 2009).
Tuttavia, nonostante le dichiarazioni di principio, la scuola professionale viene rappresentata come l’unico luogo che offre ad adolescenti neo arrivati la possibilità di coniugare l’apprendimento della lingua italiana con un percorso di formazione qualificante. Laddove le scuole superiori offrono teoricamente questo diritto, la formazione professionale sembra realizzarlo in pratica. Gli adolescenti arrivano alla formazione professionale, poiché “tutte le altre porte sono chiuse”, come emerge dalle parole di alcuni docenti intervistati, dal momento che la scuola secondaria di II grado viene presentata come un contesto in cui non ci sono capacità, mezzi e volontà per rispondere ai bisogni dei ragazzi stranieri neo-arrivati. Inoltre, la missione degli enti di formazione professionale è proprio quella di accogliere, accompagnare, seguire, rivolgere la propria attenzione ai soggetti deboli e svantaggiati, sostenendoli in un percorsi di riuscita nella formazione e nel lavoro: si tratta quasi di un ambiente “protetto” in cui inserire questi giovani affinché ritrovino un clima adatto per una crescita equilibrata dal punto di vista personale, formativo e professionale, un contesto formativo “normale”, anche quando non è considerato come tale nell’ambito
16
delle scuole secondarie di I e II grado. Tali ostacoli all’accesso all’istruzione secondaria di II grado derivano, senza
dubbio, da una disuguaglianza, generata da fattori socio-economici e culturali (e ciò vale anche per gli italiani), da difficoltà negli apprendimenti linguistici, da carenze nei processi di orientamento da parte delle scuole e da scarsa disponibilità o preparazione all’accoglienza da parte dei licei.
Io non potevo andare nelle altre scuole, perché sono in Italia da poco tempo e anche quando ho cominciato questa scuola non potevo parlare l'italiano, Ho cominciato questa scuola per imparare l'italiano in fretta. Non ho trovato un'altra scuola (Afghanistan, M).
Si è iscritta alla formazione professionale perché è l’unico posto dove l’hanno presa senza la scuola media italiana. Per la vostra legge, senza la scuola media italiana, non possiamo entrare da nessuna parte (Russia, madre). Purtroppo molti licei ed istituti tecnici non accettano i ragazzi stranieri arrivati da poco per il problema della lingua, noi quando accogliamo i ragazzi all'atto dell'iscrizione, tramite dei test, vediamo com’è il loro livello di italiano e se è proprio basso basso consigliamo di frequentare i CTP del territorio per acquisire poi la padronanza della lingua che gli permetta poi di venire qua da noi (prof).
I migranti arrivano nei centri di formazione proprio perché tutte le altre porte sono chiuse e da un lato c'è l'immagine positiva che la formazione professionale fa arrivare subito alla cosiddetta qualifica e ad un possibile impiego, magari con lo stage in modo particolare in azienda, dall'altro anche una semplificazione delle cose, perché l'immaginario sulla formazione professionale non è positivo, nell'immaginario è una scuola di serie B… Nelle scuole non credo si abbia il background per accogliere, se un ragazzo non ha il background di partenza per cui conosce bene l'italiano e altre competenze minime, la scuola non lo prende, lo emargina già subito e deve essere uno già bravo dal punto di vista cognitivo e delle conoscenze altrimenti non credo, per come funziona la scuola, che sia in grado di accogliere questo tipo di utenza. La scuola superiore non interviene, un po' non c'è la volontà è un po' probabilmente non ci sono le capacità e i mezzi per rispondere a questi bisogni. Invece la formazione professionale un po' viene aiutata con i finanziamenti e un po' è proprio la nostra vocazione. Io non penso che le famiglie straniere abbiano la percezione che noi siamo di serie B, ma semplicemente siamo un punto dove vengono accolti e seguiti, accompagnati, quindi traggono soddisfazione anche perché da altre parti, non dico che abbiano ricevuto porte chiuse, ma magari non hanno ricevuto lo stesso interesse, la stessa attenzione (prof).
Per quanto riguarda il diritto allo studio, non basta discutere dell’accesso al sistema di istruzione e formazione, ma occorre porre attenzione al tipo di partecipazione, ai risultati scolastici degli allievi stranieri, al diritto di fruire di pari opportunità educative, alle condizioni necessarie per il conseguimento del successo scolastico. I dati, in proposito, sono piuttosto preoccupanti. Dalle interviste emergono le difficoltà che incontrano i ragazzi immigrati a proseguire gli studi dopo la scuola secondaria di I grado, nonché situazioni di ritardo e abbandono scolastico rilevanti. Analisi recenti rendono evidente che le diversità di scelta permangono, anche a
17
parità di riuscita scolastica (Canino, 2010). La presenza degli immigrati interroga le modalità concrete di realizzazione dei principi di uguaglianza, anche in termini di organizzazione del sistema di istruzione/formazione (doppio canale e percorsi comuni, età delle scelte, sistemi di alternanza) che interessano gli stranieri non diversamente dagli studenti italiani. Per i primi, oltre alla maggiore probabilità di dover fare i conti con scarse risorse economiche, si aggiungono più complessi problemi di elaborazione di un progetto scolastico che si coniughi realisticamente con il progetto migratorio personale e familiare (Giovannini, 2010).
Nella formazione professionale, così come emerge dalle interviste, non sussistono notevoli differenze negli esiti tra allievi stranieri e italiani. La formazione professionale acquisisce il suo significato più autentico per i ragazzi stranieri, proprio per il valore e lo spazio che attribuisce all’esperienza pratica, alla manualità, ad un processo di apprendimento che alterna le ore di laboratorio alla teoria. I ragazzi sviluppano così la percezione di imparare competenze nuove, scoprendo le loro passioni e attitudini, dimostrando di saper superare le difficoltà delle parole con l’abilità manuale, così da saper arrivare con una preparazione adeguata ad affrontare le sfide del mondo del lavoro (cfr. Sennett, 2008). Esistono anche alcuni giovani che manifestano una preferenza per la teoria, per le materie di base – come italiano e matematica –, rivelando la loro collocazione errata nell’ambito della formazione professionale.
La sfida, in questo campo, riguarda soprattutto la necessità di produrre nei docenti la consapevolezza rispetto alle caratteristiche degli allievi stranieri, differenti dall’utenza italiana per quanto riguarda le motivazioni e le competenze: l’atteggiamento di accoglienza generalizzata, talvolta, non porta a verificare il percorso pregresso degli allievi stranieri, che nella maggior parte dei casi non sono soggetti privi di competenze. Tale atteggiamento, oltre alla difficoltà di valutare con cognizione di causa gli allievi stranieri, possono costituire limiti nel raggiungimento di un pieno successo formativo. Sebbene il successo formativo si fondi ad un primo livello nei processi di apprendimento dell’italiano, i giovani stranieri evidenziano l’importanza della valorizzazione dei propri patrimoni linguistico-culturali, sottesi al bagaglio di partenza, con funzione motivante e promozionale (in particolar modo per chi presenta rischi di disagio e di marginalità). Mi piace fresare, squadrare, misurare i pezzi, poi anche fare il controllo numerico (Marocco, M).
Mi piace il laboratorio termoidraulico, con la teoria non capisco bene le cose e non riesco a farle bene, ho un po' di difficoltà con le parole (Romania, M).
Io faccio elettricista, mi piace di più quando andiamo in aula computer, informatica, oppure in laboratorio. Io direi meno orale e più pratica, più ore di laboratorio e più ore di qualcosa che ci può servire quando andremo a lavorare, la teoria serve, però è la pratica che conta, quando arrivi sul
18
posto di lavoro e ti chiedono: “Fai questo”, e non lo sai fare, non serve a niente dirglielo a parole, quindi secondo me più pratica e meno teoria (Albania, M).
Un ultimo passaggio essenziale nella possibilità di costruzione di cittadinanza
sociale per gli allievi stranieri riguarda l’accompagnamento nella transizione al lavoro, laddove abbandonare in questa fase può costituire un grave rischio per la dispersione (Fondazione Giovanni Agnelli, 2010). Tra l’altro, la mancanza della cittadinanza italiana nel mercato del lavoro crea maggiori difficoltà agli stranieri. Certamente, la condizione del giovane straniero si rivela piuttosto fragile e legata a filo doppio alla possibilità di trovare un lavoro, se si pensa che il rinnovo del permesso di soggiorno è possibile solo se si ha un contratto di lavoro. All’avvicinarsi della maggiore età, questo elemento diviene una minaccia reale per il futuro: a partire dalla paura di non poter rimanere in Italia, si spiega la disponibilità di diversi giovani, in particolare minori non accompagnati, di rispondere alle richieste del datore di lavoro, sottostando a qualsiasi condizione per mantenere il posto di lavoro.
In generale, i giovani intervistati immaginano che la frequenza della formazione professionale garantirà una collocazione lavorativa adeguata, in cui l’essere straniero non avrà nessuna influenza. Nelle riflessioni dei ragazzi, un elemento che sembra fare la differenza rispetto ai buoni risultati nell’ambito del lavoro non è tanto la diversità etnica, quanto il livello di impegno e la capacità di svolgere bene la propria mansione. Gli adolescenti sottolineano il fatto che gli stranieri hanno una marcia in più rispetto agli italiani, in quanto paiono più disposti al sacrificio, alla fatica, al lavoro duro, più affidabili e meno viziati dalle famiglia, e per questo vengono particolarmente apprezzati e preferiti sul lavoro. Le difficoltà insite nell’esperienza migratoria vengono considerate, inoltre, dai docenti un processo di formazione che portano l’adolescente ad impegnarsi maggiormente e a lottare per la propria affermazione. Paure più forti, ma nello stesso tempo più indefinite, riguardano il rischio di essere discriminati dal proprio datore di lavoro e rifiutati in quanto stranieri, ad esempio per il colore della pelle. Nessuno dei giovani si è ancora trovato in una situazione così grave e, nel complesso, i ragazzi vivono con tranquillità l’impegno di imparare bene il proprio lavoro, aspetto che credono sarà l’unico a contare nel rapporto con il datore di lavoro.
Le fragilità dei giovani stranieri messe in evidenza finora, tuttavia, necessitano di essere rilette alla luce del significato positivo che molti adolescenti stranieri attribuiscono alla formazione. In questo senso, i minori stranieri sono portatori di specificità rispetto agli studenti italiani. Nei racconti di docenti e studenti, si evidenzia soprattutto che: - gli stranieri mostrano un forte investimento, una grande motivazione e un profonda fiducia nel percorso di formazione professionale, utile per l’inclusione sociale e
19
lavorativa, rivelandosi una risorsa motivazionale per tutti gli allievi e positivi per i climi di classe; Nella maggioranza dei casi vediamo che i ragazzi stranieri prendono più seriamente la scuola, ma secondo me, indipendentemente dal fatto che sia formazione professionale o scuola di Stato, nel senso che tendono ad impegnarsi di più, ad essere più partecipi e quelli italiani lo sono meno… Hanno in linea di massima un interesse in più all’apprendimento proprio perché lo sentono per loro importante perché è la fase di passaggio che ti permette di integrarti meglio, di capire più a fondo la realtà che ti circonda ed è anche un modo per interloquire meglio anche con gli stessi compagni o con il contesto (prof).
- la formazione professionale viene considerata spesso, dai giovani stranieri, un punto di partenza del proprio percorso in Italia e non l’ultima chance o una scelta di ripiego, piuttosto è l’occasione di un’ulteriore opportunità formativa, nonostante la scarsa competenza nella lingua italiana di alcuni che sembra precludere, anche se non in modo definitivo, la scelta della scuola secondaria di II grado; Per gli stranieri la formazione professionale è vissuta come un punto di partenza, invece per molti ragazzi italiani, per vari motivi, motivazioni proprie o magari della famiglia o dei consigli che può dare la scuola di Stato, la formazione professionale viene vissuta molte volte, non dico come un punto di arrivo, ma un punto su cui fermarsi, cioè: “Vado lì per arrivare a quello, perché quello sarà ciò che potrò fare nella vita, perché non ho le capacità, perché non ho voglia, tanto lo so che non ce lo posso fare”, quindi uno va in formazione professionale perché comunque al limite fai quello, piuttosto che fare niente, fai quello e poi ti fermi. Invece sugli stranieri, la maggior parte, quelli che hanno una situazione stabile, quelli che sono motivati, molti la vivono come un punto di partenza anche perché, per loro comunque arrivano da situazioni in cui la fabbrica, l'officina, un lavoro stabile, non dico è un miraggio, ma è già una cosa che per loro è ancora progresso ed evoluzione, che qua invece è un po' stantia (prof). - i corsi per l’assolvimento dell’obbligo sono percepiti come una possibilità di recupero del ritardo, costruito nella fase dell’accoglienza dalla scuola italiana, e di riallineamento, nonostante la situazione di transizione e i rallentamenti inevitabili dovuti alla migrazione, nel tentativo di non perdere troppi anni e, nello stesso tempo, di non rinunciare alla formazione; In Romania ho fatto la terza media, l’ho finita e poi sono arrivata qui, sono entrata in questa scuola; ho fatto già il primo di corso IAPP, ho fatto due esami per passare nella seconda biennale l’anno scorso e sono passata… quindi ho guadagnato un anno, quando ho finito vado a cercarmi un lavoro quindi. Sono soddisfatta al 100%, perché in un anno e mezzo faccio quasi tre anni di scuola, quindi ho guadagnato tanto, sono contenta di quello che ho fatto (Romania, F). Può subentrare anche il fatto che magari sono arrivati dopo in Italia, che hanno già dovuto seguire, non so se hanno perso un anno, perché non sempre gli anni di istruzione nel loro paese coincidono con i nostri, e allora si tratta un po' di accorciare i tempi e cercare un percorso un po' più facilitato per
20
loro per l'apprendimento, un po' per la lingua, ma non è vissuto da loro come un rinunciare al percorso di studi, ma semplicemente riallinearsi, trovare magari uno sbocco più consono a quelle che sono le loro capacità, il loro livello di apprendimento, dovuto ad una situazione non tanto di ordine cognitivo, ma quanto proprio di difficoltà nel passaggio dal loro paese (prof.).
- gli allievi stranieri si dichiarano soddisfatti dell’esperienza formativa e, in genere, ottengono una buona o addirittura elevata riuscita9, derivante dall’interiorizzazione di un orientamento al successo, frutto di un’etica familiare basata sull’impegno, sul merito, sull’idea di riscatto e di miglioramento. Il successo formativo è reso possibile dal fatto che la formazione professionale offre la possibilità di coniugare l’apprendimento graduale dell’italiano con un percorso di formazione qualificante, che risponde all’interesse per la professionalizzazione, superando le difficoltà linguistiche e valorizzando le intelligenze multiple degli allievi, attraverso un’alternanza tra lezioni frontali e attività laboratoriali; Io sono nella prima acconciatrice biennio e praticamente questo corso comprende i vari moduli, i passaggi per diventare un acconciatrice, in questo corso però c'è anche un piccolo inserimento di manicure, quindi oltre ad aver a che fare con i capelli, hai a che fare anche con le mani. Questo corso mi piace ancora di più perché si ha a che fare con le persone, a me piace stare molto a contatto con le persone, se avessi dovuto continuare il liceo, magari avrei trovato un lavoro, qualcosa tipo in azienda e a me non sarebbe piaciuto. Ad esempio, se cammino e vedo una persona che ha un taglio di capelli che non mi piace, la immagino diversa e cerco di portare questa persona a vedersi più bella e a farsi vedere più bella (Marocco, F).
Le materie in cui sono più bravo è elettricista, il laboratorio mi piace molto, poi ci sono altre materie che non mi piacciono, però devo comunque impararle come ad esempio matematica, italiano, storia. Sono comunque un po' bravo, perché le studio, ma non mi piacciono. Con questo corso imparo a lavorare con le macchine, le macchine operatrici che si trovano nelle aziende, imparo a montarle, a ripararle (Romania, M).
Alla fine poi sono arrivata qua e diciamo che sono cambiata: non c’è un episodio che mi ha fatto cambiare, è tutto un insieme, se le persone che ti prendono diversamente, ti parlano con calma, ti prendono proprio diversamente, hanno molta pazienza, allora inizi a capire che comunque anche se esci dalle medie che non sai fare niente, puoi sempre imparare. Quindi con il loro aiuto, perché loro qui fanno anche recuperi e approfondimenti per chi non ha imparato, quindi ti stanno sempre dietro, ti danno comunque la possibilità di recuperare tutto quello che magari non sai fare. E facendo così comunque impari, impari perché lo vedi proprio che hanno proprio il piacere di starti dietro, di farti imparare delle cose. Loro ci provano sempre, anche se tu magari dici “non ho voglia”, loro insistono sempre e così vedi proprio questi ragazzini che arrivano qua dalle scuole medie, che non hanno voglia di far niente, che a mano a mano cambiano. Io sono cambiata, io parlo per me stessa e mi
9 Le comparazioni tra gli studenti stranieri nei diversi paesi europei (sulla base dei dati PISA 2003) mostrano che essi sono motivati nell’apprendimento e hanno un atteggiamento ottimistico verso lo studio, anche se spesso hanno performance a livello inferiore ai nativi (Oecd, 2006; Levels, Dronkers, 2008).
21
sento tanto cambiata. Mi ricordo il primo anno e mia mamma che si stupiva di me perché comunque non si sarebbe mai aspettata i risultati a scuola, il cambiamento proprio di comportamento, capito? (Romania, F). - gli studenti stranieri della formazione professionale esprimono anche un elevato benessere relazionale, in particolar modo per quanto riguarda le relazioni con i docenti, trovando in essi riferimenti adulti significativi e incrementando il proprio capitale sociale da spendere, in seguito, in ambito formativo e lavorativo; Con i professori va bene, abbiamo una buona relazione: io non ho mai partecipato a progetti specifici o corsi di lingua perché sono arrivato da piccolo, ma i professori hanno pazienza, rispiegano finché tutti non hanno capito (Albania, M). I professori con me sono molto gentili, mi aiutano, non fanno differenza, anche se io sono straniero non fanno differenza, faccio tutto come gli altri miei compagni e questo a me non dispiace, anzi sono contento che non mi trattano da straniero, mi trattano da un ragazzo italiano (Romania, M). Alle medie alcuni professori ti aiutavano, ti stavano dietro però non erano come qua. Qua non è che c’è un professore per ognuno di noi, però quando hai qualche problema, lo ripeto perché è una cosa che è successa a me, anche non a livello scolastico ma anche personale, in quel momento passi un brutto periodo, hai sempre qualcuno che ti ascolta, che ha tanta pazienza (Romania, F).
- i ragazzi stranieri, infine, nutrono aspettative positive in campo lavorativo e, talvolta, intendono continuare gli studi, impegnandosi assiduamente nel presente per realizzare un progetto personale e familiare. Io spero di lavorare nel campo in cui mi sto preparando, non tanto da elettricista ma come operatore delle telecomunicazioni e con i computer. Mio padre dice che è un bel lavoro, non è pesante e faticoso come il suo, lui è così stanco… stare sempre in ginocchio è faticoso e a volte non ce la fa più. Per questo spera che io faccia un lavoro migliore e meno pesante. A volte sono andato ad aiutarlo nel suo lavoro, ma è molto diverso dal mio, è veramente pesante. È importante quindi avere un lavoro con uno stipendio buono, ma non troppo pesante (Romania, M).
Pertanto, il lavoro è spazio in cui gli adolescenti stranieri pensano di poter
diventare cittadini, esercitando la virtù dell’onestà, educandosi ai doveri pubblici. Proprio per tale motivo, il lavoro risulta essere un obiettivo e un importante punto di arrivo per un minore che è ancora giuridicamente straniero, ma che attraverso il lavoro si può sentire parte di un contesto pubblico e collettivo, cui non appartiene per nascita ma cui vuole aderire per scelta. I ragazzi sono consapevoli, quindi, che la riuscita nel lavoro sarà indicatore del successo del progetto migratorio della propria famiglia e dell’integrazione nell’ambito del paese d’accoglienza.
22
Per me il lavoro vuol dire guadagnare soldi, diventare un cittadino onesto, lavori come tutti gli altri, paghi le tasse, questo vuol dire per me il lavoro, non vuol dire andare lì e fare casino. Lo vedo come un risultato importante per la mia vita (Romania, M).
Il ritratto che emerge è quello di una prima generazione di stranieri,
numericamente rilevante nella formazione professionale e costituita in prevalenza da ricongiunti alla famiglia, che costituisce un gruppo peculiare rispetto alle generazioni precedenti (di adulti immigrati) e successive (di giovani di origine immigrata nati nel paese d’accoglienza), alle prese con la costruzione di un progetto di vita in Italia che trova nel successo formativo e nell’inserimento lavorativo i punti di partenza dell’inclusione sociale. Questi giovani considerano la formazione uno strumento indispensabile per il raggiungimento di un esito positivo del proprio progetto migratorio, finalizzato al miglioramento socioeconomico, alla mobilità socioprofessionale, al riscatto per sé e per la propria famiglia, in un presente caratterizzato da esperienze di sacrificio e impegno, alla ricerca del successo attraverso la formazione.
Il nodo rimane, per questi giovani, arrivare a professioni che corrispondano a titoli acquisiti, aspettative e ambizioni personali e familiari, in cui il merito venga premiato, indipendentemente dalle appartenenze e dalla cittadinanza giuridica, superando i vincoli rappresentati dalla condizione immigrata per una fruizione piena delle possibilità del diritto allo studio per gli stranieri (e per tutti).
Orientamento, accoglienza, relazioni con le famiglie, accompagnamento lavorativo: tasselli delle politiche formative per gli allievi migranti
Sulla base delle evidenze empiriche emerse dalla ricerca qualitativa, nell’itinerario d’indagine, dopo aver preso in considerazione i percorsi degli adolescenti stranieri, il focus d’attenzione si è spostato sulle prassi del sistema formativo, con la realizzazione per due anni consecutivi di un censimento delle iniziative per allievi stranieri inseriti nei corsi dell’Obbligo d’Istruzione e Formazione Professionale, svolto in collaborazione con il Servizio Formazione Professionale della Provincia di Torino, con il coinvolgimento attivo della rete di agenzie formative operanti nel territorio. La ricerca si è focalizzata sulla rilevazione delle pratiche d’integrazione, messe in campo dalle agenzie formative della Provincia, a favore degli allievi migranti inseriti nei corsi di diritto-dovere/obbligo, al fine di monitorare la fruizione del diritto allo studio e le pari opportunità di formazione per gli studenti stranieri.
L’indagine si è posta lo scopo di identificare tipologie e prassi di intervento delle agenzie formative (mediante una metodologia di tipo quantitativo), rivolgendo un’attenzione specifica alle pratiche di accoglienza degli allievi stranieri (ad es.
23
modalità di iscrizione e azioni di tipo conoscitivo, amministrativo, relazionale, didattico, organizzativo, ecc.), alle relazioni con le famiglie, alla transizione al lavoro.
L’indagine ha avuto un primo esito positivo nella costruzione di un questionario strutturato (compilato da ciascun centro di formazione della Provincia) per la rilevazione di tipologie e prassi di intervento delle agenzie formative, messo a punto in collaborazione con il Gruppo migranti della Provincia di Torino, per l’analisi delle caratteristiche della domanda e dell’offerta formativa, nonché degli operatori coinvolti: la rilevazione, di tipo quantitativo, si è configurata come un’azione di sistema della Formazione Professionale, che si intende replicare in futuro e che potrà avere ricadute positive anche sul sistema di monitoraggio dei corsi, nonché nell’individuazione di specifiche “buone pratiche”, definite sulla base di criteri di qualità ritenuti significativi.
Per quanto riguarda l’analisi del punto di vista delle agenzie formative, nel complesso, l’inserimento degli adolescenti in percorsi formativi viene ritenuta una strategia di contrasto al pregiudizio e di promozione di un clima di solidarietà sociale (Tab. II): il ruolo della formazione, tra l’altro, diventa ancora più significativo se sostenuto dalle famiglie, dall’opinione pubblica e dai mass media, in un processo di integrazione che si concretizza principalmente all’interno dei centri formativi attraverso lo scambio con gli altri e mettendo in gioco la propria cultura (Tab. III).
La visione dell’integrazione come assimilazione, quindi, non costituisce un orizzonte di riferimento per gli operatori della formazione professionale: prevale lo scambio interculturale e l’integrazione pluralista e tollerante. Tab. II - Pregiudizi e ruolo della formazione secondo gli operatori dei CFP della Provincia di Torino % La formazione, di fatto, svolge un ruolo molto importante nel contrastare il pregiudizio e promuovere un clima di solidarietà sociale 57,8La formazione potrebbe svolgere un ruolo importante nel contrasto del pregiudizio nei confronti degli immigrati, ma solo se sostenuta dalle famiglie, dall’opinione pubblica, dai mass media 42,2La formazione viene spesso contrastata dalla cultura delle famiglie, dall’opinione pubblica, dai mass media e, in realtà, non riesce a contrastare i pregiudizi sugli stranieri 0 Totale 100 Tab. III - Prospettive per il futuro della società multiculturale secondo i docenti dei CFP della Provincia di Torino % Instaurare un processo di scambio con gli altri, mettendo in gioco la propria cultura 64,4 Mantenere la propria identità culturale, avendo tolleranza per le altre 35,6 Difendere le proprie radici culturali 0 Totale 100
24
Per quanto riguarda le pratiche rivolte ad allievi stranieri, tra i centri della Provincia di Torino sono diffuse prassi in una molteplicità di ambiti diversi di intervento, riadattate a partire da strategie già sperimentate con gli adolescenti italiani (Tab. IV) e nate in risposta ai bisogni specifici di ogni allievo, ma sviluppate anche come supporti specifici per gli stranieri (corsi di italiano, attività di sostegno allo studio, protocolli per l’iscrizione e l’accoglienza, ecc.). I formatori, tuttavia, avrebbero la necessità di ulteriori strumenti per fronteggiare le difficoltà e gestire classi multiculturali e multilingui, ad es. con esperienze di formazione dei formatori, collaborazione con mediatori interculturali, approfondimenti sulle lingue e culture altre.
Tab. IV - Prassi adottate anche per gli allievi italiani (%) 2008/09 2007/08 Si 95,3 90,5 No 4,7 9,5 Totale 100 100
Rispetto all’orientamento degli allievi stranieri in ingresso, anche in questo caso si
utilizzano le medesime prassi per italiani e stranieri (ovvero presentazione dei corsi presso le scuole secondarie di I grado, colloqui con genitori e allievi, ecc.), ma nel 30% dei centri si utilizzano dei dispositivi ad hoc creati appositamente per l’orientamento dell’utenza straniera (mediatori interculturali, materiali informativi plurilingui, incontri presso i CTP, utilizzo della guida “Tutti a scuola” elaborata dalla Provincia di Torino, ecc.). Si riconferma, senza dubbio, il ruolo centrale degli insegnanti delle scuole secondarie di I grado, nell’orientare gli stranieri alla formazione professionale e la scelta dei giovani e delle famiglie, spesso in alternativa alla scuola secondaria di II grado. Si tratta, tuttavia, di procedure poco formalizzate e scarsamente condivise da docenti e formatori, solo il 35,6% dei centri adotta prassi standard: limitato è anche l’utilizzo di test per l’accertamento dei livelli di competenze (linguistiche e non) in ingresso per gli allievi stranieri, pochi centri ricostruiscono le esperienze formative precedenti, mentre il criterio di orientamento maggiormente usato riguarda attitudini, propensioni e interessi dello studente.
Tab. V - Un buon orientamento alla scelta, a sostegno degli allievi… Molto +
Abbastanza Poco + Per
nulla Considera principalmente le propensioni dell’allievo 97,8 2,2 Tiene in considerazione le possibilità offerte dal mercato del lavoro 91,1 8,9 Evita l’investimento in studi di lungo periodo, quando ci può essere il rischio di abbandono
86,7 13,3
Evita la canalizzazione di studenti meritevoli verso percorsi brevi di formazione 73,3 26,7
25
Secondo il parere dei docenti (Tab. V), la migliore pratica di orientamento consiste
nell’orientare gli stranieri in studi di breve periodo per ovviare il rischio di abbandono, mentre si considera meno problematica la questione della canalizzazione formativa.
Nella fase di accoglienza, invece, emerge un’attenzione maggiore ai bisogni linguistici e di apprendimento degli allievi stranieri, proprio perché all’avvio dei corsi è centrale l’impostazione di un processo di apprendimento e potenziamento della competenza linguistica degli stranieri in italiano, cui si risponde in genere con percorsi personalizzati, mediante sostegni linguistici e recupero degli apprendimenti disciplinari. Nel corso dei due anni formativi considerati, è aumentata la percentuale di centri che hanno introdotto l’utilizzo di test standardizzati relativi alla rilevazione delle competenze linguistiche in ingresso degli allievi stranieri, anche su impulso della Provincia. Inoltre, è centrale il ruolo del tutor nell’accompagnamento e nel monitoraggio delle relazioni durante l’inserimento in classe.
Strategico, in queste fasi, iniziali è un lavoro di rete tra centri ed altri enti e soggetti dei territori, anche se l’approccio di rete sembra diminuire nel corso dei due anni formativi considerati: importante è la collaborazione sull’orientamento con scuole secondarie di I grado, servizi sociali, CTP, enti locali, genitori. Significativa per l’accoglienza sembra essere la relazione costruita con assistenti sociali, CTP, ambiti ovvero che si occupano di soggetti stranieri particolarmente svantaggiati (neo arrivati, con scarse competenze linguistiche) o a rischio (minori non accompagnati).
Particolarmente interessanti sono le riflessioni, che emergono dall’indagine, rispetto alla relazione scuola-famiglia immigrata. Innanzitutto, bisogna considerare che la famiglia immigrata costituisce un attore fondamentale nei processi educativi e formativi delle nuove generazioni: sebbene, secondo il parere dei formatori, le problematiche familiari condizionino nella stessa misura i percorsi degli allievi italiani e stranieri (nell’88,9% delle risposte), spesso la famiglia in migrazione non riconosce alcuni messaggi delle istituzioni formative, rivendicando il proprio ruolo fondamentale nella trasmissione degli insegnamenti rilevanti e riconoscendo nella formazione professionale un’agenzia che, al massimo, può offrire le competenze necessarie per il mondo del lavoro. Ancora più spesso, l’atteggiamento dei genitori stranieri nei confronti della formazione consiste nel rimanere nell’invisibilità, nello stare in disparte, anche a causa della mancanza di un progetto finalizzato alla costruzione di un rapporto continuativo e strutturato con le famiglie: non bastano gli incontri in momenti fissi dell’anno per tutte le famiglie o la partecipazione al ricevimento per discutere dei progressi formativi dei figli per costruire tale relazione significativa, che può realmente garantire la piena fruizione del diritto allo studio per i giovani stranieri.
26
Tab. VI - Azioni realizzate nei centri di formazione a favore delle famiglie straniere Sì No Incontri in momenti fissi dell’anno (rivolti a tutte le famiglie) 95,6 4,4 Incontri ad hoc con i genitori stranieri presso il centro in orari flessibili e concordati 48,9 51,1 Percorsi di formazione del personale docente per la gestione del rapporto con le famiglie straniere
13,6 86,4
Utilizzo di una comunicazione plurilingue, grazie alla presenza di esperti e/o volontari 13,6 86,4 Incontri di progettazione e verifica in cui sono stati coinvolti genitori stranieri o loro rappresentanti
11,4 88,6
Attivazione di sportelli e servizi d’orientamento per i genitori stranieri 6,8 93,2 Traduzione della modulistica ed elaborazione di materiali informativi plurilingui 6,8 93,2 Visite a casa dei genitori 2,2 97,8 Attività di mutuo aiuto e tutoraggio tra genitori 0 100 Laboratori pratici con famiglie italiane e straniere (corsi di informatica, di lingua, ecc.) 0 100
Sarebbe piuttosto necessario favorire incontri ed esperienze innovative dentro e
fuori i centri di formazione, soluzioni che non appaiono dai risultati del questionario particolarmente praticate: in questa prospettiva, è possibile guardare alle esperienze europee (Eurydice, 2009) che si sono mosse con molteplici iniziative per sviluppare il supporto dei genitori all’istruzione dei propri figli, ad esempio, con programmi di visite a casa, inviando periodicamente facilitatori e tutor delle stesse comunità presso le case delle famiglie, al fine di insegnare ai genitori come facilitare l’apprendimento dei figli attraverso una supervisione dei compiti a casa o, in alternativa, incoraggiando la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche, per favorire con lavori cooperativi l’apprendimento curricolare.
L’approfondimento dell’indagine rispetto ai percorsi di accompagnamento degli allievi stranieri nella transizione al lavoro, infine, parte dalla considerazione che l’uguaglianza delle opportunità appare essere più garantita nel campo della formazione che in ambito lavorativo. Al momento dell’ingresso nel lavoro, è possibile che i giovani stranieri scontino gli effetti sfavorevoli di un mercato professionale segmentato, dove non esistono per loro molte possibilità al di fuori dei lavori “per immigrati”, anche se i figli non vogliono svolgere più lo stesso mestiere dei genitori. Molti giovani stranieri hanno anche notevoli difficoltà nell’accesso all’occupazione, in quanto sono vittime di pregiudizi, stereotipi o discriminazioni. Le recenti analisi del Cnel (2009) mettono in luce una netta prevalenza dei percorsi informali per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, che determinano condizioni favorevoli a rapporti di impiego irregolari e in nero, fino a situazioni di estremo sfruttamento e a rischio di utilizzazione da parte della criminalità organizzata.
Sulla base di tali problematiche, emerge l’importanza dell’accompagnamento svolto dalle agenzie formative torinesi, ad esempio mediante l’inserimento di moduli sulla ricerca del lavoro nell’ambito dei corsi (relativi a scrittura e presentazione di
27
curriculum vitae, simulazione di colloqui di lavoro, presentazione dei servizi per il lavoro, sviluppo di un vocabolario specifico nei corsi di italiano su lessico tecnico specialistico, ambiente e sicurezza sul lavoro, ecc.), che si pongono gli obiettivi di offrire strumenti per la ricerca lavorativa, di mettere in contatto gli allievi con intermediari (centro per l’impiego, agenzie interinali, ecc.) ed aziende, di garantire supporto agli ex allievi nel momento delle scelte formative e lavorative. Tab. VII - Percorsi di accompagnamento al lavoro attivati presso i CFP Sì No Stage/tirocini 95,6 4,4 Inserimento nei corsi di formazione di moduli sulla ricerca del lavoro 57,8 42,2 Sportelli informativi e servizi di orientamento al lavoro 37,8 62,2 Accompagnamento individuale alla ricerca del lavoro 33,3 66,7 Collegamento tra corsi di lingua italiana e formazione al lavoro 2,2 97,8
Molto significativi per l’orientamento lavorativo sono, inoltre, gli stage e i tirocini,
che rappresentano un primo contatto degli allievi con il mondo del lavoro, rispetto ai quali i formatori spesso assolvono il compito di facilitare la comunicazione tirocinante/azienda, favorendo la comprensione linguistico-culturale in una dinamica relazionale necessariamente interculturale. Nel complesso, gli stage costituiscono esperienze positive, dal momento che in molti casi si verifica l’assunzione nell’azienda dello stage sia degli allievi stranieri sia degli italiani: solo in limitate occasioni si verifica un rifiuto di stranieri in stage da parte delle aziende. Il ruolo del CFP nel trovare lavoro, inoltre, risulta molto più importante rispetto alla rete di rapporti informali familiari o al ruolo dei servizi pubblici. Anche in questo caso, tra l’altro, si tratta al 100% di prassi adottate anche per gli allievi italiani, frutto di percorsi di accompagnamento che si sviluppano dai bisogni del singolo allievo.
In tempo di crisi, poi, l’accompagnamento al lavoro risulta essere di fondamentale importanza, in particolare per i soggetti più deboli come gli allievi stranieri, anche se nel prefigurare alcuni cambiamenti derivanti dalla crisi, i centri non evidenziano particolari difficoltà per i giovani stranieri in campo lavorativo, ma non sono neanche a conoscenza di dati certi su cui fondare le proprie affermazioni. Per far fronte alle difficoltà presenti e future, quindi, secondo l’opinione dei docenti, sarà necessario: migliorare il raccordo tra istruzione, formazione e lavoro; realizzare uno studio approfondito dei fabbisogni formativi del territorio; individuare i settori professionali in cui vi sono maggiori possibilità occupazionali per i giovani stranieri. Sarà anche opportuno sviluppare, attraverso adeguate politiche, un approccio sinergico che tenga in considerazione i bisogni dei giovani, delle loro famiglie e anche dei datori di lavoro. In effetti, è fondamentale comprendere le motivazioni e l’atteggiamento di chi
28
offre esperienze lavorative, sapendo che essi sono portatori di aspettative rispetto agli operatori che presentano loro i giovani o rispetto alle istituzioni in cui si sono formati professionalmente. Un rapporto positivo tra questi soggetti, una trasparenza su reali opportunità e limiti risulta essere, dunque, un elemento strategico. La strada da percorrere può essere, pertanto, quella della costruzione di accordi con il mondo delle imprese, indispensabile per rendere efficaci gli interventi di accompagnamento al lavoro, strutturando prassi di relazione tra le parti che rendano stabile e duratura l’azione e contribuiscano a migliorare i soggetti e i contesti in cui si opera. Alcune riflessioni conclusive
Dall’analisi complessiva dei risultati di indagine, dal punto di vista degli allievi migranti e delle politiche formative, emerge che l’inserimento in percorsi di formazione rivela una funzione centrale: - nell’incremento del capitale sociale degli stranieri (che riescono a costruire nella formazione professionale relazioni significative con docenti, tutor, orientatori, ecc., i quali accompagnano i giovani in momenti complessi di transizione, quali l’accesso al centro, il successo formativo, lo stage, la ricerca del lavoro, ecc., adulti che mediano e spesso si assumono anche la responsabilità dell’insuccesso degli allievi); - nell’incremento delle risorse culturali necessarie ad un positivo inserimento professionale, offrendo la possibilità di tempi e ritmi diversi di insegnamento (e di conseguenza di apprendimento); supportando nel passaggio dal saper fare al saper essere, con un notevole incremento di fiducia e autostima per giovani che hanno perso nel processo migratorio molti punti di riferimento, certezze e stabilità; fornendo la possibilità di rimotivarsi allo studio attraverso attività pratiche; garantendo l’opportunità di trasformare la dimensione del fare (nei laboratori e negli stages) nella dimensione dell’impegno, del prendere l’iniziativa, della progettualità; - nel favorire la capacità di convivere, collaborare e cooperare tra diversi attraverso i laboratori ed un tempo lungo di convivenza (con attività alla mattina e al pomeriggio), superando incomprensioni e conflitti; - attraverso un’esperienza in cui la formazione riesce a tutelare e promuovere i giovani nei contesti lavorativi, ma soprattutto è funzionale a percorsi di cittadinanza, di assunzione di responsabilità, di scoperta di diritti e doveri da esercitare nel mondo del lavoro e, più in generale, nel contesto sociale.
Dal canto loro, le agenzie formative, attraverso strategie consolidate, sperimentate con soggetti svantaggiati o con bisogni specifici di sostegno e accompagnamento, si trovano a dover adeguare le proprie prassi, per accogliere e sostenere gli allievi stranieri. Un’elevata personalizzazione dell’offerta formativa e una capacità di rispondere a bisogni specifici, tuttavia, costituisce il corrispettivo della diffusione di
29
prassi spontanee, poco formalizzate e scarsamente condivise; così come il riadattamento di prassi rivolte a soggetti con bisogni di sostegno parte dall’errore di assimilare tutti gli allievi stranieri ad una fascia debole e svantaggiata, dato non confermato dalle molte interviste con giovani con molteplici risorse culturali e sociali.
Per offrire reali opportunità di successo formativo e di professionalizzazione, la formazione sta attualmente cercando di passare dalla gestione dell’accoglienza generalizzata dei figli adolescenti degli immigrati – data anche dall’assenza di consapevolezza delle specificità dell’utenza straniera e dalla scarsità di risorse umane e finanziarie per trattare le diversità culturale –, alla costruzione reale di chance di inclusione sociale: ad esempio, attraverso un monitoraggio costante dei cambiamenti dell’utenza e delle pratiche dei CFP, la prevenzione della dispersione e dell’abbandono, favorendo l’accompagnamento verso sbocchi occupazionali corrispondenti ai percorsi formativi, contrastando la discriminazione e le forme stereotipate nelle relazioni nell’ambito formativo e lavorativo, garantendo così la necessaria attenzione alla disuguaglianza di opportunità degli stranieri nel mercato del lavoro.
A partire dal riconoscimento dell’importanza di questo ampliamento di orizzonte – dall’accoglienza alla costruzione di spazi di cittadinanza –, le istituzioni formative potranno essere decisive nel percorso di cittadinizzazione di queste nuove generazioni, proprio perché orientate alla formazione per il lavoro (e quindi per la cittadinanza), mediante una presa di coscienza dell’integrazione come progetto da chiarire e da costruire, in un percorso formativo che offra non assistenza a giovani disagiati ma promuova percorsi di cittadinanza.
Bibliografia di riferimento Ambrosini M., (2000). Accogliere attivamente. La risorsa della formazione professionale per la promozione
sociale degli immigrati, Torino, Casa di Carità Arti e Mestieri. Asgi, (2009). I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l’entrata in vigore della legge n.
94/2009 [Online]. Available: www.asgi.it/ Banks J. A., (2008). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age. Educational
Researcher, vol. 37, n. 3, 129-139, [Online]. Available: er.aera.net/ Beck U., (2003). Lo sguardo cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale, Bologna, il Mulino. Besozzi E., (2009). “Dimensioni della cittadinanza e nuovi cittadini”, in Luatti L. (a cura di), Educare alla
cittadinanza. Luoghi, metodi, discipline, Roma, Carocci, 21-31. Besozzi E., Colombo M., (a cura di), (2007). Giovani stranieri tra presente e futuro, Milano, ORIM, Fondazione
Ismu. Besozzi E., Colombo M., (a cura di), (2009). Tra formazione e lavoro. Giovani stranieri e buone pratiche nel
sistema della formazione professionale regionale, Milano, ORIM, Fondazione Ismu. Besozzi E., Colombo M., Santagati M., (a cura di), (2009). Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una
generazione ponte, Milano, FrancoAngeli.
30
Canino P., (a cura di), (2010). Stranieri si nasce… e si rimane? Differenziali nelle scelte scolastiche tra giovani italiani e stranieri, Quaderni dell’Osservatorio, n. 3, Fondazione Cariplo, Milano.
Cesareo V., (2009). “Quale integrazione”?, in Cesareo V., Blangiardo G. C., Indici di integrazione, Milano, FrancoAngeli, 11-28.
Cnel, (2009). Indici di integrazione degli immigrati in Italia. Il potenziale di inserimento socio-occupazionale dei territori italiani. VI Rapporto, Roma [Online]. Available: www.portalecnel.it/
Colombo E., (2010). Figli di migranti in Italia. Identificazioni, relazioni, pratiche, Torino, Utet Università. Colombo E., Domaneschi L., Marchetti C., (2009). Una nuova generazione di italiani. L’idea di cittadinanza tra i
giovani figli di immigrati, Milano, FrancoAngeli. Colombo M., Santagati M., (2010). Interpreting social inclusion of young immigrants in Italy. Italian Journal of Sociology of Education, digital review (www.ijse.eu), n. 1, 9-48. Commission of the European Communities, (2008). Green Paper. Migration and mobility: challenges and
opportunities for EU Education Systems, Bruxelles [Online]. Available: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:EN:PDF/
Crul M., Thomson M., (2007). The Second Generation in Europe and the United States: How is the Transatlantic Debate Relevant for Further Research on the European Second Generation? Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 33, n. 7, 1025-1041.
Crul M., Vermeulen H., (2003). The Second Generation in Europe. International Migration Review, vol. 37, n. 4, 965-986.
Dahrendorf R., (1981). La libertà che cambia, Roma-Bari, Laterza. Eurydice, (2009). Integrating Immigrant Children into Schools in Europe, Brussels, European Commission
[Online]. Available: www.eurydice.org/ Fondazione Giovanni Agnelli, (2010). Rapporto sulla scuola in Italia 2010, Roma-Bari, Laterza. Gilardoni G., (2008). Somiglianze e differenze. L’integrazione delle nuove generazioni nella società multietnica,
Milano, FrancoAngeli. Giovannini G., (2010). Immigrati: diversi/non “speciali”, Intervento al Seminario Interregionale del MIUR sull’Orientamento, Ischia [Online]. Avalaible: www.graziellagiovannini.it/ Hagan J., MacMillan R., Wheaton B., (1996). New Kid in Town: Social Capital and the Life Course Effects of
Family Migration on Children. American Sociological Review, vol. 61, n. 3, 368-385. Isfol, (2009). Rapporto 2008, Cosenza, Rubbettino. Kymlicka W., (1999). La cittadinanza multiculturale, Bologna, il Mulino. Levels M., Dronkers J., (2008). Educational performance of native and immigrant children fron various countris of
origin. Ethnic and Racial Studies, vol. 31, n. 8, 1404-1425. Luciano A., (2004).Scuola, formazione e lavoro. Transizioni difficili. Quaderno Formazione e Lavoro, Torino,
Provincia di Torino, Città di Torino, 9-17. Luciano A., (2005). “Dieci anni di formazione professionale a Torino”, in Osservatorio del mondo giovanile,
Giovani 2000. Rapporto sulla condizione giovanile negli ultimi 10 anni, Torino, Regione Piemonte, Città di Torino, 71-90.
Malizia G., Pieroni V., Santos Fermino A., (2008). Individuazione e raccolta di buone prassi mirate all’accoglienza, formazione e integrazione degli immigrati, CNOS FAP, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, CIOFS, Roma.
Marshall T. H., (2002). Cittadinanza e classe sociale, Roma-Bari, Laterza. Miur, (2009). Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.s. 2008/09, Roma, [Online]. Available:
www.istruzione.it/ Niessen J. et Al., (2007). Indice delle politiche per l’integrazione degli immigrati, Bruxelles, British Council. Nomisma, (a cura di), (2009). L’immigrazione in Italia tra identità e pluralismo culturale, Ministero dell’Interno,
DDE Editrice, Roma. Nusche D., (2009). What works in migrant education? A review of evidence and policy options, Directorate for
education, OECD Working paper n. 22, [Online]. Available: www.oecd.org/document/ Oecd, (2006). Where immigrant students succeed. A comparative review of performance and engagement in
PISA 2003, Programme for International Student Assessment, Paris, [Online]. Available: http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf/
31
Osservatorio Istruzione Piemonte, (2009). Rapporto 2008, Regione Piemonte, [Online]. Available: http://www.sisform.piemonte.it/irapporto.html/
Portes A., Fernandez-Kelly P., Haller W., (2009). The Adaptation of the Immigrant Second Generation in America: A Theoretical Overview and Recent Evidence. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 35, n. 7, 1077-1104.
Procacci G., (2008). “Quale cittadinanza per gli immigrati?”, in Besozzi E. (a cura di), Immigrazione e contesti locali, Milano, Vita e Pensiero, p. 107-122.
Ravecca A., (2009). Studiare nonostante. Capitale sociale e successo scolastico degli studenti di origine immigrata nella scuola superiore, Milano, FrancoAngeli.
Regione Piemonte, (2005). Politiche formative e del lavoro. Quaderni della Regione Piemonte, n. 1. Ricucci R., (2010). Italiani a metà. Giovani stranieri crescono, Bologna, il Mulino. Rozzi E., (2009). Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e
all’accesso ai servizi socio-educativi dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/09, [Online]. Available: www.asgi.it/
Santagati M., (2007). “Ruolo della formazione nel lavoro di cura”, in Lazzarini G., Santagati M., Bollani L. (a cura di), Tra cura degli altri e cura di sé. Percorsi di inclusione lavorativa e sociale delle assistenti familiari, Milano, FrancoAngeli, 233-264.
Santagati M., (2009a). “La scuola”, in Fondazione Ismu, Quindicesimo Rapporto sulle migrazioni 2009, Milano, FrancoAngeli, 107-124.
Santagati M., (2009b). “Un’indagine sugli adolescenti stranieri nella formazione professionale della provincia di Torino: percorsi dei giovani e prassi del sistema formativo”, in Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in Provincia di Torino, Rapporto 2008, Città di Torino, Prefettura di Torino, Torino, 276-286.
Scardigno A. F., (2005). Tra scuola e formazione. La sperimentazione del doppio canale, Molfetta, La Meridiana. Sennett R., (2008). L’uomo artigiano, Milano, Feltrinelli. Zanfrini L., (2007). Cittadinanza. Appartenenza e diritti nella società dell’immigrazione, Roma-Bari, Laterza. Zincone G. (a cura di), (2006). Familismo legale. Come (non diventare italiani), Roma-Bari, Laterza.
































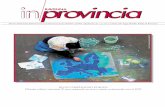





![Αποδείξεις αστικής ιδιότητας στην Κρήτη το 17ο αιώνα [Prove di cittadinanza a Creta nel XVII secolo], in Πεπραγμένα του Ζ΄](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6316115dfc260b7102104940/podeikseis-stikis-idiotits-stin-kriti-to.jpg)