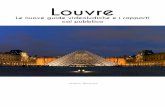La Nereide su pistrice da Posillipo. Vecchi dati e nuove acquisizioni.
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione
Transcript of Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione
RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA / a. L, n. 3, luglio-settembre 2009
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione
di Giovanna Procacci
1. Introduzione
È indubbio che il principio della cittadinanza, che siamo abituati a guardare come un principio basilare della forma demo-cratica delle nostre società, stia subendo in questi ultimi decenni delle importanti trasformazioni, per effetto dei processi di globa-lizzazione che ridisegnano lo spazio politico in cui viviamo. In effetti, nel dibattito scientifico su queste trasformazioni, un tratto comune a molti autori, pur da punti di vista diversi, consiste nel considerare la cittadinanza come un principio in un certo senso superato nella costruzione e definizione dell’appartenenza a una comunità, esauritosi con l’esperienza dello spazio nazionale che i processi di globalizzazione tendono a rendere obsoleta. Se è vero che gli stati nazionali perdono potere, si osserva da più parti, allora non è più l’appartenenza alla comunità nazionale che conta; la cittadinanza finirebbe così per descrivere ormai solo uno spazio di privilegi, e quindi di esclusione.
Il dibattito propone piuttosto altri criteri per la comunità, di carattere culturale e identitario, o transnazionale, cosmopolitico, riferito a sistemi di norme internazionali, come i diritti umani; al loro confronto, la cittadinanza appare un criterio troppo rigido per render conto della mobilità delle popolazioni, troppo politico per rispondere alle domande di società ormai fortemente multiculturali. D’altro canto, fenomeni nuovi come quello della costruzione di una società europea, che rappresentano il superamento dei confini degli stati nazionali, continuano ad essere pensati in termini di cittadinanza, come testimonia un altro dibattito che si è aperto anche nelle scienze sociali sulla cosiddetta «cittadinanza europea» che dovrebbe essere parte integrante della costruzione di una
Giovanna Procacci410
società europea. Già solo una simile contraddizione potrebbe far nascere dubbi sul fatto che la cittadinanza sia oggi solo la descrizione di una nuova frattura (cleavage) fra cittadini e non cittadini, e non esprima più una tensione a costruire comunità. Diventa allora per lo meno legittimo chiedersi se sia poi così vero che lo stato nazionale perda potere e che la cittadinanza descriva solo un’appartenenza nazionale e, in quanto tale, sia ormai superata.
La mia analisi prende le mosse da queste domande che vorrei affrontare interrogando la cittadinanza a partire dai nessi con le politiche di immigrazione. Non si propone di fare una rassegna del dibattito critico sulla cittadinanza, né di discutere le varie posizioni in cui si articola (si veda per questo l’articolo di Enzo Colombo in questo stesso numero). Non intendo nemmeno con-frontarmi direttamente con una posizione critica in particolare. Vorrei piuttosto affrontare il tema indicato a partire da un punto specifico: mi sembra che si possa rintracciare in più approcci critici della cittadinanza, pur nella varietà di prospettive già ri-cordata, un tratto comune che le attraversa, e che consiste nel trattarla prevalentemente nella sua dimensione nazionale, la quale per l’appunto si eroderebbe con l’erosione dello stato nazionale. Sembrano sparire invece altre dimensioni della cittadinanza che T.H. Marshall aveva messo in luce analizzandone la dinamica espansiva; in particolare, il mio intento è riportare nel dibattito quelle dimensioni sostanziali di attiva partecipazione alla comunità che il sociologo inglese aveva concettualizzato come «cittadinanza sociale». Vorrei qui sostenere che solo ribadendo il carattere multidimensionale della cittadinanza (parte 1) sia possibile far emergere connessioni con altri processi che sono oggi in gioco in queste trasformazioni, primo fra tutti la crisi dello stato sociale che ha portato ad abbandonare l’obiettivo politico di ridurre le disuguaglianze, cruciale nella dinamica della cittadinanza.
Altri obiettivi sono emersi prepotentemente al centro della scena politica, in particolare quelli legati al controllo delle migrazioni. È evidente che l’intensificazione dei processi migratori modifica costantemente confini e condizioni delle comunità nazionali, al-largando al loro interno la presenza di non-nazionali e sfidando, così, la cittadinanza. Ma l’analisi incrociata di questi due settori di politiche (parte 2) permette di evidenziare dei limiti delle critiche odierne alla cittadinanza: da un lato, proprio l’immigra-zione rappresenta un baluardo del potere degli stati nazionali;
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 411
dall’altro, le politiche di cittadinanza nazionale (naturalizzazione) si rivelano insufficienti ad integrare, sia perché costrette ad ade-guarsi ad obiettivi prevalenti di contenimento dell’immigrazione, sia perché nel quadro mutato delle migrazioni contemporanee tendono ad assumere significati nuovi nell’esperienza stessa dei migranti (parte 3). L’esperienza italiana (parte 4), ancorata come è a una legge di cittadinanza datata e inadeguata allo stato at-tuale dell’immigrazione nel nostro paese, conferma tutti questi limiti. L’ipotesi che avanzo, allora, è che solo rivalutando le strategie di cittadinanza sociale sia possibile rovesciare in senso virtuoso il legame fra cittadinanza e immigrazione, recuperando le potenzialità inclusive della cittadinanza per costruire un di-verso approccio alle migrazioni, che punti meno sul controllo e molto di più sull’integrazione effettiva degli immigrati nelle società in cui vivono – e di cui, proprio per questo, è cruciale che si sentano cittadini.
2. Le dimensioni della cittadinanza
Marshall (1950) ha avuto il grande merito di mettere al centro dell’analisi della cittadinanza, sino ad allora vista solo come uno status giuridico-politico, il suo carattere multidimensionale, espresso dai diversi sistemi di diritti che genera. Una dimensione è cer-tamente quella della cittadinanza formale data dall’appartenenza ad uno stato, l’esser per questo soggetto di quei diritti e doveri che regolano i rapporti politici fra stato e cittadini. In questo senso, la cittadinanza disegna la comunità come una comunità nazionale, è praticamente un sinonimo di nazionalità; anzi, il legame fra cittadinanza e nazionalità appare «naturale». Siamo qui in un sistema binario: da un lato, chi fa a pieno titolo parte di una comunità politica, la nazione, e dall’altro lo straniero che non ne fa affatto parte. Come tutti quei concetti che regolano i confini di una comunità, le linee di separazione fra chi sta dentro e chi è fuori, anche la cittadinanza ha inevitabilmente funzionato come un criterio contemporaneamente di inclusione e di esclusione; anzi, le società politiche si sono distinte per un uso più inclusivo o più esclusivo della cittadinanza. Ora, nella misura in cui i processi di globalizzazione oggi tendono a sottrarre prerogative e a limitare il potere dello stato nazionale, sembra inevitabile che il principio della cittadinanza come sinonimo di
Giovanna Procacci412
nazionalità segua le stesse sorti dello stato nazionale e subisca oggi i contraccolpi di quelle limitazioni.
Se per Marshall, però, come osserva John Crowley (1998), il carattere nazionale dello stato entro cui si sviluppa la citta-dinanza è un dato scontato, è anche vero che né la nazione, né la cittadinanza sono prese come entità fisse, ma come forze dinamiche in continuo movimento, e questo movimento implica processi sociali di integrazione che sono poi concretamente alla base della costruzione della nazione stessa. Ciò che caratterizza però una comunità nazionale costruita sulla base di dinamiche espansive di cittadinanza è che l’appartenenza alla comunità è coniugata attraverso diritti e doveri; dunque anche quando identifica l’appartenenza a una nazione la cittadinanza, nono-stante la pretesa «naturalità», non è costruita principalmente su legami originari d’identità, ma su legami di diritto che si possono acquisire o sciogliere. Anzi, può apertamente travalicare gli aspetti culturali: i cittadini di uno stato nazione non devono per forza appartenere tutti alla cultura nazionale. Cosicché, la cittadinanza ha permesso di costruire una comunità di diritto che ha rappresentato per molti anche un’emancipazione dalla comunità originaria d’identità.
Per questo l’analisi di Marshall non si concentra tanto sulla dimensione nazionale della cittadinanza, che dà appunto per scontata, quanto su come realizzare effettivamente quella egua-glianza di status che è propria della cittadinanza, su come cioè unificare la comunità al di sopra delle comunità locali (ibidem, 171), siano esse segmentate per classe, per territori locali o altro. Lo status giuridico che identifica nella cittadinanza l’appartenenza formale allo stato nazionale cede qui il passo allo studio di quei concreti processi di cittadinanza sostanziale, di quelle pratiche condivise che costruiscono identità, sentimento di appartenenza e sistemi di solidarietà. È proprio in forza di questa dimensione della cittadinanza come dinamica di integrazione sociale che le nazioni europee si sono ricostruite nel secondo dopoguerra e che le nostre società si sono politicamente consolidate attraverso una tendenziale coincidenza fra residenti stabili e cittadini, in nome di un altro principio fondamentale della democrazia secondo il quale nessuno deve essere soggetto a leggi sulla cui formulazione non ha voce né modo di influire (Carens 1989; Beckman 2006).
La cittadinanza sociale rimane un concetto fondamentale per l’esperienza moderna di cittadinanza, che ne descrive dimensioni
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 413
concrete e irrinunciabili; non è tanto l’appartenenza nazionale che regola l’accesso a questa dimensione della cittadinanza, quanto la partecipazione attiva alla vita della comunità. I diritti sociali in tanto sono basati sulla cittadinanza, in quanto nascono non dalla nazionalità, ma dalla compartecipazione di pratiche sociali: educazione, lavoro, servizi. I diritti sociali non derivano dall’ap-partenenza, ma la fondano e la costruiscono, prendendo corpo in insiemi istituzionalizzati di diritti e doveri, di moderne politiche di welfare. Da questo punto di vista, allora, la cittadinanza non descrive un’appartenenza binaria, dentro o fuori, come la nazio-nalità, ma ha una sua dinamica, una sua gradualità; espandere la cittadinanza, ancor prima di includere lo straniero, significa estendere il grado di partecipazione per realizzare una piena appartenenza basata sull’uguaglianza di status. È in quanto status sociale che la cittadinanza testimonia l’attiva partecipazione alla vita della comunità, che ha consentito di estendere il consenso sociale, di integrare nella comunità anche lo straniero, che ha rappresentato il principio espansivo capace di costruire la nazione come comunità di diritti, e non a partire da identità culturali.
La cittadinanza è dunque un concetto necessariamente mul-tidimensionale, che esprime contemporaneamente uno status, un’attività, un’identità; che si traduce in un passaporto, certo, ma anche in diritti sociali e in istituti di welfare. Eppure è proprio questo che spesso si perde di vista nelle critiche odierne contro il principio di cittadinanza, che tendono a chiamarne in gioco prevalentemente la dimensione di status giuridico che identifica un legame di nazionalità. Non c’è dubbio che questa dimensione della cittadinanza sia oggi sfidata dai movimenti migratori, come dall’intensificarsi di rapporti di interdipendenza fra stati nazio-nali sotto la spinta dei processi di globalizzazione: per effetto di questi processi cresce il numero di persone che vive altrove rispetto al paese di cui è cittadino, che appartiene dunque a più comunità. Finché la cittadinanza si era espansa in un ambito di relativa omogeneità dal punto di vista della nazionalità, tutte le sue dimensioni sono apparse utili per costruire comunità, per includere chi non era pienamente cittadino, compresi gli stranieri; anzi, è oggi un dato acquisito dalla letteratura sociologica che, nonostante limiti e difficoltà, proprio gli istituti di welfare basati sulla cittadinanza sociale abbiano contribuito in modo decisivo, all’integrazione degli immigrati nelle società di residenza (Geddes 2000, 213; Bauböck 2006, 24). Quando invece quella omogenei-
Giovanna Procacci414
tà si spezza, come appunto avviene oggi, lo status giuridico di nazionalità rischia di fondare discriminazioni fra chi lo possiede e chi no, fra nazionali e non-nazionali; tanto più che l’identità nazionale si rafforza come reazione alle insicurezze prodotte dall’omogeneità perduta. Riemerge così il confronto diretto con lo straniero, con colui che non condivide l’appartenenza di status; in questa dimensione tutta nazionale, il concetto di cittadinanza appare in effetti troppo rigido ed escludente per rendere conto di un mondo siffatto.
A questa tendenza delle critiche attuali a trattare la citta-dinanza come unidimensionale, si aggiunge un altro elemento rilevante nel disegnare il contesto politico attuale, e cioè che la cittadinanza sociale è oggi a sua volta contestata in nome della crisi dei sistemi di welfare. Cosicché alla critica della cittadinanza come status giuridico, che sarebbe incapace di interpretare il diritto in un mondo tendenzialmente post-nazionale, o cosmo-politico, o multiculturale, si affianca l’erosione della cittadinanza sociale, travolta dalla riorganizzazione delle politiche sociali su criteri diversi dai diritti sociali di cittadinanza. Non solo, ma proprio quegli istituti di cittadinanza sociale, economica, sanita-ria, educativa, ecc., che più hanno contribuito all’integrazione, sono oggi guardati con sospetto, sotto l’influenza di politiche migratorie che non li interpretano più tanto come delle vie di integrazione, ma come dei fattori di attrazione che spingono gli immigrati fino alle porte delle nostre società, da cui le politiche migratorie vorrebbero invece tenerli lontano. Succede spesso, nell’ottica economicistica che predomina la percezione politica del fenomeno migratorio come progetto puramente economico, di sentir rimproverare agli immigrati di non venire nelle nostre società solo per il lavoro, ma anche per la scuola, gli ospedali, le pensioni ecc., in una parola con intenti considerati «abusivi» sin dall’inizio. Come se ci fosse da meravigliarsi che la prospettiva di poter fare studiare i propri figli, di potersi garantire cure sanitarie e piani previdenziali attragga le persone che vivono in paesi in cui questi istituti di protezione sociale non sono garantiti.
La chiusura della cittadinanza sulla nazionalità e la perdita d’interesse politico per strategie e obiettivi della cittadinanza so-ciale convergono a delineare un orizzonte politico in cui matura la cosiddetta crisi attuale della cittadinanza. Analizzare i nessi oggi di cittadinanza e migrazioni permette allora di mettere in luce un aspetto paradossale di questa crisi: la cittadinanza viene
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 415
messa in discussione e sembra perdere d’importanza proprio quando, per effetto dell’intensificarsi dei movimenti migratori, nelle nostre società si riallarga in modo pericoloso lo scarto fra chi vi risiede e chi ne è cittadino, che invece sembrava tendenzialmente scongiurato. Il che non è privo di conseguenze dal punto di vista della tenuta democratica delle nostre società, se non altro perché aumenta il numero di persone che si tro-vano a vivere sotto leggi che non hanno in niente contribuito a determinare, in contrasto con quel principio democratico già richiamato (Beckman 2006). Si tratta dunque di un nesso che può dare anche chiavi di lettura di un problema più ampio: il deficit di democrazia che cresce oggi nelle nostre società.
3. Le politiche di cittadinanza e gli immigrati
L’esistenza stessa di procedure di «naturalizzazione» attraver-so cui è possibile acquisire una cittadinanza nazionale mette in luce la portata retorica della pretesa «naturalità» del legame di cittadinanza nella nazione; è evidente che si tratta invece di una costruzione tutta politica, soggetta alla forza di pressione e alla capacità di mediazione di portatori di interessi diversi. Certo, i fattori che incidono sull’acquisizione di cittadinanza sono molti e di natura diversa; alcuni sono di natura individuale, legati ai caratteri propri di ogni progetto migratorio e all’insieme di vantaggi e svantaggi che la scelta di diventare cittadini del pa-ese di residenza presenta rispetto a quel progetto; ci ritornerò più avanti. Ma la decisione di chiedere la cittadinanza non può prescindere anche da fattori di natura più strutturale; fra questi, le politiche di cittadinanza rivestono un ruolo decisivo, nella misura in cui fissano limiti e condizioni, determinano, appunto, vantaggi e svantaggi. Il riconoscimento, per esempio, della doppia cittadinanza da parte di un numero sempre crescente di stati (sia di accoglienza, che di origine) ha avuto un enorme impatto sulle naturalizzazioni in Europa degli immigrati extracomunitari, mentre ne ha avuto uno molto minore sugli stranieri di provenienza da altri stati membri dell’UE, nella misura in cui i vantaggi di cui godono all’interno dell’Unione, in particolare circa la libertà di movimento, non li porta se non in casi particolari a sentire il bisogno di acquisire una seconda cittadinanza nel paese di resi-denza (Böcker e Thränhardt 2006).
Giovanna Procacci416
Queste politiche variano da paese a paese e possono favorire o invece scoraggiare tali domande. Paesi a tradizione emigratoria, nell’intento di preservare il legame con i connazionali insediatisi all’estero, tendono ad ispirare le leggi di cittadinanza allo jus sanguinis e presentano in genere caratteri più restrittivi. Mentre paesi che tradizionalmente hanno ancorato le leggi di cittadinanza al principio dello jus soli, principio più idoneo a paesi d’immigra-zione, tendono ad essere più aperti. Si tratta dei due poli entro i quali si collocano le politiche nazionali (Brubaker 1992); nella pratica, né l’uno né l’altro funzionano in modo puro, ma in una qualche forma di composizione fra di loro e con altri principi, come il diritto di matrimonio e il principio della lunga residenza o jus domicilii, che tende oggi ad imporsi un po’ in tutti paesi come l’elemento chiave di queste politiche (Castles e Davidson 2000). È pur vero che, come osserva Patrick Weil (2001), mal-grado le differenze storiche, politiche e culturali, i paesi europei tendono ad orientare le loro politiche di cittadinanza in modo convergente, attraverso una certa liberalizzazione dello jus sanguinis in direzione dello jus soli e, per converso, una flessione dello jus soli verso la reintroduzione di certi aspetti di jus sanguinis. Nonostante una tale convergenza tendenziale, però, le politiche nazionali conservano variazioni significative che incidono sulle acquisizioni di cittadinanza. Addirittura all’interno dello stesso paese le politiche di cittadinanza possono cambiare, come si è visto, per esempio, in Olanda nel corso degli anni ’90: se nella prima metà del decennio un regime molto liberale basato su un ampio riconoscimento della doppia cittadinanza aveva consentito un gran numero di acquisizioni di cittadinanza, negli anni succes-sivi un irrigidimento di quelle politiche ha compresso fortemente verso il basso le naturalizzazioni di nuovi cittadini.
Un fattore cruciale che spinge verso una convergenza è rap-presentato indubbiamente dall’azione delle organizzazioni inter-nazionali, la quale in questi anni si è concentrata in particolare sulla lotta contro le discriminazioni; anzi, proprio la disciplina anti-discriminazione è uno dei settori di legislazione che sono stati maggiormente sottratti alle prerogative dello stato nazionale. Le convenzioni internazionali hanno fatto proprio l’obiettivo di lottare contro le discriminazioni, agendo in nome dell’universalismo dei diritti umani e obbligando gli stati a conformarsi; in particolare, è questo un imperativo cruciale della politica comunitaria dell’UE, consolidato in Direttive che hanno avuto un grande impatto
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 417
anche sulle politiche nazionali (Direttiva 2000/43/EC contro le discriminazioni etniche e razziali, Direttiva 2000/78/EC contro le discriminazioni sul lavoro). Le politiche di cittadinanza entrano in contatto con questo obiettivo in quanto colpisce anche la discriminazione per ragioni etniche e di nazionalità, accanto a quelle per genere, età, opinione, religione, ecc. Nella misura in cui l’intensificarsi dei processi migratori rappresenta una sfida sempre maggiore dei confini nazionali, era prevedibile che, nel loro mescolare le nazioni, mettessero in luce effetti discriminatori in nome della nazionalità. Ma può bastare la battaglia contro le discriminazioni dei non-nazionali a definire le politiche di cittadinanza?
In realtà, il modo di funzionamento delle politiche anti-discriminatorie è profondamente diverso da quello che aveva orientato l’espansione della cittadinanza: qui non si persegue la riduzione delle disuguaglianze, ma si mette al bando una dispa-rità di trattamento fondata su criteri considerati illegittimi. Il risultato è che, più che integrare in una comunità proteggendo i più esposti a certi rischi sociali che li escluderebbero, queste politiche identificano un gruppo, o una categoria che è oggetto di illegittima disparità di trattamento; nel far questo, corrono il rischio di reificare le identità e di promuovere stigmatizzazione (Procacci 2006). Il loro successo rende probabilmente conto di un modello di azione pubblica più consono ai tempi che viviamo, complessivamente più preoccupati di preservare le identità che di ridurre le disuguaglianze, ma forse permette anche di vederne alcuni limiti proprio dal punto di vista del costruire la comunità. In questo senso, se è indubbio che l’azione internazionale con-tro le discriminazioni ha consentito una graduale apertura della cittadinanza verso la riduzione delle disuguaglianze fra nazionali e non-nazionali, che li ha cioè riavvicinati sul piano del diritto (Lochak 2003), non è bastata ad impedire che la nazionalità sia fonte di privilegi.
Sono molti gli indicatori di questa duplice tendenza di evoluzione delle politiche di cittadinanza. Da un lato, ci sono molti segni di questa estensione dei diritti di cittadinanza ai non-nazionali: la diffusione sempre maggiore del riconoscimento della doppia cittadinanza, nei paesi di accoglienza come in quelli di origine; l’espansione dello jus soli, anche in paesi come la Germania tradizionalmente legati allo jus sanguinis; l’apertura in alcuni casi alla partecipazione degli immigrati al voto locale
Giovanna Procacci418
(sono 12 i paesi dell’Unione che riconoscono il diritto di voto locale a tutti i residenti stranieri); il consolidarsi di forme di accesso ai diritti anche indipendentemente dallo status formale di cittadinanza (denizenship). Più in generale, possiamo dire che il carattere multietnico delle nostre società è ormai entrato nella nostra cultura; senza contare che l’esperienza stessa della citta-dinanza europea rappresenta per tutti i cittadini dei singoli stati membri un’esperienza concreta di appartenenze multiple.
D’altro lato, però, si tratta di un’evoluzione ancora molto incompleta, che non elimina vantaggi riservati ai cittadini e non garantisce, soprattutto, da regressioni di tipo illiberale. Basti pensare alla tendenza ad accrescere le richieste per la naturalizzazione, allungando il periodo di residenza richiesto e imponendo corsi cosiddetti «di integrazione» che prefigurano uno specifico dove-re degli immigrati da cui i nazionali sarebbero esenti (Bauböck 2006, 23); o la tendenza a restringere l’accesso degli immigrati ai diritti sociali anche in paesi che li avevano aperti, perfino a reintrodurre lo jus sanguinis in paesi, come Belgio e Francia, che avevano affidato alla residenza un ruolo centrale. In un certo senso, come osserva Christian Joppke (2007), è la liberalizzazione stessa della cittadinanza che sembra aver portato in alcuni casi a delle reazioni illiberali. Rimane vero, insomma, che il principio della nazionalità agisce ancora oggi come un criterio di discrimi-nazione, sebbene grazie all’azione internazionale le discriminazioni in nome della nazionalità non possano più essere considerate la norma, ma delle «eccezioni» che devono giustificare la deroga che operano al principio generale di eguale trattamento.
A ben guardare, però, le «eccezioni» nell’azione degli stati membri restano numerose, rilevanti e per lo più ingiustificate, nonostante l’impatto delle norme comunitarie. Gli stati restringono l’esercizio della cittadinanza, riservandolo a chi ne possiede la nazionalità, non solo per il diritto di voto, ma anche per diritti civili, come l’uguale accesso alla funzione pubblica, e per diritti sociali (Lochak 2008). Il fatto è che, in realtà, l’immigrazione agisce in modo ambiguo sullo stato; da una parte è vero che introduce nelle società nazionali una dimensione globale, espo-nendole all’azione politica sovranazionale, ma dall’altra rafforza il bisogno di identità nazionale e di coesione sociale di cui lo stato ha buon gioco a presentarsi come il garante, consolidando paradossalmente il proprio ruolo (Kofman 2005) e ravvivando la retorica nazionalistica. Per garantire l’identità nazionale contro i
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 419
rischi generati dalla presenza crescente degli stranieri, sul piano della sicurezza come su quello economico-sociale o culturale, è spinto a riservare ai propri cittadini tutta una serie di diritti e di vantaggi. Per di più, questa difesa della nazionalità si coniuga con politiche d’immigrazione tendenzialmente sempre più restrit-tive, che di nuovo appaiono come un terreno di rafforzamento dello stato nazionale: l’esercizio della sua sovranità sui propri confini gli consente di regolamentare gli accessi e il soggiorno degli stranieri sul suo territorio, di mettere in atto politiche dei visti e dell’espulsione che configurano una disuguaglianza fondamentale rispetto ai suoi cittadini. Cosicché il diritto di soggiorno e di lavoro non è un libero diritto del migrante, non è mai completamente certo, resta costantemente sotto la minaccia dell’espulsione. Una simile fragilità condiziona l’esercizio di tutti gli altri diritti da parte dello straniero.
C’è dunque sempre, nella condizione dell’immigrato, quello che Danièle Lochak (2008, 11) indica come «un dualismo con-traddittorio»: lo straniero immigrato ha dei diritti, ma per eser-citarli effettivamente deve sottoporsi a delle procedure d’ingresso, ottenere dei documenti, restare sotto controllo permanente da parte dell’amministrazione e della polizia, esporsi a misure di de-tenzione e di espulsione. Senza contare che, essendo i suoi diritti strettamente collegati all’attività lavorativa, il lavoro rappresenta per lui non solo l’attività economica da cui trarre il reddito, ma addirittura l’atto originario da cui discende il suo diritto a risiedere legalmente in un certo territorio; è evidente allora che il rischio di perdere il lavoro comporta il rischio di perdere il diritto fondamentale a risiedere, lasciando spesso agli immigrati un periodo di tempo molto breve per ritrovare un lavoro (solo 6 mesi, secondo la legge Bossi-Fini in Italia). La condizione di clandestino, insomma, non è mai definitivamente dietro le spalle, è sempre possibile ricaderci; la discriminazione si annida ormai molto spesso, ancor più che nel non-riconoscimento dei diritti, nelle limitazioni e nella precarietà cui sono soggetti questi diritti, anche quando siano riconosciuti agli immigrati.
Il fatto è che l’importanza dei fenomeni migratori odierni sposta l’attenzione politica verso altri obiettivi, incarnati dalle politiche migratorie. Se il criterio della cittadinanza aveva al suo centro la battaglia per ridurre il peso delle disuguaglianze in nome di un principio di eguale appartenenza, le politiche di immigrazione sono caratterizzate nei paesi europei da ormai
Giovanna Procacci420
due decenni da obiettivi di controllo dei flussi migratori, di li-mitazione del diritto ad immigrare, di contrasto all’intensificarsi della presenza di immigrati nelle nostre società. C’è dunque una contraddizione aperta fra le due serie di politiche. Il fatto che le politiche migratorie prevalgano su quelle della cittadinanza diventa così un problema, nella misura in cui predetermina il quadro e i limiti in cui la cittadinanza stessa e la sua acquisizione possono essere pensate.
Le politiche d’immigrazione tendono un po’ dappertutto ad essere più restrittive che permissive; il loro primo obiettivo è rendere l’immigrazione più difficile e poco attraente. Per que-sto si definiscono come politiche di controllo volte a limitare il numero dei migranti, a selezionarli, a subordinarli alle esigenze economiche del paese di accoglienza – mentre altre esigenze, come per esempio quelle demografiche, pure cruciali in molti paesi dell’Unione, tendono invece a passare in secondo piano. Cosicché la cittadinanza stessa deve subordinarsi a questi obiettivi restrittivi che mirano a scoraggiare l’immigrazione: non funziona più come una leva, un punto di forza nel processo di integra-zione dell’immigrato, ma assume il significato di un traguardo raggiungibile solo al culmine di uno sforzo, del tutto peculiare allo straniero, di integrazione già pienamente avvenuta. Negli ultimi decenni un po’ dovunque in Europa i costi imposti per l’acquisizione della cittadinanza sono aumentati, con il risultato che sempre più persone restano fuori dallo statuto di cittadino e che, come dicevo, lo scarto fra residenti stabili e cittadini si riallarga.
Siccome sono le leggi di cittadinanza che definiscono le regole per diventare cittadino, questa loro subordinazione agli obiettivi politici di contrasto dell’immigrazione influisce enor-memente sulle procedure di naturalizzazione che in ogni paese rappresentano la via maestra all’acquisizione di cittadinanza da parte dei non-nazionali. Diventare cittadini non è dunque un di-ritto dello straniero, definito sulla base di strategie di espansione della cittadinanza, ma dipende da un’azione discrezionale dello stato che, però, vuole innanzitutto contrastare l’immigrazione e per questo impone condizioni sempre più elevate: periodo di residenza, carattere legale della residenza, capacità linguistiche, conoscenza della cultura e della storia del paese, condizioni economiche, fedina penale e condizioni di moralità, giuramento di fedeltà. Se guardiamo ai dati sulle naturalizzazioni, vediamo
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 421
che negli anni Novanta le acquisizioni di cittadinanza sono cre-sciute in Europa in cifra assoluta: più di 3 milioni di persone hanno acquisito la cittadinanza di un paese membro fra il 1990 e il 2000, e la crescita è arrivata fino a raddoppiare nel 2000 le cifre del 1990. Ma dato l’incremento dell’immigrazione in questo stesso lasso di tempo, il tasso di naturalizzazione rispetto al numero degli immigrati presenti sul territorio della UE non è aumentato (Eurostat 2004). E se è vero che secondo le stime dell’Eurostat (2006) il numero degli stranieri residenti nell’UE nel 2004 erano circa 25 milioni (5,5% della popolazione), rimane un fatto rilevante che la stragrande maggioranza di loro sia ad oggi priva di cittadinanza e che si apra una tale falla nelle capacità di integrazione delle nostre società.
Naturalmente questo non significa che la situazione sia la stessa in tutti i paesi, anzi. Anche il numero delle naturalizzazioni varia molto secondo i paesi; Germania, Gran Bretagna e Francia fanno la parte del leone in questa crescita. Ma varia molto an-che la composizione interna (quanti nuovi cittadini provengono da paesi europei e quanti sono invece extra-comunitari), così come la percentuale di acquisizioni rispetto alla cifra assoluta di immigrati presenti nel paese. Il risultato è che circa la metà della popolazione residente nata all’estero in Francia e Svezia è stata naturalizzata, mentre al polo opposto Germania, Italia e Austria vedono la stragrande maggioranza della popolazione di origine straniera residente nei loro territori ancora priva di cittadinanza.
Le procedure variano molto anche nei confronti delle secon-de generazioni, i figli degli immigrati che sono nati nel paese di residenza o vi sono arrivati in tenera età, che sono quindi scolarizzati e integrati. Nei paesi europei le seconde generazioni non hanno un diritto automatico alla cittadinanza, come accade invece nei paesi del Nuovo Mondo. L’Irlanda è la sola eccezione, ma si tratta dell’ultimo paese di emigrazione che solo dal 1995 ha visto il saldo migratorio rovesciarsi a favore dell’immigrazione. I figli degli immigrati devono dunque passare attraverso le pro-cedure di acquisizione della cittadinanza, nonostante anche qui ci siano alcune differenze fra paesi più orientati verso il legame di sangue, come Germania, Austria e Italia, il cui approccio è molto restrittivo, e paesi legati alla residenza che tendono a presentare condizioni più favorevoli. Recentemente però anche paesi aperti a riconoscere automaticamente la cittadinanza alla maggior età,
Giovanna Procacci422
come la Francia, hanno adottato misure più restrittive, tese a renderne la concessione non più automatica, ma solo su richiesta del candidato e soggetta a certe condizioni (Weil 2001).
Proprio la situazione delle seconde generazioni nei confronti della cittadinanza rappresenta una chiave di lettura cruciale, in quanto dimostra che non solo rimane, nonostante un’espan-sione della cittadinanza verso i diritti dei non-nazionali, una disuguaglianza di fondo fra chi è cittadino e chi non lo è, ma soprattutto che la cittadinanza nazionale ha in realtà anche un’altra faccia. Lo sanno bene tutti i «nuovi» cittadini, che pure grazie alle procedure di naturalizzazione dovrebbero ormai far parte della cinta naturale di appartenenza di pieno diritto allo stato nazionale. Le seconde generazioni sperimentano tutti i giorni sulla propria pelle la disuguaglianza di trattamento che continua a caratterizzare i nuovi cittadini dai cittadini nazionali, a dimostrazione del fatto che molto spesso anche lo status di cittadino tanto agognato non protegge da discriminazioni, non elimina i privilegi dei nazionali. Le rivolte delle banlieues francesi del 2005 ne sono state la clamorosa conferma: non si trattava di giovani che chiedevano un riconoscimento culturale della loro comunità etnica di appartenenza, ma di giovani dotati di cittadinanza francese e che pure sapevano di rappresentare la gran parte degli esclusi dal mercato del lavoro. Come testimonia lo stesso Rapporto dei Renseignements généraux del novembre 2005, la rivolta era «animata da un forte sentimento identitario che non poggiava tanto sull’origine etnica o geografica, quanto sulla loro condizione sociale di esclusi dalla società francese» (cit. in Mucchielli 2006, 18). Cosicché dietro la rivolta emergono lunghi processi di ghettizzazione, dove all’esclusione imputabile alle politiche immobiliari si aggiunge un’esclusione scolastica e dal mercato del lavoro (Centre d’analyse stratégique 2006, 64). Anche da cittadini, insomma, i membri di comunità etniche minoritarie restano svantaggiati; dunque non è il criterio della cittadinanza che in sé regola privilegi e svantaggi, piuttosto l’uso politico che ne viene fatto, e la cultura che l’accompagna, nei confronti dei nuovi cittadini; la perdita di peso della cittadinanza sociale, che caratterizza oggi questa cultura della cittadinanza, fa qui toccare con mano il vuoto che lascia nella costruzione della comunità.
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 423
4. Gli stranieri e la cittadinanza
Dicevamo che la scelta di diventare cittadino del paese di residenza, come ogni scelta, dipende anche da fattori individuali, e non solo strutturali. Intanto si tratta di una decisione indivi-duale che in genere matura quando il progetto migratorio è, o comunque diventa, di lungo periodo; in questo caso, la motiva-zione ad accedere allo status di cittadino nasce dall’aspettativa di raggiungere una condizione di uguaglianza con gli altri membri della società, e dai vantaggi che questo porta con sé. Ai vantaggi abituali, si aggiunge nel caso dei paesi europei quello di accesso all’Unione e di libertà di movimento fra gli stati membri. Sop-pesare vantaggi e svantaggi è cruciale; spiega per esempio per-ché non siano cresciute le richieste di naturalizzazione da parte di cittadini di altri paesi dell’Unione, che appunto non hanno gran ché da guadagnare nel naturalizzarsi, grazie alla libertà di movimento di cui già godono.
Questo atteggiamento strumentale verso la cittadinanza ac-compagna ogni percorso migratorio, senza per questo escludere peraltro, come vedremo, che la cittadinanza possa essere deside-rata anche per marcare un’appartenenza compiuta alla comunità in cui si vive; in fondo, lo stesso riconoscimento della doppia cittadinanza in un certo senso lo favorisce, nella misura in cui ammette implicitamente che la cittadinanza non deve necessa-riamente essere un’appartenenza esclusiva. Non c’è dubbio che l’allargamento della doppia cittadinanza anche a paesi che prima rifiutavano di riconoscerla ha permesso che l’acquisizione della cittadinanza del paese di residenza sia diventata meno conflittuale per un immigrato; poter conservare anche la cittadinanza del pae-se di origine è un punto fondamentale nel progetto migratorio. Eppure proprio questa estensione della doppia cittadinanza ne modifica il significato: a partire dal momento in cui è possibile possedere due cittadinanze, la cittadinanza non appare più come un sistema univoco di fedeltà e di alleanze, come un’appartenenza esclusiva. Mentre l’obbligo di abbandonare la cittadinanza del paese di origine poteva scoraggiare l’acquisizione di cittadinanza nel paese di residenza, nel regime di doppia cittadinanza questa acquisizione diventa compatibile con il mantenimento della cittadi-nanza nel paese d’origine, favorendo il mantenimento dei legami, ma anche il ritorno; in fin dei conti diventa un valido strumento per evitare situazioni di spaesamento e perdita d’identità.
Giovanna Procacci424
Questo però cambia anche il significato che l’acquisizione della nuova cittadinanza ricopre; diventando meno impegnativa, può anche diventare meno significativa. È ancora oggi l’acqui-sizione della cittadinanza un obiettivo cruciale nel progetto dei migranti? Oppure altri istituti, e prima di tutto il permesso di soggiorno di lunga durata, rispondono in maniera soddisfacente alle esigenze dei migranti, prendendo definitivamente il posto dell’acquisizione della cittadinanza? Si apre qui tutto uno spazio di ricerca ancora in gran parte inesplorato che può rappresentare un piano di analisi delle trasformazioni della cittadinanza più concreto e più preciso di quanto il dibattito sui principi sia in grado di fare. Un’indagine sistematica su come siano cambiati gli atteggiamenti degli immigrati verso la cittadinanza nei paesi di residenza permetterebbe di capire come la semantica della cittadinanza si sia arricchita grazie al carattere multietnico delle nostre società, abbia acquistato nuove sfaccettature che ne arric-chiscono le dimensioni, e in particolare come al suo interno si siano organizzate anche quelle richieste di riconoscimento della diversità culturale che tendiamo a considerare ancora opposte alla tensione egualitaria della cittadinanza in senso classico.
Prime ricerche qualitative avviate sui significati che gli immi-grati attribuiscono alla cittadinanza danno indicazioni interessanti: una ricerca recentissima (Colombo et al. 2008) condotta presso immigrati di seconda generazione a Milano mette in luce, per esempio, che l’acquisizione di cittadinanza formale è vista come un atto importante soprattutto perché assicura un diritto alla mobilità in Europa, perché permette di superare le pratiche aleatorie e complesse di rinnovo dei permessi di soggiorno, perché riconosce una sorta di «merito» che riscatta da una rappresentazione stere-otipata dello straniero come minaccia. Ma questo atteggiamento strumentale, come anticipavamo, non sembra esaurire i significati della cittadinanza per questi «nuovi cittadini» o aspiranti tali; senso di appartenenza, partecipazione attiva, condivisione di diritti, valori e garanzie, sono altrettante facce della cittadinanza che questi giovani esprimono, senza sentirsi per questo costretti a una identificazione esclusiva che farebbe perdere loro la propria specificità. Nel vissuto di questi giovani si combinano insieme atteggiamenti strumentali e identificazione simbolica, in una de-clinazione inedita delle molte dimensioni della cittadinanza che, come sottolineano giustamente gli autori, vale anche ad indicare agli autoctoni come sta cambiando il significato dell’italianità.
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 425
5. Il caso italiano
Guardiamo allora più da vicino al caso dell’Italia. La legisla-zione italiana sulla cittadinanza norma una situazione largamente superata dall’esperienza migratoria che caratterizza il paese. Pur essendo ormai da decenni un paese di immigrazione, l’Italia ha una legge di cittadinanza (Legge 91/1992) fondamentalmente basata sullo jus sanguinis, tipico dei paesi di emigrazione, in quanto tende a valorizzare il legame di sangue con la parte della sua popolazione che è emigrata in altri paesi; l’acquisizione di cittadinanza da parte dei discendenti dei nostri emigrati risulta così molto facilitata, rispetto alle condizioni per acquisire la cit-tadinanza sulla base del principio della residenza, relativo invece alla naturalizzazione di persone che non hanno questi legami. In questo secondo caso, la legislazione del 1992 regredisce addirit-tura rispetto alla legge di cittadinanza del 1912 che richiedeva solo sei anni di residenza, imponendo ben dieci anni (il massimo consentito dall’UE) di residenza continuativa agli extra-comunitari che chiedono la naturalizzazione in base alla residenza. Altra modalità facilitata è quella dell’acquisizione di cittadinanza per via di matrimonio con un cittadino italiano. Quanto alle seconde generazioni, i figli degli emigrati italiani, anche se magari non hanno mai messo piede sul territorio italiano, sono fortemente favoriti, e possono diventare cittadini in soli 2-3 anni, mentre i discendenti da genitori stranieri non europei, ancorché residenti di lungo periodo, hanno molta difficoltà. A questi ultimi, che possono chiedere la naturalizzazione dopo il raggiungimento dei 18 anni ed entro il diciannovesimo anno di età, viene richiesto che i genitori fossero regolarmente residenti in Italia al momento della nascita, sebbene la maggior parte degli immigrati residenti siano stati regolarizzati dopo un periodo di soggiorno irregolare; inoltre, si chiedono addirittura 18 anni di residenza ininterrotta, i quali peraltro nemmeno bastano a creare un diritto automatico alla naturalizzazione.
In questo quadro normativo, le naturalizzazioni restano molto rare, sebbene in aumento. Secondo l’Istat (2008), sulla base dei dati del Ministero dell’Interno, i cittadini italiani di origine straniera che hanno conseguito la cittadinanza italiana fino al 2007 sono 261.000, mentre erano solo 33.600 nel 1995. A titolo di contro-esempio, in Francia nei soli anni 2005-2006 sono state concesse più di 300mila nuove cittadinanze. La stra-
Giovanna Procacci426
grande maggioranza delle acquisizioni di cittadinanza in Italia sono avvenute per matrimonio (art. 5), mentre restano pochi i casi di naturalizzazione per residenza (art. 9); nel primo caso c’è una prevedibile maggioranza femminile, nel secondo invece, dati i lunghi anni di residenza continuativa richiesti per presen-tare la domanda, c’è una prevalenza maschile legata ai caratteri dell’immigrazione negli anni Settanta e Ottanta. I soggetti di queste naturalizzazioni peraltro non provengono prevalentemente da paesi a forte pressione migratoria, ma da paesi sviluppati e da paesi latino-americani (i discendenti degli emigrati italiani in Argentina, Brasile e Venezuela); il primo paese a forte pressione migratoria è la Romania, che si colloca comunque al 6° posto.
Queste cifre vanno rapportate a quelle della popolazione straniera residente in Italia, che a fine 2007 ammontava a circa tre milioni e mezzo; fra questi, sono in forte aumento le seconde generazioni: si calcola che al 1 gennaio 2008 vivano in Italia ben 767.000 minori di origine straniera, che rappresentano il 22,3% della popolazione immigrata residente. I dati del Ministero dell’Interno (2007) mostrano che per l’intero triennio 2004-2006 sono state inoltrate solo 90.000 domande di naturalizzazione, corrispondenti al 3,1% dei residenti stranieri nel 2006. Nel 2007, su 46.518 do-mande presentate, sono state concesse 38.466 nuove cittadinanze: di queste, solo 6.857 risultano acquisite per residenza, tutte le altre per matrimonio. Argentina e Romania sono le nazionalità che prevalgono nelle acquisizioni per via matrimoniale, mentre il Marocco è la provenienza largamente maggioritaria fra quelle per residenza. Al 31/10/2008 le domande presentate per il 2008 sono state 47.599, di cui solo 32.238 concesse. Se raffrontiamo questi dati sulle domande e sulle concessioni di cittadinanza alle cifre degli immigrati che avrebbero maturato le condizioni di residenza richieste dalla legge, abbiamo dei risultati ancora più sconcertanti: l’Istat (2008) infatti stima in addirittura 630.000 il numero di coloro che al 1 gennaio 2007 erano in possesso dei requisiti per acquisire la cittadinanza secondo la legge del 1992, cioè i 10 anni di residenza continuativa.
Il risultato è che il tasso di acquisizione della cittadinanza sul totale degli immigrati residenti in Italia è fra i più bassi d’Europa (0.7 nel 2005, contro il 5.7 della Gran Bretagna e l’8.2 della Svezia), per quanto costantemente in aumento anche da noi. Cosicché il Rapporto del Ministero dell’Interno già citato confer-ma che l’Italia rientra ancora fra i paesi europei più restrittivi,
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 427
che al tempo stesso richiedono condizioni elevate di accesso alla naturalizzazione e restano chiusi alle seconde generazioni.
Eppure la stabilizzazione dell’immigrazione è ormai un dato di fatto anche in Italia, anche qui il progetto migratorio tende ad essere nei fatti di lungo periodo. Dagli inizi degli anni No-vanta, l’Istat raccoglie dati sui permessi di soggiorno di cittadini extra-comunitari in Italia che vengono disaggregati anche per anno d’ingresso; risulta così che al 1° gennaio 2008, su 2.063.127 cittadini extra-comunitari titolari di permessi di soggiorno, ben 1.398.883 sono in Italia da più di 5 anni, una percentuale in costante aumento dal 1995 ad oggi. Che la popolazione immigrata tenda a stabilizzarsi è d’altronde confermato anche dal numero elevato di richieste di ricongiungimento familiare e dall’aumento costante degli alunni stranieri nelle scuole patrie, in relazione all’importanza crescente dei minori di cui abbiamo detto. In questa luce, appare ancora più irrisoria la cifra delle naturalizzazioni e ancora più vistosa l’incapacità della cittadinanza nazionale come strumento per governare lo scarto sempre crescente, nella società italiana, fra cittadini e popolazione residente non-cittadina.
Eppure, ad oggi la legislazione italiana sulla cittadinanza è ferma alla legge del 1992 e alle sue contraddizioni rispetto ad un paese in cui l’immigrazione è ormai a tutti gli effetti una componente strutturale della vita economica e sociale. Ci sono stati dei tentativi di riforma, per esempio nel 2007, quando il governo di centro-sinistra presieduto da Prodi aveva presentato il Disegno delega 15/3/2007 Amato-Ferrero, che è però decaduto con la caduta anticipata del governo; oggi i termini di quel testo sono riproposti nel Disegno di Legge depositato a nome del PD dal deputato Bressa che giace in Parlamento. Certo, non è facile valutare la forza politica di simili Disegni di Legge, in un Parlamento dominato da preoccupazioni di sicurezza, per quanto lo stesso Presidente della Camera Fini abbia recentemente dichia-rato che i tempi sono maturi per una riforma della legge sulla cittadinanza. Può comunque essere un esercizio utile andare a vedere le proposte di riforma che contengono, se non altro per individuare una linea di tendenza della possibile trasformazio-ne. I punti più innovativi appaiono sicuramente la proposta di ridurre i tempi di residenza richiesti per la naturalizzazione da 10 a 5 anni e il fatto di recepire il principio della residenza per chi nasce in Italia. Vengono invece mantenuti anche in questi Disegni di Legge sia requisiti di reddito, che la subordinazio-
Giovanna Procacci428
ne della concessione della cittadinanza alla «verifica della reale integrazione linguistica e sociale», in linea con quella tendenza diffusa in molti altri paesi europei a rafforzare i requisiti per richiedere la naturalizzazione, rendendo obbligatori test cosiddetti «di integrazione». La conoscenza della lingua, storia, cultura civica, ecc. del nostro paese diventerebbero così condizioni per la richiesta di naturalizzazione; verrebbe insomma ad affermarsi una pratica che stabilisce un dovere specifico dei migranti, il «dovere di integrazione», usato come un’occasione per ribadire legami di lealtà nazionale, con il rischio di prefigurare un caso di discriminazione su base etnica. Eppure, lo stesso Rapporto del Ministero degli Interni (2007, 166) notava che una simile tendenza a innalzare i requisiti per l’acquisizione della cittadinanza faceva apparire quest’ultima meno come uno strumento per favorire l’integrazione e quindi la costruzione di un rapporto di lealtà, quanto come il coronamento di un processo di integrazione che deve essere già compiuto.
Sebbene dunque l’approvazione del Disegno Amato-Ferrero avrebbe rappresentato un netto miglioramento della politica di cittadinanza in Italia, riaccostandola a quella degli altri paesi europei, questi Disegni di Legge risentono ancora di una su-bordinazione agli obiettivi di controllo dell’immigrazione, invece di individuare le linee proprie di una politica espansiva della cittadinanza che miri ad integrare nella rete di diritti e doveri almeno i residenti di lunga durata e le seconde generazioni, come da tempo sostiene chi si occupa di questi temi (Codini e D’Odorico 2004). Purtroppo il clima politico generale attuale, più ostile verso gli immigrati e tutto preso da preoccupazioni di sicurezza, ha solo aggravato la situazione e rende ancora più difficile sperare in una politica della cittadinanza che si eman-cipi dalla soggezione a politiche restrittive verso l’immigrazione. Ne è prova la pretesa dell’attuale governo di centro-destra di eliminare l’obbligo a funzionari e sanitari di non denunciare l’immigrato clandestino con cui entrano in contatto, il che non fa che confermare le paure che tengono lontani da servizi e istituzioni non solo i clandestini, ma anche gli immigrati regolari di cui abbiamo detto la situazione di fragilità in cui si trovano, o comunque si sentono.
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 429
6. Osservazioni conclusive
Come osservano Castles e Davidson (2000, 127), rispondere alla domanda «Chi è il cittadino?» diventa oggi sempre più difficile. Certo, sembra sempre meno possibile rispondere sem-plicemente attraverso l’equivalenza di cittadinanza e nazionalità; anzi, l’intensificarsi della mobilità nel mondo globalizzato tende ad allargare i territori di cui ci sentiamo, volente o nolente, cittadini. Ma la risposta di tipo cosmopolitico rischia di consacrare nuove fratture nella misura in cui, al di là di speculazioni sociologiche sul nomadismo, l’attaccamento al luogo in cui si vive rimane decisivo per la gran parte della popolazione, per la quale esser spostati e ritrovarsi proiettati in un mondo globale continua a comportare soprattutto sofferenza. Senza contare che la domanda sociale di ibridazione, cruciale per i sostenitori del cosmopoli-tismo, è largamente contraddetta da domande di sicurezza che spingono in una direzione opposta (Turner 2006).
Le critiche attuali alla cittadinanza, considerata come un cri-terio politicamente superato, tendono ad esaltarne la dimensione nazionale, di cui denunciano la rigidità eccessiva rispetto ad un mondo globalizzato, dove gli stati nazionali sarebbero sempre meno importanti. Tali critiche rischiano, però, di sottovalutare il ruolo degli stati nazionali, in particolare proprio in materia di politiche di contrasto all’immigrazione, dove gli stati sembrano in grado di perpetuare sistemi discriminatori nonostante la pressione delle convenzioni internazionali. I limiti delle politiche di naturalizza-zione che ho cercato di rintracciare confermano la capacità degli stati di esercitare le loro prerogative per stabilire vantaggi per i loro cittadini, e di subordinare le politiche di cittadinanza agli obiettivi restrittivi che perseguono nei confronti dell’immigrazione. D’altronde, la stessa lotta contro le discriminazioni di per sé non può bastare ad aprire nuove vie di cittadinanza, in quanto non fornisce gli strumenti di un’integrazione nella comunità.
Se dunque la prospettiva della cittadinanza in un contesto di globalizzazione non può che passare attraverso il suo distacco dalla nazionalità, la sua «denaturalizzazione» (Zanfrini 2007), si possono immaginare per questo distacco altri percorsi. Da questo punto di vista colpisce l’assenza, nelle critiche mosse al principio di cittadinanza nazionale, del tema della cittadinanza sociale come principio di riconoscimento di diritti indipendentemente dalla nazionalità. Il concetto di cittadinanza sociale di Marshall può
Giovanna Procacci430
essere denso di sviluppi anche in una comunità multietnica, nella misura in cui designa uno status sociale che lega l’individuo alla comunità in cui vive e cui contribuisce e per questo gli attribu-isce il diritto ad esser posto in condizioni di pari opportunità. Il suo carattere attivo e partecipativo permette di immaginare una comunità fondata sulla residenza e sulla cooperazione, in-vece che sull’identità culturale. L’esclusione dei non-nazionali è basata sull’esaltazione del carattere nazionale della cittadinanza; denazionalizzare la cittadinanza potrebbe invece voler dire che se ne accentuino le dimensioni sociali, che la si riporti a quelle pratiche che la costruiscono concretamente nell’esperienza di ognuno e fondano un’uguaglianza di accesso a tali pratiche, che se ne rivitalizzi la capacità di attaccare le disuguaglianze che ten-gono tanti nuovi cittadini ancora ai margini. Potrebbe diventare così possibile usare la cittadinanza come leva per incidere sulle stesse politiche migratorie, rovesciando quella sudditanza di cui abbiamo detto. Solo politiche aperte di cittadinanza, che rinno-vino la vitalità della cittadinanza nel creare comunità attraverso i diritti e la partecipazione attiva, possono permettere di riaprire politiche d’immigrazione di lungo periodo, che la favoriscano anche in competizione con paesi come gli Stati Uniti o il Ca-nada (Münz 2004). E soprattutto di riaprirle al futuro, la cui chiave è certamente l’acquisizione di cittadinanza delle seconde generazioni (Castles e Davidson 2000) a condizione però che, come insegnano le rivolte delle banlieues francesi, si chieda alla politica della cittadinanza di perseguire anche l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e di governare l’integrazione.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Bauböck, R. (a cura di)2006 Migration and Citizenship, Amsterdam, Amsterdam University Press.Beckman, L.2006 Citizenship and Voting Rights: Should Residents Aliens Vote?, in «Citi-
zenship Studies», 10, 2, pp. 153-165.Böcker A. e D. Thränhardt2006 Multiple Citizenship and Naturalization, in «Journal of International
Migration and Integration», 7, 1, pp. 71-94.Brubaker, R.1992 Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, Mass,
Harvard University Press.
Le nuove sfide della cittadinanza in un mondo di immigrazione 431
Castles, S. e A. Davidson2000 Citizenship and Migration. Globalization and the Politics of Belonging,
New York, Palgrave.Centre d’analyse stratégique2006 Enquêtes sur les violences urbaines, Paris, La Documentation Française.Codini, E. e M. D’Odorico2004 Per una nuova disciplina della cittadinanza, Milano, ISMU.Colombo, E., Domaneschi, L. e C. Marchetti2008 Giovani immigrati e nuove definizioni della cittadinanza, Rapporto di
Ricerca, Provincia di Milano.Crowley, J.1998 The National Dimension of Citizenship in T.H. Marshall, in «Citizenship
Studies», 2, 2, pp. 165-178.Eurostat2004 Acquisition of Citizenship, «Statistics in focus», Population and Social
Condition, 3.2006 Non-National Populations in the EU Member States, «Statistics in focus»,
Population and Social Condition, 8.2008 Recent Migration Trends, «Statistics in focus», Population and Social
Condition, 98.Geddes, A.2000 Thin Europeanisation, in M. Bommes e A. Geddes (a cura di), Im-
migration and Welfare, Challenging the Borders of the Welfare State, London, Routledge.
Istat2008 La popolazione straniera residente in Italia al 1 gennaio 2008, in «Sta-
tistiche in breve».Joppke, C.2007 Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity, in «Citizenship
Studies», 11, 1, pp. 37-48.Kofman, E.2005 Citizenship, Migration and the Re-assertion of National Identity, in
«Citizenship Studies», 9, 5, pp. 453-467.Lochak, D.2003 Loi du marché et discrimination, in D. Borrillo (a cura di), Lutter contre
les discriminations, Paris, La Découverte.2008 Immigrés sous contrôle, Paris, Editions Le Cavalier bleu.Marshall, T.H.1950 Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge, Cambridge
University Press; trad. it. Cittadinanza e classe sociale, Roma-Bari, La-terza, 2002.
Ministero dell’Interno2007 Primo Rapporto sugli Immigrati in Italia.Mucchielli, L. e V. Le Goaziou (a cura di)2006 Quand les banlieues brûlent… Retour sur les émeutes de novembre
2005, Paris, La Découverte.
Giovanna Procacci432
Münz, R.2004 Migrants, Labour Markets and Integration in Europe: A Comparative
Analysis, Global Commission on International Migration (GCIM) http://www.gcim.org
Noiriel, G.2007 Immigration, antisemitisme et racisme en France, Paris, Fayard.Procacci, G.2006 Invisible Poverty: Migrants, New Social Policies and the Risk of Exclu-
sion, in Achieving Social Cohesion in a Multicultural Europe, Strasbourg, Council of Europe Publishing.
Turner, B.2006 Citizenship and the Crisis of Multiculturalism, in «Citizenship Studies»,
10, 5, pp. 607-618.Weil, P. 2001 Access to Citizenship. A Comparison of Twenty Five Nationality Laws,
in A. Aleinikoff e D. Klusmeyer (a cura di), Citizenship Today: Global Perspectives and Practices, Washington, D.C., Carnegie Endowment for International Peace.
Zanfrini, L. 2008 Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell’immigrazione,
Roma-Bari, Laterza.
























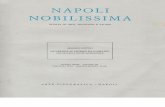

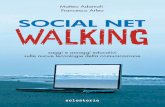

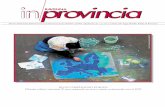
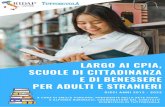





![Giosue Carducci - Rime nuove [ebook ITA]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6345631cf474639c9b04d2fd/giosue-carducci-rime-nuove-ebook-ita.jpg)
![Αποδείξεις αστικής ιδιότητας στην Κρήτη το 17ο αιώνα [Prove di cittadinanza a Creta nel XVII secolo], in Πεπραγμένα του Ζ΄](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6316115dfc260b7102104940/podeikseis-stikis-idiotits-stin-kriti-to.jpg)