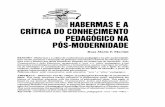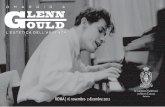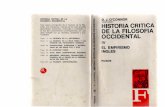Due dispersi darziani: nuove domande per la critica
Transcript of Due dispersi darziani: nuove domande per la critica
13
monografia
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
di Alberto Sebastiani
La bibliografia darziana: una storia infinita
È ormai evidente che non è possibile, a tutt’oggi, delineare in modo esaustivo la bibliografia darziana. Non per mancanza di ricerche, ma perché sembra che ogni
ritrovamento di testi inediti o “dispersi”, ovvero editi, ma dimenticati e riscoperti spesso per caso, presagisca alla scoperta di altri ancora. Esistono, ad esempio, lettere che lasciano pensare all’esistenza di scritti ancora ignoti. Già nella compilazione del recente volume Opere1 si era giunti al ritrovamento di un testo disperso, apparso con il titolo Inchiesta sulla narrativa nella rivista “Le carte parlanti” (a. V, n. 19, gennaio 1944), della casa editrice Vallecchi, richiesto espressamente a D’Arzo da Adriano Seroni in una lettera dell’8 giugno 1943, per un «fascicolo speciale» dedicato «ai narratori contemporanei che hanno pubblicato o pubblicheranno le loro opere da Vallecchi», che ospitasse loro «riflessioni e appunti sul problema narrativo».2 Uno scritto, una dichiarazione di poetica, in cui il quasi ventiquattrenne “Silvio D’Ar-zo”, così si firma Ezio Comparoni3 (1920-1952) in quell’occasione, come già per All’insegna del Buon Corsiero, pubblicato da poco dall’editore fiorentino, parla delle difficoltà di ogni giovane autore, dell’impervio cammino che non sempre concede di arrivare alla capacità di «narrare», e lascia come in «esilio», magari alla ricerca di un’imprecisata «atmosfera», che però può essere considerata il primo passo verso la meta della maturità artistica.4 D’Arzo sente di vivere questo «esilio», ma cerca disperatamente la meta, concepita magari in modo impreciso, intuita, ma nella certezza della sua esistenza. La persegue attraverso una personale ricerca poetica, che cresce negli anni, che si muove nel rac-conto, breve o lungo che sia, per adulti e per ragazzi, o nel dialogo con i grandi autori europei e americani, sui quali scrive saggi che sono discussioni e riflessioni, in cui pone in relazione la propria e la loro ricerca.5 Le lettere conducono il lettore dietro le quinte di questo cammino, rivelano la sua impervietà, ma anche l’infaticabile tenacia di D’Arzo: autore, ideatore di volumi e promotore di se stesso e del proprio lavoro, del
14
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
quale è anche critico severissimo, per nulla indulgente. Ed è sempre grazie alle lettere che si sono recuperati i disegni di Gian Battista Cavani, collega e amico di Comparoni, per l’edizione, mai avvenuta, di Gec dell’avventura, altro testo di cui a tutt’oggi non si hanno testimoni. Illustrazioni delle quali lo scrittore è committente, ma anche vigile supervisore.6 E proprio questa natura “imprenditoriale” lo porterà ai numerosi contatti con editori, critici, giornalisti, intellettuali italiani, ma anche all’incredibile progetto di promozione dei suoi testi per ragazzi all’estero, in Europa e negli Stati Uniti, che, anche per questo loro peregrinare, richiedono ancora ricerche e chiarimenti.7Una storia infinita, dunque. D’altronde la geografia della produzione letteraria di Silvio D’Arzo è talmente complessa che in larga parte è ancora da esplorare. Sembra incredibile, pensando che lo scrittore reggiano è morto appena trentaduenne, ma la sua attività è stata incessante e intensa, fin dalla tenerissima età. Per questo, e per la mancanza di una documentazione esauriente in merito, continuano e continueranno a lungo ad apparire testi inediti o dispersi. Ne sono prova i due racconti che vengono pubblicati in questo volume: La valanga e Fine di Mirco. Se il primo risale al 1934, e sarebbe quindi il primo racconto dello scrittore reggiano pubblicato, il suo esordio, sotto lo pseudonimo “Raffaele Comparoni”, il secondo è una versione che presenta numerose varianti del racconto, già noto ai lettori darziani, uscito con il medesimo titolo su “Meridiano di Roma”, il 23 giugno 1940. Circa due settimane prima, in-fatti, Fine di Mirco, nella redazione che viene qui pubblicata, appare su “Quadrivio - Tevere. Grande settimanale letterario illustrato di Roma”, il 9 giugno 1940. Due testi, sconosciuti, dei quali è difficile ricostruire l’iter che li ha portati alle stampe, per assenza (al momento) di documenti, di materiale avantestuale, dei dattiloscritti e ma-noscritti relativi, ma sui quali è doveroso investire alcune parole per contestualizzarli, commentarli, e anche, necessariamente, per formulare ipotesi sulla loro genesi.
La valanga (1934)
Come accade in molti casi analoghi, il ritrovamento, per questo come per l’altro racconto, è stato casuale. La valanga era “sepolta” in un’antologia degli anni Trenta e nessuno ne aveva notizia. Poi un incontro quasi da romanzo: nel 2006, alla manife-stazione “Pordenone legge”, un lettore appassionato di D’Arzo conosce un libraio, questi gli rivela l’esistenza di un racconto sconosciuto di Comparoni, antecedente a quelli noti, il suo vero esordio, e il lettore chiama la casa editrice che ha pubblicato le opere dello scrittore reggiano.8 Il titolo del volume in cui era “sepolto” il testo è Antologia dei giovani scrittori e poeti italiani, pubblicato da Edizioni Novecento9 di Milano nel 1934, con un’intro-duzione di Guido Milanesi. Ospita testi di novantacinque autori, la maggioranza dei quali rimasti lontani dai successi letterari.10 Non è dato sapere se il libro fosse il risultato di un concorso, o di una selezione di autori scelti da osservatori di riviste letterarie (in tal caso, sarebbe interessante scoprire dove Comparoni pubblicasse). Non è indicato nemmeno il curatore del volume. Milanesi pare essere una firma che
15
monografia
ha una funzione promozionale. È uno scrittore in voga tra le due guerre, fascista convinto, autore di romanzi e racconti d’avventura, di ambientazione coloniale.11 La sua introduzione non dice nulla di specifico sui racconti, suona oggi retorica e vuota, come un banale biglietto d’auguri:
Cari miei,voi mi suggerite un’immagine tolta dal mare in cui ho trascorso la massima parte della mia vita.Quando uno sciame di vele s’avvicina al porto nelle sere tempestose, se ne vede l’insieme punteggiare l’orizzonte, ma non se ne distingue particolarmente nessuna. Ed ecco che poco a poco quelle dotate di migliori qualità veliere vengono avanti, si distaccano dalla massa, ingrandiscono, lasciano leggere sullo scafo il nome che viene ripetuto in festa lungo tutta la spiaggia e si fanno riconoscere, mentre le altre sono ancora laggiù, ignote, anonime, pronte a svanire nell’oscurità della imminente notte.Lo sciame di vele siete voi: il mare è quello dell’arte, eternamente in tempesta. Il vento delle idee da cui siete spinti è gagliardo. Ma appunto per questo, mantenetevi larghi l’uno dall’altro, badando sempre ad avere spazio intorno, per evitar urti pericolosi e spesso letali. Seguite la rotta del vostro talento e della vostra sincerità, preparandola con lo studio e la ponderazione, senza curarvi di dove corrono gli altri e rispondendo col disprezzo a quanto l’invido livore delle onde rotte vi getterà addosso.Non disperdete con l’avventura e l’impazienza il vostro nuovo carico da offrire all’Italia.Soprattutto, non fermatevi in gruppo, il che equivale a morir di ciarle.Già qualche nome, che è promessa, si legge tra di voi sull’indistinguibilità dello sciame.Avanti: per la mia gioia di vecchio marinaio, felice di segnalar le giovani vele e pilotarle all’ancoraggio.Avanti: per la festa della letteratura italiana, oggi resa triste da folle di ciarlatani impotenti, per quanto rumorosi, e impaludata in premi che spesso non si sa che cosa premiino.Con la pura energia dei vostri anni, spazzate via tutto ciò. Sotto, miei cari! Ben decisi e a fondo.Per farlo, voi avete le due armi migliori che possa offrir la gioventù: fede e sincerità.Ma bisogna adoperarle presto, perché sono appunto le due più pronte alla ruggine.Vostro:
Guido Milanesi12
Retorica di quegli anni profusa a piene mani. Milanesi potrebbe anche non aver letto i racconti. Al limite poteva conoscere qualche autore. Probabilmente non Comparoni, visto che il nome del prefatore non appare nella corrispondenza darziana, nemmeno citato con editori, amici, critici. Come d’altronde non viene mai citata questa antolo-gia. Eppure sarebbe il suo esordio. È vero, per altro, che non si conoscono lettere di
16
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
questo periodo, e lo è altrettanto che, presentandosi a editori e critici (almeno stando alle missive pervenuteci), non citerà mai esplicitamente nemmeno le altre due opere uscite l’anno successivo: i racconti di Maschere. Racconti di paese e di città, pubblicati dall’editore Carabba di Lanciano, e le liriche di Luci e penombre. Liriche, stampate dalla Tipografia La Quercia di Milano, entrambi del 1935.13 Anch’esse, come La valanga, appaiono firmate con lo pseudonimo “Raffaele Comparoni”. Ed è, ovviamente, nel confronto con i testi ospitati in queste due raccolte che va letto il racconto del 1934. Rispetto ad esse, però, l’Antologia offre una particolare sorpresa. Infatti, una foto-grafia e una sinteticissima biografia, in terza persona, introducono il racconto:
[Raffaele Comparoni] È un ragazzo. Nato a Reggio Emilia nel febbraio del 1920, frequenta il ginnasio. Ha in corso di stampa, presso un editore emiliano, un libro di poesie.14
L’unica altra biografia pubblicata, se si escludono quelle più o meno veritiere apparse, ad esempio, nelle lettere a Enrico Vallecchi15 e a Emilio Cecchi16, si trova sulla rivista “Le carte parlanti” (a. III, n. 3, Firenze, 15 marzo 1942, p. 7) e appare in occasione dell’imminente uscita di All’insegna del Buon Corsiero:
Sono nato a Fellettino (La Spezia) il 5 gennaio 1917. Ho fatto gli studi classici e mi sono laureato in legge. Dopo questa laurea, mi sono indirizzato al terzo anno della Facoltà di Lettere. Mi trovo da qualche tempo a Reggio Emilia – tre anni circa – dove lavoro senza quasi nessuna conoscenza e dedito ai miei lavori letterari. Collaboro a Quadrivio e a Meridiano. Altro non c’è. Quanto all’“Insegna del Buon Corsiero”, credo che sia molto meglio lasciarlo così com’è, con quell’aura cioè di sospensione che è coerente del resto col carat-tere dell’opera: aveva sulle prime pensato all’epilogo soltanto per amore di compiutezza: ma la caccia al diavolo, osservata nei suoi particolari e le sue fasi, avrebbe tolto molto di quell’aria così vaga ed imprecisa (s’intende, quando si tratta del Funambolo) che invece ho conservato per l’intera favola. In altre parole: la caccia al Funambolo, semplicemente enunciata – mentre le due donne pensano che sempre e ovunque si ricorderanno di quel sorriso triste e sempre ne saranno soccorse, ad ogni ora – oltre che essere, per dir così, meno compromettente, rende molto più facile il respiro.17
È una biografia falsa e lacunosa. Falsi sono il luogo e la data di nascita, sono taciute le pubblicazioni del 1935, ed è addirittura truccata la fotografia che appare col testo, con baffi finti e una pettinatura diversa da quella solita.18 La biografia apparsa nel-l’Antologia del 1934, invece, se non altro, afferma correttamente il luogo e la data di nascita di Comparoni. C’è però, in questa, un dato che allo studioso darziano suona come un campanello d’allarme, una di quelle tracce che rivelano, o permettono di supporre, che possano esistere ancora altri volumi dello scrittore reggiano. Si tratta del volume in uscita per un «editore emiliano». In realtà, Luci e penombre, ovvero l’unico libro di poesie darziane noto, effettivamente pubblicato pochi mesi dopo l’uscita dell’Antologia, viene stampato da una tipografia milanese. Per qualsiasi co-
17
monografia
noscitore o studioso di D’Arzo, è chiaro che non è per nulla assurdo ipotizzare l’esistenza di un altro volumetto di poe-sie. Potrebbe trattarsi di un errore della biografia, o di un contatto editoriale finito nel nulla, al limite di una bugia di Comparoni, ma non è detto. D’altronde la produttività dello scrittore è nota19, ed è tale fin dall’infanzia. Se, infatti, La valanga viene pubblicata quando Ezio Comparoni è appena quattordicenne, un’età che rivela un’indubbia precocità della scrittura, non va dimenticato che le sue prime esperienze letterarie vanno fatte risalire ad alcuni anni prima. Se ne ha documentazione in una lettera all’in-tellettuale reggiana Virginia Guicciardi Fiastri datata 17 agosto 1929:
Stimatissima Signora.Non saprei esprimere la mia conso-lazione nell’aver Ella tanto buona acconsentito di leggere i miei versi!Per tanta bontà Iddio le conceda tut-to quel bene che il suo cuore merita. Con distinta stima e ossequi.20
Essendo nato nel 1920, si deve dedurre che già all’età di nove anni Comparoni componesse versi. Allo stato degli studi, però, non è possibile sapere quali avesse letto la Guicciardi Fiastri, né, ovviamente, se essi siano in qualche relazione con quelli di Luci e penombre.La valanga, comunque, è ad oggi il primo racconto conosciuto di D’Arzo. Un’ope-ra giovanile, certo, e come tale presenta diverse ingenuità, ma al fianco di una già evidente dote narrativa (per quanto in parte legata al gusto del tempo), e di una riflessione in cui è centrale il senso della finitudine21, l’idea della provvisorietà, caratteristica di tutta la sua opera.22 Il racconto, breve, è ambientato in un luogo imprecisato sulle Alpi e narra di un uomo che, il giorno delle sue nozze, deve lasciare la moglie a casa per soccorrere un escursionista inglese sorpreso dalla valanga, in pericolo di vita. Giacomo Faur-naiser, l’uomo, «intrepido scalatore», ha il dovere di intervenire in soccorso, ma verrà sorpreso a sua volta dalla valanga. La donna a casa l’attende in preghiera, che verrà esaudita solo in parte. Una curiosità: il nome della sposa presenta un refuso macroscopico (Fernando Golzi), ma sembra poco plausibile imputare a ciò il silenzio che è calato su questo racconto.
Biografia in “Le carte parlanti”, 1942
18
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
La storia dei due novelli sposi è divisibile in cinque parti: la situazione iniziale, con il matrimonio, i preparativi per la festa, l’uscita dello sposo chiamato al suo dovere; la disavventura del marito; la contemporanea attesa del suo ritorno, con la moglie che prega la Madonna; il ritorno e la fuga incomprensibile del marito; il ritrovamento del suo cadavere. La prima, la seconda, la terza e la quinta parte seguono una linea che potrebbe definirsi dei fatti, razionalmente comprensibili, accaduti nella finzione narrativa. La quarta è l’elemento fantastico che irrompe, spezzando la linearità ra-zionale degli eventi. È l’avvenimento impossibile, è la manifestazione del desiderio che nasce nella terza parte, nelle preghiere della moglie. Il ritorno del defunto per un ultimo saluto ai cari è un topos, ampiamente attestato nel repertorio folklorico. Ciò che maggiormente interessa, però, è che La valanga presenta già quel gusto del fantastico, quell’amore per le figure fantasmatiche, incorporee, lunari che caratterizzano la produzione darziana successiva. Qui è mag-giormente evidente un amore per le storie di fantasmi, con i colpi di scena, spesso orrorificamente stranianti, nel finale. Ma è altrettanto evidente anche il tentativo di costruire un’atmosfera, quella stessa imprecisata «atmosfera» di cui parlerà nell’In-chiesta sulla narrativa di “Le carte parlanti” dieci anni dopo.Nel racconto del 1934, come negli altri testi di quel primo periodo, dominano tinte fosche, ma, verrebbe da dire, a pastello, come rarefatte. Condizioni di precarietà, di ricerca di attimi di felicità di breve durata, cui succedono situazioni drammatiche, quasi a scontare il sollievo vissuto. Come in La valanga, nei racconti di Maschere domina il lutto, la morte. Rivalità selvaggia narra del matrimonio mai realizzato tra Maso e Lina, del duello “rustica-no” tra il fidanzato abbandonato e Pirso, che si conclude tragicamente per Maso. La fine del Rosso racconta le imprese di un brigante che sceglie, malato, di lasciarsi morire senza essere catturato. In Sarrù un disperato pastore sardo uccide l’usuraia che non gli concede il prestito, e torna a casa dalla moglie che partorisce, dandogli finalmente gioia, ma rumori non lontani sembrano annunciare lo straripamento del torrente, e quindi l’avvento della morte. Gosto, in Sperduti su la strada, muore solo e dimenticato nella sua capanna; lo zio di Giorgio, in L’eredità, muore maledetto dal nipote, senza contare la morte metaforica di Carlo, venditore ambulante in Piccolo mondo degl’umili, che abbandona la zona in cui lavora e la pensione in cui vive per fuggire da una delusione d’amore.La medesima e inquietante presenza è in Luci e penombre, in cui la caducità, la meschinità e la miseria della vita, la finitezza dell’uomo, la sua precarietà sono co-stantemente ribadite e la serenità è qualcosa di irraggiungibile. E, contro tutto ciò, l’uomo, che «dal nulla nacque e al nulla torna» come una bolla di sapone23 (Bolle di sapone), può solo cercare di «squarciare gli abissi dell’ignoto» (L’uomo), spingersi lontano e lottare «per la propria idealità» (Immensità), spiegare le vele e partire, per saziare la «sete di vita e di libertà» (Il canto della libertà). Luci e penombre, se lo si vuole considerare un testo omogeneo (anche se vi si possono riscontrare ana-logie tematiche più che una vera e propria coerenza interna), si sviluppa dunque sulla contrapposizione “morte” vs “ideale vitalità” (forse “disperata vitalità”, ma
19
monografia
di maniera). Un contrasto topico, espresso in modo spesso assai retorico, nel senso spregiativo del termine. “Luci e penombre”, infatti, è anche una metafora perfetta da un punto di vista critico, dato che il libretto mostra tutti i limiti di una raccolta giovanile, con numerosi cliché, un uso manieristico della mitologia e di topoi vetusti come la morte della poesia uccisa dal progresso. È inevitabile, d’altronde, data la tenera età. Come è inevitabile che si sentano in questi versi l’eco dei maestri, da Giacomo Leopardi ad Alessandro Manzoni, solo per citare i due casi più lampanti24, esattamente come sono evidenti modelli e ingenuità nei racconti.25 La valanga, però, se si esclude il topos dei poeti defunti che parlano in Il lamento del poeta di Luci e penombre, è l’unico testo di questo periodo in cui appaiono figure fantastiche, delle quali è superfluo ricordare l’importanza in un’opera futura come All’insegna del Buon Corsiero. Con il racconto dell’Antologia, però, si incontrano sia in Maschere, sia in Luci e pe-nombre, altre analogie: il contrasto tra la notte spesso tempestosa e l’alba risolutrice, anche se in modo drammatico; l’ambientazione in luoghi lontani dalla città natale di Comparoni, Reggio Emilia (ad esempio Sarrù in Sardegna, L’eredità in Brianza), o in zone di montagna. Ma soprattutto la presenza di “soglie”. Cioè il luogo del-l’incontro che incombe, svelatore, stravolgente, sorprendente, straniante, che può lasciar intuire un lembo di senso di quanto avviene, o risultare il momento della disillusione, che catalizza l’attenzione, in cui si manifesta l’inatteso. In La valanga, come in molti racconti, la “soglia” è una porta. Quella di casa. È lì che avviene l’in-contro tra moglie e marito, sulla “soglia”, nel luogo di scontro tra il desiderio e la realtà. La porta è la “soglia” dietro cui prega la moglie in attesa del marito travolto dalla valanga; che viene chiusa in faccia a Maso dalla madre della sua mancata sposa; dietro la quale si ode il vagito della nuova vita figlia di Sarrù; dietro a cui muoiono Gosto e lo zio di Giorgio, o si nasconde Rosso. È un varco che separa, più che unire. L’incontro tra i due sposi, in La valanga, sancisce la loro definitiva separazione. È come se, separati da questa soglia, esistessero un mondo interno, quello dei desideri, dei sogni, dell’ideale, e uno esterno, fisico, delle difficoltà, dei contrasti, della morte. Che incombe sempre, come fine di ogni cosa. Un tema che ricorrerà in tutta l’opera di Silvio D’Arzo, che culminerà nella realizzazione del suo testo più famoso, con la formulazione della spietata situazione che tutti i lettori conoscono, di Casa d’altri, ovvero la difficoltà di accettare di vivere, e quindi di riuscire a vivere, «in casa d’altri».26
La valanga è un racconto decisamente molto lontano da Casa d’altri. Non c’è an-cora la consapevolezza, la profondità di quelle pagine, la forza e la personalità di quella scrittura. “Raffaele Comparoni”, l’autore del racconto nell’Antologia, è solo un quattordicenne. È però interessante notare questa costante dei suoi racconti: la “soglia”, un concetto che tornerà spesso nella produzione di Silvio D’Arzo, ma anche una parola chiave che lo scrittore reggiano utilizzerà per formulare, anni dopo, in Inchiesta sulla narrativa, l’idea dell’esilio in cui vive ogni giovane autore, o chiunque ancora non abbia raggiunto l’agognata meta, diventare un vero narratore:
20
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
Esilio, questo loco, che poi – nella più parte – non è proprio esilio, dopotut-to, ma semmai un modo di aver coscienza di sé, questo piuttosto, uno “stare sull’argine”, dirò, con un piede già alzato sulla soglia.
È fin troppo facile affermare che La valanga è lo scrittore che si affaccia all’argine. Forse ha già consapevolezza che la “soglia”, che ora appare nei suoi racconti, e che domani citerà nell’Inchiesta, teorizzando metaforicamente la sua e altrui condizione artistica, è davanti a sé. È un’immagine suggestiva. È d’altronde affascinante, anche se non sempre risponde al vero, leggere un percorso omogeneo, lineare, nella for-mazione di un autore. È lecito e plausibile vedere nelle opere giovanili dei tratti che possono presagire alle caratteristiche della maturità, ma rischia di essere qualcosa di mistificante, falso. Anche per D’Arzo, per quanto non si possono ignorare nel racconto dell’Antologia alcuni aspetti stilistici, qui ancora immaturi, che, mondati dai vizi della tenera età, saranno poi caratteristici della scrittura della maturità dell’autore.27
Da un lato, infatti, si rivelano ingenui eccessi, ad esempio, nei paesaggi di gusto romantico, profusi di immagini considerabili cliché, di maniera, ma anche in aspetti legati allo stile, come nelle descrizioni. Basti pensare a quella della porta di casa dei due sposi, meticolosa fino all’ossessione, decisamente ridondante:
rustica porta di quercia, di quella giovane quercia che cresce gagliarda ai venti impetuosi e alle gelide nevi di settentrione sui ripidi fianchi selvosi della montagna […].28
O alla tendenza, tipica dello stile letterario alto, di far antecedere l’aggettivo al sostantivo, come, ad esempio, in apertura del racconto: «alpestre tempietto», «car-niche roccie», «sacro giuramento», «candido altare». O all’uso diffuso di doppie aggettivazioni enfatiche («caldo pane biondo», «saporosa e fumante minestra»), di preziosismi («glauche pupille», «nivea tovaglia»). Va poi considerato, nella struttura della frase, il gusto letterario per la posposizione del verbo:
Giacomo, senza proferir parola, soffocando nel petto forte e generoso i pro-fondi sospiri, partì.29
Come anche, da un punto di vista retorico, la ricerca dell’enfasi attraverso l’insistito uso di anafore:
Ma il vino spumeggiante sulla nivea tovaglia, ma il caldo pane biondo, ma la saporosa e fumante minestra, ma l’arrosto dorato che la madre aveva preparato con cura e pazienza la sera innanzi in segreto, non furono toccati.30
Parlarono rudi, senza inutili aggeggi né stupide finzioni; parlarono semplici e sinceri, pur sapendo di recar dolore al più caro dei compagni.31
Ma lui non le rispose, non le sorrise, non le rivolse uno sguardo affettuoso […].32
21
monografia
O quello dell’elenco:
Si sa che il loro compito è santo ma pericoloso e che ogni affetto, ogni amore, ogni cura, nulla rappresentano di fronte all’inesorabile dovere. Si devono prendere funi, piccozza, viveri e partire senza proferir parole poiché la neces-sità lo esige.33
O quello del climax:
E la valanga precipita dalla vetta del monte, e tutto avvolge, travolge e divelle, pietre, alberi e roccie, nella sua corsa pazza […].34
emettendo un suono gutturale che sembrava un rantolo di moribondo, un grido di dolore, un’esclamazione di furore disperato.35
Discorso particolare va fatto per i paragoni. Le similitudini sono un elemento portante dello stile darziano, e numerose sono già in questo primo raccontino, per quanto, va detto, ancora poco personalizzate, alcune quasi banali: «udirono le labbra appassionate degli sposi pronunciare come un soffio il sacro giuramento», «due uomini forti e bruni come la terra che li nutriva», «gelo pungente come punte di spillo», «Faurnaiser corre come una renna per lo scosceso pendio», «nevischio tagliente come vetro», «terribile come l’ira di un Dio sterminatore», «quell’istante, lungo come un secolo di dolori e tormenti», «rigido come una statua scolpita nella viva roccia», «alto e forte come un gigante», «guaiolando come un cane scudisciato». Paragoni che spesso attingono al repertorio animalesco, come se ne incontrano an-che, altrettanto topici, nei racconti di Maschere, dove però ne appaiono alcuni più originali, quali, per limitarsi a un paio di esempi: «il disco del sole appariva ancora come un’enorme moneta d’ottone» (Rivalità selvaggia), «l’ultimo riflesso del sole si era spento dietro una chiara nuvola, leggera come un velario» (Sarrù). Questo aspetto, che andrebbe considerato segno di maturazione, lascerebbe supporre che realmente La valanga preceda gli altri racconti poi apparsi nella raccolta del 1935.D’altra parte, però, si incontrano anche alcuni aspetti che saranno propri della scrittura, decisamente meno ridondante, della maturità. In La valanga Comparoni è certo ancora lontano dall’adozione delle strutture essenziali dell’italiano parlato36, se si esclude la presenza di lui per egli, compensata per altro dall’occorrenza di ella («Ella stava presso il focolare»), e il periodare del racconto è ancora complesso, ma va comunque sottolineato, ad esempio, l’accostamento di un aggettivo legato al campo morale, al limite estetico, con un sostantivo che esprime una condizione fisica: «squallida stanchezza». È una relazione straniante, e formulazioni analoghe saranno proprie dell’uso scrittorio della maturità darziana. Nel testo del 1934, inoltre, sono già riscontrabili i rimandi interni al testo tipicamente darziani, la ripresa di parole chiave, come «stanza felice», presente in apertura del racconto e ribaltata nel finale «stanza senza felicità». Soprattutto, però, sono già presenti gli interventi autoriali, poi onnipresenti nelle narrazioni successive, qui all’interno di un inciso:
22
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
Negli occhi che ridono ora, è una massima di non so più quale scrittore norve-gese, fra qualche istante luccicheranno due lacrime amare che li faranno brillare di dolore come ora sfavillano di gioia. Difatti – la loro felicità era troppo grande perché potesse durare – fu bussato alla rustica porta di quercia […].37
Sono parole, per altro, che non lasciano dubbi riguardo all’idea di precarietà, di finitudine, di miseria dell’uomo propria della narrativa darziana. A questo riguardo, sempre in La valanga, si trova anche il sintagma «piccolo essere impotente», riferito al Faurnaiser di fronte alla valanga. La piccolezza e la miseria dell’uomo, topos letterario di antica data, che verrà rielaborato in modo molto personale da Silvio D’Arzo, è già in questo primo lavoro. L’espressione, così esplicita, non riapparirà più. Ricorrerà l’indicazione della piccolezza dei personaggi, ad esempio in Essi pensano ad altro, e anche il termine «impotente», riferito alle mani di Riccardo, sempre in Essi pensano ad altro38, o alla disperazione di Lelio («furiosa ma impotente»), alla collera di Sar-torio, alla meraviglia di Schiavone («stanca e impotente»), in All’insegna del Buon Corsiero.39 Un’espressione esplicita come «piccolo essere impotente», dunque, non apparirà altrove, ma il concetto attraverserà l’opera di D’Arzo. Questa immagine forte e netta, quasi una sentenza, testimonia, se non già la consapevolezza, il sentore della precarietà, della piccolezza, al limite della meschinità della condizione umana fin dalla prima prova narrativa conosciuta. Gli aspetti tematici, retorici, lessicali, sintattici, finora mostrati, rivelano dunque come La valanga sia un racconto legato, nello stile e negli argomenti, nonché nel gusto letterario, ai racconti di Maschere e ai versi di Luci e penombre. Come d’altronde è inevitabile che sia, dato che sicuramente è stato composto più o meno nello stesso periodo. Inoltre, presenta già timidi accenni allo stile della maturità. Il perché sia poi stato escluso dalla raccolta del 1935, il perché non sia stato più citato (almeno nei documenti noti), e come sia giunto alla pubblicazione nella Antologia del 1934, restano ad oggi domande senza risposte. Ma le esigono, perché potrebbero rivelare l’esistenza di altri testi dispersi e definire con più chiarezza quale sia stato il cammino darziano, dai primi testi ai racconti del 1940-41 e oltre, verso la maturità.
Fine di Mirco (1940)
Tutti i darziani, lettori appassionati o studiosi che siano, sanno che dopo i racconti e i versi del 1935 (d’ora in poi dovremo dire: “del 1934-35”), si passa a quelli del 1940-41. Questi sono stati più volte raccolti e editi, ma della versione di Fine di Mirco qui pubblicata non si aveva alcuna notizia. Tutti conoscono la redazione apparsa su “Meridiano di Roma. L’Italia letteraria, artistica, scientifica”, il 23 giugno 1940, pubblicata anche in Opere40, ma quella presentata in questo volume è un’edizione antecedente. Appare due settimane prima del testo noto alle bibliografie, nella rivista “Quadrivio - Tevere. Grande settimanale letterario illustrato di Roma”, il 9 giugno (a. VIII, n. 33, pp. 4, 6), corredata da due illustrazioni di Ciarrocchi. Si è trattato, anche in questo caso, di un ritrovamento fortuito.41
23
monografia
La storia raccontata nelle due pubblicazioni è la medesima. Come è noto, narra di Mirco, una figura angelica, o qualcosa di analogo, che avverte un anarchico impe-gnato in una riunione politica delle cattive condizioni di salute, forse della morte, del figlio. Anche in questo caso, come in La valanga e nei racconti di Maschere, il tema della morte è centrale, e si incontra anche la porta, o meglio l’«uscio», come “soglia”. Due elementi che ricorrono pure in alcuni degli altri racconti di questo periodo. Infatti, tra il 1940 e il 1941, sono pubblicati diversi testi a firma “Silvio D’Arzo” su “Quadrivio - Tevere”, “Meridiano di Roma” e “Quadrivio. Grande set-timanale letterario illustrato di Roma”, le più importanti riviste romane: I morti delle povere case (“Meridiano di Roma”, 14 gennaio 1940), Una storia così (“Quadrivio”, 4 febbraio 1940), Sera sul fiume (“Meridiano di Roma”, 18 febbraio 1940), Fine di Mirco (“Quadrivio - Tevere”, 9 giugno 1940; “Meridiano di Roma”, 23 giugno 1940), Peccato originale (“Quadrivio - Tevere”, 7 dicembre 1941). In essi il tema della morte appare ovunque: Marco deve elaborare la morte del fratello (I morti nelle povere case), il professor Lidemo Gori si confronta addirittura con la morte della Morte (Una storia così), il fratellino atteso non nasce (Peccato originale), sta morendo il figlio del leader degli anarchici (Fine di Mirco). La “soglia” appare esplicitamente, come sostantivo, in Una storia così: le «soglie del nuovo bosco»42, dove gli angeli conducono Gori, e dove il professore rinuncia a fermarsi; ma appare, sempre con il suo consueto valore separativo, anche l’«uscio», dietro al quale è nascosto il gioco assassino in Peccato originale43, o quello presente in Fine di Mirco, dietro a cui si svolge la riunione degli anarchici, e che, aperto, porta un’aria fredda, del mondo esterno da cui Mirco, unico tra i personaggi chiusi nella stanza, si scopre separato spazialmente e temporalmente.Nei racconti del 1940-41 appare anche una nuova figura: l’angelo, presente in Una storia così e in Fine di Mirco, ma citato anche in Peccato originale. Un personaggio riconducibile al mondo del fantastico e del soprannaturale. Sono però angeli ben poco tradizionali. E diversi tra loro. Quelli di Una storia così sono messaggeri, caratterizzati dalla leggerezza («leggere come farfalle»), che «camminano lievi e composti come sogni», definiti «buoni»44, colti, tanto da conoscere Chesterton45, lontani46 ma accondi-scendenti.47 Però, più che le classiche figure del cielo, divine, sembrano dei funzionari, non freddi, ma distanti e come indulgenti verso i comportamenti dell’essere umano, ai loro occhi quasi ingenuo, infantile, risibile. I suoi usi e costumi, la sua psicologia sembrano produrre pena, magari curiosità, ma nulla di più. Questi “messaggeri” sono figure eteree, e la loro iconografia non è certo quella tradizionale.48 Come, per altro, non la è quella di Mirco, in Fine di Mirco: una figura malinconica e “contaminabile”. Sembra anch’essa lontana, ma prova compassione per gli uomini, li guarda con «sim-patia come di madre», «sentiva quasi di amarli», e quando si “contamina”, parlando con loro, respirando i loro respiri, diventa «goffo e pesante» come loro. Nel Buon Corsiero, pubblicato da Vallecchi due anni dopo, ma accettato dall’editore fiorentino nel 1941, quindi, verosimilmente, ideato e cominciato più o meno nel medesimo periodo in cui appare Fine di Mirco, si legge che gli angeli non portano con sé «un senso così fondo, così vasto, ed a tratti perfino un poco amaro, d’in-
24
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
quietudine», come invece porta il Funambolo.49 Mirco vive questa «inquietudine», che è terribilmente umana e inumana allo stesso tempo, come lo sono i personaggi darziani, quelli incapaci di partecipare alla vita.50 Quelli in esilio, diversi, altri. Quelli che restano al di là della “soglia” che divide invece di unire. L’angelo Mirco, come Giacomo Faurnaiser defunto che torna sulla porta di casa, sono figure del soprannaturale, non in grado di partecipare alla vita, che restano sulla “soglia”. Faurnaiser è certamente ancora una figura stereotipata, figlia dell’im-maturità artistica di “Raffaele Comparoni”, lontana dalla complessità dei personaggi che seguiranno. Una differente lontananza, invece, è la diversità dell’angelo Mirco da quelli di Una storia così. Quelli sono analoghi agli angeli che vede o a cui vuole credere Lauretta del Buon Corsiero, quelli che vivono in una «serenità quasi scon-certante»51. Mirco no: è contaminabile, ha compassione per gli umani, ma non riesce a comunicare con loro; è umano, ma dell’umanità darziana, radicalmente diversa, ospite poco a suo agio in «casa d’altri», sempre e ovunque. Ovviamente, dunque, Mirco e Faurnaiser sono due figure molto distanti tra loro, ma appartengono alla stessa famiglia. Quel sottoinsieme di personaggi fantastici proprio dell’insieme del-l’umanità darziana, impossibilitata a vivere, come, secondo modalità via via sempre più raffinate, i personaggi di Essi pensano ad altro e dei romanzi successivi.
Il funambolo tedesco Arturo Strohschneider a Reggio Emilia, Corso Garibaldi
25
monografia
Il dialogo tra i personaggi del racconto del 1940 e quelli del romanzo ambientato a Bologna, ma anche degli altri testi del periodo, è pure in altri dettagli. Si pensi al para-grafo di Fine di Mirco, presente in entrambe le redazioni pubblicate, in cui si legge:
Mirco non parlava mai di politica né aveva le tasche. Perciò non era un uomo: era un angelo. Solo gli uomini, strano, hanno le tasche: ne sentono un bisogno potente, irre-sistibile, anche se per lo più non se ne accorgono apertamente. Create una notte lunga, senz’aurora, e metteteci un uomo solo, in riva a un mare vuoto del volo dei gabbiani: un uomo solo e senza tasche. Lo udrete piangere sconsolato.52
Le «tasche» sono la distinzione tra l’uomo e l’angelo, e sono una spia che richiede attenzione. Sono, in questo periodo, l’immagine della solitudine dell’uomo. Ap-paiono anche nel racconto I morti delle povere case:
Pensò per un momento a un castigo cattivo e inverosimile, ad una ben strana condanna: e di doverla portare per sempre, fino alla morte della famiglia, come il negro la sua pelle. Poi uscì fra gli uomini, per strada: e fu allora che s’accorse, che scoprì quasi, di avere le tasche, in cui affondò subito le mani, sorpreso come di un dono sotto il piatto.Le tasche. Era vero. Se l’uomo non avesse le tasche, si sentirebbe troppo solo.53
Un passaggio pressoché identico si incontra in L’uomo che camminava per le strade:
Per ora egli vagava contento: di tutto, di sé, della notte ampia sulle case, delle sue tasche, in cui aveva affondato ora le mani. Le tasche. Era vero. Se ne ac-corgeva ora soltanto, sorpreso come di un dono sotto il piatto.Se non ci fossero le tasche, l’uomo si sentirebbe troppo solo.54
Questi passaggi potrebbero essere usati come chiosa esplicativa per le molto più sintetiche affermazioni che appaiono in Essi pensano ad altro:
Riccardo si cacciò le mani in tasca, per dimenticarle e dimenticare con loro anche se stesso […]55
Una malinconia sconsolata come può avere soltanto un uomo in riva al mare di notte e senza tasche.56
O per le riflessioni dei due fratellini, nel racconto Peccato originale:
Non avevamo nemmeno le tasche, e neanche, d’altra parte, riuscivamo a comprenderle e ad amarle.57
26
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
Senza considerare che risale a questo periodo l’ossessione per i ciechi, usati come personaggi (semplici comparse e riferimenti ermetici, come in Fine di Mirco, o veri e propri protagonisti, come Ladi di L’uomo che camminava per le strade), o come termini di paragone in varie situazioni, sia nei racconti, sia nei romanzi.58 Sembra dunque evidente che sia nato, o meglio si sia ampliato, il repertorio darziano, e che esista un travaso di materiale, di immagini, di formule, di espressioni tra i testi.59 Ed è altrettanto evidente che i temi chiave dell’opera darziana si sono ormai consolidati. Il percorso di cui è frutto questa maturazione, però, è solo supponibile.60 Mancano ancora molti documenti, purtroppo. E studiare questo momento della sua produ-zione non è facile. I dati parlano chiaro: i racconti delle riviste romane, privi di qualsiasi biografia, non-ché fotografia, dell’autore, appaiono dopo cinque anni di presunto silenzio. Dopo Maschere e Luci e penombre non viene pubblicato nient’altro. È però un silenzio poco convincente, da indagare. Non sono certo anni di inattività. Le lettere della casa editrice Garzanti e quelle a Vallecchi, tra la fine degli anni Trenta e i primissimi Quaranta, testimoniano una produzione notevole. Prende vita in questo periodo Ragazzo in città, di cui si ha notizia nelle lettere fin dal 193961, e che verosimilmente dovrebbe essere una prima redazione di Essi pensano ad altro. Prendono poi vita L’osteria, l’incompiuto L’uomo che camminava per le strade, Peccato originale come primo abbozzo di Un ragazzo d’altri tempi, e All’insegna del Buon Corsiero.62 L’unico testo pubblicato con l’autore in vita è notoriamente l’ultimo, uscito per Vallecchi nel 1943 (ma datato 1942). Gli altri sono postumi. Se tali scritti possono mostrare una netta maturazione nella scrittura darziana ri-spetto ai testi del 1934-35, resta comunque da scoprire cosa sia successo nei cinque anni del presunto silenzio. Capire in che momenti, in che modo, sia avvenuta quella maturazione. E se D’Arzo (o “Raffaele Comparoni”) non abbia effettivamente pubblicato altri racconti. Il fatto stesso che Peccato originale e Sera sul fiume siano in stretta relazione con Un ragazzo d’altri tempi e L’uomo che camminava per le strade, e che ricorrano in testi diversi alcune espressioni, certe immagini, come quella delle tasche, sono fenomeni che dimostrano quanto il materiale travasasse da testi complessi come romanzi a più semplici come i racconti, o viceversa. Che i testi potessero essere scorporati. Che, quindi, possano esistere stralci dei romanzi noti pubblicati, ma dispersi. O che possano addirittura esistere altri scritti, magari nati nell’orbita dei romanzi, ma poi cresciuti autonomamente. Non sono fantasie, ma supposizioni lecite, legittimate anche dal metodo di lavoro darziano.63 Sono domande che richiedono ricerche ulteriori. Di certo, al momento, non si conoscono manoscritti o dattiloscritti inediti riconduci-bili al periodo. Come non se ne hanno dei testi apparsi su “Meridiano”, “Quadrivio” e “Quadrivio - Tevere”, né si ha documentazione o altro relativa a questa edizione finora ignota di Fine di Mirco. Non si hanno accenni, nelle lettere, ai nomi di Telesio Interlandi, Luigi Chiarini e Alfredo Mezio, rispettivamente direttore responsabile, vicedirettore e redattore di “Quadrivio - Tevere”, nemmeno nelle corrispondenze del periodo con Vallecchi. Inoltre, da nessuna parte appare alcun accenno specifico
27
monografia
alla pubblicazione di Fine di Mirco, come degli altri racconti apparsi sulle riviste romane. Solo un fugace accenno nella presentazione già citata, apparsa tempo dopo, nel 1942, su “Le carte parlanti”, e un’abiura alla pubblicazione di Peccato originale, quando, nel 1947, D’Arzo scrive a Vallecchi della trasformazione del racconto in Un ragazzo d’altri tempi.64 Come Comparoni sia entrato in contatto con le riviste romane non è noto. “Qua-drivio”, “Quadrivio - Tevere” e “Meridiano” sono riviste che ospitano (anche se, in alcuni casi, solo occasionalmente), tra gli anni Trenta e i primi Quaranta, significative firme di vari ambiti culturali, non solo letterari: Giacomo Debenedetti, Ezra Pound, Elsa Morante, Mario Alicata, Carlo Muscetta, Antonello Trombadori, Girolamo Sotgiu, Alberto Bragaglia, Ugo Betti, Alberto Consiglio, Francesco Bruno, Giulio Carlo Argan, Carlo Cassola, Renato Guttuso, Luigi Chiarini, Marcello Gallian, Francesco Pasinetti, Filippo Tommaso Marinetti, Alberto Savinio, Luigi Diemoz, Giulio Petroni… Non risultano però, al momento, corrispondenze dirette con questi o altri collaboratori dei due periodici. Sarà necessario, quindi, attuare nuove ricerche anche in questa direzione. Nel frattempo, comunque, Fine di Mirco, edizione “Quadrivio - Tevere”, offre molti spunti. In primo luogo è una redazione diversa da quella nota, con varianti sostanziali e accidentali. Come per gli altri racconti, non si hanno manoscritti, dattiloscritti o bozze per verificare quali siano stati gli eventuali interventi redazionali e quali quelli d’autore. Il risultato è una versione che mostra difformità rispetto all’altra nella pun-teggiatura, in alcune scelte lessicali, ma anche per via di due corposi tagli rispetto alla redazione su “Meridiano”, nella quale, però, mancano una battuta e una similitudine particolarmente significativa, presenti invece in “Quadrivio - Tevere”.Non è possibile affermare con certezza se si tratti di due redazioni originariamente identiche, sulle quali sono stati effettuati interventi successivi da parte dell’autore, magari sotto richiesta dei redattori delle riviste, o se si tratti di due redazioni ori-ginariamente diverse, scritte in due momenti differenti. La seconda ipotesi, data la vicinanza delle due date di pubblicazione, sembra poco plausibile, ma non è da escludere, perché la comparazione dei due testi riserva molte sorprese.Per quanto riguarda le varianti accidentali, di sicuro l’edizione di “Quadrivio - Teve-re” presenta una punteggiatura molto meno puntuale. Per limitarci a un esempio:
Il cielo ora, colle sue meste nebulose, era lontano da lui come le cose dimenticate: un mondo immensamente lontano, ora, quello: o più che lontano assurdo, irreale, come quello che ci fiorisce in mente alle volte e per un po’ ci rapisce, guardando i re dei tarocchi. (“Quadrivio - Tevere” > ultra, p. 42)
Il cielo ora, colle sue meste nebulose, era lontano da lui come le cose dimenticate: un mondo immensamente lontano, ora, quello: o, più che lontano, assurdo, irreale, come quello che ci fiorisce in mente, alle volte, e per un po’ ci rapisce, guardando i re dei tarocchi.(“Il Meridiano di Roma” > Opere, p. 476)
28
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
Si notano poi alcune distinzioni nella divisione o nell’accorpamento di paragrafi, ma è possibile che si tratti di interventi redazionali. Ben più importante è notare un altro aspetto della punteggiatura: il trattino per l’incidentale. Un espediente grafico che, come si è visto, appartiene alla scrittura darziana fin dal suo esordio editoriale, nel 1934. Nell’edizione “Quadrivio - Tevere” di Fine di Mirco si legge:
il tempo era qualcosa di concreto, come i sassi e la pioggia, che passava in silen-zio – senza fretta o lentezza: passava – sugli uomini, sulle cose e le acque.66
In quella di “Meridiano”:
il tempo era qualcosa di concreto, come i sassi e la pioggia, che passava in silenzio senza fretta o lentezza: passava sugli uomini, sulle cose e le acque.67
Non è una differenza solo di forma. Lo è anche di sostanza. Nel primo caso l’af-fermazione viene assolutizzata, non è legata direttamente alla vita degli uomini. Ha dunque un valore diverso. Inoltre, il fatto di isolare un’affermazione all’interno di un inciso è, secondo lo schema stilistico darziano, una delle forme di intervento della voce autoriale che specifica, corregge o puntualizza quanto narrato. In questo caso, tale operazione acquista particolare valore anche per la presenza del sintagma «senza fretta o lentezza», che gli studiosi darziani ben conoscono. È il «tic darzia-no» che appare anche in Essi pensano ad altro, in Un minuto così68, L’osteria69, nel saggio Henry James (di società, di uomini e fantasmi)70, e soprattutto in Casa d’altri, dove caratterizza «la gestualità senza tempo» di Zelinda.71 È questa la prima volta che l’espressione viene pubblicata72, e sembra che nella prima edizione sia come sottolineata, pare le venga dato un rilievo maggiore rispetto alla seconda. Continuando il confronto tra le due edizioni, anche per quanto riguarda la morfolo-gia, la morfosintassi e il lessico, le varianti non mancano: numerose d eufoniche (e > ed) sono assenti nell’edizione su “Meridiano”, dove per altro la grafia «lagrime» (in “Quadrivio - Tevere”) appare «lacrime», mentre «s’immaginò che ci fosse» si mostra nella forma «s’immaginò che vi fosse», «ora che stava passando sotto un fanale» si presenta «ora che egli stava passando sotto un fanale», «ammettiamolo» si legge «noi
Come si vede, nella seconda edizione le virgole sono molto più ossessive. Così è anche nel resto del testo, e sono rarissimi i casi in cui, al contrario, le virgole vengo-no aggiunte. In due casi, inoltre, in luogo dei due punti65 si incontra il punto fisso:
Ma il vescovo soprattutto. Un vecchio prelato anglicano, pallido […] (“Quadrivio - Tevere” > ultra, p. 42)
sentiva che era quello il momento. Certo come della luna che guardava ora vergine le cose. (“Quadrivio - Tevere” > ultra, p. 45)
Ma il vescovo soprattutto: un vecchio prelato anglicano, pallido […] (“Il Meridiano di Roma” > Opere, pp. 476-477)
sentiva che era quello il momento: certo come della luna che guardava ora vergine le cose. (“Il Meridiano di Roma” > Opere, p. 480)
29
monografia
lo ammettiamo», «ma bensì antico» e «gli poggiava quasi sulla testa» si riducono a «bensì antico» e «gli poggiava sulla testa», «sembravano nascere a tratti da lei solo» è «parevano nascere a tratti da lei soltanto», «colletto azzurro-marca da bollo» è invece «colletto azzurro marcadabollo», il verbo e l’avverbio di «come un attore che abbia finito proprio ora la sua parte» appaiono «come un attore che ha finito proprio adesso la sua parte», «in quella sua desolata solitudine» è «in quella sua disperata solitudi-ne», lo «sconsolato dolore» finale è «sconsolato rimpianto». Sono varianti di diverso peso: in alcuni casi si tratta di sostituzioni con sinonimi, in uno di un’univerbazione grafica, in altri dell’aggiunta del soggetto, o di riorganizzazioni formali, ma in un paio di casi cambia proprio il senso del dettato. Ad esempio: dolore e rimpianto non sono sinonimi equivalenti, il primo è generico, il secondo è più specifico, legato al tema della nostalgia, della perdita, ovvero a uno dei temi darziani per eccellenza. Una questione diversa, invece, pone un’altra variante: «nell’oscurità densa come cali-gine e a momenti impalpabile»73 di “Quadrivio - Tevere” si presenta in “Meridiano”: «nell’oscurità densa come caligine e a momenti palpabile».74 A logica, in questo caso, si dovrebbe dar ragione alla seconda edizione, una scelta per altro confortata anche dall’occorrenza di un accostamento analogo in Essi pensano ad altro: «luce densa e palpabile della lampada».75 Si potrebbe dunque trattare di un refuso redazionale. In questo caso, quindi, sarebbe anche lecito intervenire ed emendare l’errore. Ma negli altri casi non lo è altrettanto. Non è possibile conoscere l’autore delle varianti e, se si può pensare che le differenze nella punteggiatura possano essere frutto di interventi redazionali, sembra poco plausibile pensare che lo siano anche i diversi termini che appaiono nelle due redazioni. D’Arzo, per altro, è un autore scrupoloso, attento alle bozze, all’impaginazione, e soprattutto fonda buona parte della sua poetica sul-l’importanza della scelta lessicale, curando quasi maniacalmente il ritmo, il suono, il significato, il senso delle parole. Non sembra possibile che abbia abbandonato al suo destino, o alle mani altrui, in modo così pesante, il suo testo (i suoi testi?). Senza considerare che le domande più interessanti che pone l’edizione “Quadrivio - Tevere” sono legate al fatto che non presenta alcune parti leggibili in “Meridiano”.76 Dedurne che la seconda edizione sia quella completa sarebbe uno sbaglio. È infatti il caso di parlare di due redazioni differenti. Alla seconda mancano parti della prima, come alla prima parti della seconda. Nell’edizione di “Quadrivio - Tevere”, infatti, si legge una battuta assente in “Meridiano”:
E il capo teneva ancora, della vita di un momento prima, solo un gran pacco di fogli scritti che lasciò poi nelle mani di un compagno.
Ed uscirono all’aria. Il cielo li aspettava, come un vigile amico, alto fra i comignoli ed i galli di latta.(“Meridiano di Roma” > Opere, p. 481)
E il capo teneva ancora, della vita di un momento prima, solo un gran pacco di fogli scritti che lasciò poi nelle mani di un compagno. «Sono qua», ripeté sollecito e ansimante.Ed uscirono all’aria. Il cielo li aspettava, come un vigile amico, alto fra i comignoli ed i galli di latta.(“Quadrivio - Tevere” > ultra, pp. 45-46)
30
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
Si potrebbe ipotizzare che dalla redazione di “Quadrivio - Tevere” abbiano chiesto a D’Arzo di tagliare il racconto, per questioni di lunghezza, e che contemporaneamente questi avesse inviato il medesimo testo a “Meridiano”, dove invece non gli avrebbero creato problemi. A questo punto, D’Arzo, tagliando il racconto per “Quadrivio - Tevere”, potrebbe aver rivisto il testo e inserito le aggiunte e le varianti. È però solo una supposizione, per altro anche discutibile, in quanto sembra poco verosimile che l’autore abbia attuato la scelta di sostituire «rimpianto» con «dolore». A meno che non sia intervenuto sostituendo a «dolore» «rimpianto» nella correzione delle bozze per “Meridiano”, ammesso che sia avvenuta una correzione di bozze.La verità è che senza documentazione di appoggio non è possibile rispondere a tutte queste domande, che il testo (im)pone con decisione.D’altronde questo saggio non ha intenzione di chiudere, chiarendolo, un capitolo della produzione darziana. Al contrario: vuole dimostrare come, proprio a partire da queste nuove scoperte, la ricerca continui, e le domande, invece di trovare rispo-ste, incontrino nuove domande, moltiplicandosi. Il che significa che è necessario moltiplicare le ricerche per fornire le risposte opportune. Vale però la pena soffermarsi, chiudendo, sulla similitudine «come un pipistrello». Se i paragoni con il repertorio animalesco sono consueti, in D’Arzo, questo volatile notturno non vanta numerose presenze. Appare in un testo certamente più tardo quale Tobby in prigione77, ma soprattutto in un saggio, anch’esso successivo, scritto nel 1950 (come testimonierebbero le lettere ad Attilio Bertolucci e ad Ada Gorini78) e pubblicato su “Paragone” nello stesso anno: Henry James (di società, di uomini e fantasmi). Nel saggio sullo scrittore americano, infatti, parlando della mostruosità dei fantasmi, D’Arzo scrive:
Non hanno storia né, quindi, società. La loro ottusa fedeltà a un ambiente è dettata da necessità, diciamo, biologiche e nient’altro, come quella di un pipistrello alla sua torre.79
In Fine di Mirco l’apparizione della guardia notturna evoca il suo girare, appunto, la notte, solo, senza vita sociale, preso dal suo dovere, silenzioso, nell’ombra. Si immagina appunto un giro sempre uguale, in effetti professionale e non biologico, ma il pipi-strello, figura notturna topica, vampiresca, ibrida (tra il ratto e il volatile), repellente, con quel suo svolazzare goffo e improbabile, cieco come molti personaggi darziani,
Non solo, sempre nella prima edizione appare una similitudine assente nella seconda:
qualche nera guardia notturna come un pipistrello scivolava in bicicletta sulle strade lucide di freddo.(“Quadrivio - Tevere” > ultra, p. 46)
qualche nera guardia notturna scivolava in bicicletta sulle strade lucide di freddo.
(“Meridiano di Roma” > Opere, p. 481)
31
monografia
risulta qui un significativo termine di paragone. È legato ai fantasmi, nel discorso su James, e i «fantasmi sono incorporei e come tali vivono una vita da esiliati».80 È l’esilio, la lontananza, la distanza che si manifesta in ogni momento. L’immagine della guardia notturna, evidentemente, è un’apparizione fantasmatica, sfuggente. Come avviene an-che in L’uomo che camminava per le strade, risalente più o meno al medesimo periodo di Fine di Mirco, dove si legge un’immagine pressoché identica a quella del racconto del 1940, ennesimo segno del travaso di materiale da un testo all’altro:
Si erano lasciati, quando, per le vie lucide di ferro, cominciavano a sparpagliarsi come pipistrelli le guardie notturne.81
Anche in questo caso la guardia notturna è un’apparizione. Insignificante, perché è più che altro un segno del tempo, la notte che sopraggiunge, e il personaggio Stresa non entra con lei in alcun tipo di rapporto. È un istante, un passaggio, una figura che sfugge, uno sfondo, se si vuole: qualcosa di biologicamente legato alla notte, come il pipistrello alla sua torre. In Fine di Mirco, Mirco, angelo contaminato e quindi divenuto uomo darziano, solo, precario, in esilio, che non riesce a varcare la “soglia”, non può entrare in comunicazione con chicchessia. Lui e questo «pipistrello», la guardia, sono due figure che appartengono alla stessa famiglia, in qualche modo. Mirco e la guardia sono due esiliati, come fantasmi e pipistrelli: due solitudini di-verse. Ed è feroce, D’Arzo, a mostrare questa scena: per Mirco è il primo incontro con un essere umano, da contaminato, da umano consapevole di essere tale. Ed è già un’incontro mancato, presagio di solitudine.
32
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
Note
1 Silvio D’Arzo, Opere, a cura di Stefano Costanzi, Emanuela Orlandini e Alberto Sebastiani, Parma, Mup Editore, 2003. Sono tratte da questo volume tutte le citazioni del saggio, eccetto quelle relative ai due racconti qui pubblicati.2 Silvio D’Arzo, Lettere, a cura di Alberto Sebastiani, Parma, Mup Editore, 2004, p. 62.3 Lo scrittore reggiano Ezio Comparoni, come è noto, firmava i suoi testi (racconti, romanzi, ma anche lettere) con degli pseudonimi, il più noto dei quali è, appunto, “Silvio D’Arzo”.4 Cfr. Silvio D’Arzo, Inchiesta sulla narrativa, in Id., Opere, cit., pp. 559-560.5 Cfr. Rodolfo Macchioni Jodi, D’Arzo critico letterario e collaboratore di riviste, in Silvio D’Arzo. Lo scrittore e la sua ombra. Atti delle giornate di studio Reggio Emilia 29-30 ottobre 1982, Firenze, Vallecchi, 1984, pp. 99-114; Eraldo Affinati, Introduzione, in Silvio D’Arzo, Contea inglese. Saggi e corrispondenza, a cura di Eraldo Affinati, Palermo, Sellerio, 1987, pp. 11-16; Massimo Raffaeli, D’Arzo lettore, in Silvio D’Arzo scrittore del nostro tempo. Atti della giornata di studi (Reggio Emilia, 13 aprile 2002), Reggio Emilia, Aliberti, 2004, pp. 23-27.6 Cfr. Alberto Sebastiani, Nota ai disegni: Gec dell’avventura, in Silvio D’Arzo, Opere, cit., pp. 953-961.7 Cfr. Alberto Sebastiani, Luoghi oscuri nell’opera di Silvio D’Arzo, in “Nuovi Argomenti”, n. 27, luglio-settembre 2004, pp. 317-325.8 Si ringrazia per questo Roberto Flego, appassionato bibliofilo e lettore darziano di Udine, che con la sua telefonata ha reso possibile il ritrovamento e la pubblicazione di questo racconto.9 Edizioni Novecento di Milano pubblicherà anche altri volumi analoghi, con il medesimo titolo Antologia dei giovani scrittori e poeti italiani, sempre nel 1934 (con un’introduzione di Lucio D’Ambra) e nel 1935 (con un’introduzione di Nino Salvaneschi).10 Tra gli autori compaiono nomi che in quegli anni stavano pubblicando libri di poesia (Carlo Zapelloni, Mily Nomade, Ezio Borfecchia, Umberto Dondi, Anna Barbesino, Agostino Macchi, Ida Dumonal), romanzi o racconti (Tito Lori, Maria di Gioacchino Modena). Alcuni diventeranno autori teatrali (Werther Bellodi, Felj Silvestri), ma ci sono anche futuri studiosi del calibro di Lodovico Magugliani e Rina Virgillito.11 Cfr. Antologia degli scrittori fascisti, a cura di Mario Carli e Giuseppe Attilio Fanelli, Firenze, Bemporad, 1931, pp. 628-629; I best seller del Ventennio. Il regime e il libro di massa, a cura di Gigliola De Donato e Vanna Gazzola Stacchini, Roma, Editori Riuniti, 1991, pp. 390-391.12 Guido Milanesi, Guido Milanesi, scrittore e nocchiero, parla ai giovani autori…, in Antologia dei giovani scrittori e poeti italiani, cit.13 I racconti e le liriche dei due volumi sono ora in Silvio D’Arzo, Opere, cit., pp. 431-458, 645-669. 14 Antologia dei giovani scrittori e poeti italiani, cit., p. 179.15 Silvio D’Arzo, Lettere, cit., p. 53. 16 Ivi, p. 326.17 Ivi, p. 293.18 Cfr. Silvio D’Arzo 1920-1952. Mostra documentaria, a cura di Anna Luce Lenzi, Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Biblioteca Municipale “A. Panizzi”, 1982, p. 21.19 Basti ricordare che nel volume Opere, ad oggi la più completa raccolta di testi darziani, sono ospitati sei romanzi (o racconti lunghi), diciotto racconti, quattordici saggi letterari, ventiquattro poesie, quattro romanzi per ragazzi e molti frammenti.20 Silvio D’Arzo, Lettere, cit., p. 417.21 Cfr. Emanuela Orlandini, “Essi pensano ad altro”. Raccontare la finitudine, in “Bollettino ‘900”, nn. 1-2, I-II semestre, 2002.22 Cfr. Emanuela Orlandini, Silvio D’Arzo. Scrittore della presenza, in “Palazzo Sanvitale”, a. III, n. 6, set-tembre, 2001, pp. 95-111.23 A ulteriore testimonianza della relazione stretta tra i testi di questo periodo, si noti anche come si presentino veri e propri travasi: il paragone con la «bolla di sapone» ritorna anche in Rivalità selvaggia, il racconto che apre Maschere, dove Maso dice a Gauro, dopo il fallito matrimonio: «Tutto è finito, Gauro, tutto come una bolla di sapone, e non c’è più rimedio…» (Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 433).
33
monografia
24 Recensendo l’edizione Sansoni di Casa d’altri, Luciano Serra ripercorrerà la produzione darziana nota al tempo, sottolineando come in Luci e penombre, «esile raccolta», «le parole e i modi erano quelle del Me-tastasio e del Monti, degli ultimi romantici e del D’Annunzio, del Carducci e del Pascoli, in una varietà di metri. Qua e là tuttavia s’avvertiva un dolce impeto come nella lirica “Ritorno e distacco” e una leggerezza d’immagini che, entro l’origine troppo evidente dell’Aquilone pascoliano, creava in “Bolle di sapone” un certo clima di felice incantesimo» (Luciano Serra, Silvio D’Arzo, Casa d’altri, in “Convivium”, a. XXII, nuova serie, n. 1, gennaio-febbraio, 1954, p. 103).25 Cfr. Roberto Carnero, Silvio D’Arzo. Un bilancio critico, Novara, Interlinea, 2002, p. 22: «La prima conside-razione di ordine critico è necessariamente limitante: l’opera precocissima del quindicenne Ezio Comparoni risente delle caratteristiche della prova di apprendistato e di esecuzione scolastica. Ad esempio, la natura è quasi sempre rappresentata in termini “romantici” o “preromantici”: le condizioni meteorologiche quando vengono descritte sono per lo più cattive (neve, pioggia, vento, ecc.) e i personaggi si trovano spesso a lot-tare contro una natura ostile. Oppure, all’opposto, le descrizioni possono scadere nel manieristico arcadico ed edulcorato. Le immagini scelte sono sempre un po’ leziose, da antologia; c’è un insistito metaforismo decorativo e un po’ scolastico (da manuale di “bello scrivere”) dell’aggettivazione. I toni sono sempre molto netti, violenti ed esasperati; manca la capacità di usarne di intermedi e di suggerire sfumature».26 Silvio D’Arzo spiega a Vallecchi, in una lettera del 15 giugno 1950, la ragione del titolo del suo testo più noto in questi termini: «Quanto al titolo “Casa d’altri” a me pare chiarissimo: quando si vive come la vecchia, in quel modo inumano e impossibile, il mondo non è più casa nostra: è “casa d’altri”: quando un uomo come il prete non ha la possibilità di far niente per aiutare la vecchia, il mondo non è più “casa nostra”: è “casa d’altri”» (Silvio D’Arzo, Lettere, cit., p. 286).27 Cfr. Paolo Lagazzi, Comparoni e “l’altro”, in Id., Comparoni e “l’altro”. Sulle tracce di Silvio D’Arzo, Reg-gio Emilia, Diabasis, 1992, p. 18: «[in Maschere], incredibilmente, c’è già (sia pure come da una distanza “anteriore”, da uno spazio umano remoto, ma anche, bisogna dirlo, senza eccessive ingenuità) tutta una serie di spunti tematici e stilistici poi ripresi nel corso dell’intera produzione darziana. E non solo le statue e le osterie, ma anche i monti che si tingono di viola e la vecchia dalla figura un po’ stregonesca, e perfino l’idea del suicidio».28 Ultra, p. 38.29 Ultra, p. 39.30 Ultra, p. 38.31 Ultra, p. 38.32 Ultra, p. 40.33 Ultra, p. 39.34 Ultra, p. 39.35 Ultra, p. 40.36 Cfr. Enrico Testa, Lingua e dialogo in “Casa d’altri”, in Silvio D’Arzo scrittore del nostro tempo. Atti della giornata di studi (Reggio Emilia, 13 aprile 2002), cit., pp. 29-41.37 Ultra, p. 38.38 Cfr. Silvio D’Arzo, Essi pensano ad altro, in Id., Opere, cit., pp. 51, 59. Nel romanzo occorre anche il termine «impotenza», riferito a Piadeni (ivi, p. 85).39 Cfr. Silvio D’Arzo, All’insegna del Buon Corsiero, in Id., Opere, cit., pp. 244, 255, 262.40 Cfr. Silvio D’Arzo, Opere, cit., pp. 473-482.41 Il caso a volte è rivelatore: stavo sfogliando la rivista per controllare che effettivamente le date relative ai racconti darziani apparsi sul settimanale in questione fossero riportate correttamente nelle bibliografie dell’autore e, per puro caso, per curiosità, ho sfogliato l’annata pagina per pagina, trovando Fine di Mirco.42 Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 471.43 Ivi, p. 490.44 Ivi, p. 469.45 Ivi, p. 470.46 Ivi, p. 471.47 Ivi, p. 472.48 L’iconografia classica degli angeli appare nelle fantasie del Prof. Gori, in Una storia così: «si sentì leggero
34
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
come un angelo e credette perfino di aver due ali morbide e bianche sulla schiena. Due placide ali da serafino che lo portassero in alto, oltre le meste comete» (ivi, p. 467), e in quelle dei due fratellini in Peccato originale, che li vedono apparire «remoti e calmi» (ivi, p. 485) sui cornicioni, o in sogno: «Le ali erano grandi e dolci, da fare volere bene perfino alle nostre mani che le toccavano pian piano» (ivi, p. 486). Da notare anche, in L’uomo che camminava per le strade: «Pensò per un momento che Ladi fosse un angelo e che sotto la giacca avesse due grandi ali morbide come il collo dei colombi» (ivi, p. 155).49 Silvio D’Arzo, All’insegna del Buon Corsiero, cit., p. 203.50 Sull’argomento si rimanda inevitabilmente al saggio di Fabrizio Frasnedi, Pensare ad altro. Saggio su Silvio D’Arzo, in Silvio D’Arzo, Opere, cit., pp. XXV-LXXIV.51 Silvio D’Arzo, All’insegna del Buon Corsiero, cit., p. 243.52 Ultra, p. 42.53 Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 462.54 Ivi., p. 171. Sempre in L’uomo che camminava per le strade, si legge anche: «Le mani, per qualche istante, si possono anche dimenticare in fondo alle tasche, assieme ad un fiammifero e a un bottone: sono qualcosa di diverso, più lontane, meno nostre» (ivi, p. 148).55 Ivi, p. 66.56 Ivi, p. 71.57 Ivi, p. 486. 58 Presenti solo in due momenti nei racconti del 1934-35 (nelle metafore spente della descrizione della «gente cieca e crudele» che non si accorge dell’autore in Il primo libro, e dell’espressione «cieco di furore», riferita al protagonista di Sarrù, cfr. Silvio D’Arzo, Opere, cit., pp. 438, 446), si incontrano quasi ossessivamente nei testi, nei racconti e soprattutto nei romanzi, dei primi anni Quaranta.59 Esistono espressioni riscontrabili solo nei racconti apparsi sulle riviste romane, come la beffarda «nté, nté», per indicare, attraverso una sorta di lallazione, ironicamente infantile, l’impossibilità della realizzazione di un’aspettativa, un sogno, un desiderio; l’inutilità di certi sforzi per modificare lo stato (spiacevole) delle cose. Si veda la ricorrenza dell’espressione beffarda in I morti delle povere case e Una storia così, (rispetti-vamente in Silvio D’Arzo, Opere, cit., pp. 461, 469). O come l’immagine dell’aquilone sfuggito, presente sia in Fine di Mirco («provò uno sconsolato dolore, come a un aquilone che sfugge», ultra, p. 46; «provò uno sconsolato rimpianto, come a un aquilone che sfugge», Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 482), sia in Una storia così («qualcosa di vago, d’indefinibile gli entrava in cuore assieme all’aria che respirava: un sentimento simile – ma non proprio così – a quello che provava da ragazzo quando il filo del suo aquilone si spezzava e lui lo guardava affondarsi nel cielo, senza poter far nulla per trattenerlo»; ivi, p. 469). O ancora come la descrizione delle parole, definite come «qualcosa di solido, di concreto» (Una storia così), «quasi corpose» (Fine di Mirco), «corpose, forse solide» (Peccato originale). O, per limitarci a un’immagine particolare, nei racconti e nei romanzi, si noti come il «desiderio d’infranger vetri e spezzettar radici» ricorra identica in Essi pensano ad altro (ivi, p. 51), L’uomo che camminava per le strade (ivi, p. 154), All’insegna del Buon Corsiero (ivi, p. 193) e Peccato originale (ivi, p. 489).60 Come sostiene Alberto Bertoni, per il quale la formazione di questi anni del Comparoni avviene anche grazie ai corsi frequentati all’Università di Bologna: «se il D’Arzo quindicenne (nel 1935) è soprattutto un poeta che ha letto, secondo modi e tempi scolastici, d’Annunzio e Pascoli, ma certo non Montale né Ungaretti, il D’Arzo che giunge al termine degli studi universitari e si vede contemporaneamente accettare da Vallecchi il testo All’insegna del Buon Corsiero che, con la data del ’42, uscirà nei primi giorni del 1943 è già uno scrittore piuttosto indipendente rispetto ai canoni d’epoca, alternati tra gli estremi dell’“Italia magica” e un gusto neoveristico già abbastanza diffuso, passando per la memorialistica cara all’ambiente di “Solaria”. […] Su questo crinale di fine anni Trenta, D’Arzo (che sta compiendo il suo cursus universitario a Bologna) definisce i nuclei di un orizzonte espressivo già decisamente originale: non tanto dal punto di vista del lavoro sulla lingua, quanto da quello tematico e strutturale» (cfr. Alberto Bertoni, Verso l’opera mondo: per un’introduzione a D’Arzo, in Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. X). 61 Cfr. Silvio D’Arzo, Lettere, cit., pp. 5, 425.62 Per le datazioni dei testi darziani, si rimanda a Nota all’edizione, in Silvio D’Arzo, Opere, cit., pp. 909-945.63 Si veda a questo proposito, ad esempio, la corrispondenza con la casa editrice Einaudi del 1946-1947, in
35
monografia
particolare per quanto riguarda la narrazione della stesura di Peccato originale, e del suo divenire Un ragazzo d’altri tempi (cfr. Silvio D’Arzo, Lettere, cit., pp. 299-308).64 Ivi, p. 198. 65 In un caso, invece, in luogo dei due punti dell’edizione “Quadrivio - Tevere” si incontra la virgola: «sta-rei per dire senza vita: che non si comunicava» (ultra, p. 44) appare «starei per dire senza vita, che non si comunicava» (Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 479). 66 Ultra, p. 42.67 Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 476.68 Ivi, p. 554. 69 Ivi, pp. 286, 315, 319.70 Ivi, p. 603.71 Uso l’espressione «tic darziano» mutuandola dal citato intervento di Fabrizio Frasnedi, Pensare ad altro. Saggio su Silvio D’Arzo, che nel suo saggio dedica alcune pagine (pp. LXIV-LXV) al sintagma «senza fretta o lentezza», ricorrente in Essi pensano ad altro e in Casa d’altri.72 L’uso di espressioni con disgiunzioni stranianti caratteristiche della scrittura di Silvio D’Arzo iniziano ad apparire in questi anni, anche se forse è riscontrabile qualche timida anticipazione in Maschere, nel racconto Rosso: «come un’ombra o una nebbia» (Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 439). Le due edizioni di Fine di Mirco presentano una situazione particolare anche a questo riguardo: mentre in “Quadrivio - Tevere” si legge «polvere di astri e di luna» (ultra, p. 45), in “Meridano” si ha «polvere di astri, o di luna» (Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 480).73 Ultra, p. 44.74 Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 479.75 Ivi, p. 79.76 Si tratta di due paragrafi: «Un bisbiglio […] alla maniera degli uomini» e «La cantina allora […] storie semplici e grasse» (ivi, pp. 480, 481).77 Ivi, p. 838.78 Cfr. Silvio D’Arzo, Lettere, cit., pp. 354, 403, 409-410.79 Cfr. Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 603. Il passaggio appare anche nella citazione del saggio che D’Arzo scrive ad Ada Gorini nell’agosto 1950 (cfr. Silvio D’Arzo, Lettere, cit., p. 410). 80 Cfr. Raffaele Crovi, I luoghi di D’Arzo, in Silvio D’Arzo scrittore del nostro tempo. Atti della giornata di studi (Reggio Emilia, 13 aprile 2002), cit., p. 62.81 Silvio D’Arzo, Opere, cit., p. 160.
Nota ai testi
Si pubblicano i testi dei due racconti così come appaiono nella loro edizione originale. Non sono stati emen-dati i refusi, segnalati classicamente con [sic!]. Si conserva la grafia «roccie». Gli unici interventi riguardano gli accenti, riscritti correttamente.In Fine di Mirco, in tre occasioni segnalate nel testo con l’asterisco (*), l’avverbio niente e gli articoli in-determinativi che, data la situazione, dovrebbero presentare l’apostrofo, ne sono privi. Non si tratta di un refuso, ma conseguenza del fatto che, nell’impaginazione originale, cadevano a fine riga, fatto che impediva la presenza dell’apostrofo.
38
Due “dispersi” darziani: nuove domande per la critica
Il cielo delle Alpi, il più bel cielo del mondo, inviolato perfino dall’aquila e dal-l’avvoltoio, accolse la promessa dei due giovani, e i marmi bianchi dell’alpestre
tempietto, che s’ergeva semplice e modesto fra le carniche roccie, udirono le labbra appassionate degli sposi pronunciare come un soffio il sacro giuramento, dinanzi al candido altare.Senza nessun corteo, senza nessuna festa, ma con la loro grande felicità e il loro amore immenso, Giacomo Faurnaiser, l’intrepido scalatore di ogni più scosceso dirupo, e Fernando [sic!] Golzi univano per sempre i loro cuori al cospetto di Dio. Ma il vino spumeggiante sulla nivea tovaglia, ma il caldo pane biondo, ma la saporosa e fumante minestra, ma l’arrosto dorato che la madre aveva preparato con cura e pazienza la sera innanzi in segreto, non furono toccati.Negli occhi che ridono ora, è una massima di non so più quale scrittore norvegese, fra qualche istante luccicheranno due lacrime amare che li faranno brillare di do-lore come ora sfavillano di gioia. Difatti – la loro felicità era troppo grande perché potesse durare – fu bussato alla rustica porta di quercia, di quella giovane quercia che cresce gagliarda ai venti impetuosi e alle gelide nevi di settentrione sui ripidi fianchi selvosi della montagna, e due uomini forti e bruni come la terra che li nutriva, entrarono nella stanza felice per parlare con Giacomo.Parlarono rudi, senza inutili aggeggi né stupide finzioni; parlarono semplici e sinceri, pur sapendo di recar dolore al più caro dei compagni. Si tratta di salvare un inglese che la valanga aveva bloccato e che sarebbe certamente perito dal gelo pungente come punte di spillo, senza il suo valido aiuto.Giorgio non fiatò; la legge dei figli dei monti non ammette che si apra bocca né che si cerchi un pretesto per rifiutarsi alla chiamata dei fratelli.
La valanga*
di Raffaele Comparoni
* In Antologia dei giovani scrittori e poeti italiani, introduzione di Guido Milanesi, Milano, Edizioni Nove-cento, 1934, pp. 179-182.
39
monografia
Si sa che il loro compito è santo ma pericoloso e che ogni affetto, ogni amore, ogni cura, nulla rappresentano di fronte all’inesorabile dovere. Si devono prendere funi, piccozza, viveri e partire senza proferir parole poiché la necessità lo esige.E Giacomo, senza proferir parola, soffocando nel petto forte e generoso i profondi sospiri, partì.
***
Il tramonto lo sorprese in cammino. Il cielo s’oscuriva: enormi nubi nerastre si raggruppavano e s’addensavano cupe e minacciose, mentre lontano, oltre mille vette, sublimi fantasmi che s’ergevano aguzzi e maestosi nella volta di piombo, il tuono muggiva fragorosamente e moriva ad un tratto con sordi boati per farsi udire ancora più assordante, ed i lampi con vividi bagliori rossastri squarciavano il cielo, facendolo sfolgorare sinistramente.Bisognava accelerare il passo, correre con tutte le forze che la disperazione di pe-rire e la speranza di salvarsi gli infondevano e raggiungere al più presto possibile il rifugio lontano[.]Non badando al vento che fischia e sibila, sollevando al suo passaggio raffiche che tolgono quasi il respiro, Giacomo Faurnaiser corre come una renna per lo scosceso pendio.Via… via… via… attraverso svolte e curve, fra picchi che scendono a burrato, col pericolo di cadere in un baratro profondo… Via… via… via… e con i piedi lividi e gonfi, col viso sferzato a sangue dal terribile nevischio tagliente come vetro, colla morte al fianco che non perde un palmo, che lo segue inesorabilmente in quella paurosa immensità.È impossibile giungere al rifugio prima che sopraggiunga la valanga; e la speranza che lo aveva prima sorretto, ora lo abbandona completamente, mentre nel suo animo abbattuto subentra la più squallida stanchezza. E la valanga precipita dalla vetta del monte, e tutto avvolge, travolge e divelle, pietre, alberi e roccie, nella sua corsa pazza, terribile come l’ira di un Dio sterminatore, con un fragore che assorda, con un balenìo che acceca. È una massa bianca ed informe che tutto distrugge e calpesta nella vorticosa discesa che non conosce ostacoli.Giacomo osserva con gli occhi sbarrati e le narici dilatate lo spettacolo pauroso che gli offre la natura ed il suo pensiero in quell’istante, lungo come un secolo di dolori e tormenti, vola alla piccola casa lontana che non rivedrà più. Chiude gli occhi impazzito, vuol gridare, ma dalla sua bocca non esce alcun suono. Il terrore lo ha reso muto. E la valanga invece di seppellire e di annientare quel piccolo essere impotente, si scaglia sdegnosa giù nella pianura dove il suo impeto cessa con un frastuono che fa tremare tutte le viscere della montagna.
***
Giovanna pure non aveva toccato cibo, ma si era inginocchiata dinnanzi alla immagine sbiadita della Madonnina delle Nevi che sorrideva, avvolta da un mantello violetto, dietro una debole fiammella di croco palpitante fioca con rapidi tremolii fugaci.
40
La valanga
Ed aveva pregato. Aveva pregato perché la valanga non glielo rapisse, perché la sera vicina glielo riportasse fra le sue braccia, confidando alla Grande Madre tutte le pene che tormentavano il suo cuore quando un’onda di vento le portava un’eco lontana di tuono, tutte le ansie che le torturavano l’animo quando una mano bussava alla porta, e tutte le fitte che la pungevano quando entrava nella misera stanza senza felicità qualcuno che non era «Lui».E la Madonna, che veglia su tutte le Alpi, immacolata Regina di bontà e di purezza, che mostra un dolce sorriso luminoso e uno sguardo divino di misericordia per chi lotta e chi soffre, esaudì l’infelice, salvandole lo sposo dal furore degli elementi scatenati…Giunse a casa verso le tre quando il sole, penetrando fra il verde cupo dei gagliardi abeti, si rispecchiava nella fredda bellezza degli alpestri ghiacciai.Ella stava presso il focolare che ancora mandava qualche scintilla, con il rosario fra le mani, con un librettino di preghiere aperto sul grembiule nero, quando una mano vigorosa batte tre colpi alla porta.Quei tre colpi furono tre punte di pugnale conficcate nelle carni di lei. Corse ad aprire con la disperazione che si leggeva negli occhi stanchi, e con un’esile fiamma di speranza che mandava l’ultimo guizzo laggiù in fondo al suo cuore addolorato.Spalancò l’uscio e, mirabile visione miracolosa, le si parò di fronte bello ed aitante, lui, che la Madonnina Sacra e pietosa aveva restituito al suo amore. Gli saltò al collo felice come non lo era stata mai, più felice ancora del giorno dietro perché la gioia si fa sentire più dolce e più viva dopo un dolore od un pericolo e gli parlò con le parole più care che sapesse, con i termini più belli che il suo cuore potesse trovare. Ma lui non le rispose, non le sorrise, non le rivolse uno sguardo affettuoso; nelle sue glauche pupille balenava una stilla di pianto.Rigido come una statua scolpita nella viva roccia, alto e forte come un gigante, la fissò un attimo torvo e taciturno.Poi aprì la bocca, la bocca che sapeva spezzare l’acciaio, mostrando la lingua ver-miglia ed emettendo un suono gutturale che sembrava un rantolo di moribondo, un grido di dolore, un’esclamazione di furore disperato.E fece capire con gli occhi ciò che con la bocca non poteva più; poi, assalito da chissà quali pensieri, fuggì lontano dietro la casa del Moro, guaiolando come un cane scudisciato. E la gente del paese non lo ritrovò che due giorni dopo nella sottostante pianura con il cranio fracassato e le gambe staccate dal resto del corpo, accanto a ciottoli, a roccie e a mucchi di neve; i residui della valanga impetuosa domata e distrutta. Ma nessuno seppe mai…
41
monografia
Fine di Mirco*
di Silvio D’Arzo
Gli uomini passavano in fretta nella prima sera: rapidi e scuri contro le insegne luminose delle vetrine. E Mirco li stava guardando con simpatia come di madre.
Sentiva quasi di amarli, ora, gli uomini. Essi continuavano intanto a passare nella neb-bia, e parole uscivano a tratti dalle loro bocche, giungendo, attraverso la strada folta di cose, fino a lui, per cadere infine come esauste dal cammino alle sue orecchie. Parole calde, quelle: parole quasi corpose in un certo senso. Uscivan dalla bocca, assieme a nuvole coloro [sic!] di niente, come nelle vignette dei giornali per bambini, e facevan pensare, così tiepide nella nebbia, a cose intime e calde, come a un bue in un fienile, ad esempio, o anche, se vogliamo, ad una caldarrosta in una vasca [sic!]: e si sperdevan quindi nell’aria. Ma gli uomini non si accorgevano affatto di esse: o, forse le trascuravano del tutto: piccole cose e di nessun valore. Mirco ebbe quasi il desiderio ad un tratto, istintivo però come il ribrezzo e la paura, di allungar una mano nell’aria e di afferrarne anche una sola, per le ali, come una farfalla o una rondine. Ecco ecco: era presa. Forse avrebbe potuto, magari, prender «volentieri» uscita adesso adesso in una nube calda e densa di fiato, dalla bocca di quell’uomo insignificante come una seppia. «Ehi, signore: avete perso qualcosa. Questo è vostro, signore.» Magnifico. Sarebbe stato magnifico sul serio. E sorrise, anche, un istante. Poi guardò di nuovo le insegne dei negozi, che gli apparvero, così luminose e raggianti, come una lampadina vista fra le lagrime: e si decise infine a scendere sulla strada. A vederla, così, dall’alto sembrava quasi avesse una vita propria la strada, avesse un cuore: e fosse lei a muoversi in quel modo nella prima sera, a scorrere e a snodarsi fra marciapiedi e case, come uno strano aspro fiume fatto di luci, di metalli, di voci. Era a terra: e voci e persone lo sfioravano rapide, di sfuggita, come ali.
* In “Quadrivio - Tevere. Grande settimanale letterario illustrato di Roma”, a. VIII, n. 33, 9 giugno 1940 – XVIII, pp. 4, 6.
42
Fine di Mirco
Il cielo ora, colle sue meste nebulose, era lontano da lui come le cose dimenticate: un mondo immensamente lontano, ora, quello: o più che lontano assurdo, irreale, come quello che ci fiorisce in mente alle volte e per un po’ ci rapisce, guardando i re dei tarocchi. La prima scoperta che fece, toccando l’asfalto lucido e fosco, fu che nessuno, sotto i portici o fra i fanali e le edicole, s’accorgeva veramente del tempo. Passare il tempo doveva essere qui soltanto un modo di dire, e nient’altro. Un minuto non era, in fondo, che un fattorino che passa in bicicletta, un carretto trainato da un normanno, o un gobbo fermo sul marciapiede: non di più. E nessuno mostrava d’accorgersi, invece, che il tempo era qualcosa di concreto, come i sassi e la pioggia, che passava in silenzio – senza fretta o lentezza: passava – sugli uomini, sulle cose e le acque. Mirco non parlava mai di politica né aveva le tasche. Perciò non era un uomo: era un angelo. Solo gli uomini, strano, hanno le tasche: ne sentono un bisogno potente, irresistibile, anche se per lo più non se ne accorgono apertamente. Create una notte lunga, senz’aurora, e metteteci un uomo solo, in riva a un mare vuoto del volo dei gabbiani: un uomo solo e senza tasche. Lo udrete piangere sconsolato. Infine si mosse. Mirco era un angelo che guardava ora, con un sorriso docile e vasto, le cose degli uomini: gli orologi, le pietre, le bandiere.
***
Era venuto in terra, fra gli uomini semplici e vivi, per ascoltare un concerto di ciechi. C’era Mozart dicevano. E c’erano pure Boccherini e Vivaldi. Solo nella musica infatti, sfiorando un’arpa o un violino – almeno era questa la sua opinione in proposito, alla quale però si manteneva dolcemente attaccato come la coda alle remote comete – i cari uomini sotto il caldo sole non apparivano così goffamente rozzi. Egli aveva conosciuto moltissimi uomini in vita: mille uomini forse: e forse anche di più di mille, certo, dal vescovo al poliziotto dilettante. Ma il vescovo soprattutto. Un vecchio prelato anglicano, pallido, quasi interiormente, come tutti gli uomini di chiesa, che emetteva, parlando, una bontà e una grazia singolari, ed aveva due strane agili mani che mai avrebbero potuto inumidirsi di sudore o d’altro. E non vecchio, anzi: ma bensì antico, colla pacata finezza di tutte le antiche cose. Ma, in una sfumatura soltanto, era goffo anche lui alla maniera degli uomini. Gli uomini hanno sul viso, accanto agli occhi, qualcosa d’atroce ed inverosimile come la barba, non conoscono la quadratura del circolo e credono, convinti, che dopo il sei venga il sette: e sorridono anche, sorridono, se si scuote a questa loro asserzione la testa. Quando però s’avvicinano a un flauto è un’altra cosa; egli lo ammetteva senz’altro, serenamente. Nemmeno un confronto, Signore. Ad ogni modo Mirco preferiva i ciechi; perché anch’essi, silenziosi e composti, e
43
monografia
senza riso, rassomigliavano stranamente agli angeli. O li ricordavano, meglio. I ciechi poi, sono gli unici che ringraziano sempre Dio del sole.
***
La città gli risultò subito fatta di vie, di case, di porte e d’usci: con sassi grigi dap-pertutto (niente c’è di più informe di una pietra) e dappertutto muri uguali di color morto. Una nube soltanto, di quelle nubi violacee che ai tramonti s’accavallano nel cielo come mandre, può coprire una città senza sforzo, può avvolgerla e riempirla di livido e di notte. Eppure il cielo gli appariva infinitamente più semplice; senza nemmeno possibilità di confronto. E Mirco si trovava già un poco a disagio: sentiva qualcosa d’indefinito, di vasto, quasi, come un lieve malessere, invaderlo, prenderlo lentamente tutto, propagarsi come un’onda ampia e lenta per il freddo sangue. Qualcosa di simile, infine, ma non proprio così, a quello che è fra gli uomini il sentimento delle cose perdute: un che di vago come il rimpianto. Pensò alle cose del caro cielo, alto e quieto ora sugli uomini che passavano indiffe-renti. Una* indifferenza assurda la loro: quasi offensiva a pensarci. Nessuno infatti, fra i milioni di uomini sparsi come foglie sulla pianura e ai margini delle acque, in quel momento pensava al cielo ampio su di loro. Non ci pensavano affatto, ora gli uomini: lo ignoravano anzi del tutto come le cose che non esistono. Quell’uomo là per esempio sulla piazza, dal profilo volgare e la cravatta stravagante, pensava forse ad una donna dai bei seni, in quel momento, una donna chissà dal nome francese, e ignorava il cielo che veniva ad adagiarsi perfino sulla sua casa. Mirco scosse la testa e volle anche sorridere un poco: ma il sorriso non fece a tempo a fiorirgli sulle labbra, estinguendosi arido per via. Intanto bisognava trovare la via dei suonatori ciechi. I ciechi dalle mani scarne e dal lontano sorriso potevano forse cambiare atmosfera, fargli forse ritrovare se stesso. E continuò la strada fra le strade. Quando, infine, giunse in Via dei Mercanti, un uomo secco e scarnito come un minatore, e che doveva aspettare lì da qualche tempo, gli fece cenno d’entrare in un uscio miserabile che macchiava la compagine lattiginosa della facciata. Mirco pensò allora a strane cose.
***
L’odor del buio e del freddo umido di cantina lo accolse di colpo al suo entrare e gli scese nel cuore assieme all’aria che respirava. Una* aria che sapeva d’intonaco am-muffito, questa, di terra nera e molle su cui piedi nudi potevan lasciare l’impronta. S’immaginò anche che ci fosse, allineata oltre l’alone scialbo della candela, una lunga fila di bottiglie color scarafaggio ed anche, magari, una rustica trappola per topi. Pensò pure, poi, senza saperne bene il perché, che, in quella luce tremula di candela, una farfalla avrebbe assunto proporzioni enormi, impressionanti. Attorno a lui sedevano uomini: altri uomini – o immagini d’uomini – stavano pure
44
Fine di Mirco
da ogni lato, in piedi, o appoggiati al muro: e le faccie apparivano e scomparivano tutte o in parte, a seconda dei battiti della candela. Di reale sembrava esserci lei soltanto, così bianca e decisa sul tavolo: e facce, profili, occhiate, sembravano na-scere a tratti da lei solo. Un battito, come di ciglia; ed ecco che la fronte di quell’uomo e il mento del suo compagno sparivano di colpo nel buio. Come se non fossero mai esistite [sic!]. Poi le parole, lentamente acquistarono significato anche per lui, coprendosi a grado a grado d’un senso che non vi aveva ancora scorto, rivestendosene direi quasi. Si rivelarono, insomma, ed apparvero simili del tutto a quelle degli altri uomini che passeggiavano ora sotto i fanali o stavano magari ascoltando in composta serenità Boccherini e Vivaldi. Anche Mirco si mise in ascolto. Parlava ora un uomo magrissimo, irriducibilmente mesto come un tipografo; un uomo, pensò Mirco, che non doveva mai essere stato bambino. «Dal punto di vista giuridico, oggi, quel che noi abbiamo in mente di attuare è in un certo senso condannabile. Ammettiamolo pure senza timore, amici. Ma dal punto di vista umano, la ragione è nostra, profondamente nostra: la ragione siamo noi anzi. E l’anarchia è l’unica nostra linea di condotta e di vita un’anarchia pura, però, un’anarchia intransigente.» E sorrise: ma fu un sorriso fermo, quasi scolpito, starei per dire senza vita: che non si comunicava cioè a tutto il viso, ravvivando gli occhi ed allargando la fronte: come quello di certi pugili stanchi quando ricevono un colpo secco sul mento. Poi un’ombra se lo rimangiò di colpo, inflessibile, assieme al cappello grigio di un altro ed al colletto azzurro marcadabollo di un terzo, più in fondo. Altre parole intanto si incrociavan per l’aria, facevano il giro della stanza, per sper-dersi poi nell’oscurità densa come caligine e a momenti impalpabile: Mirco sospettò anzi, un istante, che intingendo un dito sopra di sé, nel buio che gli poggiava quasi sulla testa, avrebbe potuto scrivere sulle pareti della stanza. Che erano pareti non propriamente bianche, a guardarle un poco, ma con infiltrazioni quasi azzurrine, come il sangue degli scarafaggi. Mirco pensava a queste cose a balzi, senza il minimo ordine o collegamento, perché il senso stanco di disagio che adesso lo teneva tutto gli impediva ormai di riflettere. Era un altro, ora, che parlava, forse il capo, circospetto negli atteggiamenti e lo sguardo come i baritoni quando entrano in scena. «Occorrerebbe una letteratura anarchica, come c’è una letteratura gialla: un romanzo anarchico come c’è un romanzo storico, insomma, o d’amore o di avventure non so. La questione è lì, vedete. Dovremmo avere un Farrel anarchico, o, per inten-derci, un Farrel che riuscisse ad esplicare tutta la sua arte in opere esclusivamente anarchiche, mi spiego. Molti poi sono anarchici, senza saperlo, senza conoscere che i loro sentimenti sono anarchici, o, per lo meno, sintomi d’anarchia. Occorrerebbe anche, di conseguenza, una specie di propedeutica all’anarchica. Ad ogni modo io credo bene agire questa sera stessa». L’uscio s’aprì un istante, in quel momento, per lasciare entrare un altro uomo e,
45
monografia
nella striscia di luce delineatasi, sgusciò rapido in cantina buono odor di mondo e di cielo.
***
L’odor di mondo invase subito la cantina, senza per altro estinguersi di colpo come una folata di vento o di fumo. E Mirco parve solo allora ricordarsi che, fuori dal livido e dal buio, continuavano ad esistere, come prima, come sempre, strade lunghe ed insegne luminose. E che sopra di esse calmo ed amico come tutte le cose senza tempo, si estendeva uguale il cielo con nebulose e comete. E non lontano, come le illusioni o i morti, ma a quattro cinque passi soltanto. L’aria che era entrata ora, sgusciando come un respiro nella stanza senza luce, era aria di strada e di cielo; aria che aveva forse portato con sé per qualche tempo polvere di astri e di luna. Gli sembrava, ad ogni modo, di essere lì da millenni o da sempre, non sapeva: ed aveva come la sensazione che questa folata rapida e fresca gli avesse fatto affiorare di colpo cose immagini e mondi sepolti da sempre nel cuore. Gli uomini invece non se ne accorgevano affatto; dall’uscio, aperto all’improvviso, era entrato, per loro, un uomo in tuta grigia e niente* altro. Un uomo colle sue idee e la sua voce, e deciso, soprattutto deciso, ad agire fra poco o anche ora. Gli uomini intanto, cominciavono [sic!] a muoversi: s’accorgevano ora, dopo una lunga pausa assente, d’aver un corpo grande ed ossuto, d’aver braccia e mani. Mani che si potevano anche stringere, volendo, con insospettata violenza. Una scoperta: una rivelazione sul serio. Avevano insomma ritrovato se stessi, come riscossi da un assai lungo torpore. Fu allora che Mirco si decise, perché sentiva che era quello il momento. Certo come della luna che guardava ora vergine le cose. E si avvicinò senza rumore, in punta di piedi e strisciando fra schiene e spalle che odoravano di benzina e di tabacco, all’uomo che aveva parlato poco prima. Un uomo grande, enorme, ora che lo vedeva da vicino, fino a sentirgli il fiato aspro di grappa. Egli parlava a questo ed a quest’altro, diceva certo, diceva questa sera ed altre cose. E Mirco intuì che dopo la candela (che però stava in fretta perdendo la sua linea snella e decisa) era la cosa più importante lì in mezzo; e quasi indispensabile, a momenti. Fu allora che gli disse, battendogli anche un poco sulla spalla, ma piano piano, con garbo, come si conviene con persone rispettabili e potenti: «Vostro figlio. Son qui per questo, signore: da quasi un’ora forse e non osavo disturbarvi. Dicevate cose grandi e importanti: davvero non osavo. Ma vostro figlio sta male, non so in verità che cosa abbia, non ne ho la minima idea. Ma sta male molto, questo so». Il capo disse vengo. Eccomi vengo. Sembrava che si fosse ora tolto baffi e parrucca, tinte e ceroni come un attore che abbia finito proprio ora la sua parte un po’ lon-tana ed irreale, d’altri tempi, e che torni ora fra pompieri ed elettricisti, tenendo in mano ancora, ma impacciato, e senza sapere proprio che farsene, la sua spada color ottone-fanfara. E il capo teneva ancora, della vita di un momento prima, solo un gran pacco di fogli scritti che lasciò poi nelle mani di un compagno. «Sono qua», ripeté sollecito e ansimante.
46
Fine di Mirco
Ed uscirono all’aria. Il cielo li aspettava, come un vigile amico, alto fra i comignoli ed i galli di latta.
***
Mirco rimase solo. La gente non passava più ora sui marciapiedi, e qualche nera guardia notturna come un pipistrello scivolava in bicicletta sulle strade lucide di freddo. Ma rara, di tanto in tanto. I pneumatici sull’asfalto davano uno strano suono. Ciechi, cantina e anarchici, gli sembravano adesso solo un incubo o un brutto sogno; e gli rimaneva nel cuore ancora quel senso confuso e vago di smarrimento che lascia appunto un sogno oscuro ed opprimente. Nel silenzio il cielo sembrava più vicino, e questo lo rincuorò del tutto. Allora volle rialzarsi: oltre le grondaie e i cornicioni la notte era sua. Alzò i piedi, d’un salto leggero, e guardò su di sé la notte che occupava ogni cosa; ma non riuscì a librarsi nell’aria, come sempre. Goffo e pesante ormai: incredibilmente goffo e pesante, ed anche ridicolo un poco, se lui non avesse invece cominciato a capire. E fece due tre tentativi ancora, ma senza alcuna speranza: colla certezza, anzi, di nessun risultato, come quando si picchia una quinta volta alla porta che già per quattro non ci ha risposto. Più nulla da fare ormai: né allargar le braccia né guardare fisso il cielo di sempre. Aveva parlato cogli uomini, ora, e li aveva anche toccati: i loro respiri, nella cantina degli anarchici, si erano confusi col suo. E adesso non poteva più rialzarsi. Era giusto, tutto questo: o comprensibile almeno. Aveva ora soltanto un bisogno infantile di piangere piangere, piangere, in quella sua desolata solitudine; ma non ci riusciva. Anche la sua ombra, ora che stava passando sotto un fanale, scomparve improvvisamente. Era rimasto veramente solo. E, a vedere il cielo immutato, colle sue grandi nubi sulle case provò uno sconsolato dolore, come a un aquilone che sfugge.
48
Bibliografia di Silvio D’Arzo
Si inseriscono nella seguente bibliografia le pubblicazioni, in ordine cronologico, dei romanzi, dei racconti, dei saggi e delle lettere di Silvio D’Arzo. A seguire, si
segnalano anche le loro traduzioni all’estero. Tutti gli scritti qui citati sono pubblicati nei volumi Silvio D’Arzo, Opere, a cura di Stefano Costanzi, Emanuela Orlandini e Alberto Sebastiani, e Silvio D’Arzo, Lettere, a cura di Alberto Sebastiani, entrambi pubblicati da Mup Editore (Parma, 2002 e 2003), con la sola esclusione dei testi tradotti in lingua straniera e dei due racconti “dispersi” pubblicati in questo volume. Questa bibliografia aggiorna, in alcuni casi corregge, con i più recenti ritrovamenti, quelle apparse nel volume Opere, nello studio di Roberto Carnero Silvio D’Arzo. Un bilancio critico (Novara, Interlinea, 2002, pp. 137-140) e in Conoscere Silvio D’Arzo. L’uomo, lo scrittore, di Luciano Serra e Giovanna Malanca (Reggio Emilia, Consulta, pp. 31-37). Prima di alcuni titoli, tra parentesi tonda, sono segnalati gli pseudonimi diversi da “Silvio D’Arzo” con cui l’autore si è firmato in quelle specifiche occasioni.
Bibliografia di Silvio D’Arzo
di Alberto Sebastiani
49
monografia
1934
(Raffaele Comparoni) La valanga, in Antologia dei giovani scrittori e poeti italiani, Milano, Edi-zioni Novecento, pp. 179-182.
1935
(Raffaele Comparoni) Luci e penombre. Liriche, Milano, La Quercia.(Raffaele Comparoni) Maschere. Racconti di paese e di città, Lanciano, Carabba.
1940
I morti nelle povere case, «Meridiano di Roma. L’Italia letteraria, artistica, scientifica», 14 gennaio.Una storia così, «Quadrivio. Grande settimanale letterario illustrato di Roma», 4 febbraio.Sera sul fiume, «Meridiano di Roma. L’Italia letteraria, artistica, scientifica», 18 febbraio.Fine di Mirco, «Quadrivio - Tevere. Grande settimanale letterario illustrato di Roma», 9 giugno.Fine di Mirco, «Meridiano di Roma. L’Italia letteraria, artistica, scientifica», 23 giugno.
1941
Peccato originale, «Quadrivio - Tevere. Grande settimanale letterario illustrato di Roma», 7 dicembre.
1942
All’insegna del Buon Corsiero, Firenze, Vallecchi.
1944
Inchiesta sulla narrativa: Silvio D’Arzo, «Le carte parlanti», a. V, n. 19, gennaio.
1945
(Andrews Mackenzie) Purgatorio di A. Nervud, professore (1897...), «Il Contemporaneo», a. I, n. 4, settembre.Invito a Conrad (parte I), «Il Contemporaneo», a. I, n. 6, novembre-dicembre.
1946
Invito a Conrad (parte II), «Il Contemporaneo», a. II, n. 7, dicembre-gennaio.Polonio o il sentimento serio della vita, «Il Contemporaneo», a. II, n. 8, marzo-aprile [poi, col titolo Le vie tortuose e la morte della persona, «Il Giovedì», a. II, n. 40, 15 ottobre 1953].Io, Robinson Crusoe, «Il Contemporaneo», a. II, n. 11, settembre.(Oreste Nasi) Canto d’amore del supplente Fleirbig, «La Fiera Letteraria», a. I, n. 29, 24 ottobre [poi «Paragone Letteratura», a. IV, n. 40, aprile 1953, p. 55].
50
Bibliografia di Silvio D’Arzo
(Tullio Mari) Il lamento dell’Anna-dei-bambini. Imitazione da una ballata inglese, «Il Contempo-raneo», a. II, n. 12, 31 ottobre.Kipling e l’Isola (I puntata), «Il Contemporaneo», a. II, n. 13, novembre-dicembre.
1947
(Sandro Nadi) Elegia alla signora Nodier, «Cronache», n. 3, 18 gennaio.(Sandro Nadi) Due vecchi, «Cronache», nn. 29-30, 19-26 luglio.Conrad e l’Umanità, «L’Umanità», 30 dicembre.
1948
Robinson ’48, «L’Umanità», 26 febbraio.(Sandro Nedi) Io prete e la vecchia Zelinda, «L’Illustrazione Italiana», nn. 29-30, 18-25 luglio, pp. 128-130, 138.
1949
Un buon compagno, «Il Gazzettino», 5 febbraio.(Sandro Nedi) Villon, buon compagno, «Il Giornale dell’Emilia», 30 settembre.(Sandro Nedi) Fra Cronaca e Arcadia, «Il Giornale dell’Emilia», 10 ottobre.
1950
(Sandro Nedi) Una fasciatura ben fatta, «Il Secolo XIX», 24 febbraio.Joseph Conrad o dell’“Umanità”, «Il Ponte», a. VI, n. 5, maggio, pp. 505-510.L’isola di Tusitala, «Paragone Letteratura», a. I, n. 6, giugno, pp. 35-39.Henry James (di società, di uomini e fantasmi), «Paragone Letteratura», a. I, n. 12, dicembre, pp. 13-21.
1951
T. E. Lawrence, «Paragone Letteratura», a. II, n. 16, aprile, pp. 72-76.Hemingway, «Paragone Letteratura», a. II, n. 22, ottobre, pp. 77-79.
1952
Saggio su Maupassant, «Il Raccoglitore. Pagina quindicinale delle lettere e delle arti» («Gazzetta di Parma»), n. 17, 26 giugno [poi in Il Raccoglitore. Pagina quindicinale della Gazzetta di Parma, a cura di P. Briganti, Parma, La Pilotta, 1979, pp. 54-60].Saggio su Maupassant, «Nuova Gazzetta di Reggio», 8 luglio.Casa d’altri, «Botteghe oscure», Quaderno X, pp. 352-400.
1953
Casa d’altri, Firenze, Sansoni.
51
monografia
Canto d’amore del supplente Fleirbig, «Paragone Letteratura», a. IV, n. 40, aprile, p. 55.Le vie tortuose e la morte della persona, «Il Giovedì», a. II, n. 40, 15 ottobre.
1957
Alla giornata, a cura di F. Squarcia, «Palatina», a. I, n. 2, aprile-giugno, pp. 5-8 [poi in Narra-tori di Emilia e Romagna, a cura di G. Raimondi e R. Bertacchini, Milano, Mursia, 1968, pp. 305-309].
1958
Casa d’altri, in Racconti italiani, a cura di G. Carocci, Milano, Lerici, pp. 313-362.Un minuto così, «Palatina», a. II, n. 6, aprile-giugno, pp. 23-29 [poi in Antologia di “Palatina”, a cura di P. Lagazzi, Parma, La Pilotta, 1981, pp. 57-63].
1959
Silvio D’Arzo: Penny Wirton (cap. IX), a cura di A. Bevilacqua, «La Fiera Letteraria», a. XIV, 21 giugno, p. 5.Uno strano corteo per la città di Pictown (brano di Penny Wirton e sua madre), «Lettere emiliane», n. 1, novembre, pp. 51-53.
1960
O vecchio Barnaba Rag, Omero del sabato sera, «Palatina», n. 13, gennaio-marzo, p. 30.Una morte più bella di un poema, «Palatina», n. 13, gennaio-marzo, pp. 31-33 [poi in Antologia di “Palatina”, a cura di P. Lagazzi, Parma, La Pilotta, 1981, pp. 165-168].Prefazione a “Nostro lunedì”, «Paragone Letteratura», a. XI, n. 124, aprile, pp. 83-91.Kipling senza trombe, «Il Ponte», a. XVI, n. 7, luglio, pp. 1107-1112.Nostro lunedì. Racconti, poesie, saggi, a cura di R. Macchioni Jodi, Firenze, Vallecchi (il volume comprende: i racconti lunghi All’insegna del Buon Corsiero, pp. 3-120; L’Osteria, pp. 121-188; Casa d’altri, pp. 189-235; Prefazione a “Nostro lunedì”, pp. 237-249; i racconti I morti nelle povere case, pp. 253-255; Una storia così, pp. 257-269; Fine di Mirco, pp. 271-281; Peccato originale, pp. 283-291; L’aria della sera, pp. 293-296; Elegia alla signora Nodier, pp. 297-306; Due vecchi, pp. 307-318; Una fasciatura ben fatta, pp. 319-325; Alla giornata, pp. 327-330; Un minuto così, pp. 331-341; le poesie Purgatorio di A. Nervud, professore, pp. 345-346; O vecchio Barnaba Rag, Omero del sabato sera, p. 347; Canto d’amore del supplente Fleirbig, pp. 348-349; Rimpianto, p. 350; Il lamento dell’Anna-dei-bambini, pp. 351-352; I bambini hanno il vestito nuovo, p. 353; i saggi Un buon compagno, pp. 357-360; Polonio o il sentimento serio della vita, pp. 361-366; Robinson 1948, pp. 367-370; Henry James (Di società, di uomini e fantasmi), pp. 371-382; L’isola di Tusitala, pp. 383-389; Una morte più bella di un poema, pp. 391-395; Maupassant. Il sentimento virile della vita, pp. 397-408; Joseph Conrad o dell’“Umanità”, pp. 409-417; Kipling senza trombe, pp. 419-428; T. E. Lawrence: una vita difficile, pp. 429-438; Ernest Hemingway, pp. 439-443; Società, americani e altre cose, pp. 445-449; Fra Cronaca e Arcadia, pp. 451-453).
52
Bibliografia di Silvio D’Arzo
1968
Alla giornata, in Narratori di Emilia e Romagna, a cura di G. Raimondi e R. Bertacchini, Milano, Mursia, pp. 305-309.
1976
Essi pensano ad altro, a cura di P. Lagazzi, Milano, Garzanti.
1977
Il pinguino senza frac, in A. L. Lenzi, Silvio D’Arzo. (“Una vita letteraria”), Reggio Emilia, Tipo-litografia Emiliana, pp. 93-106.Cinque lettere a Enrico Vallecchi, in A. L. Lenzi, Silvio D’Arzo. (“Una vita letteraria”), Reggio Emilia, Tipolitografia Emiliana, pp. 109-114.
1978
Penny Wirton e sua madre, a cura di R. Macchioni Jodi, illustrazioni di A. Manfredi, Torino, Einaudi.Il pinguino senza frac, illustrazioni di A. Manfredi, Reggio Emilia, Prandi.
1979
Saggio su Maupassant, in Il Raccoglitore. I. Pagina quindicinale della Gazzetta di Parma, a cura di P. Briganti, Parma, La Pilotta, pp. 54-60.Lettere di Silvio D’Arzo a Ada Gorini, a cura di A. L. Lenzi, «Nuovi Argomenti», n. 62, aprile-giugno, pp. 10-23 [poi in Contea inglese. Saggi e corrispondenza, a cura di E. Affinati, Palermo, Sellerio, 1987, pp. 119-127; e in Una storia così. Lettere per Ada, Reggio Emilia, Diabasis, 1995, pp. 9-33].
1980
Lettere di Silvio D’Arzo a Emilio Cecchi, a cura di E. Affinati, «F M» (Annali dell’Istituto di Filologia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma), nn. 1-2, pp. 249-257.Casa d’altri e altri racconti, Torino, Einaudi (il volume comprende: Casa d’altri, pp. 3-50; Elegia alla signora Nodier, pp. 51-63; Due vecchi, pp. 65-79; Un minuto così, pp. 81-93).
1981
Un minuto così, in Antologia di “Palatina”, a cura di P. Lagazzi, Parma, La Pilotta, pp. 57-63.Una morte più bella di un poema, in Antologia di “Palatina”, a cura di P. Lagazzi, Parma, La Pilotta, pp. 165-168.Lettere di Silvio D’Arzo a Emilio Cecchi, a cura di E. Affinati, «Contributi», a. V, n. 9, gennaio-giugno, pp. 65-82 [poi in Contea inglese. Saggi e corrispondenza, a cura di E. Affinati, Palermo, Sellerio, 1987, pp. 99-118].
53
monografia
Un inedito giovanile di Silvio D’Arzo: “L’uomo che camminava per le strade”, a cura di A. L. Lenzi, «Contributi», a. V, n. 9, gennaio-giugno, pp. 83-123 [poi in Un ragazzo d’altri tempi, Firenze, Passigli, 1994, pp. 5-59; L’uomo che camminava per le strade. Racconti, a cura di D. Garbuglia, Macerata, Quodlibet, 1993, pp. 21-72].
1983
Il pinguino senza frac e Tobby in prigione, illustrazioni di A. Manfredi, Torino, Einaudi.Casa d’altri, in Racconti italiani del Novecento, a cura di E. Siciliano, Milano, Mondadori, 1059-1112.Un nuovo inedito di Silvio D’Arzo: “Un ragazzo d’altri tempi”, a cura di R. Macchioni Jodi, «Contributi», a. VII, n. 13, gennaio-giugno, pp. 63-113 [poi in Un ragazzo d’altri tempi, Firenze, Passigli, 1994, pp. 61-131].
1984
Silvio D’Arzo - Enrico Vallecchi, Carteggio 1941-1951, a cura di A. L. Lenzi, «Contributi», a. VIII, nn. 15-16.
1985
Il pinguino senza frac, in La bottega dello stregone. Cent’anni di fiabe italiane, a cura di E. Ghidetti e L. Lattarulo, Roma, Editori Riuniti, pp. 273-286.
1986
Nostro lunedì di Ignoto del XX secolo, a cura di A. L. Lenzi, Modena, Mucchi.
1987
Contea inglese. Saggi e corrispondenza, a cura di E. Affinati, Palermo, Sellerio (il volume com-prende: i saggi Un buon compagno, pp. 21-23; Polonio o il sentimento serio della vita, pp. 24-28; Robinson 1948, pp. 29-31; Henry James (di società, di uomini e fantasmi), pp. 32-41; L’isola di Tusitala, pp. 42-46; Una morte più bella di un poema, pp. 47-50; Maupassant. Il sentimento virile della vita, pp. 51-60; Joseph Conrad o dell’“Umanità”, pp. 61-68; Kipling senza trombe, pp. 69-76; T. E. Lawrence: una vita difficile, pp. 77-84; Ernest Hemingway, pp. 85-89; Società, americani e altre cose, pp. 90-93; Fra Cronaca e Arcadia, pp. 94-96; le lettere a Emilio Cecchi, pp. 99-118, e a Ada Gorini, pp. 119-127).Vita da capra (brano di Casa d’altri), in R. Bertacchini, Letteratura delle origini d’Italia. Storia e testi. Emilia Romagna, Brescia, La Scuola, pp. 300-301.
1988
All’insegna del Buon Corsiero, Milano, Lombardi.
54
Bibliografia di Silvio D’Arzo
1989
Sera sul fiume, Reggio Emilia, Mavida.
1990
Una storia così (Capitolo II), a cura di A. L. Lenzi e P. Lagazzi, «Idra», a. I, n. 2, pp. 87-114.Il professor Comparoni (tre lettere inedite di Silvio D’Arzo), a cura di A. L. Lenzi, «Studi e problemi di critica testuale», n. 41, ottobre, pp. 165-173.(Ezio Comparoni) Aggiunte e correzioni all’A.I.S. per il centro 444, a cura di U. Bellocchi, Centro studi sul dialetto reggiano, Comune di Albinea.
1991
Un minuto così, in Novelle italiane. Il Novecento, a cura di G. Finzi, Milano, Garzanti, pp. 589-598.
1992
Una storia così, in P. Lagazzi, Comparoni e “l’altro”, sulle tracce di Silvio D’Arzo, Diabasis, Reggio Emilia, pp. 105-136 [poi in Una storia così, Reggio Emilia, Diabasis, 1995, pp. 9-41].
1993
Penny Wirton e sua madre, a cura di B. Laprea, Torino, Einaudi scuola.L’uomo che camminava per le strade. Racconti, a cura di D. Garbuglia, Macerata, Quodlibet (il volume comprende: Prefazione a “Nostro lunedì”, pp. 7-19; L’uomo che camminava per le strade, pp. 21-72; I morti nelle povere case, pp. 75-77; Una storia così, pp. 79-94; Fine di Mirco, pp. 95-107; Peccato originale, pp. 109-119; L’aria della sera, pp. 121-126; Elegia alla signora Nodier, pp. 127-139; Due vecchi, pp. 141-155; Una fasciatura ben fatta, pp. 157-165; Alla giornata, pp. 167-172; Un minuto così, pp. 173-185).
1994
Un ragazzo d’altri tempi, Firenze, Passigli (il volume comprende: L’uomo che camminava per le strade, pp. 5-59, Un ragazzo d’altri tempi, pp. 161-131, Peccato originale, pp. 133-143, Tre lettere di Silvio D’Arzo, pp. 145-158, Maschere. Racconti di paese e di città, pp. 159-204).
1995
All’insegna del Buon Corsiero, Milano, Adelphi.Una storia così, Reggio Emilia, Diabasis (il libro è diviso in 3 volumi: Una storia così; Lettere per Ada; Poesie, che comprende: Purgatorio di A. Nervud, professore, p. 11; Così, vinti dal dolore..., p. 13; Canto d’amore del supplente Fleirbig, p. 15; Rimpianto, p. 17; Il lamento dell’Anna dei bambini, p. 18; I bambini hanno il vestito nuovo, p. 21; Preghiera come un’altra, p. 25; Gli eruditi di W. B. Yeats, p. 27).L’aria della sera e altri racconti, a cura di S. Perrella, Milano, Bompiani (il volume comprende:
55
monografia
Piccolo mondo degli umili, pp. 3-11; I morti nelle povere case, pp. 13-15; Una storia così, pp. 17-30; Sera sul fiume, pp. 31-34; Fine di Mirco, pp. 35-46; Peccato originale, pp. 47-56; Elegia alla signora Nodier, pp. 57-68; Due vecchi, pp. 69-82; Una fasciatura ben fatta, pp. 83-89; Casa d’altri, pp. 90-138; Alla giornata, pp. 139-143; Un minuto così, pp. 144-155; L’aria della sera, pp. 156-160; Il pinguino senza frac, pp. 161-177; Prefazione a “Nostro lunedì”, pp. 181-192).Gec, «Marka», a. XV, n. 32, pp. 66-71.
1998
L’Osteria, Macerata, Quodlibet.
1999
Casa d’altri e altri racconti, a cura di E. Affinati, Torino, Einaudi (il volume comprende: Casa d’altri, pp. 3-50; Prefazione a “Nostro lunedì”, pp. 51-56; Alla giornata, pp. 67-72; Una fasciatura ben fatta, pp. 73-80; L’aria della sera, pp. 81-86; Elegia alla signora Nodier, pp. 87-99; Due vecchi, pp. 110-115; Un minuto così, pp. 117-129).
2001
L’annegata. Inedito da Casa d’altri, a cura di S. Costanzi, «Palazzo Sanvitale», n. 6, settembre, pp. 85-93.
2002
Casa d’altri. Edizione critico-genetica, a cura di S. Costanzi, Torino, Aragno.Casa d’altri. Il libro, a cura di P. Briganti e A. Briganti, Reggio Emilia, Diabasis.Essi pensano ad altro, a cura di R. Carnero, Milano, Bompiani.Luci e penombre. Liriche, a cura di G. Pedullà, Reggio Emilia, Diabasis.
2003
Opere, a cura di S. Costanzi, E. Orlandini e A. Sebastiani, Parma, Mup Editore.
2004
Lettere, a cura di A. Sebastiani, Parma, Mup Editore.Il pinguino senza frac, illustrazioni di R. Meli, Parma, Mup Editore.Tobby in prigione, illustrazioni di R. Meli, Parma, Mup Editore.
2005
Il pinguino senza frac, Parma, Mup Editore.Tobby in prigione, Parma, Mup Editore.Casa d’altri, Parma, Mup Editore.
56
Bibliografia di Silvio D’Arzo
2006
Fine di Mirco, a cura di P. Di Palmo, Pistoia, Edizioni Via del Vento.
2007
I morti nelle povere case, in Miserabili in prosa: Novecento, a cura di G. Greco, F. Marri, L. Tinti, Bologna, Clueb, pp. 204-205.
Traduzioni:
Exile (a long story), trad. di B. Wall, «Encounter», n. 5, febbraio, 1954, pp. 12-34. Des andern Haus, trad. di I. Von Kaschnitz, Wiesbaden, Im-Insel Verlag, 1959.Exile (a long story), trad. di B. Wall, in Stories of modern Italy, a cura di B. Johnson, New York, 1960, pp. 450-503.Huis van anderen. Novelle, trad. di J. H. Klinkert Pötters Vos, Amsterdam, Meulenhoff, 1978.Penny Wirton en zijn moeder, trad. di J. H. Klinkert Pötters Vos, Amsterdam, Meulenhoff, 1981 (comprende anche De pinguïn zonder rok).Casa de otros. Y algunos relatos, Universidad autonoma metropolitana, 1984.Le Camp des castors. Récit, trad. di S. Charre e C. Grillon, L’École des Loisirs, Paris, 1985.Maison des autres. Récit, trad. di B. Simeone, con introduzione di A. Bertolucci, Lagrasse, Ver-dier, 1988.Des andern haus. Erzählung, trad. di I. Schnebel-Kaschnitz, Frankfurt, Suhrkamp, 1992. The house of other, trad. K. Botsford, Evaston (Illinois), The Marlboro Press, 1995.Maison des autres, suivi de Un moment comme ça, trad. di P. Renard e B. Simeone, Lagrasse, Verdier, 1998.À l’enseigne du Bon Coursier, trad. e introduzione di B. Simeone, Lagrasse, Verdier, 1998.Casa d’altri. Idegen égbolt alatt, trad. di S. Ferenc, Budapest, Noran, 1999.
57
monografia
La presente bibliografia della critica darziana, organizzata in ordine cronologico, integra e aggiorna, tramite ulteriori ricerche nei repertori informatici e cartacei,
quelle compilate da Eraldo Affinati (Silvio D’Arzo. Rassegna stampa 1943-1982, Reggio Emilia, Biblioteca Municipale “A. Panizzi”, 1982), da Anna Luce Lenzi (in Silvio D’Arzo 1920-1952. Mostra documentaria, a cura di A. L. Lenzi, Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Biblioteca Municipale “A. Panizzi”, 1982, pp. 59-67), Stefano Costanzi (del 1999, disponibile sulle pagine dedicate all’autore nel sito dell’ITC “Silvio D’Arzo” di Montecchio – Reggio Emilia, all’indirizzo www.istitutodarzo.it/darzo/biblio/critica.html), Roberto Carnero (in Silvio D’Arzo. Un bilancio critico, Novara, Interlinea, 2002, pp. 137-157) ed Emanuela Orlandini (in “Bollettino ‘900”, rivista on line del Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna, giugno-dicembre 2002, nn. 1-2).Sono inclusi: monografie e saggi pubblicati sia su supporto cartaceo, sia on-line, apparsi in atti di convegni, riviste e miscellanee; prefazioni, postfazioni, note ai testi e introduzioni nei volumi che ospitano opere dell’autore; schede bio-bibliografiche. Sono inseriti nel repertorio anche articoli di periodici e quotidiani. I testi di questa bibliografia sono relativi totalmente o solo parzialmente (in questo caso le pagine dedicate all’autore sono specificate) all’opera di Silvio D’Arzo. Si è inoltre deciso di inserire anche scritti relativi alle manifestazioni (convegni, rappresentazioni teatrali, letture pubbliche) dedicate all’autore, per avere un quadro il più completo possibile dell’interesse critico suscitato dal lavoro di Silvio D’Arzo, nonché per rendere fruibile il repertorio anche a chi vorrà studiare l’ambito dei tributi allo scrittore reggiano.
Bibliografia su Silvio D’Arzo
di Alberto Sebastiani
58
Bibliografia su Silvio D’Arzo
1943
SUSSURRO, Ultime dalla letteratura, «Tempo di scuola», a. IV, n. 3, gennaio, p. 225.Silvio D’Arzo. All’insegna del Buon Corsiero, «Le carte parlanti», a. IV, n. 11, marzo, p. 10 [poi in S. D’ARZO, Lettere, a cura di A. Sebastiani, Parma, Mup Editore, 2004, p. 294].M. DONATI, Romanzi, viaggi e racconti, «Quadrivio», 18 aprile.A. COLANTUONO, D’Arzo, uno e due, «Temperamento», nn. 2-3, aprile-maggio.W. BINNI, Letteratura contemporanea, «La nuova Italia», maggio-giugno, pp. 70-73. L. GIGLI, Narratori d’oggi, «La Gazzetta del Popolo», 26 giugno.W. DIAS, Scrittori moderni, «Corriere mercantile», 13 luglio.
1952
Silvio D’Arzo, «Paragone», a. III, n. 26, febbraio, p. 80. G. DEGANI, Ricordo di Silvio D’Arzo, «Emilia», n. 4, giugno, pp. 132-133.G. DEGANI, Ricordo di Silvio D’Arzo, «Il Raccoglitore», 26 giugno [poi in Il Raccoglitore. I. Pagina quindicinale della Gazzetta di Parma. 1951-1959, a cura di P. Briganti, Parma, La Pilotta, 1979, pp. 52-53].N. GALLO, [scheda a] “Botteghe oscure”, Quaderno X (1952), «Società», a. VIII, n. 4, dicembre, pp. 780-781 [poi in ID., Scritti letterari, a cura di O. Cecchi, C. Garboli e G. C. Roscioni, Milano, Il Polifilo, 1975, pp. 58-59].
1953
G. DEGANI, Ricordo di Silvio D’Arzo, in S. D’ARZO, Casa d’altri, Firenze, Sansoni, pp. 7-10.Scartafaccio. Botteghe oscure, «Il Nuovo Corriere», 3 gennaio.D. PAUL, Whispering Gallery, «The Observer», 4 gennaio.F. SQUARCIA, Tre scrittori reggiani. Varni, Lugli, D’Arzo, «Giovedì», 12 febbraio.Silvio D’Arzo. Casa d’altri, «Gazzettino Sera», 24 giugno.E. FALQUI, Una strana storia, «Il Tempo», 27 giugno [poi in ID., Novecento letterario italiano. IV, Firenze, Vallecchi, 1954, pp. 851-855].G. DEGANI, L’opera incompiuta di Ezio Comparoni, «La Verità», 28 giugno [poi, col titolo L’opera incompiuta di Ezio Comparoni. Ricordo di uno scrittore reggiano prematuramente scomparso, in Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 2002, pp. 51-52].F. T., Casa d’altri, «Alto Adige», 30 giugno.Silvio D’Arzo. Casa d’altri, «Pomeriggio Bologna», 1 luglio.A. SERONI, La penna e la cetra, «La Sera», 1 luglio.Casa d’altri, «Giornale dell’Emilia», 6 luglio.G. A. C., Addio di uno scrittore, «Stella», 17 luglio.L. GIGLI, Presenze, «Gazzetta del Popolo», 25 luglio.G. LUTI, Ricordo di Silvio D’Arzo, «Il Popolo», 17 settembre. N. GALLO, L’ultima narrativa italiana, «Società», a. IX, n. 3, settembre, pp. 399-410 [poi in ID., Scritti letterari, a cura di O. Cecchi, C. Garboli e G. C. Roscioni, Milano, Il Polifilo, 1975, pp. 61-73: 69].C. GORLIER, D’Arzo, «Paragone», a. IV, n. 48, dicembre, pp. 96-99.
59
monografia
1954
E. FALQUI, Una strana storia, in ID., Novecento letterario italiano. IV, Firenze, Vallecchi, pp. 851-855.L. SERRA, Silvio D’Arzo, Casa d’altri, «Convivium», a. XXII, nuova serie, n. 1, gennaio-febbraio, pp. 103-105.S. MORINI, La storia di un paese dove non accadeva mai nulla, «l’Unità», 18 febbraio.E. MONTALE, Letture. Silvio D’Arzo, «Corriere della Sera», 10 marzo [poi in Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 2002, pp. 119-120]. R. CROVI, Ricordo di Silvio D’Arzo (Ezio Comparoni), «La Libertà», a. III, n. 10, 14 marzo. G. ZANELLI, Silvio D’Arzo, «Carlino Sera», 10 maggio.N. ACQUARONE, Ricordo di D’Arzo, «Gazzetta di Parma», 15 maggio.P. CITATI, D’Arzo und Cassola, «Neue Zürchere Zeitung», 8 agosto.
1955
E. N. BARAGIOLA, Aus dem Nachlaß eines Jungverstorbenen, «Volkshochschule» (Zürich), marzo-aprile.
1958
W. GIBERTI, Dopo Casa d’altri non è venuto lunedì, «Il Tricolore», 19 aprile.P. BONFIGLIOLI, Silvio D’Arzo e il senso della società, «Palatina», a. II, n. 6, aprile-giugno, pp. 3-22 [poi in Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 2002, pp. 31-48].G. DEGANI, Un libro non scritto, «l’Unità», 24 luglio.A. BEVILACQUA, Silvio D’Arzo, «La Fiera Letteraria», 3 agosto.R. MACCHIONI JODI, D’Arzo e la conquista della realtà, «Il Ponte», a. XIV, nn. 8-9, agosto-settem-bre, pp. 1134-1142.
1959
R. FRATTAROLO, Bibliografia speciale della letteratura italiana, in ID., Problemi e orientamenti critici di lingua e letteratura italiana. Notizie introduttive e sussidi bibliografici, Parte II, Milano, Marzorati, pp. 515-516.A. BEVILACQUA, Un personaggio simbolico, «La Fiera Letteraria», 21 giugno.F. AZZALI, L’estro di Ezio Comparoni, «Il Resto del Carlino», 23 dicembre.G. F., “Casa d’altri” presentata in forma di lettura scenica, «Avvenire d’Italia», 23 dicembre.G. BO., Lettura di “Casa d’altri” seguita con vivissimo interesse, «Gazzetta di Reggio», 24 dicem-bre.
1960
R. MACCHIONI JODI, Introduzione a D’Arzo, in S. D’ARZO, Nostro Lunedì. Racconti, poesie, saggi, a cura di R. Macchioni Jodi, Firenze, Vallecchi, pp. VII-XXII.G. DEGANI, In memoria di Silvio D’Arzo, in S. D’ARZO, Nostro Lunedì. Racconti, poesie, saggi, a cura di R. Macchioni Jodi, Firenze, Vallecchi, pp. 455-461.
60
Bibliografia su Silvio D’Arzo
R. MACCHIONI JODI, Postilla a due inediti di Silvio D’Arzo, «Palatina», a. IV, n. 13, gennaio-marzo, pp. 33-35.R. MACCHIONI JODI, Le opere complete di Silvio D’Arzo, «Il Ponte», a. XVI, n. 7, luglio, pp. 1102-1106.R. MACCHIONI JODI, L’opera completa di Silvio D’Arzo, «Le carte parlanti», nn. 38-41, novembre-febbraio (1960-1961).
1961
R. MACCHIONI JODI, Silvio D’Arzo, «Provincia di Reggio Emilia» (Premio Provincia di Reggio Emilia 1960), Reggio Emilia.Nostro Lunedì, «Ricerche», febbraio.R. VALERIANI, È apparsa nelle librerie l’“opera omnia” di Silvio D’Arzo, «l’Unità», 21 febbraio.G. MANACORDA, Uno scrittore scomparso. Le opere di D’Arzo, «Paese Sera», 25 febbraio.J. OSTI, Nostro Lunedì, «La Libertà», 25 febbraio.V. VETTORI, D’Arzo come Pavese, «Rassegna di cultura e vita scolastica», a. XV, n. 2, 28 febbraio, pp. 1-2 [poi in ID., Storia letteraria della civiltà italiana, Pisa, Giardini, 1969, pp. 547-548]G. PAMPALONI, Tutto Silvio D’Arzo, «L’Approdo», n. 715, 4 marzo.I libri della settimana. “Nostro Lunedì”, «La settimana a Roma», 17 marzo.Libri in vetrina. “Nostro Lunedì” di D’Arzo, «Corriere d’informazione», 18 marzo.S. BRUSCHI, Silvio D’Arzo, «Corriere dell’Adda», 18 marzo.G. CAGNOLATI, Dal “Buon Corsiero” a “Casa d’altri”, «Commento radicale», a. II, n. 3, 30 marzo.P. CITATI, Scrisse un racconto perfetto e poi morì a trentadue anni, «Il Giorno», 31 marzo [poi, col titolo Scrisse un racconto perfetto e morì a trent’ anni, in Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 2002, pp. 53-56].V. VOLPINI, Novità di scrittori italiani, «Humanitas», a. XVI, n. 4, aprile, pp. 353-360: 354-355.G. FORNACIARI, Tutto Silvio D’Arzo in splendida veste, «Gazzetta di Reggio», 11 maggio.L. GIGLI, Diorama letterario. Non succede mai niente, «La Gazzetta del Popolo», 31 maggio.M. LAVAGETTO, Silvio D’Arzo, «Paragone», a. XII, n. 138, giugno, pp. 52-58.V. AMORUSO, Silvio D’Arzo, «Nuova Corrente», a. VIII, n. 22, aprile-giugno [poi in ID., Le contrad-dizioni della realtà. La narrativa italiana degli anni ’50 e ’60, Bari, Dedalo, 1968, pp. 97-103].S. BEVILACQUA, Vita ed opera di Silvio D’Arzo, «Il Popolo», 16 luglio.S. BEVILACQUA, Vita ed opera di Silvio D’Arzo, «Il Giornale di Brescia», 22 luglio.E. N. BARAGIOLA, Silvio D’Arzo (1920-1952), «Neue Zürchere Zeitung», 6 agosto.G. ZANELLI, Le opere d’uno scrittore morto a trent’anni, «Corriere del Ticino», 24 agosto.L. GIGLI, Nostro lunedì. Le opere d’uno scrittore morto a trent’anni, «Corriere del Ticino», 24 agosto.R. SCRIVANO, Un anno di narrativa, «Il Ponte», a. XVII, n. 12, dicembre, p. 1761-1777.
1965
G. BARBERI SQUAROTTI, La narrativa del dopoguerra, Bologna, Cappelli, pp. 232-233.
1967
R. MACCHIONI JODI, Introduzione a D’Arzo, in ID., Scrittori e critici del Novecento, Ravenna, Longo, pp. 147-165.G. MANACORDA, Storia della letteratura contemporanea (1940-1965), Roma, Editori Riuniti, p. 314.
61
monografia
1968
V. AMORUSO, Silvio D’Arzo, in ID., Le contraddizioni della realtà. La narrativa italiana degli anni ’50 e ’60, Bari, Dedalo, pp. 97-103.
1969
V. VETTORI, Storia letteraria della civiltà italiana, Pisa, Giardini, pp. 376, 542, 547-548.G. PAMPALONI, La nuova letteratura, in Storia della letteratura italiana. IX. Il Novecento, diretta da E. Cecchi e N. Sapegno, Milano, Garzanti, p. 749-879: 873.
1970
A. GALLONI, Ricordo di Silvio D’Arzo, «Pagine aperte», febbraio.
1971
G. BASSANI, Quaderno. Lettere d’amore smarrite, «Corriere della Sera», 14 luglio.A. BERTOLUCCI, Riproporre Silvio D’Arzo alle nuove generazioni, «Il Giorno», 4 agosto [poi in Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 2002, p. 79].
1972 H. J. KLINKERT-PÖTTERS VOS, Over Silvio D’Arzo en zijn “Casa d’altri”, «Litterair Paspoort», n. 258, aprile, pp. 63-65.H. J. KLINKERT-PÖTTERS VOS, Silvio D’Arzo: auteur die zich verstopte, «Het Vaderland», 25 no-vembre.
1974
R. MACCHIONI JODI, Silvio D’Arzo, in Letteratura Italiana. I contemporanei. V, Milano, Marzorati, pp. 1067-1082 [poi in Novecento. I contemporanei. VIII, ideazione e direzione di G. Grana, Milano, Marzorati, 1979, pp. 7783-7797].Silvio D’Arzo, in Dizionario generale degli autori italiani contemporanei. I, Firenze, Vallecchi, pp. 393-394.
1975
N. GALLO, [scheda a] “Botteghe oscure”, Quaderno X (1952), in ID., Scritti letterari, a cura di O. Cecchi, C. Garboli e G. C. Roscioni, Milano, Il Polifilo, pp. 58-59.N. GALLO, L’ultima narrativa italiana, in ID., Scritti letterari, a cura di O. Cecchi, C. Garboli e G. C. Roscioni, Milano, Il Polifilo, pp. 61-73: 69.A. L. LENZI Per un moderno (la formazione di Silvio D’Arzo), «Studi e problemi di critica testuale», n. 11, ottobre, pp. 222-230.
62
Bibliografia su Silvio D’Arzo
1976
F. AZZALI, Fantasmi a Reggio, in Luci e colori della nostra Reggio, Modena, Artioli, pp. 20-23.A. BERTOLUCCI, [Quarta di copertina], in S. D’ARZO, Essi pensano ad altro, Milano, Garzanti.P. LAGAZZI, Postfazione, in S. D’ARZO, Essi pensano ad altro, Milano, Garzanti, pp. 157-159.G. BARBERI SQUAROTTI, Il tragico come guaito, «Sigma», nuova serie, nn. 1-2, pp. 315-362 [poi, col titolo Il tragico nel romanzo, in ID., Le sorti del “tragico”. Il Novecento italiano: romanzo e teatro, Ravenna, Longo, 1978, pp. 29-96].Segnalibro. Silvio D’Arzo. Essi pensano ad altro, «Bollettino Artigiano», ottobre.A. BARBERIS, Vino, violini, e malinconia, «Corriere della Sera», 3 ottobre.R. CANTINI, Essi pensano ad altro, «Epoca», 6 ottobre.M. CUCCHI, I passi strani di Silvio D’Arzo, «l’Unità», 6 ottobre. M. CUCCHI, I passi strani di Silvio D’Arzo, «Bollettino artigiano», ottobre.E. SICILIANO, Quando a mungere c’è Mozart, «Il Tempo», 10 ottobre.L. MONDO, Magia di D’Arzo, «La Stampa», 15 ottobre.C. VILLA, Uno studente va in città, «Paese Sera», 15 ottobre.G. RABONI, D’Arzo, “caso” e leggenda, «Tuttolibri» («La Stampa»), 30 ottobre.G. FINZI, I fantasmi prediletti, «Il Giorno», 3 novembre.D. PORZIO, Essi pensano ad altro, «Panorama», 9 novembre.F. AZZALI, Sopra i tetti e oltre ancora, «Il Resto del Carlino», 9 novembre.P. LAGAZZI, Comparoni e “l’altro”, «Nuovi argomenti», nuova serie, nn. 51-52, luglio-dicembre, pp. 47-75 [poi in ID., Comparoni e “l’altro”. Sulle tracce di Silvio D’Arzo, Reggio Emilia, Diabasis, 1992, pp. 15-43].
1977
A. L. LENZI, Silvio D’Arzo (Una vita letteraria), Reggio Emilia, Tipolitografia Emiliana.F. FORTI, Premessa, in A. L. LENZI, Silvio D’Arzo (Una vita letteraria), Reggio Emilia, Tipolitografia Emiliana, pp. 5-7.G. MANACORDA, Storia della letteratura contemporanea (1940-1975), Roma, Editori Riuniti, pp. 357-358. R. MACCHIONI JODI, D’Arzo, «Paragone», a. XXVIII, n. 324, febbraio, pp. 107-112.A. L. LENZI, Per gli inediti di Silvio D’Arzo: “Penny Wirton e sua madre”, «Studi e problemi di critica testuale», n. 15, ottobre, pp. 187-199.A. L. LENZI, P. Lagazzi, Comparoni e l’altro, «Studi e problemi di critica testuale», n. 15, ottobre, pp. 242- 245.R. MACCHIONI JODI, Pinocchio e Penny Wirton: Il Pinguino senza frac, «La Provincia di Reggio Emilia», n. 10, dicembre, pp. 52-56.
1978
R. MACCHIONI JODI, Nota introduttiva, in S. D’ARZO, Penny Wirton e sua madre, Torino, Einaudi, V-VIII.G. BARBERI SQUAROTTI, Il tragico nel romanzo, in ID., Le sorti del “tragico”. Il Novecento italiano: romanzo e teatro, Ravenna, Longo, pp. 29-96.C. RABOTTI, Inediti pregevoli di Silvio D’Arzo, «Il Giornale», 21 febbraio.N. MANFREDI, Uno studio su D’Arzo ed un suo racconto inedito, «Il Resto del Carlino», 22 febbraio.
63
monografia
A. BERTOLUCCI, Silvio D’Arzo: una storia di milioni e promesse in carta da bollo, «la Repubblica», 25 febbraio [poi in Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 2002, pp. 81-82].S. CASTELLI, Un altro capolavoro di Silvio D’Arzo, «l’Avanti», 26 febbraio.E. SICILIANO, Dov’è il segreto di Silvio D’Arzo, «Corriere della Sera», 26 febbraio.F. AZZALI, Come capire D’Arzo, «Il Resto del Carlino», 9 marzo.G. RABONI, Un D’Arzo tutto nuovo, «Tuttolibri» («La Stampa»), 11 marzo [poi in Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 2002, pp. 83-84].C. RABOTTI, Libri illustrati, «Analisi», 15 marzo.N. M[ANFREDI]., “Penny Wirton e sua madre: un altro racconto di D’Arzo”, «Il Resto del Carlino», 23 marzo.L. DI MALTA, In un romanzo per ragazzi il segreto della breve vita di Silvio D’Arzo, «Grazia», 2 aprile.L. MONDO, I lunedì di D’Arzo, «La Stampa», 12 aprile.C. BARIGAZZI, Quando lo scrittore si nasconde, «TR Canale 40 – Telereggio», n. 3, aprile.L. SERRA, D’Arzo e la ricerca dell’identità, «La Provincia di Reggio Emilia», nn. 4-5, aprile-mag-gio [poi in Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 2002, pp. 85-88].Inedito. Un grafico di Ezio Comparoni, «Il Giornale Nuovo», 17 maggio.L. SERRA, D’Arzo e la ricerca dell’identità, «Il Ponte», a. XXXIV, n. 10, ottobre, pp. 1288-1290.
1979
R. MACCHIONI JODI, Silvio D’Arzo, in Novecento. I contemporanei. VIII, ideazione e direzione di G. Grana, Milano, Marzorati, pp. 7783-7797.G. RABONI, Racconti di D’Arzo, in Novecento. I contemporanei. VIII, ideazione e direzione di G. Grana, Milano, Marzorati, pp. 7798-7799.G. DEGANI, Ricordo di Silvio D’Arzo, in Il Raccoglitore. I. Pagina quindicinale della Gazzetta di Parma. 1951-1959, a cura di P. Briganti, Parma, La Pilotta, pp. 52-53.A. BERTOLUCCI, Raccontare per salvarsi, intervista a cura di G. Giannini, «Panorama», 9 gennaio.H. D. J., Huis van anderen, «Prozawerken de Lektuurgids», gennaio.A. VANNESTE, Dit leven verlaten, «De Standaard» (Brussel), 2 marzo.R. MACCHIONI JODI, Silvio D’Arzo narratore per ragazzi, «Il Ponte», a. XXXV, n. 4, aprile, pp. 471-480.P. TUSCANO, Ritorno di D’Arzo, «Italianistica», a. VIII, n. 1, gennaio-aprile, pp. 198-201.A. L. LENZI, Lettere di Silvio D’Arzo a Ada Gorini, «Nuovi argomenti», n. 62, aprile-giugno, pp. 10-23 [poi in S. D’ARZO, Una storia così. Lettere per Ada, Reggio Emilia, Diabasis, 1995, pp. 35-43]. Casa d’altri, «Elzevier’s Magazine», 11 agosto.A. L. LENZI, R. Macchioni Jodi, Silvio D’Arzo narratore “per ragazzi”, «Studi e problemi di critica testuale», n. 19, ottobre, pp. 256-258.
1980
V. GAZZOLA STACCHINI, Letteratura e società fra il benessere e il malessere, in Letteratura italiana. Storia e testi. X, t.1, Bari, Laterza, pp. 367-481: 406-407. E. AFFINATI, Lettere di Silvio D’Arzo a Emilio Cecchi, «F M» (Annali dell’Istituto di Filologia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma), nn. 1-2, pp. 249-257.
64
Bibliografia su Silvio D’Arzo
L. G., Un vivo ricordo di Silvio D’Arzo, «Il Giornale Nuovo», 23 marzo.A. M. MORACE, Per una lettura darziana: Penny Wirton e sua madre, «Tabella di Marcia», a. I, n. 0, giugno, pp. 73-92 [poi, col titolo D’Arzo fra favola e coscienza del reale: «Penny Wirton e sua madre», in ID., Spettrografie narrative, Roma, Herder, 1984, pp. 3-19].A. L. LENZI, Traspare la tradizione reggiana della narrativa di Silvio D’Arzo (I), «Reggio storia», a. III, n. 5, settembre-ottobre, pp. 51-53.A. L. LENZI, Traspare la tradizione reggiana della narrativa di Silvio D’Arzo (II), «Reggio storia», a. III, n. 6, novembre-dicembre, pp. 57-60.
1981
P. LAGAZZI, Figure non ordini, in Antologia di “Palatina”, a cura di P. Lagazzi, Parma, La Pilotta, pp. XVII-XXXII: XXII, XXV, XXVI, XXX.G. MARCHETTI, Vita da capra, «Gazzetta di Parma», 19 febbraio.A. MOSTI, Il “gruppo dei dodici” nacque al bar della stazione, «Reggio storia», a. IV, n. 1, gennaio-marzo, pp. 40-42.M. LUNETTA, La colpa e, poi, la coazione, «Il Messaggero», 11 marzo.F. PIEMONTESE, “Padre, mi posso uccidere?”, chiede una vecchia al prete, «Paese Sera», 13 marzo.C. LAURENZI, Casa d’altri, «Il Giornale», 15 marzo.F. AZZALI, L’esule Silvio D’Arzo (uno scrittore infelice e sconosciuto), «Il Resto del Carlino», 21 marzo.C. MARABINI, Ma com’è bella la casa d’altri, «Il Resto del Carlino», 21 marzo.E. AFFINATI, Sedici lettere di Silvio D’Arzo a Emilio Cecchi (I), «Reggio storia», a. IV, n. 1, gen-naio-marzo, pp. 37-39. L. DI MALTA, Solitudine e disperazione in uno sperduto paese degli Appennini, «Grazia», 5 aprile.E. SQUASSABIA, Un parroco intellettuale confessa la sua crisi, «l’Unità», 16 aprile.G. CHERCHI, Un Capolavoro del (nostro) Novecento?, «Linus», n. 4, aprile, pp. 132-133 [poi in ID., Scompartimento per lettori e taciturni: articoli, ritratti, interviste, Milano, Feltrinelli, pp. 49-51].E. SICILIANO, Se il mondo diventa una “Casa d’altri”, «Corriere della Sera», 18 maggio [poi in ID., La bohème del mare. Dieci anni di letteratura, 1972-1982, Milano, Mondadori, 1983, pp. 273-277].G. MANGANELLI, Torna a casa D’Arzo, «L’Europeo», 1 giugno.E. AFFINATI, Prefazione, in Lettere di Silvio D’Arzo a Emilio Cecchi, a cura di E. Affinati, «Con-tributi», a. V, n. 9, gennaio-giugno, pp. 65-82.A. L. LENZI, Un inedito giovanile di Silvio D’Arzo: L’uomo che camminava per le strade, «Contri-buti», a. V, n. 9, gennaio-giugno, pp. 83-89.E. AFFINATI, Sedici lettere di Silvio D’Arzo a Emilio Cecchi (II), «Reggio storia», a. IV, n. 2, aprile-giugno, pp. 64-65.A. L. LENZI, Silvio D’Arzo, “Casa d’altri e altri racconti”, «Studi e problemi di critica testuale», n. 23, ottobre, pp. 232-234.A. L. LENZI, Eraldo Affinati, Lettere di Silvio D’Arzo a Emilio Cecchi (I e II), «Studi e problemi di critica testuale», n. 23, ottobre, pp. 262-263.F. VAN DOOREN, Zoon van een zadelmaker, «N. R. C. Handelsblad», 30 ottobre.M. ANDRIES, Silvio D’Arzo: op zoek naar de eigen identiteit, «De Nieuwe Gazet», 13 novembre.N. V., Een onbekende Italiaan, «Laatste Nieuws» (Brussel), 27 dicembre.
1982
Silvio D’Arzo 1920-1952. Mostra documentaria, a cura di A. L. Lenzi, Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Biblioteca Municipale “A. Panizzi”.
65
monografia
A. L. LENZI, Premessa, in Silvio D’Arzo 1920-1952. Mostra documentaria, a cura di A. L. Lenzi, Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Biblioteca Municipale “A. Panizzi”, pp. 5-7.Silvio D’Arzo. Rassegna stampa 1943-1982, a cura di E. Affinati, Reggio Emilia, Biblioteca Mu-nicipale “A. Panizzi”.P. P. TEDESCHI, Una lettura del «Buon Corsiero», omaggio a Silvio D’Arzo, Milano, Il Foglio Volante.A. BERTOLUCCI, Presentazione, in P. P. TEDESCHI, Una lettura del «Buon Corsiero», omaggio a Silvio D’Arzo, Milano, Il Foglio Volante, pp. 5-6.P. LAGAZZI - G. MARCHETTI, Silvio D’Arzo 30 anni dopo, «Gazzetta di Parma», 30 gennaio.P. LAGAZZI, “Casa d’altri” o della suspense, «Gazzetta di Parma», 30 gennaio. G. MARCHETTI, La maschera e il volto, «Gazzetta di Parma», 30 gennaio.M. NORD, Schitterend schrijver, «Parool Boeken», 12 marzo.A. L. LENZI, Donate alla biblioteca le lettere di D’Arzo all’amico Canzio, «Gazzetta di Reggio», 14 aprile.G. MARCHETTI, D’Arzo: un nome, una storia, un libro, «Gazzetta di Parma», 28 agosto.P. MAGNANI, L’osservatorio di Piazza del Monte, «Reggio storia», a. V, n. 3, luglio-settembre, pp. 4-8.L. SERRA, Proposte per una lettura di Silvio D’Arzo, «Reggio storia», a. V, n. 3, luglio-settembre, pp. 13-15.Silvio D’Arzo e la sua ombra, «Il Resto del Carlino», 21 ottobre.E. SICILIANO, Un sognatore che si è buttato nella realtà, «Corriere della Sera», 23 ottobre.Alla scoperta di Silvio D’Arzo, «Il Resto del Carlino», 23 ottobre.Da domani il convegno sul romanzo di D’Arzo, «Il Resto del Carlino», 23 ottobre.L. S., Avrà un respiro internazionale, il convegno reggiano su Silvio D’Arzo, «Gazzetta di Reggio», 23 ottobre.Reggio finalmente scopre il valore di Silvio D’Arzo, «l’Unità», 24 ottobre.A. BERTOLUCCI, Lo scrittore e la sua ombra, «la Repubblica», 28 ottobre.F. AZZALI, Quel solitario, ironico, disperato Silvio D’Arzo, «Il Resto del Carlino», 29 ottobre.Da oggi si parla di Silvio D’Arzo, «l’Unità», 29 ottobre.G. RABONI, D’Arzo: un grande che veniva da un’altra cultura, «Tuttolibri» («La Stampa»), 30 ottobre.BREN, Una giusta valorizzazione dell’opera di Silvio D’Arzo, «l’Unità», 31 ottobre.M. GUIDI, D’Arzo, un provinciale che riuscì ad emergere, «Il Resto del Carlino», 31 ottobre.R. ROVERSI, Ditta Anniversari, finalmente scopri qualcosa!, «l’Unità», 31 ottobre.L. SALSI, D’Arzo ha ritrovato le sue radici reggiane, «Gazzetta di Reggio», 31 ottobre.L. SERRA, Proposte per una lettura di Silvio D’Arzo, «Reggio storia», a. V, n. 4, ottobre-dicembre, pp. 13-15.P. MONTEFOSCHI, Lo scrittore e l’ombra, «Il Tempo», 5 novembre.G. MARCHETTI, Silvio D’Arzo, l’ombra e la voce, «Gazzetta di Parma», 6 novembre.
1983
P. MAGNANI, La “Gioconda” di D’Arzo, in Strenna 1983 del Pio Istituto Artigianelli, Reggio Emilia, Pio Istituto Artigianelli, pp. 35-37.E. SICILIANO, “Casa d’altri”, in ID., La bohème del mare. Dieci anni di letteratura, 1972-1982, Milano, Mondadori, pp. 273-277.E. SICILIANO, Silvio D’Arzo, in Racconti italiani del Novecento. II, a cura di E. Siciliano, Milano, Mondadori, pp. 849-851.E. SICILIANO, Notizie biografiche. Silvio D’Arzo, in Racconti italiani del Novecento. II, a cura di E.
66
Bibliografia su Silvio D’Arzo
Siciliano, Milano, Mondadori, p. 1997.R. MACCHIONI JODI, D’Arzo o la finzione dell’immaginario, «Corriere del Ticino», 31 marzo.R. MACCHIONI JODI, Premessa, in Un nuovo inedito di Silvio D’Arzo: Un ragazzo d’altri tempi, «Contributi», a. VII, n. 13, gennaio-giugno, pp. 63-73.P. LAGAZZI, Il breve tempo di Comparoni, «Reggio storia», a. VI, n. 3, luglio-settembre, pp. 53-57.
1984
Silvio D’Arzo. Lo scrittore e la sua ombra. Atti delle giornate di studio Reggio Emilia 29-30 ottobre 1982, Firenze, Vallecchi (Il volume comprende i seguenti interventi: M. FESTANTI, Presentazione, p. 5; A. GIULIANI, “Casa d’altri” e il povero dopoguerra, pp. 7-17; M. BIONDI, Silvio D’Arzo e il mito della provincia, pp. 19-29; C. MARTIGNONI, Per l’elaborazione testuale e stilistica di “Casa d’altri”, pp. 31-49; A. L. LENZI, Silvio D’Arzo scrittore per ragazzi, pp. 51-64; E. CHIERICI, La poetica di un “lettore” (Silvio D’Arzo critico letterario), pp. 65-72; E. AFFINATI, La critica darziana, pp. 73-97; R. MACCHIONI JODI, D’Arzo critico letterario e collaboratore di riviste, pp. 99-114; C. MARAZZINI, Lingua e stile nell’opera di Silvio D’Arzo, pp. 115-128; P. BRIGANTI, Le strutture narrative di “Casa d’altri”, pp. 129-149; S. CALABRESE, Silvio D’Arzo e l’immaginario popolare, pp. 151-167).A. M. MORACE, D’Arzo fra favola e coscienza del reale: “Penny Wirton e sua madre”, in ID., Spet-trografie narrative, Roma, Herder, pp. 3-19.A. ZINI, Il “caso” D’Arzo, Como, [dattiloscritto].M. BIONDI, Un dialogo di letteratura: lettere di amicizia e di editoria, in S. D’ARZO - E. VALLECCHI, Carteggio 1941- 1951, «Contributi», a. VIII, nn. 15-16, pp. 7-21.A. L. LENZI, Introduzione, in S. D’ARZO - E. VALLECCHI, Carteggio 1941- 1951, «Contributi», a. VIII, nn. 15-16, pp. 23-40.
1985
C. TOSCANI, S. D’Arzo-E. Vallecchi, Carteggio 1941-1951, «Otto/Novecento», a. IX, nn. 5-6, settembre-dicembre, pp. 239-240.Silvio D’Arzo, in La bottega dello stregone. Cent’anni di fiabe italiane, a cura di E. Ghidetti e L. Lattarulo, Roma, Editori Riuniti, p. 274.
1986
A. L. LENZI, Introduzione, in S. D’ARZO, Nostro Lunedì di Ignoto del XX secolo, a cura di A. L. Lenzi, Modena, Mucchi, pp. 13-37.A. L. LENZI, Silvio D’Arzo, l’isola e il mondo, in Scrittori nei due ducati, Montecchio Emilia, Comune di Montecchio Emilia, pp. 3-25.Dal carteggio emerge il letterato non il personaggio, «Gazzetta di Reggio», 10 gennaio.U. BONAFINI, Quel giovane professore alla Tony Curtis, «Gazzetta di Reggio», 10 gennaio.R. ROVERSI, Carteggio disperato tra Silvio D’Arzo e l’editore Vallecchi, «l’Unità», 19 gennaio.C. TOSCANI, Le fiabe di Silvio D’Arzo, «Il Belpaese», a. III, n. 4, maggio, pp. 401-407. C. TOSCANI, Silvio D’Arzo, l’isola, il tesoro, «Uomini e libri», a. XXII, nn. 108-109, aprile-giugno, pp. 56-61. P. LAGAZZI, Le ombre della città, «Malacoda», a. II, n. 6, maggio-giugno, pp. 18-23 [poi in ID., Comparoni e “l’altro”. Sulle tracce di Silvio D’Arzo, Reggio Emilia, Diabasis, 1992, pp. 45-53].E. AFFINATI, Ritratto dell’autore da ignoto, «Paese Sera», 25 agosto.P. LAGAZZI, Un narratore degli anni ’40: Silvio D’Arzo, «Stazione di Posta», nn. 11-13, ottobre,
67
monografia
pp. 31-36 [poi in ID., Comparoni e “l’altro”. Sulle tracce di Silvio D’Arzo, Reggio Emilia, Diabasis, 1992, pp. 73-83].A. M. TOSI, Silvio D’Arzo - Enrico Vallecchi, Carteggio 1941 - 1951, «Studi Novecenteschi», a. XIII, n. 31, giugno, pp. 152-154.
1987
V. AMORUSO, Silvio d’Arzo, in Letteratura italiana contemporanea. IV/1, Roma, Luccarini, pp. 233-239.E. AFFINATI, Introduzione, in S. D’ARZO, Contea inglese. Saggi e corrispondenza, a cura di E. Affinati, Palermo, Sellerio, pp. 11-16. R. BERTACCHINI, Letteratura delle origini d’Italia. Storia e testi. Emilia Romagna, Brescia, La Scuola, pp. 50, 300.G. PAMPALONI, Modelli ed esperienze della prosa contemporanea, in Storia della letteratura italiana. IX. Il Novecento, t. II, diretta da E. Cecchi e N. Sapegno, Milano, Garzanti, pp. 433-712: 625-626.P. LAGAZZI, Maschere di paesaggi, «Nuovo Raccoglitore» [poi in ID., Comparoni e “l’altro”. Sulle tracce di Silvio D’Arzo, Reggio Emilia, Diabasis, 1992, pp. 85-86] G. MARCHETTI, Recensione al carteggio Silvio D’Arzo - Enrico Vallecchi, «Inventario», a. VIII, n. 578, 31 ottobre, pp. 105-108.G. TESIO, Il caso di Silvio D’Arzo. Un classico rimasto in provincia, «Tuttolibri» («La Stampa»), 31 ottobre.R. BARBOLINI, “Contea inglese”, smaglianti saggi di Silvio D’Arzo, «Il Giornale», 29 dicembre.A. M. TOSI, Nostro Lunedì di Ignoto del XX secolo, «Filologia e Critica», a. XII, n. 3, settembre-dicembre, pp. 447-452.T. NANUZZI, Nostro Lunedì, «Letteratura italiana contemporanea», a. VIII, n. 22, settembre-dicembre.
1988
M. SPINELLA, Il diavolo e il funambolo, in S. D’ARZO, All’insegna del Buon Corsiero, Milano, Lombardi, pp. 7-12.E. AFFINATI, L’opera letteraria di Silvio D’Arzo, in C. REPETTI, Inverni, Genova, Edizioni del Teatro di Genova, pp. 27-37. R. MACCHIONI JODI, Dolente magia di Silvio D’Arzo, in C. REPETTI, Inverni, Genova, Edizioni del Teatro di Genova, pp. 16-26.E. SICILIANO, Una figura dolce e fiera, in C. REPETTI, Inverni, Genova, Edizioni del Teatro di Genova, pp. 39-43.A. BERTOLUCCI, Préface, in S. D’ARZO, Maison des autres, trad. di B. Simeone, Verdier, Lagrasse, pp. 9-16.A. BERTOLUCCI, È tutto da scoprire, «Panorama», 21 febbraio.O. MAURIES, Les clarines de Montelice, «Liberation», 7 marzo.E. GOLINO, Un Robinson della Bassa, «la Repubblica», 23 marzo.O. GUERRIERI, I silenzi di D’Arzo diventano teatro, «La Stampa», 23 marzo.A. TINTERRI, Tutti gli inverni di D’Arzo, «Il Secolo XIX», 29 marzo.V. RODA, Silvio D’Arzo, Nostro Lunedì di Ignoto del XX secolo, «Studi e problemi di crititca testuale», n. 36, aprile, pp. 254-256.C. TOSCANI, Silvio D’Arzo, Nostro Lunedì di Ignoto del XX secolo, «Otto/Novecento», a. XII, n. 2, marzo-aprile, pp. 228-229.
68
Bibliografia su Silvio D’Arzo
F. ASSO, Une souveraine simplicité, «La quinzane littéraire», 15 maggio.P. KE., Le drame invisible de Silvio D’Arzo, «Le monde», 29 luglio.C. DE MICHELIS, Prosa d’arte, «Gazzettino», 8 agosto.S. PERRELLA, Come il funambolo sul filo della scrittura, «Il Mattino», 27 settembre.R. BARBOLINI, Il cammino della leggerezza, «Paragone», a. XXXIX, nuova serie, n. 11 (464), ottobre, pp. 96-100.
1989
G. M. ANSELMI - A. BERTONI, L’Emilia e la Romagna, in Letteratura Italiana. III. Storia e geografia, diretto da A. Asor Rosa, Torino, Einaudi, pp. 385-462: 441-442.R. MACCHIONI JODI, Silvio D’Arzo. Mistero e magia di un autore contemporaneo, «Cultura e scuola», a. XXVIII, n. 110, aprile-giugno, pp. 21-28. M. BIONDI, Silvio D’Arzo, iniziazione ed esilio di una biografia letteraria, in Letteratura dimenticata. Un itinerario critico nel Novecento italiano, Genova.Anticipato a domani lo spettacolo di D’Arzo, «Gazzetta di Reggio», 14 marzo.Prosa, «l’Unità», 15 marzo.Storie di anime sole, «Gazzetta di Reggio», 15 marzo.All’Ariosto amari Inverni, «Gazzetta di Reggio», 15 marzo.M. Z., “Inverni” reggiani, «Il Resto del Carlino. Reggio», 15 marzo.L. GABBI, Silvio D’Arzo, un temerario sognatore, «Gazzetta di Reggio», 16 marzo. A. L. LENZI, La sua donna fiera e forte tra autobiografia e realtà, «Gazzetta di Reggio», 16 mar-zo.C. REPETTI, “Inverni”, ovvero la teatralizzazione della dimensione epica e narrativa, «Gazzetta di Reggio», 16 marzo. A. B. SPADONI, Immerso fino al naso nel bavero alzato del cappotto, vicino al Caffé Centrale, il professor Comparoni me lo ricordo così, «Gazzetta di Reggio», 16 marzo. E. AFFINATI, Le parole dell’incanto: “Casa d’altri” e i racconti, «Gazzetta di Reggio», 16 marzo.P. LAGAZZI, I colori e le maschere di un pittore-regista, «Gazzetta di Reggio», 16 marzo.F. FAGIOLI, Tra la via Emilia e il west end, «Il Giornale», 3 settembre.
1990
U. BELLOCCHI, Ezio, compagno di una breve primavera, in E. COMPARONI, Aggiunte e correzioni all’A.I.S. per il centro 444, a cura di U. Bellocchi, Centro studi sul dialetto reggiano, Albinea, pp. IX-XV.G. MACCIOCCA, Silvio D’Arzo, in Letteratura italiana. Gli autori. Dizionario bio-bibliografico. I (A-G), Torino, Einaudi, pp. 659-660.A. L. LENZI, “Una storia così”: Silvio D’Arzo alla festa dell’infanzia, «Idra», a. I, n. 2, pp. 97-102. P. LAGAZZI, La fiaba e il labirinto, «Idra», a. I, n. 2, pp. 103-114 [poi in ID., Comparoni e “l’altro”. Sulle tracce di Silvio D’Arzo, Reggio Emilia, Diabasis, 1992, pp. 55-64].G. M. ANSELMI, Le capitali di provincia: Carducci sì, ma anche Antonio Delfini e Silvio D’Arzo, sino a Benni e Cavazzoni, intervista a cura di S. Casi, «2000 incontri. Mensile di Bologna e dell’Emilia Romagna», nn.1-2, gennaio-febbraio, pp. 9-12.A. L. LENZI, Il professor Comparoni (tre lettere inedite di Silvio D’Arzo), «Studi e problemi di critica testuale», n. 41, ottobre, pp. 165-173.
69
monografia
1991
G. FINZI, Silvio D’Arzo, in Novelle italiane. Il Novecento, a cura di G. Finzi, Milano, Garzanti, p. 589.G. PONTREMOLI, Autori incantati, bambini, pupazzi, osservazioni sulla letteratura per l’infanzia, «Linea d’ombra», a. IX, n. 57, febbraio, pp 40-42.L. ORSENIGO, Evento fatale e opaca continuità del vivere nell’opera di Silvio D’Arzo, «Campi immaginabili», fascicolo III, pp. 127-137.
1992
P. LAGAZZI, Comparoni e “l’altro”. Sulle tracce di Silvio D’Arzo, Reggio Emilia, Diabasis.S. CALABRESE, D’Arzo e il modello contiguo di R***, in ID., L’esilio del flâneur: la provincia di Delfini, Guanda e Zanfrognini, Pisa, Pacini, pp. 123-138.F. FRASNEDI, Ritmo e lettura a viva voce, in ID., Leggere per scrivere, Roma, Editori Riuniti, pp. 253-278.M. BIONDI, Scrittura e identità: la vita letteraria di Silvio D’Arzo, in Prosa del Novecento («I quaderni del “Gioia”», 3), a cura di Casa Moretti, Piacenza, Liceo Classico Melchiorre Gioia, p. 65-83. G. MACCIOCCA, D’Arzo, Silvio, in Dizionario della letteratura italiana del Novecento, diretto da A. Asor Rosa, Torino, Einaudi, pp. 177-178.M. BIONDI, Silvio D’Arzo il nostro Pessoa, «La Nazione», 31 gennaio.P. PERMOLI, Così una generazione intera sognava con gli scrittori e i film anglo-americani, «La Voce Repubblicana», 13-14 febbraio.
1993
G. PICONE, Prefazione, in C. PIERSANTI, Casa di Nessuno, Ripatransone, Sestante, pp. 7-11.D. GARBUGLIA, Nota, in S. D’ARZO, L’uomo che camminava per le strade, Macerata, Quodlibet, pp. 189-190. P. V. TONDELLI, Una conferenza emiliana (1989), in L’abbandono. Racconti dagli anni Ottanta, a cura di F. Panzieri, Milano, Bompiani, pp. 52-61.R. SCRIVANO, La “grazia” e le “opere”. Metamorfosi di un modello: Bernanos, Lisi, D’Arzo, Pomilio, in Etica cristiana e scrittori nel Novecento, a cura di F. M. Iunnance, New York, Forum Italicum, pp. 221-223.R. BARBOLINI, Vietato Guardare, «Panorama», 31 gennaio.E. SICILIANO, Storie di coppie e destini incrociati, «Corriere della Sera», 8 marzo.P. MAFFEO, D’Arzo, i percorsi della solitudine, «Inserto Gutemberg» («L’Avvenire»), 3 aprile, p. 3.F. FRASNEDI, La voce e il senso, «Il Verri», IX serie, nn. 1-2, marzo-giugno, pp. 45-72.C. PIERSANTI, Esercizi di umanità “non possiamo giudicare, solo guardare”, «Il Mattino», 16 luglio.M. BIONDI, Scrittura e identità: la vita letteraria di Silvio D’Arzo, «Michelangelo», a. XXII, n. 3, luglio-settembre, pp. 4-13. P. LAGAZZI, Venture editoriali ed altro: D’Arzo nel carteggio inedito Bertolucci-Degani, «Miche-langelo», a. XXII, n. 3, luglio-settembre, pp. 14-19.P. GIROLAMI, In “Casa d’altri” il romanzo dell’“alterità” di Ezio Comparoni, «Michelangelo», a. XXII, n. 3, luglio-settembre, pp. 20-23.R. DEIDIER, Se lo scrittore guarda il lettore nel più strano dei modi possibili, «La Voce Repubbli-cana», 23 novembre.
70
Bibliografia su Silvio D’Arzo
R. SCRIVANO, La “grazia” e le “opere”. Metamorfosi di un modello: Bernanos, Lisi, D’Arzo, Pomilio, «Italianistica», a. XXII, nn. 1-3, gennaio-dicembre, pp. 237-246.I. LANDOLFI, Tandem D’Arzo-Lagazzi, «Il ponte», a. IL, n. 12, dicembre, pp. 1494-1497.
1994
P. LAGAZZI, Per un ritratto dello scrittore da Mago, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 33-39.Silvio D’Arzo. Uno Pseudonimo per legittima difesa. Testimonianze e riflessioni, Atti del Convegno «Pomeriggio Ezio Comparoni» (Corte Tegge, 11 marzo 1994), Cavriago, Bertani (il volume com-prende i seguenti interventi: U. BELLOCCHI, Introduzione, pp. 4-11; R. BARAZZONI, Ezio Comparoni critico, pp. 17-25; F. BOIARDI, La ricchezza di averlo come insegnante, pp. 27-31; V. CAVICCHIONI, Riserbo e favolismo di Ezio Comparoni, pp. 33-39; A. GIANOLIO, Il mito dell’isola in Silvio D’Arzo (da lettere di Giannino Degani e da testimonianze di amici reggiani), pp. 41-46; ID., La ridefinizione critica di Silvio D’Arzo nelle tesi di laurea (1972-1986), pp. 49-65; ID., Testimonianza di un amico (Testimonianze del pittore Renzo Tamagnini), pp. 151-156; U. GIGLIOLI, «Non si insegna quello che si sa... si insegna quello che si è» (indagine fra ex allievi di Ezio Comparoni), pp. 67-73; L. L. LANDIONI, Silvio D’Arzo uno pseudonimo per legittima difesa, pp. 75-87; A. L. LENZI, A proposito di un’opera mancata: “Un ragazzo d’altri tempi”, pp. 89-95; P. MAGNANI, Il male oscuro di Ezio Comparoni. Lord Jim in piazza del Monte, pp. 97-104; E. MANICARDI, Ezio Comparoni da Reggio Emilia: nom de plume, Silvio D’Arzo, pp. 107-113; A. MANUELLI, Una vita da un soldo, pp. 115-124; R. MASEROLI BERTOLOTTI, Il fantasma del padre nel malessere della poetica darziana, pp. 127-135; M. MAZZAPERLINI, Ricordo del professore Ezio Comparoni, pp. 137-149; G. TUMIATI, I decasillabi di Silvio D’Arzo, pp. 159-164; M. A. VERONESI, Silvio D’Arzo nel ricordo di Werther Cadoppi, pp. 165-183; ID., Il Pinguino senza frac. Commento da un soldo, pp. 185-188).C. TOSCANI, Paolo Lagazzi, Comparoni e “l’altro”. Sulle tracce di Silvio D’Arzo, «Otto/Novecento», a. XVIII, n. 1, gennaio-febbraio, pp. 240-241.G. PONTREMOLI, Gran ciarla sulla scena e silenzi sul bosco, «Linea d’ombra», a. XII, n. 92, aprile, pp. 69-71. M. PICCHI, Silvio D’Arzo, L’uomo che camminava per le strade, «Libri e riviste d’Italia», a. XLVI, nn. 527-530, gennaio-aprile, p. 24.G. RABONI, Gli incanti di una vita incompiuta, «Corriere della Sera», 15 maggio.C. PIERSANTI, Silvio D’Arzo. L’ignoto del XX secolo, «La rivista dei libri», nn. 7-8, luglio-agosto, pp. 17-18.M. GOBBI, Un posto al sole per Silvio D’Arzo, «Gazzetta di Reggio», 1 settembre.S. SERRI, Incontro con D’Arzo. Risorge dalle nebbie l’autore dimenticato, «l’Unità», 1 settembre.M. FESTANTI, La “Panizzi” e Silvio D’Arzo, «Gazzetta di Reggio», 5 settembre.M. GOBBI, Lo scrittore invisibile, «Gazzetta di Reggio», 16 settembre.A. SCANSANI, Ezio comparoni da Reggio Emilia. Nom de plume Silvio D’Arzo. Uno scrittore in una città d’altri, «Rendiconti», nn. 35-36, maggio-settembre, pp. 89-93. F. FRASNEDI, Casa d’altri. La scrittura e il metronomo. Per ricordare il più bel racconto di Silvio D’Arzo, «I Quaderni di Cultura del Galvani», a. I, nuova serie, n. 1, novembre, pp. 19-31. G. BERTONCINI, P. Lagazzi, Comparoni e “l’altro”. Sulle tracce di Silvio D’Arzo; Silvio D’Arzo, Una storia così, «Italianistica», a. XXIII, nn. 2-3, maggio-dicembre, pp. 589-591.G. MACCARI, Paolo Lagazzi, Comparoni e l’“altro”, «La rassegna della letteratura italiana», a. 98°, serie VIII, n. 3, settembre-dicembre, pp. 293-294.A. SCANSANI, Silvio D’Arzo, scrittore in una città d’altri, «Il Ponte», a. L, nn. 11-12, novembre-dicembre, pp. 165-169.
71
monografia
1995
A. L. LENZI, Nota al testo, in S. D’ARZO, All’insegna del Buon Corsiero, Milano, Adelphi, pp. 135-147.E. TUROLLA, Premessa, in S. D’ARZO, All’insegna del Buon Corsiero, Milano, Adelphi, pp. 11-17.P. LAGAZZI, Una piccola fiaba per Viviana (e per tutti i bambini), in S. D’ARZO, Una storia così, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 7-8. G. SCALIA, Solitari lunedì, in S. D’ARZO, Una storia così. Poesie, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 5-8.S. COLLI, Un ricordo impossibile, in S. D’ARZO, Una storia così. Lettere per Ada, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 7-9.A. L. LENZI, Lettere di Silvio D’Arzo a Ada Gorini, in S. D’ARZO, Una storia così. Lettere per Ada, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 35-43.S. PERRELLA, Silvio D’Arzo: un trasparentissimo mistero, in S. D’ARZO, L’aria della sera e altri racconti, a cura di S. Perella, Milano, Bompiani, pp. V-XV.W. PEDULLÀ, La narrativa italiana contemporanea. 1940-1990, Roma, Newton Compton, p. 29.G. CALCAGNO, D’Arzo, il piacere di nascondersi, «Tuttolibri» («La Stampa»), 25 febbraio.P. RUFFILLI, Un angelo sul ‘900 , «Il Resto del Carlino», 1 marzo.M. RAFFAELI, Amori in bilico, «La talpa libri» («Il manifesto»), 2 marzo.P. CITATI, D’Arzo, angelo sparito in volo, «la Repubblica», 28 marzo.E. REGAZZONI, Tra donne, fumo e nebbia, «la Repubblica», 28 marzo.F. MODICA, Il diavolo in carrozza e tricorno, «Il Giornale», 29 marzo.M. BERNARDI BIANCHI, Apertura di credito verso l’ignoto, «Il Secolo d’Italia», 15 aprile.A. PAOLINI, Stile settecentesco per il giovane D’Arzo, «Letture», a. 50, quaderno 508, maggio, p. 45.A. GUGLIELMI, Diciott’anni, un fiume di parole, «L’Espresso», 5 maggio.G. SOAVI, Lo scrittore che cambiò nome, «Il Giornale», 29 giugno.F. CORDELLI, D’Arzo, autore segreto, «L’Indipendente», 3 agosto.M. DENTONE, Silvio D’Arzo, «Il Ragguaglio Librario», a. 62°, nn. 7-8, luglio-agosto, p. 222.R. LA CAPRIA, Il mistero di D’Arzo. Una prosa in breve, «Corriere della Sera», 14 settembre.J. MARCUS, Books in brief: Fiction. The house of others, «New York Times Book Review», 29 ottobre, p. 42. M. DALL’AQUILA, Silvio D’Arzo. All’insegna del Buon Corsiero, «Oggi e domani», n. 10, ottobre, pp. 65-66.E. TREVI, Le avventure terrene di Silvio D’Arzo, «Nuovi argomenti», n. 5, ottobre-dicembre, pp. 116-118.
1996
Il gioco della finzione, generi e percorsi della letteratura. Il Novecento. III, a cura di M. Romano, Torino, Talia, pp. 421-423, 783-786, 798, 800.L. SERRA, Silvio D’Arzo il ricordo di un amico, «IBC», a. IV, n. 1, gennaio-febbraio, p. 31.C. DE MATTEIS, Silvio D’Arzo. All’insegna del Buon Corsiero, «Lettera dall’Italia», a. XI, n. 41, gennaio-marzo, p. 25. E. BACCARANI, Silvio D’Arzo: la voce, il linguaggio, «Poetiche», a. I, fasc. 3, pp. 71-88. G. PONTREMOLI, Elogio delle azioni spregevoli, «Linea d’ombra», a. XIV, n. 117, settembre, pp. 63-68. E. CAPOCCETTI, D’Arzo e il filo della poesia, «Lettera dall’Italia», a. XI, nn. 43-44, luglio-dicem-bre, p. 24.
72
Bibliografia su Silvio D’Arzo
1997
G. CHERCHI, Un Capolavoro del (nostro) Novecento?, in ID., Scompartimento per lettori e taciturni: articoli, ritratti, interviste, Milano, Feltrinelli, pp. 49-51.B. SIMEONE, De plus loin que Reggio, in ID., Acqua Fondata, Verdier, Lagrasse.G. ANSELMI - A. BERTONI, Una geografia letteraria tra Emilia e Romagna, Bologna, Clueb, pp. 381-384. J. SOLDATESCHI, Silvio D’Arzo, in Dizionario critico della letteratura italiana del Novecento, a cura di E. Ghidetti e G. Luti, Roma, Editori Riuniti, pp. 237-239.G. PONTREMOLI, Gli orizzonti inaspettati di Silvio D’Arzo, «Linea d’ombra», a. XV, n. 128, set-tembre-ottobre, pp. 108-119.
1998
A. L. LENZI, Gli uomini di Sìvilek all’osteria, in S. D’ARZO, L’osteria, Macerata, Quodlibet, pp. 83-89.R. WEST, Outsiders from A to Z: Antonia, Zelinda, and the Suicide’s Imperative, in L’esilio come certezza. La ricerca d’identità culturale in Italia dalla rivoluzione francese ai nostri giorni, a cura di A. Ciccarelli, P. A. Giordano, West Lafayette, Bordighera Inc..D. MARCHESCHI, La letteratura per l’infanzia, in Storia generale della letteratura italiana. XII. Sperimentalismo e tradizione del nuovo, diretta da N. Borsellino e W. Pedullà, Milano, Motta, pp. 516-551: 533-534.P. KÉCHICHIAN, Le miracle D’Arzo. Trois textes pour découvrir un libre génie de la littérature ita-lienne, «Le Monde des livres», 17 aprile. D. BIANCO, Con occhi d’orfano, nella Bassa piovosa. Ripescato un Silvio D’Arzo d’annata, «La talpa libri» («Il manifesto»), 23 aprile.F. PIERANGELI, Silvio D’Arzo, L’osteria, «Sincronie», a. II, n. 3, gennaio-giugno, p. 316.R. CARNERO, Una nuova “Osteria” per Silvio D’Arzo, «Il Ponte», a. LIV, n. 7, luglio, pp. 145-147.
1999
C. SPILA, Casa d’altri, in Letteratura italiana. Dizionario delle opere. I (A-L), Torino, Einaudi, pp. 165-166.E. AFFINATI, Silvio D’Arzo: una vita in affitto, in S. D’ARZO, Casa d’altri e altri racconti, Torino, Einaudi, pp. V-XXVII.W. BINNI, Letteratura contemporanea: rassegna bibliografica, in ID., Poetica e poesia. Letture no-vecentesche, Firenze, Sansoni, pp. 90-98. V. ARNONE, La figura del prete nella narrativa italiana del Novecento, Cinisello Balsamo, San Paolo, pp. 153-154.F. PANZIERI, I destini umani tra fiume e osteria, «Letture», a. 54, quaderno 554, aprile, p. 38.R. BARILLI, D’Arzo, lo scrittore che conciliò Stracittà e Strapaese. All’osteria, «Corriere della Sera», 27 maggio.R. CARNERO, Il moderno disagio della diversità. Per «Essi pensano ad altro» di Silvio D’Arzo, «Il Ponte», a. LV, nn. 7-8, luglio-agosto, pp. 148-162.A. ZAMBONELLI, Uomo ombroso e scrittore geniale «Silvio D’Arzo» fu un caso letterario, «Ultime Notizie Reggio», 1 agosto.F. PANZIERI, L’epigrammista Ionico, «Alias» («Il manifesto»), 13 ottobre.R. CARNERO, Una generazione all’insegna di Casa D’Arzo, «Alias» («Il manifesto»), 18 dicembre.
73
monografia
2000
T. IIERMANO, Identità regionali fra storia e visionarismo. Il realismo lirico di Silvio D’Arzo, in Storia della letteratura italiana. IX. Novecento, diretta da Enrico Malato, Roma, Salerno, pp. 828-830.A. BERTONI, Una partitura geografica: il caso Emilia Romagna, in ID., Partiture critiche, Pisa, Pacini, pp. 231-261: 249-257.R. CARNERO, Un dramma tutto interiore, «Letture», a. 55, quaderno 564, febbraio, pp. 36-37.R. CARNERO, “Casa d’altri”, racconto (a)religioso, «Nuova Prosa», nuova serie, n. 28, pp. 131-145.R. CARNERO, Il permesso di suicidarsi in “Casa d’altri”, «l’Unità», 10 giugno.R. CARNERO, Settecento arcadico su diabolico filo: “All’insegna del Buon Corsiero” di Silvio D’Arzo, «Critica Letteraria», a. XXVIII, n. 108, luglio-settembre, pp. 547-569.R. CARNERO, Sull’esile poesia di Silvio D’Arzo, «Il Ponte», a. LVI, n. 10, ottobre, pp. 136-142.R. CARNERO, La produzione saggistica di Silvio D’Arzo, «Poetiche», nuova serie, fasc. 2, ottobre, pp. 281-299.R. CARNERO, “E domani sarà lunedì”: i racconti per ragazzi di Silvio D’Arzo, «La rassegna della letteratura italiana», a. 104°, serie IX, n. 2, luglio-dicembre, pp. 451-462.D. ARGAGNI, Segni e segnali del nuovo millennio, «L’Ortica», n. 80, dicembre, pp. 18-22. W. ANSELMI, Flessibilità della poetica, «Rivista di Studi Italiani», nuova serie, n. 2, dicembre, pp. 252-258.
2001
C. SPILA, Silvio D’Arzo, in Opere del Novecento. Schede di lettura. Storia della letteratura italiana. Novecento. Scenari di fine secolo 2, direzione e coordinamento N. Borsellino e L. Felici, Milano, Garzanti, p. 965.P. CUDINI, Silvio D’Arzo, in Schedario dei poeti e dei prosatori. Storia della letteratura italiana. Novecento. Scenari di fine secolo 2, direzione e coordinamento N. Borsellino e L. Felici, Milano, Garzanti, pp. 323-325.R. CARNERO, Per un canone alternativo. Il caso Silvio D’Arzo, in Sentieri narrativi del Novecento, a cura di R. Carnero e G. Ladolfi, Novara, Interlinea, pp. 49-62.M. RAFFAELI, D’Arzo e Delfini, in ID., Novecento italiano. Saggi e note di letteratura (1979-2000), Roma, Luca Sossella, pp. 88-92. A. M. MORACE, D’Arzo tra favola e coscienza del reale, in ID., Orbite novecentesche, Napoli, Esi, pp. 295-310.G. P. BIASIN, Narratives of self and society, in The Cambridge Companion to Modern Italian Culture, ed. by Z. G. Baranski e R. J. West, Cambridge University Press, pp. 151-172: 156.F. PARAZZOLI, D’Arzo come Tozzi?, «Avvenire», 2 giugno.S. COSTANZI, Silvio D’Arzo. Uno scrittore in casa d’altri, «Palazzo Sanvitale», a. III, n. 6, settembre, pp. 79-80.S. COSTANZI, Silvio D’Arzo. Appunti per un inedito, «Palazzo Sanvitale», a. III, n. 6, settembre, pp. 81-84.E. ORLANDINI, Silvio D’Arzo. Scrittore della presenza, «Palazzo Sanvitale», a. III, n. 6, settembre, pp. 95-111.S. COSTANZI, Bibliografia di Silvio D’Arzo, «Palazzo Sanvitale», a. III, n. 6, settembre, pp. 112-118. R. CARNERO, Dopo Tondelli, nel 2002 omaggio a Silvio D’Arzo?, «l’Unità», 29 ottobre.B. QUARANTA, D’Arzo. Un mistero sull’Appennino, «Tuttolibri» («La Stampa»), 22 dicembre.A. CILENTO, Pier Vittorio Tondelli, “Corpo” e “anima”. Un’analisi della sua scrittura, attraverso i precedenti di Silvio D’Arzo, Antonio Delfini, Alberto Arbasino, Giovanni Testori, Gianni Celati, «Dossier», 14 dicembre, www.italialibri.net/dossier/tondelli/tondelli-1.html.
74
Bibliografia su Silvio D’Arzo
2002
R. CARNERO, Silvio D’Arzo. Un bilancio critico, Novara, Interlinea.S. COSTANZI, Storia compositiva ed edizione critico-genetica di “Casa d’altri”, in S. D’ARZO, Casa d’altri. Edizione critico-genetica, a cura di S. Costanzi, Torino, Aragno, pp. 107-148.A. BERTONI, Prefazione, in S. D’ARZO, Casa d’altri. Edizione critico-genetica, a cura di S. Costanzi, Torino, Aragno, pp. 7-25.P. BRIGANTI - A. BRIGANTI, Un giallo esistenziale, in S. D’ARZO, Casa d’altri. Il libro, a cura di P. Briganti e A. Briganti, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 5-6.P. BRIGANTI - A. BRIGANTI, Nota al testo, in S. D’ARZO, Casa d’altri. Il libro, a cura di P. Briganti e A. Briganti, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 135-182.L. GIROLETTI, Silvio D’Arzo (1920-1952). La religione della scrittura, Firenze, Atheneum.R. CARNERO, Il moderno disagio della diversità, in S. D’ARZO, Essi pensano ad altro Milano, Bom-piani, pp. I-XVII.Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Reggio Emilia, Palazzo Magnani (Il volume comprende i seguenti interventi: S. PARMIGGIANI, Celebrare Silvio D’Arzo, pp. 9-12; R. CROVI, Appunti sull’opera di D’Arzo, pp. 13-15; L. SERRA, D’Arzo, Watteau, Chagall e i colori, pp. 17-19; S. COSTANZI, D’Arzo, lo spazio, i sensi e le immagini, pp. 21-24; S. PARMIGGIANI - G. P. MINARDI, Palatina e Silvio D’Arzo. Una conversazione, pp. 27-29, P. BONFIGLIOLI, Silvio D’Arzo e il “senso della società”, pp. 31-48; G. DEGANI, L’opera incompiuta di Ezio Comparoni. Ricordo di uno scrittore reggiano prematuramente scomparso, pp. 51-52; P. CITATI, Scrisse un racconto perfetto e morì a trent’ anni, pp. 53-56; A. BERTONI, Quel funambolico “Buon Corsiero”, pp. 75-78; A. BERTOLUCCI, Riproporre Silvio D’Arzo alle nuove generazioni, p. 79; ID., Storie di milioni e promesse in carta da bollo, pp. 81-82; G. RABONI, Un D’Arzo tutto nuovo, pp. 83-84; L. SERRA, D’Arzo e la ricerca dell’identità, pp. 85-88; P. BRIGANTI, Casa d’altri: le parole, il silenzio, pp. 107-111; M. RASCLARD, La Signora Disperazione. Ovvero la disperazione, pp. 112-113; G. IACOLI, Bologna mi uccide. D’Arzo e lo spazio estraneo di “Essi pensano ad altro”, pp. 115-118; E. MONTALE, Silvio D’Arzo, pp. 119-120; K. BOTSFORD, On translating D’Arzo, pp. 141-142]. G. IACOLI, Atlante delle derive. Geografie da un’Emilia postmoderna: Gianni Celati e Pier Vittorio Tondelli, Reggio Emilia, Diabasis, pp. 17, 97, 109, 155.G. CONTI, Gli occhi di capra di Silvio D’Arzo, «L’Astrolampo», a. I, n. 2, dicembre-gennaio.R. CARNERO, Il dramma di Zelinda fu pure della madre?, «Vita Pastorale», a. XC, n. 1, gennaio, pp. 102-103.V. ARNONE, Un sacerdote in… “Casa d’altri”, «Vita Pastorale», a. XC, n. 1, gennaio, pp. 104-105.R. CARNERO, D’Arzo, la dignità del dolore, «l’Unità», 30 gennaio.F. PANZERI, Silvio D’Arzo e il sacro “censurato”, «Avvenire», 30 gennaio.F. AZZALI, Una vita straniera. D’Arzo, un mondo ai margini del mondo, «Gazzetta di Parma», 30 gennaio.A. BI., Una biblioteca intitolata a Silvio D’Arzo, «Gazzetta di Reggio», 18 marzo.G. BORGATTI, Silvio D’Arzo 50 anni fa, «Reporter», 29 marzo.V. OTTOLENGHI, Omaggio a D’Arzo con Gabriele Vacis a Reggio Emilia, «Gazzetta di Parma», 4 aprile.D’Arzo: Via alle iniziative, «Reporter», 5 aprile.Recitar poetando – Per D’Arzo. “Essi pensano ad altro”, «Reporter», 5 aprile.Gabriele Vacis e Roberto Tarasco in Casa D’Arzo, «Ultime Notizie Reggio», 6 aprile.Omaggio a D’Arzo tra prosa e poesia, «Gazzetta di Reggio», 6 aprile.G. B., Gabriele Vacis rilegge i racconti di Silvio D’Arzo, «Il Resto del Carlino. Reggio», 6 aprile.A. NOBILI, “Casa d’altri”: esce, senza variazioni e censure, l’autentico Silvio D’Arzo, «Il Resto del Carlino. Reggio», 8 aprile.
75
monografia
Nuova Edizione Critico Genetica di Silvio D’Arzo, «Ultime Notizie Reggio», 8 aprile.“Casa d’altri” oggi all’Arco, «Gazzetta di Reggio», 8 aprile.“Casa d’altri” di D’Arzo ieri all’Arco, «Gazzetta di Reggio», 9 aprile.G. BASSI, D’Arzo riletto tra le sue pagine, «Il Resto del Carlino. Reggio», 9 aprile.A. CODELUPPI, Presentata alla libreria all’Arco la riedizione di Casa d’altri, «Gazzetta di Reggio», 10 aprile.A. CODELUPPI, Ecco il primo disegno di D’Arzo, «Gazzetta di Reggio», 12 aprile. A. CODELUPPI, Il ritratto degli ex compagni di scuola “Ezio era un ragazzo timido e schivo”, «Gaz-zetta di Reggio», 12 aprile.Scrittori a convegno per parlare di D’Arzo, «Gazzetta di Reggio», 12 aprile.U. BONAFINI, D’Arzo, o meglio Comparoni il fascino di un intellettuale, «Gazzetta di Reggio», 12 aprile.Oggi D’Arzo a convegno, «Gazzetta di Reggio», 13 aprile.Giornata di studi su Silvio D’Arzo, «Il Resto del Carlino. Reggio», 13 aprile.A. CODELUPPI, Silvio D’Arzo e le molte vite di un “racconto perfetto”, «la Repubblica», 13 aprile.M. APPIOTTI, Quante case si inaugurano in onore di Silvio D’Arzo, il buon corsiero emiliano, «Tuttolibri» («La Stampa»), 13 aprile.A. LOLINI, La casa di D’Arzo sottratta all’ombra, «Il manifesto», 13 aprile.E. LUCCHETTI, Silvio D’Arzo, letteratura e mistero, «la Repubblica», 14 aprile.Silvio D’Arzo copiato e misterioso, «Ultime Notizie Reggio», 14 aprile.A. CODELUPPI, Omaggio all’“esule” D’Arzo, «Gazzetta di Reggio», 14 aprile.C. MAGNANI - A. BIANCHI, Ezio Raimondi: “D’Arzo vive ancora con noi”, «Ultime Notizie Reggio», 14 aprile.C. MAGNANI, I “non-luoghi” reggiani dello scrittore, «Ultime Notizie Reggio», 15 aprile.D’Arzo, mostra documentaria alla Panizzi, «Ultime Notizie Reggio», 15 aprile.G. BASSI, La mamma ispirava Silvio D’Arzo, «Il Resto del Carlino. Reggio», 15 aprile.M. CUCCHI, Alla scoperta di Silvio D’Arzo, «La Stampa», 24 aprile.S. LECCHINI, D’Arzo, autore infinito. Parlano i curatori parmigiani della nuova e più completa edizione di “Casa d’altri”, «Gazzetta di Parma», 25 aprile.A. CASOLI, Silvio D’Arzo tra passato e presente, «Reporter», 26 aprile.F. PANZERI, Il piccolo classico dell’Appennino, «Famiglia Cristiana», n. 17, 28 aprile.R. BARBOLINI, Lo Stevenson della via Emilia, «Panorama», 9 maggio.V. AMOROSO, Il racconto perfetto di Silvio D’Arzo, «Corriere della Sera», 22 maggio.A. BERTONI - J. SISCO, Ritorno a casa D’Arzo, «IBC», n. 3, giugno, pp. 85-89.A. GIULIANI, Silvio D’Arzo, un caso molto speciale, «la Repubblica», 7 giugno.S. SALIS, Provinciale ma europeo, «Domenica» («Il sole 24 ore»), 21 luglio.A. GUGLIELMI, D’Arzo, uno stile per il suicidio, «l’Unità», 27 agosto.L. DE FEDERICIS, Passaggi, «Indice dei Libri del Mese», nn. 7-8, luglio-agosto, p. 9.R. CARNERO, Silvio D’Arzo: un’inattesa modernità, «Letture», a. 57, quaderno 589, agosto-settembre, pp. 74-75. V. FAGGI, Silvio D’Arzo, Casa d’altri. Edizione critico-genetica, a cura di S. Costanzi, «Oggi e domani», n. 10, ottobre, p. 34. M. MORAZZONI, Silvio D’Arzo in cinquanta pagine, «Erasmo», a. II, n. 11, ottobre, pp. 95-96.R. CARNERO, Silvio D’Arzo, “grande minore”, «Jesus», ottobre, p. 95.C. MARABINI, Diario di lettura, «Nuova Antologia», n. 2224, ottobre-dicembre, pp. 107-119.G. IACOLI, Difformi agli occhi del mondo: D’Arzo e la costruzione della diversità in “Essi pensano ad altro”, «Poetiche», nuova serie, fasc. 3, dicembre, pp. 415-443. R. CARNERO, Silvio D’Arzo, «La rivista dei libri», n. 12, dicembre, pp. 41-43.
76
Bibliografia su Silvio D’Arzo
M. STRACQUADAINI, Da riscoprire. Silvio D’Arzo, Casa d’altri (il libro), «Studi Cattolici», a. XLVI, n. 502, dicembre, p. 936.G. RONCHINI, Silvio D’Arzo, Casa d’altri. Edizione critico-genetica, a cura di S. Costanzi, «Campi immaginabili», nn. 26-27, pp. 272-275.E. ORLANDINI, “Essi pensano ad altro”. Raccontare la finitudine, «Bollettino ‘900», rivista on line del Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna, giugno-dicembre, nn. 1-2, I e II semestre, www3.unibo.it/boll900/numeri/2002-i/Orlandini.html.F. BASSOLI, Silvio D’Arzo 1920-1952. La religione della scrittura, «StradaNove», 28 giugno, www.stradanove.net/news/testi/libri-02b/labas0207021.html.
2003
A. BERTONI, Verso l’opera mondo: per un’introduzione a D’Arzo, in S. D’ARZO, Opere, a cura di S. Costanzi, E. Orlandini, A. Sebastiani, Parma, Mup Editore, pp. VII-XXIV.F. FRASNEDI, Pensare ad altro. Saggio su Silvio D’Arzo, in S. D’ARZO, Opere, a cura di S. Costanzi, E. Orlandini, A. Sebastiani, Parma, Mup Editore, pp. XXV-LXXIV.A. SEBASTIANI, Note ai disegni: Gec dell’avventura, in S. D’ARZO, Opere, a cura di S. Costanzi, E. Orlandini, A. Sebastiani, Parma, Mup Editore, pp. 953-961.G. MALANCA - L. SERRA, Conoscere Silvio D’Arzo. L’uomo, lo scrittore, Reggio Emilia, Consulta.F. CORDELLI, Lontano dal romanzo, a cura di M. Raffaeli, Firenze, Le Lettere, pp. 86-89.M. CARPI, Silvio D’Arzo, “Casa d’altri. Il libro” e “Luci e penombre”, «Civiltà cattolica», a. 154, n. 368, 19 aprile, pp. 203-204.V. FAGGI, Per Silvio D’Arzo, «Resine», a. XXV, n. 96, aprile-giugno, pp. 97-98.L. DONINELLI, I tormenti di un solitario, «Il Giornale», 24 settembre.G. MARCHETTI, Silvio D’Arzo, il genio inafferrabile, «Gazzetta di Parma», 26 settembre.C. DONATI, Piccoli editori, grandi autori nella due giorni di Belgioioso, «Il Resto del Carlino», 27 settembre.F. PANZERI, Tutto il mistero di Silvio D’Arzo in mille pagine, «Avvenire», 27 settembre.C. DONATI, Piccoli editori, grandi autori nella due giorni di Belgioioso, «Il giorno», 27 settembre.N. VACCA, Silvio D’Arzo, l’uomo provvisorio, «Il Secolo d’Italia», 9 ottobre.G. PEDULLÀ, Mille pagine e più di qualche torto, «Alias» («Il manifesto»), 11 ottobre.R. BERTACCHINI, Sivio D’Arzo. Uno scrittore emiliano più inglese degli inglesi, «Libero», 17 ottobre.A. CASOLI, Un meridiano di provincia, «Stilos» («La Sicilia»), 11 novembre.R. BARBOLINI, Tutto il mondo in Emilia-share. L’opera omnia dello scrittore reggiano…, «Panora-ma», 20 novembre.A. M. TOSI, Silvio D’Arzo, Casa d’altri. Il libro, a cura di Paolo Briganti, Andrea Briganti, «Studi Italiani», a. XV, fasc. 2, luglio-dicembre, pp. 144-146.F. PIERANGELI, Silvio D’Arzo – Giorgio Barberi Squarotti, Opere – Il tragico cristiano. Da Dante ai moderni, «Sincronie», a. VII, n. 14, luglio-dicembre, pp. 198-202.
2004
A. SEBASTIANI, La scrittura ansimante, in S. D’ARZO, Lettere, a cura di A. Sebastiani, Parma, Mup Editore, pp. V-XXI.Silvio D’Arzo scrittore del nostro tempo. Atti della giornata di studi (Reggio Emilia, 13 aprile 2002), Reggio Emilia, Aliberti (Il volume comprende i seguenti interventi: E. RAIMONDI, Silvio D’Arzo scrittore del nostro tempo, pp. 13-21; M. RAFFAELI, D’Arzo lettore, pp. 23-27; E. TESTA, Lingua e
77
monografia
dialogo in “Casa d’altri”, pp. 29-41; A. BERTONI, Postille a D’Arzo poeta, pp. 43-58; R. CROVI, I luoghi di D’Arzo, pp. 59-65; S. COSTANZI, Ancora sul testo di “Casa d’altri”, pp. 67-81; E. ORLANDINI, Il primo D’Arzo: sospensione e silenzio, pp. 83-92; S. CALABRESE, D’Arzo e il romanzo dell’artista, pp. 93-104; G. PONTREMOLI, Silvio D’Arzo e la cosiddetta letteratura per l’infanzia, pp. 105-125).E. AFFINATI, I capolavori che cerchiamo all’estero li abbiamo in casa, «Il Giornale», 21 gennaio.R. CARNERO, Piccolo-grande D’Arzo, «Famiglia cristiana», n. 6, 8 febbraio, p. 81.E. SICILIANO, Silvio D’Arzo. La breve vita infelice di uno scrittore di culto, «la Repubblica», 22 febbraio.Il pinguino senza frac, «Gazzetta dei piccoli-Gazzetta di Parma», 16 marzo.R. CARNERO, Silvio D’Arzo, scrivere il silenzio, «l’Unità», 24 marzo.Le opere di D’Arzo, «Gazzetta di Parma», 26 marzo.E. M. BRUTTI, Silvio D’Arzo e le sue opere, «Gazzetta di Reggio», 28 marzo.R. CARNERO, Sivio D’Arzo, scrittore del silenzio, «Il grande fiume», primavera.Tobby in prigione, «Gazzetta dei piccoli-Gazzetta di Parma», 20 aprile. G. MARCHETTI, La fiaba di D’Arzo su Tobby il castoro, «Gazzetta di Parma», 22 aprile.R. STRACUZZI, Silvio D’Arzo, Opere, a cura di S. Costanzi, E. Orlandini, A. Sebastiani, «Strumenti critici», a. XIX, fasc. 2 (n. 105), maggio, pp. 334-336.R. WEST, Silvio D’Arzo, Casa d’altri. Il libro, a cura di Paolo Briganti e Andrea Briganti, «Annali d’Italianistica», n. 22, pp. 482-485.R. WEST, Silvio D’Arzo, Luci e penombre. Liriche, a cura di Gabriele Pedullà, «Annali d’Italiani-stica», n. 22, pp. 482-485.M. APPIOTTI, Belgioioso apre le lettere di D’Arzo e riscopre Bassani, «Tuttolibri» («La Stampa»), 18 settembre.A. SEBASTIANI, Luoghi oscuri nell’opera di Silvio D’Arzo, «Nuovi Argomenti», n. 27, luglio-set-tembre, pp. 317-325.R. STRACUZZI, Problemi di filologia darziana: intorno a due recenti edizioni di “Casa d’altri”, «Studi e problemi di critica testuale», n. 69, ottobre, pp. 149-171.G. MACCARI, Silvio D’Arzo, Opere. Introduzione di Alberto Bretoni e Fabrizio Frasnedi, a cura di Stefano Costanzi, Emanuela Orlandini, Alberto Sebastiani, «La rassegna della letteratura italiana», a. 108°, serie IX, n. 2, luglio-dicembre, pp. 648-650.Intervista a Eraldo Affinati, a cura di S. Ciavatta, «Pickwick.it», 4 aprile, www.pickwick.it/mo-dules.php?name=News&file=article&sid=4594.
2005
Dedicato a Silvio D’Arzo, a cura di S. Parmiggiani e L. Iotti, Castelnuovo ne’ Monti.G. MARCHETTI, D’Arzo e gli altri, «Gazzetta di Parma», 18 gennaio.R. CARNERO, D’Arzo, nelle lettere la genesi dei romanzi, «Letture», anno 60°, quaderno 615, marzo, p. 20.P. BRIGANTI - A. BRIGANTI, Per una filologia ‘testuale’ di “Casa d’altri” (e in difesa di un’edizione del manoscritto), «Studi e problemi di critica testuale», a. IL, n. 70, aprile, pp. 219-229. G. MACCARI, Silvio D’Arzo, Lettere, a cura di Alberto Sebastiani, «La rassegna della letteratura italiana», a. 109°, serie IX, n. 1, gennaio-giugno, pp. 348-349.F. SECCHIERI, Silvio D’Arzo, Lettere, «Strumenti critici», a. XX. fasc. 3 (n. 109), settembre, pp. 508-510.A. COLOMBO, Silvio D’Arzo, Lettere, a cura di Alberto Sebastiani, «Giornale Storico della Lette-ratura Italiana», vol. CLXXXII, fasc. 599, luglio-settembre, pp. 462-464.O. INNOCENTI, Una fuga in terra straniera? Travestimenti esterofili della letteratura giovanile italiana, «Italianistica», a. XXXIV, n. 3, settembre-dicembre, pp. 83-94.
78
Bibliografia su Silvio D’Arzo
S. CACCIANI, D’Arzo, Carneade moderno, «L’Informazione», 8 ottobre.S. UGOLOTTI, Casa D’Arzo, «Gazzetta di Parma», 16 ottobre.
2006
P. DI PALMO, Gli angeli con le mani in tasca, in S. D’ARZO, Fine di Mirco, a cura di P. Di Palmo, Pistoia, Edizioni Via del Vento, pp. 29-31.F. SECCHIERI, Prima dei significati: “Essi pensano ad altro” di Silvio D’Arzo, «Testo: studi di teoria e storia della letteratura e della critica», nuova serie, a. XXVII, n. 51, gennaio-giugno, pp. 95-106.N. D. L., Parole svelate, «Gazzetta di Parma», 5 ottobre.Il pinguino senza frac trova il “suo” palco, «Gazzetta di Parma», 21 novembre.
2007
G. MARCHETTI, Silvio D’Arzo. “Casa d’altri” 1948, 1952, in ID., CentoLibriNovecento. Le opere in prosa fondamentali per capire un secolo, Parma, Mup Editore, pp. 80-81.E. BERGAMASCHI, Come vivere pensando ad altro, «La Voce di Mantova», aprile.R. CARNERO, Silvio D’Arzo. Vita breve di uno scrittore appartato, «Letture», a. 62, quaderno 637, maggio, pp. 123-130.F. PIERANGELI, “Casa d’altri” di Silvio D’Arzo, «Fili d’aquilone», n. 7, luglio-settembre, www.filidaquilone.it/num007pierangeli.html.