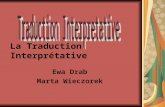Archeologia della pesca nella Sicilia sud-orientale: tra metodologie di ricerca e nuove linee...
Transcript of Archeologia della pesca nella Sicilia sud-orientale: tra metodologie di ricerca e nuove linee...
RICERCHE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA E POST CLASSICA IN SICILIA
Questa innovativa serie monografica nasce dalla volontà di promuovere sul territorio siciliano nuovi studi e ricerche che, superando la frammentazione che spesso ha contraddistinto lo spirito della ricerca archeologica in Sicilia, guidino verso un approccio globale e multidisciplinare al fenomeno storico ed archeologico di età classica e post-classica. Essa riflette anche il recente revival che sul tema del documento, del paesaggio e della cultura materiale si è avviato in questi ultimi anni. L’aggettivo “post-classico” non è inteso esclusivamente nel suo significato storiografico restrittivo ma serve, invece, per creare una congiunzione tra culture recenti spesso immeritatamente trascurate.L’obiettivo è chiaro: dar vita ad una piattaforma operativa che possa vedere finalmente dialogare, con un linguaggio comune improntato su metodologie di approccio nuove e stimolanti, specialisti di discipline diverse il cui contributo, specie in ricerche di ampio respiro come queste qui presentate, è sicuramente innegabile. L’elemento aggregante è quello delle metodologie di approccio all’argomento in virtù delle quali oggi si può cercare di analizzare e studiare uno specifico tema da angolazioni e punti di vista differenti, da competenze professionali diverse all’interno di un ampio contenitore cronologico che sia in grado di far valutare un territorio o un manufatto non nella specificità di uno o due secoli solamente ma, al contrario, all’interno di una sequenza cronologica di sei, sette o più secoli, l’unica in grado di far emergere dati coerenti con lo sviluppo storico complessivo cui i medesimi dati appartengono.
Daniele Malfitana - Giuseppe CaCCiaGuerra
arCheoloGia ClassiCa in siCilia e nel MediterraneodidattiCa e riCerCa nell’esperienza Mista Cnr e università
Il contributo delle giovani generazioni. Un triennio di ricerche e di tesi universitarie
con la collaborazione di annarita di Mauro e Maria luisa sCrofani
testi di G. aMara, p. aMato, s. Barone, B. Basile, a. BranCa, G. CaCCiaGuerra,
a. Cannata, p. Cannia, C. Capelli, l. Carilli, l. Claessens, l. de GiorGi, a. di Mauro, G. fraGalà, C. franCo, i. Giordano, v. Guarnera, v. Gullotta,
l. idà, M. indeliCato, r. lanteri, G. leuCCi, d. Malfitana, a.M. Manenti, n. Masini, G. Monterosso, M. MusCo, M.e. MusuMeCi, C. pantellaro, v. reina,
C. rizza, C. santaGati, G. sCardozzi, a. sCienza, M.l. sCrofani, e. shehi, v. sMiriGlio
Catania
2014
© Tutti i diritti riservati. è vietata la riproduzione di testi ed illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore, dei Curatori, del Responsabile scientifico dei progetti e degli Autori.
Ricerche di archeologia classica e post-classica, vol. II
arCheoloGia ClassiCa in siCilia e nel Mediterraneo. didattiCa e riCerCa nell’esperienza Mista Cnr e università.Il contributo delle giovani generazioni. Un triennio di ricerche e di tesi universitarie
446 pp., ill. 17 x 24 cm.ISBN(13): 978-88-89375-12-9
I. Malfitana, Daniele <1967>II. Cacciaguerra, Giuseppe <1977>
Progettazione grafica ed impaginazione: Maria Luisa ScrofaniCoordinamento grafico e rielaborazione immagini dei contributi: Giovanni Fragalà, Maria Luisa ScrofaniCopertina: Giovanni Fragalà, Samuele BaroneCoordinamento editoriale: Daniele Malfitana, Giuseppe CacciaguerraCuratela redazionale: Annarita Di Mauro, Maria Luisa Scrofani
INDICE
Introduzionedaniele Malfitana, Archeologia classica oggi: il “modello catanese” nell’interazione CNR e Università. Opportunità di crescita ed innovazio-ne per le giovani generazioni
daniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Il quadro delle ricerche e delle attività in laboratorio e sul campo. Strategie per la crescita delle nuo-ve generazioni
BeatriCe Basile, anGela Maria Manenti, Giuseppina Monterosso, Le collaborazioni tra l’IBAM e il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa
rosa lanteri, Le collaborazioni tra l’IBAM e l’Unità Operativa Beni Ar-cheologici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
Cultura materiale e società: processi di conoscenza, analisi ed intepretazioneRicerche di archeologia della produzione e del consumo: il quartiere artigianale di Siracusadaniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Il progetto di ricerca sul quartiere artigianale di Santa Lucia
paolo aMato, alBerto BranCa, Gli scarti di fornace e gli strumenti per la produzione ceramica
valeria reina, Cristina rizza, La ceramica tipo “San Giuliano”
Claudia pantellaro, Le ceramiche fini da mensa a vernice nera e rossa. Introduzione
valerio Gullotta, Le ceramiche a vernice nera con impasto grigio tipo “Campana C”
lorenza Carilli, La ceramica fine a vernice nera: le “pinecone moldmade bowls”
Claudia pantellaro, Le produzioni a vernice nera e rossa: anfore e broc-chette
antonino Cannata, La ceramica a pareti sottili e altre produzioni fini
valeria Guarnera, La coroplastica
viviana sMiriGlio, Gli unguentari
pag.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
11
25
35
37
43
53
63
69
71
73
79
85
91
97
Ricerche di archeologia urbana a Siracusarosa lanteri, daniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Il progetto di ricerca di via Mauceri
Cristina rizza, La ceramica comune tipo “San Giuliano”
Claudia pantellaro, Le produzioni italiche e le importazioni orientali
antonino Cannata, La ceramica a pareti sottili
viviana sMiriGlio, Le lucerne
paola Cannia, La sigillata italica: nuovi bolli da Siracusa e dalla Sicilia
Insediamenti, territorio, paesaggi: strumenti, metodologie e tecnichedaniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Ricerche multidisciplinari nel territorio di Priolo Gargallo. Un progetto di ricerca per lo sviluppo sostenibile
daniele Malfitana, Giovanni leuCCi, Giuseppe CaCCiaGuerra, lara de GiorGi, Giovanni fraGalà, La Guglia d’Agosta: indagini archeo-geo-fisiche per una nuova conoscenza e percezione culturale del monumento
rosa lanteri, italo Giordano, Indagini archeologiche preventive: nuovi dati sulla viabilità antica nel territorio megarese
daniele Malfitana, rosa lanteri, Giuseppe CaCCiaGuerra, Archeolo-gia a Ponte Diddino (Priolo Gargallo, SR). Un progetto multidisciplinare su un sito rurale ellenistico, romano e bizantino. Note per un campo scuola di archeologia classica e post-classica per gli studenti
daniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, Archeologia della pesca nella Sicilia sud-orientale: tra metodologie di ricerca e nuove linee inter-pretative
livio idà, MarCo MusCo, Archeologia della pesca nella Sicilia sud-orien-tale: ricerche e nuovi dati
Archeologia sperimentaleattilio sCienza, Quando il DNA incontra la storia: nuovi riscontri sui rapporti genetici di alcuni vitigni dell’Italia meridionale e della Sicilia
Mario indeliCato, Una vigna “romana” archeo-sperimentale alle pendici dell’Etna
pag.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
101
111
113
119
125
131
141
161
181
195
205
211
237
239
Le ricerche in Turchia
daniele Malfitana, Maria luisa sCrofani, La ceramica di Sagalassos decorata a matrice. Tipologia, cronologia, iconografia. Gli oinophoroi
liesBeth Claessens, From iconography to cultural identity, based on the mould-made wares from late Roman Sagalassos
Le ricerche in Albaniadaniele Malfitana, eduard shehi, Giovanni leuCCi, Giuseppe CaC-CiaGuerra, niCola Masini, Giuseppe sCardozzi, Giovanni fraGalà, Cettina santaGati, Maria elena MusuMeCi, A Late Roman villa in Dürres (Albania). Digital restitution from an integrated archaeological, remote sensing and geophysical research
Saggidaniele Malfitana, CarMela franCo, Giuseppe CaCCiaGuerra, Giovanni fraGalà, Archeologia della Sicilia romana, tardoantica e medievale: focus e prospettive di ricerca su documenti, cultura materiale e paesaggi
daniele Malfitana, Giuseppe CaCCiaGuerra, CarMela franCo, annarita di Mauro, Giovanni fraGalà, Merci e scambi tra il Nord e il Sud dell’Italia: dati ed osservazioni da alcuni contesti della Sicilia romana, tardoantica e bizantina. Il contributo del «Roman Sicily Project: Ceramics and Trade»
daniele Malfitana, La “Campana C” in Sicilia: un problema archeolo-gico-archeometrico aperto
CarMela franCo, Claudio Capelli, Sicilian flat-bottomed amphorae (1st-5th century AD). New data on typo-chronology and distribution and from an integrated petrographic and archaeological study
Giulio aMara, Archeologia e statalismo in Rostovtzeff. L’Egitto tolemaico del III sec. a.C.
Maria luisa sCrofani, Abbreviazioni bibliografiche
Organigramma, autori coinvolti nell’edizione del volume e collaboratori
pag.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
253
263
269
287
303
333
341
363
377
437
ArcheologiA dellA pescA nellA siciliA sud-orientAle:trA metodologie di ricercA e nuove linee interpretAtive
dAniele mAlfitAnA, giuseppe cAcciAguerrA
un progetto per l’ArcheologiA dellA pescA nellA siciliA sud-orientAle
Sono passati più di vent’anni dalla pubblicazione di G. Basile, G. Di Stefano e I. Lena su Approdi, porti, insediamenti costieri e linee di costa della Sicilia Sud-Orientale dalla preistoria alla tarda antichità1, un lavoro ancora oggi fondamentale che nono-stante il tempo trascorso rappresenta il punto di partenza per affrontare la ricerca archeologica lungo questa fascia costiera.
Nel corso degli ultimi due decenni si è assistito ad una progressiva diminuzio-ne della produzione scientifica sul tema dell’archeologia della pesca e degli inse-diamenti costieri di questa parte della Sicilia. Rispetto alla dinamicità della ricer-ca degli anni ’50-’70 del XX secolo che ha avuto il merito di sollevare questioni e proporre modelli insediativi attraverso le indagini condotte a Punta Castelluccio, Thapsos, Ognina e Kaukana, le successive indagini sono state mirate piuttosto alla soluzione di specifiche problematiche in relazione a singoli contesti. Proprio queste indagini hanno permesso di affrontare per la prima volta il tema dell’archeologia della pesca grazie agli scavi condotti in alcuni stabilimenti per la lavorazione del pesce.
Il progetto “Archeologia della pesca nella Sicilia sud-orientale”, condotto in collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa e con l’Università di Cadice (prof. Dario Bernal Casasola), ha lo scopo di rispondere alle numerose pro-blematiche che ancora oggi permangono su questi impianti produttivi, dall’orga-nizzazione della produzione e delle strutture, ai modi e tempi di trasformazione, alla loro contestualizzazione in relazione agli altri insediamenti costieri e del terri-torio ed alla disponibilità e qualità del pescato (Fig. 1). Si tratta, come è evidente, di ricerche che devono essere necessariamente affrontate con un approccio multidi-sciplinare, l’unico capace di offrire una documentazione utile ad una interpretazio-ne globale che superi l’attuale stato della ricerca.
In questa prima fase, l’obiettivo principale che ci si è posti è stato quello di inse-rire gli stabilimenti nel contesto degli insediamenti costieri della Sicilia sud-orien-tale, tentando di comprendere come essi si relazionassero alle comunità residenti lungo la costa e come essi si inserissero nei modelli insediativi del territorio. è stato programmato, pertanto, un piano di ricerche territoriali che prevede la ricognizio-ne del territorio costiero per l’individuazione di tutti i siti archeologici presenti lun-go la costa. I due giovani laureandi impegnati nella ricognizione, Livio Idà e Marco Musco, coadiuvati nelle operazioni sul campo da altri giovani ricercatori che col-laborano con la cattedra di “Metodologie, cultura materiale e produzioni artigia-nali del mondo antico” stanno ora provvedendo all’individuazione, censimento e catalogazione di tutti i siti archeologici della fascia costiera, lavoro che permetterà di comprendere le dinamiche insediative e le trasformazioni dei paesaggi sul lun-
1 lenA - BAsile - di stefAno 1988.
206 Daniele Malfitana - Giuseppe CaCCiaGuerra
go periodo. Il survey, oltre ad individuare nuovi siti, consentirà anche di risolvere que-stioni specifiche legate a particolari contesti problematici per defi-nirne cronologia e ruo-lo nell’organizzazione territoriale. In secondo luogo, il lavoro sarà utile alla contestualiz-zazione e localizzazio-ne di vecchie segnala-
zioni e rinvenimenti casuali di cui è disseminato il territorio. Queste ricerche saran-no mirate alla creazione di una cartografia archeologica che possa consentire una analisi rinnovata e costruita su nuovi parametri. A questo scopo, il lavoro prevede la creazione di una piattaforma GIS che fornirà la base per la gestione e l’interpre-tazione dei dati archeologici.
d. mAlfitAnA
ArcheologiA degli insediAmenti costieri minori dellA siciliA: Breve notA metodologicA e definizione degli oBiettivi di ricercA
L’archeologia degli insediamenti costieri minori della Sicilia è un tema che di rado è stato affrontato con l’autonomia metodologica e interpretativa necessaria. Ad eccezione di pochi lavori, infatti, le ricerche archeologiche sui siti costieri della Sicilia sud-orientale evidenziano spesso una indagine superficiale sul piano della definizione e variazione dei singoli fenomeni insediativi e del ruolo socio-econo-mico rivestito, spesso senza un adeguato confronto con gli assetti delle campagne e delle aree più interne che possono anche risultare divergenti.
Si è riscontrata, in primo luogo, la frequente e non sempre condivisibile equa-zione insediamento costiero = porto = mercato, ruoli non sempre rivestiti contem-poraneamente da questi siti e senza dubbio dalla connotazione spesso piuttosto sfumata o soggetta a variazione nel corso dei secoli (Fig. 2). Ne consegue pertanto una eccessiva semplificazione nell’indagine sul ruolo economico, sui rapporti ge-rarchici e i sistemi di scambio che, viceversa, risultano più complessi e variabili sul lungo periodo e, soprattutto, tutt’altro che scontati. Si è spesso dimenticato, infatti, che il ruolo degli insediamenti costieri nella struttura socio-economica di una re-gione è determinato da altri fattori come le gerarchie portuali, l’amministrazione e l’organizzazione fiscale e doganale, la presenza di fiere e mercati costieri tempora-nei, l’influenza esercitata dalle élites mercantili, ecc.
In realtà, in una parte considerevole di siti si praticavano attività economiche
Fig. 1. Vendicari (Noto, SR). Tonnara.
207ArcheologiA dellA pescA nellA siciliA sud-orientAle
subalterne e su scala anche “familiare”, come ad esempio la pesca, piuttosto che attività legate allo scambio e al commercio regionale o mediterraneo, come spesso affermato anche per siti di modesta entità. Di fatto, in età storica, i grandi flussi me-diterranei spesso sfioravano appena molti insediamenti costieri e queste relazioni venivano mediate dai grandi porti, come Siracusa o Messina. Nel mondo rurale e nei piccoli insediamenti costieri, infatti, l’accesso ai prodotti extraregionali avveni-va attraverso una più o meno capillare attività di piccolo e medio scambio attraver-so i mercati rurali e il trasporto faceva leva su una fitta rete stradale e il cabotaggio costiero dai grandi porti. Allo stesso modo, i piccoli insediamenti costieri sovente non erano i punti di partenza per destinazioni dirette verso i principali porti del Mediterraneo ma, per motivi fiscali, dovevano fare tappa in porti dotati di struttu-re doganali, presenti solo in alcune realtà.
è necessario ricordare, inoltre, che non tutti gli insediamenti costieri devono essere considerati come necessariamente legati al mare e alle svariate attività che ad esso possono essere associate. è possibile, infatti, che essi avessero una doppia economia, marittima e agraria, che a seconda dei casi potevano essere o diventare complementari o sviluppate stagionalmente. Non bisogna escludere, inoltre, che siti posti sulla costa o molto vicini ad essa non avessero una economia marittima. Solo per fare un esempio, le numerose grotte disseminate lungo la costa di Monte Tauro, in territorio di Augusta, sono ancora oggi utilizzate da pastori transumanti
Fig. 2. Thapsos (Priolo Gargallo, SR). Veduta aerea da Sud-Est.
208 Daniele Malfitana - Giuseppe CaCCiaGuerra
come ricovero del bestiame e i pascoli si estendono fino a pochi metri dalla battigia (Fig. 3).
Su un altro piano, con poche eccezioni, la ricerca del secondo dopoguerra ha messo in evidenza elementi di longue durée troppo spesso accettati senza un’analisi critica ed un esame più approfondito dei fenomeni. Si dà per scontata e ovvia, ad esempio, la continuità di insediamenti dotati di porti naturali ma la cui tenuta inse-diativa nel corso dei secoli va comprovata da resti materiali ed indagini approfon-dite piuttosto che basarne il successo sul solo potenziale come luogo di approdo.
Allo stesso modo, per alcuni contesti costieri dotati di condizioni favorevoli all’insediamento su cui non sono mai state condotte indagini archeologiche si è per troppo tempo negata a priori l’esistenza di insediamenti antichi. Il caso di Augusta, dove è stata spesso scartata l’ipotesi dell’esistenza di siti precedenti la fondazione federiciana nel XIII secolo, è paradigmatico al riguardo. Le recenti ricerche con-dotte su materiali sporadici rinvenuti nell’area intorno il Castello Svevo e lungo il versante orientale dell’isola attestano con certezza una fase preistorica2, una col-locabile genericamente tra l’età ellenistica e la prima età imperiale e una meglio documentata tra il V secolo e l’età islamica3.
Si dimentica, inoltre, che esiste una tipologia di scali temporanei o stagionali, solitamente con bassa visibilità archeologica e assenza di documentazione stori-
2 russo - giAnino - lAnteri 1996, p. 152; lAnteri 1997, pp. 68-69; russo 2005.3 I materiali, conservati ed esposti nel Museo della Piazzaforte di Augusta, sono in corso di studio da parte del sottoscritto. Ringrazio l’avv. Antonello Forestiere, Direttore del Museo, per avermi affidato lo studio dei materiali e dimostrato ampia disponibilità nelle fasi di ricerca, e l’avv. Vittorio Sardo per il costante supporto nelle fasi di documentazione e studio.
Fig. 3. Punta Tonnara, Brucoli (Augusta, SR). Pascoli in riva al mare.
209ArcheologiA dellA pescA nellA siciliA sud-orientAle
ca, che non viene spesso presa in con-siderazione dalla ricerca ma che rap-presentava una par-te rilevante dei siti costieri in età antica e medievale. In rela-zione a ciò, bisogna ricordare che esi-stevano numerose attività “parallele” che si svolgevano al
di fuori delle regole doganali, fiscali e in generale di diritto, che non lasciano trac-ce documentarie scritte, ma la cui continuità potrebbe avere prodotto una sia pur minima e sporadica traccia archeologica che andrebbe comunque documentata. è anche su questo fronte che bisognerebbe sviluppare la ricerca.
C’è molto da lavorare anche sulle dinamiche insediative, il rapporto con l’or-ganizzazione territoriale e le relazioni tra costa ed entroterra. Sotto quest’ultimo aspetto, un punto che credo debba essere messo in discussione, o quanto meno verificato caso per caso, è il rapporto duale tra un insediamento costiero e uno dell’entroterra, solitamente di maggiore entità, troppo spesso richiamato per spie-gare le relazioni tra costa ed entroterra o, meglio, tra un grande centro dell’interno, relativamente vicino al mare, e un centro costiero con funzione di scalo o emporio. Ipotesi o certezza di relazioni di questo tipo sono state proposte per il periodo protostorico dell’area iblea tra Xythia/Leontinoi e Punta Castelluccio (Fig. 4)4 o tra Pantalica e Ortigia5 e, su scala minore, per il periodo tardoantico, tra San Foca e Thapsos6.
Nell’analisi dei fenomeni di trasformazione degli insediamenti costieri ci si scontra ancora oggi con numerosi luoghi comuni. Mi riferisco, ad esempio, all’am-piamente accettato fenomeno di abbandono delle coste siciliane tra il VII e il IX secolo d.C., causato dalle incursioni arabe, che avrebbero determinato l’emergere di siti di altura o rupestri nella Sicilia sud-orientale. Le indagini condotte nell’area megarese hanno dimostrato che questa dinamica si è verificata solo nel corso del IX secolo, ma per periodi di difficile definizione. Di fatto, in questo caso, le dinamiche insediative dell’area costiera seguono un trend simile a quello delle aree interne7.
Si tratta di un quadro profondamente influenzato dalla storiografia ottocente-
4 BernABò BreA 1968, p. 167; BernABò BreA 1971, pp. 16-17; BernABò BreA 1973b, pp. 55-56; BernABò BreA 1990, pp. 53, 55.5 BernABò BreA 1968, p. 166; BernABò BreA 1971, p. 16. Critica in TusA 1983, pp. 521-522 e non più riproposto in BernABò BreA 1990.6 orsi 1899c e più volte richiamato in studi successivi. Critica in CAcciAguerrA 2011e, pp. 219-220.7 CAcciAguerrA 2009a, p. 300; CAcciAguerrA 2011f, p. 241; CAcciAguerrA 2011l, pp. 301-303.
Fig. 4. Punta Castelluccio (Augusta, SR). Veduta da Sud-Est.
210 Daniele Malfitana - Giuseppe CaCCiaGuerra
sca, se non addirittura in alcuni casi a tradizioni popolari siciliane e ad un imma-ginario tramandatosi dall’età moderna che troppo spesso viene posto sullo stesso piano e indirettamente paragonato con il periodo delle incursioni turco-barbare-sche del XV e XVI secolo, dimenticando che si trattò di fenomeni profondamente diversi per intensità, tempi e investimento economico, ma soprattutto che interve-nivano su situazioni di fatto molto differenti e quindi non paragonabili. Nel corso del IX secolo, gli attacchi arabi furono condotti soprattutto via terra dalla Sicilia occidentale già occupata.
Infine, è pressoché sconosciuta la cultura materiale che presenta peculiarità le-gate ad una struttura socio-economica differente rispetto a quella delle aree inter-ne. Con poche eccezioni, si nota la poca o nulla conoscenza delle strutture materiali mobili e immobili dell’insediamento, necessarie per la lettura dei suddetti feno-meni. Per i contesti bassomedievali, ad esempio, si possiedono delle importanti ri-cerche sugli edifici castrali i quali, tuttavia, hanno monopolizzato troppo spesso le indagini ponendo in secondo piano le strutture abitative o produttive e rendendo di fatto incompiuta una visione complessiva delle dinamiche antropiche costiere.
g. cAcciAguerrA