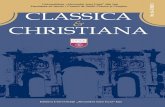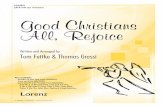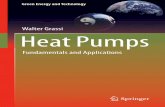F. GRASSI, 2006, Reperti ceramici tardoantichi e medievali dai saggi III, IV, XX, in M. APROSIO, C....
Transcript of F. GRASSI, 2006, Reperti ceramici tardoantichi e medievali dai saggi III, IV, XX, in M. APROSIO, C....
REPERTI CERAMICI TARDOANTICHI E MEDIEVALI DAI SAGGI III, IV, XX
In questo contributo vengono prese in considerazione tutte le ceramiche diepoca medievale provenienti dai saggi III, IV e XX, assieme ad alcuni repertipiù antichi, attribuibili al periodo della tarda antichità. Si tratta nella totalità di33 frammenti ceramici, corrispondenti a 24 forme, calcolate utilizzando il me-todo del numero minimo di individui. Le fasce cronologiche interessate daqueste ceramiche sono tre e corrispondono nel dettaglio ai secoli V-VI, VII-IXe X-XII (Fig. 1).
V-VI sec. VII-IX sec. X-XII sec. TOTALI
n. minimo frammenti n. minimo frammenti n. minimo frammenti n. minimo frammenti
Saggio III 1 1 - - 7 12 8 13
Saggio IV 2 4 2 2 2 2 6 8
Saggio XX 4 5 2 2 4 5 10 12
TOTALI 7 10 4 4 13 19 24 33
Fig. 1 - Numero minimo delle forme e numero di frammenti re-lativi ai contesti ceramici esaminati (sopra) e percentuale di atte-stazione dei reperti in ogni fascia cronologica (espressa con il n.minimo delle forme).
176 Francesca Grassi
Per molti frammenti si è presentato il problema della definizione cronologi-ca: infatti, laddove il contesto di ritrovamento non ci ha permesso associazionicon altri materiali, la datazione puntuale del singolo reperto è stata molto diffi-coltosa. Questo fattore ha determinato un margine molto ampio di incertezzanella datazioni proposte per la ceramica appartenente ai secoli della transizio-ne tra il tardoantico e l’altomedioevo: difatti questo periodo storico si caratte-rizzerebbe per un’estrema frammentarietà e diversificazione formale, riscon-trata nelle produzioni anche in ambito regionale (CIAMPOLTRINI 1998; GRASSI
2005a; FRANCOVICH, VALENTI 1997). Minori dubbi si sono presentati invece per le ceramiche che rientrano nella
fascia cronologica compresa tra X e XII secolo e che, nel caso di Populonia, sipossono ricondurre totalmente alle ben note produzioni di ambito pisano(BERTI, MENCHELLI 1998; GRASSI 2005b).
Il saggio III
Dal saggio III, posto alla base del terrazzamento ad arcate delle Logge (COC-COLUTO, BARTALI, MINUCCI, in questo volume), provengono 13 frammenti di ce-ramica, 12 dei quali sono attribuibili al pieno medioevo, trattandosi di orcioli,brocche o pareti di grandi contenitori con impasto molto depurato, simili alleforme provenienti dalle fosse di spoliazione situate sull’acropoli (GRASSI 2005b).Soltanto un frammento tra quelli esaminati non sembra appartenere al periodomedievale, ma si collocherebbe piuttosto nella tarda antichità (Fig. 2).
Per quanto riguarda i materiali di produzione pisana, sono attestate due for-me, la brocca e l’orciolo. Le brocche non sono riconducibili ad un tipo parti-colare, in quanto l’attribuzione formale è stata effettuata soltanto in presenzadi frammenti di parete. Appare dunque non definibile l’appartenenza ai tipipiù antichi, prodotti dalla seconda metà del X secolo già individuati nelle fossedi spoliazione del saggio XX (GRASSI 2005b, p. 100). Poiché gli esemplari nonsembrerebbero presentare steccature delle superfici o trattamenti tecnologiciparticolari, li inseriamo nel gruppo tipologico G.II oppure G.III (BERTI, MEN-CHELLI 1998, p. 319), prodotti entrambi a Pisa tra XI e XII secolo.
I due grandi orcioli (US 1603, att. 430, periodo IV b1 e US 1619, att. 409,periodo IV b1, Fig. 3, n. 1) sono confrontabili con quelli provenienti da Pisa erecuperati in contesti di XII secolo sia nel castello di Rocca San Silvestro, sianella Rocca di Campiglia Marittima (BOLDRINI, GRASSI 1999, p. 444; BOLDRINI
et al. 2004).L’unico frammento di ceramica da fuoco presente è un’olla con pareti molto
sottili (US 1605, att. 409, periodo IV b1), prodotta a tornio veloce con orlo
Reperti ceramici tardoantichi e medievali dai saggi III, IV, XX 177
Fig. 2 - Le ceramiche esaminate nel saggio III (sopra) e percen-tuale di attestazione dei reperti per fascia cronologica (espressacon il n. minimo delle forme).
estroflesso e arrotondato ed una sottile fascia che ne marca il collo (Fig. 3, n.2). Reca inoltre evidenti tracce di fumigazione esterne ed interne, sicuramentedovute al suo utilizzo. Per la forma e per la tecnologia di esecuzione molto ac-curata (testimoniata ad esempio dalla sottigliezza delle pareti) il reperto è stato
Saggio US Attività Periodo Classe-forma Datazione Produzione
III 1605 409 IV b1 a. grezzaolla, fig. 3, n. 2 V-VI secolo incerta
III 1602 401 IV b2 a.depuratabrocca X-XII secolo pisana
III 1619 409 IV b1 a.depuratagrande orciolo, fig. 3, n. 1 X-XII secolo pisana
III 1603 430 IV b1 a.depuratagrande orciolo X-XII secolo pisana
III 1604 400 IV b1 a. depuratabrocca X-XII secolo pisana
III 1596 401 IV b2 a. depuratabrocca X-XII secolo pisana
III 1610 208 IV b1 a. depuratabrocca X-XII secolo pisana
III 1610 208 IV b1 a. depuratabrocca X-XII secolo pisana
178 Francesca Grassi
Fig. 3 - Principali tipi ceramici provenienti dal Saggio III (nn.1-2), dal Saggio IV (nn.3-5) e dal Saggio XX (nn. 6-13).
Reperti ceramici tardoantichi e medievali dai saggi III, IV, XX 179
1 Questa olla trova un confronto con alcune forme provenienti da uno scavo urbano nel centro diSiena, si veda CANTINI 2005, tav. 30, tipi 5.72 e 5.73, datati tra la fine del V e la metà del VI secolo d.C.
2 BOLDRINI et al., 2004, tav. 5, p. 287. 3 Per Cosa, CIRELLI, HOBART 2003, fig, 147, n.9; per Donoratico, GRASSI, LIGUORI 2004, tav. 2,
n. 11.
datato nella tarda antichità, probabilmente tra V e VI secolo1. A livello forma-le, la presenza della fascia che costituisce il bordo suggerisce un collegamentodiretto con il pentolame da fuoco di età classica, mentre non ha nessun richia-mo con le forme utilizzate nell’altomedioevo.
Il saggio IV
Dal saggio IV, ubicato anch’esso alla base dell’edificio delle ‘Logge’ (COC-COLUTO, BARTALI, MINUCCI, in questo volume), provengono 8 frammenti diceramica (Fig. 4). Tali frammenti sono molto più complessi da identificare ri-spetto a quelli dal saggio III, in quanto molte pareti oscillano nella datazionetra i secoli finali della tarda antichità e l’altomedioevo. Inizieremo dunquel’analisi a ritroso, partendo dai frammenti più facilmente collocabili in unambito cronologico preciso.
I reperti relativi ai secoli centrali del medioevo consistono, anche in questocaso, in pareti di grandi contenitori da acqua, riconducibili a brocche od or-cioli. Nonostante la frammentarietà dei frammenti rinvenuti (valutabili soltan-to in base all’impasto ceramico, dato che non sono presenti elementi caratte-rizzanti di alcuna forma), saremmo propensi ad associarli ai manufatti pisani,per analogia con i reperti del saggio III e con quelli già esaminati all’internodelle fosse di spoliazione ubicate nei saggi XX e XXI (GRASSI 2005b).
Passando all’altomedioevo, inseriamo in questa fascia cronologica un piccoloorciolo e un boccale. L’orciolo (US 2244, att. 251, periodo IV b2, Fig, 3, n. 3) hapareti molto sottili e superfici esterne lisciate. La cronologia ipotizzabile è traVIII e IX secolo ed i confronti possibili sono con analoghi materiali recuperatinella Rocca di Campiglia Marittima (LI)2. La stessa cronologia può essere indi-cata per il boccale con orlo sagomato ed ansa a nastro (US 2227, att. 429, perio-do IV a, Fig. 3, n. 4), che trova confronti con produzioni presenti a Cosa (GR) enel castello di Donoratico (LI)3. Per entrambi i reperti è esclusa una produzionelocalizzabile nell’area pisana: gli impasti sono molto depurati ed alcune analisiarcheometriche effettuate durante lo studio di simili materiali provenienti dallaRocca di Campiglia Marittima non hanno permesso di definire con certezza l’a-reale di provenienza di queste argille. Potrebbe trattarsi di produzioni locali, so-stituite a partire dalla fine del X secolo secolo dall’arrivo delle ceramiche pisane.
180 Francesca Grassi
4 Si veda PATTERSON, ROBERTS 1998, ed in particolare i contesti provenienti da Casale San Dona-to (fig. 5, n. 14 e fig. 7, n. 1) attestati tra V e VI secolo.
Infine, dal saggio IV provengono due forme che non rientrano nell’ambitocronologico medievale. Si tratta di tre pareti di una forma chiusa – una broc-chetta – caratterizzate da una rifinitura rossa delle superfici esterne, forse pra-ticata in cottura (US 2227, att. 429, US 2224, att. 209, US 2248, att. 429, perio-do IVa). Questo trattamento, che richiama sensibilmente i prodotti sigillati everniciati di rosso, può essere inserito cronologicamente nei secoli V-VI. Coe-vo sembrerebbe un boccale con ansa sagomata (US 2248, att. 429, periodo IVa, Fig. 3, n. 5), per il quale si trovano confronti in area laziale, in particolarenella zona della Sabina, nell’ambito di produzioni di V e VI secolo4. Nei ritro-
Fig. 4 - Le ceramiche esaminate nel saggio IV (sopra) e percen-tuale di attestazione dei reperti per fascia cronologica (espressacon il n. minimo delle forme).
Saggio US Attività Periodo Classe-forma Datazione Produzione
IV 2227/ 429 IV a a. depurata V-VI non identificabile2224 209 IV a f. chiusa
IV 2248 429 IV a a. depurata V-VI area lazialeboccale, fig. 3, n. 5
IV 2227 429 IV a a. depurata VIII-IX locale o pisanaboccale, fig. 3, n. 4 secolo
IV 2244 251 IV b2 a. depurata VIII-IX locale o pisanaorciolo, fig. 3, n. 3 secolo
IV 2244 251 IV b2 a. depurata X-XII pisanaf. chiusa secolo
IV 2244 251 IV b2 a. depurata X-XII pisanaf. chiusa secolo
Reperti ceramici tardoantichi e medievali dai saggi III, IV, XX 181
5 CANTINI 2005, acroma depurata, p. 106, tav.19, tipo 4.98, datato in base alla propria posizionestratigrafica.
6 Luni II, tav. 336, n.4, proveniente dal riempimento della Buca 2 datata all’XI secolo; GRASSI
2005a, tipo 1, gruppo 14, I.2.1 datata al X secolo.7 GRASSI 2005a, boccale tipo 5, gruppo 1, II.1.5, datato tra X e XI secolo; orciolo tipo 1, gruppo
2, II.1.8, datato nell’XI secolo.8 Si tratta della brocca fig. 1, n. 6 edita in GRASSI 2005b, p. 98, attribuita a Pisa, tipo G.I A (BERTI,
MENCHELLI 1998).
vamenti urbani senesi, invece, questo tipo di ansa sembra avere un periodo divita più lungo, che giungerebbe sino al VII secolo5. Occorre ricordare che giànel 2002 dal saggio IV erano emersi reperti risalenti alla tarda antichità, qualiceramiche dipinte di rosso, imitazioni locali di sigillate africane e ceramica dafuoco confrontabile con forme provenienti da Luni, datate al IV secolo (APRO-SIO 2004, pp. 109-110).
Il saggio XX
Durante la campagna 2003 il saggio XX aveva già restituito alcuni esemplariceramici di età altomedievale e medievale; nel caso dei primi l’interpretazioneal momento rimane dubbia, potendo trattarsi dei resti di frequentazioni spora-diche o di riutilizzi a scopo abitativo di alcune porzioni dell’acropoli. Nel casodei secondi, invece, il rinvenimento per lo più all’interno di fosse di spoliazio-ne ha portato ad interpretarli come tracce di frequentazioni collegate ad episo-di di recupero di materiali da costruzione dalle strutture di età romana, coeveall’impianto del castello di Populonia (GRASSI 2005b).
La campagna 2004 ha ulteriormente arricchito questo panorama, amplian-do l’arco cronologico documentato dai materiali con ben quattro forme ricon-ducibili ai secoli V e VI (Fig. 5), su un totale di 12 frammenti.
Al bassomedioevo risalgono quattro forme: un’olla, un orciolo, un boccaleed una brocca. L’olla (US 407, att. 314, periodo IV b, Fig. 3, n.6) è foggiata atornio veloce e presenta una filettatura molto marcata sulla superficie esterna.È databile ai secoli centrali del medioevo (X-XI secolo) in base ad alcuni con-fronti con materiali di Luni e di vari castelli della Toscana meridionale6.
L’orciolo (US 407, att. 314, periodo IV b, Fig. 3, n.7) ed il boccale (US 451,att. 336, periodo IV b) hanno impasti molto depurati e lisciature delle superficiesterne e sembrano rientrare tra i prodotti pisani della prima fase produttiva,datata a partire dal X secolo7. La stessa datazione è associabile a due frammentidi parete di una grande brocca (US 374, 323, att. 336, periodo IV b), entrambirelativi ad una forma già pubblicata, proveniente anch’essa dal saggio XX8.
182 Francesca Grassi
Fig. 5 - Le ceramiche esaminate nel saggio XX (sopra) e percen-tuale di attestazione dei reperti per fascia cronologica (espressacon il n.minimo delle forme).
Saggio US Attività Periodo Classe-forma Datazione Produzione
XX 323 336 IV b a. depurata V-VI secolo incertaf. aperta, fig. 3, n. 13
XX 444 426 IVa a. depurata V-VI secolo incertaboccale, fig. 3, n. 10
XX 323 336 IV b Dipinta di rosso, V-VI secolo incertafig. 3, n. 12
XX 451 336 IV b Dipinta di rosso, V-VI secolo incertafig. 3, n. 11
XX 444 426 IVa a. depurata VII-VIII secolo localebrocca, fig. 3, n. 8
XX 444 426 IVa a. depurata VII-VIII secolo localebrocca, fig. 3, n. 9
XX 374 336 IV b a. depurata s. metà X - pisanabrocca s. metà XI secolo
XX 323 336 IV b a. depurata s. metà X - pisanabrocca s. metà XI secolo
XX 451 336 IV b a. depurata X-XI secolo pisanaboccale
XX 407 314 IV b a. grezza X-XI secolo localeolla, fig. 3, n. 6
XX 407 314 IV b a. depurata X-XI secolo pisanaorciolo, fig. 3, n. 7
Reperti ceramici tardoantichi e medievali dai saggi III, IV, XX 183
9 FENTRESS et al. 1991, fig. 17, n. 6, p. 217.10 CANTINI 2005, tav. 14, fondi di acroma depurata con piede ad anello.11 Per il boccale vi sono confronti che giungono sino al VII secolo, tra cui a Siena (CANTINI 2005,
tav. 42, tipo 7.28 datato alla prima metà del VII secolo) e a Roma (RICCI 1998, p. 377). L’ansa non hainvece confronti puntuali.
Alle fasi altomedievali vengono attribuite due brocche (Fig. 3, n. 8 e n. 9),delle quali si conservano rispettivamente un frammento di orlo sagomato e diun’ansa a nastro. Nonostante le ridotte dimensioni dei frammenti, che impedi-scono di trovare confronti bibliografici puntuali, l’uso di argille molto depura-te e di lisciature delle superfici consentono la datazione di entrambi gli esem-plari tra VII e VIII secolo.
Infine, ad epoca tardoantica sono riconducibili due classi di reperti, distin-guibili in base al rivestimento, totalmente assente in un caso e costituito da uningobbio rosso nell’altro. Nel primo gruppo la forma più riconoscibile è un’ansasagomata di boccale (US 444, attività 426, periodo IV a, Fig. 3, n. 10), con con-fronti a Luni tra V e VI secolo, ma tra i prodotti con ingobbio rosso9. L’altroframmento presente è un fondo con piede ad anello di foma aperta (US 323, at-tività 336, periodo IV b, Fig. 3, n. 13), molto generico per riuscire a trovare unconfronto puntuale, ma ben attestato come tipologia tra V e VI secolo, anchetra i reperti provenienti da Siena10. Quanto alle ceramiche dipinte con ingobbiorosso, già attestate a Populonia negli strati di abbandono e distruzione del mo-numento delle Logge (att. 204, APROSIO 2004, p. 110), sono documentate nelsaggio XX da due forme distinte: un boccale con orlo sagomato (US 323, atti-vità 336, periodo IV b, Fig. 3, n. 12) ed un’ansa a nastro di brocca o boccale(US 451, attività 336, periodo IV b, Fig. 3, n. 11), rivestiti entrambi con un in-gobbio rosso molto diluito e steso a macchie, in maniera non omogenea11.
Conclusioni
L’analisi di questi reperti ceramici ha fornito testimonianze importanti sulleproduzioni tardoantiche e altomedievali nell’area della costa toscana e, nelcontempo, ha permesso di illuminare alcune fasi di frequentazione della cittàdi Populonia nel momento in cui i monumenti d’età romana già si presentava-no in avanzata fase di distruzione.
Tra i reperti d’età tardoantica compaiono ceramiche con ingobbi rossi e ce-ramiche comuni prive di rivestimento, che trovano molte analogie con i corre-di presenti negli stessi secoli nella vicina città di Cosa e nell’area laziale. È pre-sumibile che si tratti dei resti di attività di risistemazione delle macerie già pre-senti sull’acropoli e di parziali riutilizzi di alcune strutture.
I reperti altomedioevali, che coprono un arco cronologico che va dal VII al
Reperti ceramici tardoantichi e medievali dai saggi III, IV, XX 185
R. FRANCOVICH, M. VALENTI, 1997, La ceramica di uso comune in Toscana tra V-X secolo. Ilpassaggio tra età tardoantica ed altomedioevo, in La céramique médiévale enMéditerranée, Actes du Vme Colloque (Aix en Provence 1995), pp. 129-137.
F. GRASSI, 2005a, Gli apparati produttivi, i mercati ed il consumo della ceramica nella Tosca-na meridionale (VIII-XIV secolo): il confronto tra siti rurali e urbani, Tesi di Dottorato inArcheologia Medievale, XVII ciclo, Università di Siena.
EAD., 2005b, Reperti ceramici medievali dai saggi XX e XXI, in Materiali 4, pp. 99-102.F. GRASSI, S. LIGUORI, 2004, Per un preliminare catalogo dei reperti ceramici: i contesti di
ante X-XI secolo, in G. BIANCHI (a cura di), Castello di Donoratico. I risultati delle primecampagne di scavo (2000-2002), Firenze, pp. 115-138.
Luni II = A. FROVA (a cura di), Scavi di Luni. II. Relazione delle campagne di scavo 1972-1973-1974, Roma.
Materiali 3 = M.L. GUALANDI, C. MASCIONE (a cura di), Materiali per Populonia 3, Firenze,2004.
Materiali 4 = A. CAMILLI, M.L. GUALANDI, (a cura di), Materiali per Populonia 4, Firenze,2005.
H. PATTERSON, P. ROBERTS, 1998, New light on dark age Sabina, in L. SAGUÌ (a cura di), Ce-ramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di J. Hayes (Roma 1995), Fi-renze, pp.421-437.
M. RICCI, 1998, La ceramica comune dal contesto di VII secolo della Crypta Balbi, in L. SA-GUÌ (a cura di), Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Atti del Convegno in onore di J. Hayes(Roma 1995), Firenze, pp. 343-351.