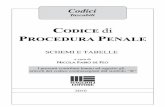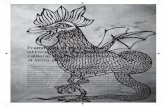1992a Una nuova procedura per il disegno di frammenti ceramici archeologici
Transcript of 1992a Una nuova procedura per il disegno di frammenti ceramici archeologici
•
IL DI EG 'o ARCHEOLOGICO DELLA
CERANIICAG L ard c.r lo
E ALTRI PROBLEMI
. T. Lp,~. X .II .rhplt, S.Prucchta. P'R 1'01•. Jfl '"ù,le
altuarie dal laboratorio del Piovego 2
UNA UOVA PROCEDURA PER IL DISEGNODI FRAMMENTI CERAMlCI ARCHE01.pGICI
Introduzione
Il disegno dei materiali archeotoglcl (BJtOPORlf> 1971; GVfIl.lE$(."tU 1980; JQl.KOWSKt 198(); ADXlN.$ e ADwoo 1989) rappresenta unacomponente essenziale di ognirapportodj $ClIvO f) pubblicazione di materiale archeologico . Dlsegnare un oggettoimplica moltospessoun livello lnrerpretaurcsuperiore a quellopropriodclla fotosrafia(HOt.E eH l:.l m 191); 207); perquestemotivo. moltiarcheologi sono essi stessidisegnatori. QutS18 ar~
Iermazione è panicclarmenre fondata per I materiali ceramici,in quanto le convenzioni di rappresentazione grafica normal·mente adottate per un vaso o per un frammento OOO"OWSICY1980: 41 5..426) permettono una drtcace siaresì di diversi ordinidi informazioni immediatamente deSumibili (dimensioni, moroIclogìa. trattamenti di superficie. elementi f'igunulvi) .
E curioso notare come in due" bibbie" della ceramclogiaarcheologica come O!ramicslor 1MArrhaeologisl$ di A. O. Shepard (1968)eli più r«elllePollery Anal.vs!<di P. M. RJ<e 11981)l'argomento del disqno de"a ceramica sia quasiccmpletamemetrascurato. e, quando viene trattato, gli autori si riferisconoesclusivamente a forme intere. A. O. Shepard asserisce che uFOfpurposes oJ il/U$trutlon. there ls probob/y no suòst;luJe far ogoodphofOgroph>. (1968: lil). QUC5ta affermazione. chesuonaparadossale a un archeologo del Vecchio Mondo, ! probebìlmente dovutaal fatto chelacategoria di lo!tipo" negli Stati Unitiè stata storicamente usate OOJ) il signifICato chenoi comunementeauribulamo al termine di "classe ceramica"; una fotografia, inquesta prospettiva, riproduce efficacemente gli esemplari ceramici fornendo il livello di informazione richiesto(ad esempio.nelcasodi un panìcclarètipo di decorazione per incisione o inR
gubbilllura).La diffU$ione dei personal computef$. In primo luogo dei
piccoli sistemi portatili, permeneoggi di organizzarecd elaborare massedi dati archeoJogicllncooceplbili sino a pocotempofa. Data la rilevanza quanùtatiya e le ìnfìnìte pOlen:daJJll informeuve dellaceramica (tra gli alttj loow.o\lU)! et 01. 1989),I'informatiuazione di questo aspetto della ricerca può permettere08&1 una piccola rivoluzione scientifica. Tuttavia, a questa accresciuta capacitàdi immagazzinare ed elaboraredali nan ii cororisposta una paralleladiffusione qualitativa e quantitatlva nelleprocedure di acquisizione dei dati stessi.Nel casodellaceramica
-17
78
questo problema può essererlcondcno Il due aspenì principali.lo primo luogo, mentre le potenziaUta di gestionedei da.t.l
perJ'analisi tipometrieain termini di hordwareesofl'M!areWOogiunte negli ultimi anni a livelli chepochi tra gli archeologisonoin gradodi sìruuare pienamente, benpochi sisonoposti Inmodoprcpositìvo il problema dell'analisiupometrica di frammenti ccramici t della loro eventuale corrclabilità con forme intere (masi veda il recente articolo di HAGSTIlUM e H.uJ)E8RA.~D 1990).Inoltre, mancandoio Italiauna tradizione didaulcaa livello universitariosulla teoria e pratica deldisegnodei materialiarcheologici, per lo studio del materialepubblicatosi è costretti a utilizzare disegni di qualità non standardinata, spesso Insoddisfeceuu e comunque difficilmente conrrcllablli. Il numero diesemplari pubblicati, inoltre, rappresema quasi sempre un campione esiguo rispetto alla tOlalità del dati. A queste difficoltàsi aggluJl8e l'elevato margine di approssimazioneche comportala deflnlzione di una forma ceramicasulla base di un unicoprofilo. dimostrato da recenti contributi (U VI e v...~lJ!Tt1 1990).
In secondo luogo,lutte le misurazioni necessarie aU'ana.Jisj tipometrica VCtIgQDO ancora effettuatemanualmente, conmarginidi more mollo eleYaLi e tempi per lo più proibitivi. SecondoGuerreschi (1980: 46) il cerretro rilievo di un frammento ceremico preistorico seconde leconvenzioni grafIChe correnti e la suainchiosrrarura finale richiedono rispettivamente 60e 30minuti.
In un progettodi scavo archeologico e pubblicazione deimater iali , il COSIO totale del rilievografico della ceramica non puòessere esclusivamente valutato In termini di "tempo-lavoro"speso per ogni coccio misurato,ma anche e scprarrunc nei termini del costo complessivo richiesto dallo studio di un interocorpus ceramico. Lo studio di una eoneacne di scavo richiedeil trasporto del campione ceramicoscelto per l'analisi nell'apposito laboratorio, o l'organizzazione di una fase di lavoro interememe dedicata alla documentazione e studio dei materialirinvenuti. Gran pane deidati tipometrlci vengono ricavati usualmente dalla riproduzionegraficadei peui . JI costanteproblemadella riproduzionegraficadelmanufattoviene spesso risolto conl'ausilio di un disegnatore professionista che, se da una paneassicura risultati affidabili e risparmia " tempo-lavoro" ell'a rcheologo, dall'altra ccaìuslsce una dtUe voci più elevare nelleprevisioni di spesa delle ricerche. Anche se i prezzi sono relatìvememevariabili, nonsiamomollolontanidalla realtà stì.mandoun costo medio di almeno 15000 lire per elementodisegnato.QuestO significa che pubblicare: un gruppo di 300frammenti (uncampione comunque infimo rìspeuc allamassa di esemplari dia·gtl,osticì rinvenuti nel normale scavo di un abitato prolOStorico)verrebbe a ccsrerecirca 4SOOOOO lire. una cifra comunqueecnslderevole per moW progenl di ricerca archeologica dì piccola·media portata.
0 1fronte a queste difficoltà, gli archeologi (almeno quelliCOn problemi di finanziamento) banno adottato diverse strate-
•
•
"
gie. La po<i5ibilità di acquisizionedci dali relativi alle dimensioni del vasoe alla sua morfologia con l'uso dell'elaboratoreelettronico e di tutte le sue periferichee in corso di spehmenratione (dr . TUJl.NER: et al. 1990; KAMf'FF'MEYER et 01. 1988), mal'assenza di utilitiesspecifiche (BI.IZZAMCA 1990)t l'elevato costodell'elaborazionedel$OJtwore e deglistrumenti a esso coUegati(telecamere, scanners, tavolette grafiche, CCl.: .). e la generaìescarsa portebllnà delle stazioni necessarie rendono ancora ardue utilizzazioni pratiche. Altre soluzioni sono state ricercatenetìosviluppo di piccoli sistemi meccanici a bassocostoche permeucnc di limitare ì marginidi errore nella riproduzionegrafica e, al tempo Stesso, di accelerare i tempi dì produzione.Esempi classici. da tempo acquisiti nei laboratori archeclogkì.sono piattaforme dì disegno con riferimenti crtogonaìlper il rìneve di vasi interi (SHEPARD 1968: fig. 33; JQUJ:OWSKY 1980:ftgg. 16-37), diversi tipi di panlografi per il rilievo manuale, opiccoli dispositivi con piani$Ovrapposti in plexiglas per il d isegno di piccoli manufatti, utilizzati con una certa frequenza inNordEuropa. Laprocedurachedescriviamo rientnl coneeuuatmente in questo secondo filonedi ricerca, ed è stata da noi svi~
luppata con specifico riferimentoalla necessità di documentarelulC'fUmcnle collezioni di cocci provenienti da scavi di abitato.
Il metodo
La procedurada noi sperimentate prevedel'utilizzazione diun semplice dispositivo meccanico" medìame il quale è pcsstbile ricavare, In negativo. l' impronta or ientata della sezione delframmento. l'elemento più importante del rilievo grafico. Lostrumentoutilizza tavolettedì schiume fenolica espansa a granarelativamente fine (fia. I). Sono state utilizzate, in questa applicazione, le tavolettecomunemente impiegarein onopedia perimpronte plamert e distribuiteda grossisti di forniture ospedatiere.
Il dispositivo si compone delle seguenti parti meccaniche:
I) una piattaforma basale di forma rettangolare;
2) una piastragirevole Imperniata sudi un cusdneuc a sfera,fissata al centro di questa piattaforma, ricavata ragliando unsettore di una tomiella per ceramica. Su Questo elementoè Ilssata una prolunga in alluminio,che pona un cerchicmerrn predisposto per la misurazione dei diametri dei (rammenti:
3) un SOStegnometallico con sezionea ..L", destinate a scrreggere la tavoletta di schiuma, perfettamente perpendicolare
i Oesidc!riamo rlnanu:lmìI~. F. Caposroui che bi ~1()mu.c..tnenlt .11'riabarI~dt'1dkpo:sìtlvo,~ k' pn:puioni KlItoakuni..pelli Importanti.
79
• Fil· J • (ho (hl t/lsptuIth'fì PfI' Il rifltvo d(flt MlImlrhl flrrM<HOI u:lIt(pat1ko1.,. dd/(I prOl:tdllfQ di rNf;a,pz)()M dt:Il'imp«mllt).
81
-
82
telecamera. e di elaborare e archiviare: le Immagini in appositidata bases. Queste possiblJìtà sono auuaìmenre incorsodi sperimemezicne presso il Centro Trauameam Dati ddl'JsMEOerrcs.
Vanlll" l del melodo
J) Precisione. L'impronta,e la sua fotocopia, sono perdeflnìzicne maggiormente precise della sezione ideale ricavata daldisegnatoremedìanre unaserie di misurazioni successive, ricomposte in una ipotesidi ricostruzione. Esperlmentì da noi efCettuati dimostrano tbc Ometodo descnrrc risulta .sensìbtlmentepiil preciso del rilievo manuale (per i limiti di quest'ultimo siveda anche DEBoa 1980). Il metodo dell'Impronta riduce sensibltmente nrischio chel'archeologo o il disegnatore, inconsciamente, diano maggioreo mìncre n1ievo a determinate caratteristiche morfcloglche deipezzi. L'uso della procedura, inoltre,consente unanotevole precisione anche a un operatore conmlnime esperienze dìdisegno, chepuòoosl fornirepresWioniparagonabill a Quelle del dlsegnluore proìessìcniste (il dlsegno sulucido. inquestocaso, diviene ovviamente nmomento piùdelicato).
2) Standarditznlone drl rlsufllUI. Lo sfruttamento delle imopronte consente di ridurre sensibilmente la variabllità individualedei disegnatori. Inquesto modo la documentazione detl'lnrerccorpusceramico risulta omogenea e Il margine d'errore ~ costante e quaatificablle.
3) Rlpidilì di esecuzreee. Quando il gruppo di frammentiè stato gij numerato e ordinato, e i diametri registrati, un ope-ratore medio può produrre fino a IQO. IS0 impronte per ora(ng. J). Lo stesso operatore (ancht senza particolari capacitàdi disegno) può trasformare sino a 10 impronte fctocoplete indisegni ìncbìostrati in una&iornata di lavoro. In situazioni particolari, come nelcasodi scavi all'estero che richiedano lo studio del materiale in fOC(}, il procedimento permette di operareosservazioni dettagliate e tipologie preliminari nel COM delloscavo stesso (fig. 4). Questo metodo è stato sperimentato consuccesso nel novembre 1990 da pane della Missione Archeologica Italiana in Nepal . Nel corsodellescavocondottodaS. Pracchlanelgiardino del p.alazzo reale denacinA di Patan e nelgìardino del tempiodi Pashupatìnalh, è' 51810 possibile documentare1'85""deiframmenti d'orlodiagnostici per un totaledicirca8tXX)impronte. Un simile arcl1ivio di tmprcme costituisce una baseper l'analisi dpologica ben più affidabile di quelli tradizionali .
4) Coi to ridotto dd mOft rillil. Unatavoletta di schiuma, chepuò O$pitm 15-30 impronte, C05Ul intornoaUc 2OOllire. A queSta spesa si aggiungono i normali costi relativi ai materiali dadisegno.
, '"
•
•
-
•
'> ColUtnIl~done. dellesupernd . La schiuma sonhulsce erIicacememe i penìnì sagOtnatOri con denti melaDici tanto aborriti dai restauratori.
Sn ntllggl del metodo
I) U mili di rilievo. In alcuni casi le decorazioni plastichepossono causare dei prcbìemt. Solcaìure o decorazioni a pettine dì profondità :i I mm. in genere, non lascianotracce rìconoscib:ili nell'impronta. Tutte le- decorazioni ìneise in Dtgath'oo leggermente impresse non sonorilevablll. Va comunque rìccrdato che in simili casi imprimendo la superficiedecorata nellaschiumasì ricavanofacilmente negativi per calchirelativamentefedelI. Il problemaprincipale,comunque, consiste nel fatto cheleimpronte regisu'8oo necessarìameme il profilocumulati\O dellemassime espansioni della pane del frammentochepenetra nellaschiuma. In altre parole. se la superficie del coccio presenta irregolarità come protuberanze e depressioni, l'impronta ')arAdeterminata dall'insiemedeUe protuberanzepresenti nellaparteimmersa nella schiuma. Per questo, l'uso del dtspositlvc vienerecccmandaro in primoluogoper complessi ceramici tcmltì aUaruota. Negli altri casi la proctdura è comunque utlliuabUe prestando la dovuta attenzionealla presenza di irregolaritànei pro.mi studiati. ~ comunque chiaroche11 disegno del profilo della
83
----- --
Fil. 4 · Kafhft/(Jndu. Nt'paf. UIOdd dispositivo tk:ft;rIUQ Mi /t$lop«1iJ tttllfrad~dfJJ' ~JdHtdi tatrO
(1m).
sezioneva sempre effenuaro controllando COStantemente l' impronta con U frammento da disegnare.
2) P'oblemi dJ (t>ptrlbllli' dci materiali. Anche se le tavolette di schiuma espansa sembrano essere usate con frequenzain ambito crtcpedìco, non vengono vendute al deuaghc e perl'acquisto è necessario il numero di partita IVA. Un ulterioreproblema potrebbeessereeostituìtc dall'accesso continuo il unabuona fotocopiatrice.
3) Vb acido drella sclIluma. Prove effettuate preno l'fCRhanno dimostrato che li materiale è lievemente acido. Alcunepersone sembrano risultare leggermente allergiche a un usoprolungato. ln questi casi• .si consiglia di ulilìuare la schiuma conguanti di plastica e maschere di carte,
ConduSlo nl
Abbassare j costi e i tempi della dccumernazrcne significaaiutare la promozione di progetti dì ricerca archeologica emergenti e non sufficientemente finanziati . In prospettiva. la procedura che stiamo sperimentando potrebbe portare al superamentodella necessità di operareartifidaJl sdezioni nel marerìaleda studiare. chespesso si risolvono nell'eliminazione dei frammenti più mlnurl e di difficile manipolazione. Poiché le variecategoriedi ccntemrort ceramici non si frantumano a tempi castanti e in uguali quantitAdi frammenti , in molli contesti ar·cheologlci l'eliminazlcne diquesta componente delladocumentazione può determinare una falsificazione sistematica dei datidi scavo. ( frammenti diorlo più minuti rappresentano una componente statisticamente essenziale di molti assemblaggi, e, sedocumentati come i frammenti apparentemente più. sipìfitativi,possono fornireuna baseper valutazioni tipOlogicbee croncloglebepiù fondate. U.n aspetto della ricerca archeologica che sìbasa ancera treppo spt'$O su affermazioni scarsamente ccmrollate di earenere quelitauvo può cosìevolvere nelladirezionediun pio efficiente controllo quamltatlvo dei dati.
M. Mi(:hf ll, S. Pn Ct:hia, F. Rispoll e M. Vld..le
--------8S
86
BIBLIOGRAFIA
ADilJol$ L. e ADKINS R. A. 1989. An:haeologirol ttlustratìon.Cambridge ManuaJs in Archuology, ew York .
BRODDIUPC. 1971 . Drowing An:haeologit:o/ Fmds. AssocìauonPresso New Vort.
BUllANCA G. 1990. Ttcnologieinjormatichedi rilievo eroppre.senun;on~ : qualeruoloper il resuluro? Aaa GeoarcheclogicaUrblce 3: II-Ici,
CAUlOU GIUUAl'« F . 1983. Archrologia1J«umentadone Grafico, Roma.
DE80EJt w. 1980. V~J Shapt [rom Rim Shertb: (In Ex/N'n'.mtnlO1l tneEl/te,o/,!Ie lndividuo/lI/ustratOf. Journal or FieldArc.hacology 7; 133·135.
GuaIlESCHI G. 1980. La tip% gia della ceramico. Pordenone.
HAOSTIl Ufol M. B. e Hn.DEBltN<1l J. A. 1990. Tne T'k'Q-Curwl1ureMethod/o( RI!OO1I$1lUCling CMJmJc M()f1Jh%gy. American Antlquiry SS (2): 388-403.
Ho.t.& f . t H.I!.ll El R. F. 1973. An Introducrion to PrthistorkArchoeology. 3rd Editioo, New York.
JOUKowsn M. 1980. A Complete Mtl1Iual 01 Field An;h~oloV. Prentìce HaU, Englewood Cliffs.
KAMpf.TMEVEa u.. LM.!l:;l.<'Is K. H•• TE.EGEN W. R. e ZAMPEItQ:'f1P.1988. Nuove esperienu sullac1assifu:ailone computHiu.Dta delleforme ceromiche condottesui materialisepoiuo!i dei/o necropoli di Veio. In Archeologiae Jtiformlltko, Quaderni dei Dialoghi di Archeologia 4: 1S1·170.
Loow.kDI Q .• PIlAoctUAS. e VIOi\ l.f M . 1988. L'indict1tore ceramica neiptrcor.siarcheologici. In DoItrilfll emetodologia dellarlcerca preistorict1. (XXVII Riunione Scientirtea dclJ'UPP, 17-20novembre 1987, Ferrara), Ferrara: 85·104.
Uvl S. l'. t VA!'Wml A. 1990. Lafu/sa regolarilQ di un lipOceramicofoggiato 0/ tornio in una necropoliprolOSIOriCO, Comunicazione al convegno Generazioni? del/a Cullura Moteriole.Archeologica. Processi, Roma 12.7.1990.
RIC$ P. M. 1987. PoueryAna/ysis. A Sourcebook. Chicago.
SHliPAID A . O. 1%8. Ceramìcsfor lhé Arc:hot!OIogist, 6th Edidon, Washington D.C.
T VRNEIl J. O.• KIlA.IY A. C. e P&.COClC D. P. S. 1990. DrowingPOlSherds; tov-çosr Compuru·&.ttd..sysrem. Arcbaecmetry32.2: 177-182.
i