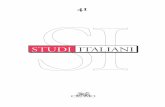"Per sghignazzarmi del mondo". La lettera faceta nel Cinquecento
Fornaci e scarti ceramici a Pisa tra Quattro e Cinquecento
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Fornaci e scarti ceramici a Pisa tra Quattro e Cinquecento
13
Fornaci e scarti ceramici a Pisa tra Quattro e Cinquecento
Marcella Giorgio
Premessa
Pisa fin dall’antichità ha posseduto, tra le tante spe-cializzazioni artigianali che la connotarono, anche una spiccata manifattura di vasellame ceramico1. Quest’ul-timo dal Bassomedioevo viene fabbricato con terre ar-gillose raccolte presso gli argini peri-urbani del fiume Arno che, una volta cotte, doneranno ai manufatti il caratteristico colore rosso-arancio degli impasti.
Molto si è scritto negli scorsi decenni sulla produ-zione ceramica pisana dall’XI secolo in poi grazie agli studi di Liana Tongiorgi e Graziella Berti. A queste due studiose si deve la grande stagione di ricerche su questa tematica che ha interessato Pisa a partire dagli anni ’60 del secolo scorso e che ha coinvolto diverse tipologie di specialisti che nel corso del tempo hanno collaborato con Graziella Berti col fine di ampliare sempre di più le conoscenze sul passato della città marinara.
Nello specifico, l’ottica multidisciplinare che ha af-frontato lo studio della ceramica pisana ha visto coinvol-to chimici, storici, archeologi, storici dell’arte ed arche-ometri, permettendo col tempo la ricostruzione di un passato che era stato dimenticato. Ciò appare curioso se pensiamo che l’ultima grande fabbrica di ceramiche a Pisa, la Richard Ginori, ha chiuso i battenti solo negli anni ’80 del Novecento2. Sono bastati meno di trent’an-ni per vedere alterata e parzialmente persa la memoria di tale grande esperienza economica e lavorativa, tanto che a tutt’oggi nulla o quasi resta degli impianti e spazi di lavorazione (riconvertiti nel tempo ad altro uso) se non una ciminiera abbandonata nei giardini di un condomi-nio di nuova costruzione.
A questo punto non deve meravigliare se, l’aver af-frontato lo studio della ceramica non solo come ma-
1 Si veda, ad esempio, Menchelli 1995 per la produzione di si-gillata a Pisa in epoca romana.
2 A questo proposito si veda Di Sacco 2005.
nufatto in sé ma come rilevante momento di sviluppo cittadino, è risultato essere essenziale per comprendere una tradizione che, fondando le radici nell’antichità, si è protratta nei secoli sino ai giorni nostri.
Gli studi documentari hanno permesso di com-prendere almeno in parte per i secoli dal XIII al XV l’organizzazione delle botteghe e le fasi di lavorazione e approvvigionamento delle materie prime, ma soprattut-to ci hanno fatto conoscere i nomi dei vasai che spesso trasmettevano le conoscenze e le manifatture di padre in figlio3.
Le ricerche effettuate sui manufatti, recuperati prima negli sterri e successivamente tramite indagini stratigra-fiche urbane, hanno consentito di conoscere l’articola-zione dei prodotti fabbricati ed immessi sul mercato4, la composizione dei corredi domestici nelle varie epoche5, le tecnologie con le quali furono prodotti, le specializ-zazioni produttive, la cronologia e l’evoluzione degli stessi6.
L’affinarsi delle tecniche di analisi nel corso degli anni ha permesso di specificare sempre di più i caratteri esclusivi dei prodotti pisani rispetto a quelli regionali ed extra-regionali: il confronto con gli altri oggetti rinve-nuti negli scavi in ceti sociali diversificati e l’evoluzione cronologica sempre meglio specificata ne hanno fatto dei fossili guida per coloro che si approcciano agli studi sul Medioevo pisano e, più generalmente, tirrenico.
L’introduzione dell’ingobbiatura a Pisa
Negli ultimi anni le ricerche si sono concentrate sempre di più sulla fase Quattrocentesca della produzio-
3 Si veda Tongiorgi 1964, 1972, 1979 e quanto scritto da Giu-seppe Clemente e Daniela Stiaffini in questo volume.
4 Berti 1994, 1997, 2005; Berti, Tongiorgi 1977, 1982.5 Giorgio 2011c, 2012b.6 Giorgio 2011a, 2012a; Giorgio, Trombetta 2011.
14 15
ne. Questo momento si caratterizza per l’introduzione di nuove tecnologie presso le botteghe che già sforna-vano maioliche arcaiche ed invetriate da mensa senza soluzione di continuità a partire dai primi decenni del Duecento. Come accaduto per la vetrificazione dei corpi ceramici (smalto e vetrina) agli inizi del XIII secolo, an-che nel corso del XV secolo si assiste all’introduzione di un sapere maturo e pressoché privo di sperimentazioni. In questo caso si tratta della tecnica dell’ingobbiatura, miscela a base di argille caoliniche, che viene arricchita tramite la decorazione graffita e l’apporto cromatico, e resa impermeabile dalla vetrina.
Ancora non sappiamo in che maniera e da chi i ceramisti pisani appresero i rudimenti per l’utilizzo dell’ingobbio (la scelta delle terre giuste, la corretta composizione della miscela caolinica ecc..). Un’ipotesi condivisa7, già suggerita da Graziella Berti8, propone un’acquisizione di competenze attraverso maestran-ze padane scese in Toscana settentrionale attraverso la Garfagnana, che già nel XV secolo era area di interesse degli Estensi e luogo di scambio di saperi9. Attualmente questa tesi resta la più valida, sostenuta da dati docu-mentari che vedono l’ingresso di nuovi ceramisti a Pisa provenienti da Milano e da Lucca (che potrebbe forse aver fatto da tramite) nel primo quarto del XV secolo10. Si conoscono, inoltre, orciolai di origine padana attivi a Montelupo fiorentino nella seconda metà dello stes-so secolo11, forse giunti dall’area modenese attraverso l’Appennino pratese-pistoiese. È quindi possibile che ci fosse, nel corso del Quattrocento, una certa mobilità di vasai padani ed emiliani che arrivarono in Toscana attra-verso le terre estensi della Garfagnana e che si stanziaro-no primariamente a Lucca, dove iniziarono a fabbricare le tipologie diffuse nelle terre di origine. È verosimile che siano stati questi ceramisti padani operanti nelle manifatture lucchesi e montelupine, o in botteghe già
7 Trombetta 2009, p. 7.8 Berti 1994.9 Berti, Cappelli, Tongiorgi 1986.10 Tongiorgi 1979, p. 19; Berti 1997, p. 266. A Lucca sono se-
gnalati numerosi ritrovamenti di ceramiche graffite padane pro-venienti da aree modenesi, reggiane e ferraresi (ad es. il più re-cente Ciampoltrini 2013 con bibliografia precedente) e la città risulta aperta, tra Quattro e Cinquecento, all’immigrazione di artigiani ‘lombardi’ anche nel campo delle produzioni cerami-che (Ciampoltrini 2013, p. 14). Alcuni collegamenti tra vasai pisani e lucchesi sono visibili in alcuni documenti che testimo-niano, tra le altre cose, di una società tra stovigliai delle due città agli inizi del ‘400 (Moore Valeri 2004, p. 96; Tongiorgi 1979, pp. 27, 29, 60, 98, 132).
11 Berti F. 1997.
attive ma specializzate in altre produzioni, ad aver diffu-so i motivi decorativi e morfologici della graffita pada-na, come appare evidente in alcuni decori e forme che riprendono repertori decorativi padani, quali ad esem-pio la “coniglia gravida”12. L’ingresso a Pisa di tale tec-nologia può essere stata mutuata attraverso l’esperienza di questi ceramisti che possono quindi aver trasmesso ai lavoranti locali il loro bagaglio di conoscenze.
Un’unica fonte ad oggi ci permette di cogliere, forse, questo passaggio, nel momento in cui l’ingobbio arriva nelle mani e nella bottega almeno di un vasaio attorno agli anni centrali del Quattrocento. È infatti databile al 1441 un documento in cui il vasaio pisano Sano di Gherardo Borghesi paga alla Dogana della Degazia lire 1 e soldi 8 per “sacchi di bianco e altro”13. A tale dato fanno da supporto i ritrovamenti archeologici cittadi-ni che permettono di collocare nelle stratigrafie della seconda metà del XV secolo i primi oggetti da mensa ingobbiati e graffiti a punta fabbricati a Pisa.
Ancora al ceramista Sano di Gherardo Borghesi si deve, pochi anni dopo, un’altra attestazione documen-taria che conferma l’utilizzo dell’ingobbio nella sua bot-tega: il testamento con l’elenco degli oggetti presenti alla sua morte, avvenuta tra il 1472 ed il 147814. A quel momento le “terre bianche”, utilizzate per le prime in-gobbiate e graffite, sono presenti nell’atelier assieme allo “stagnio” che rappresentava l’elemento base per la com-posizione dello smalto delle maioliche arcaiche.
In questo breve arco di tempo, quindi, le fonti ci rac-contano come almeno Sano dovesse conoscere e sapere utilizzare l’ingobbiatura per produrre ceramiche ingob-biate nelle sue fornaci, e come alla secolare produzione di oggetti smaltati si iniziasse ad affiancare quella delle ingobbiate e graffite. Le numerose quantità di conteni-tori di queste classi rinvenute dentro e fuori la città di Pisa da questo periodo in poi dimostrano come tale tec-nica debba essersi presto diffusa presso altre botteghe e abbia gradualmente conquistato quelle fasce di mercato prima appannaggio della maiolica.
12 Questa tipologia decorativa è molto diffusa a Lucca (Ciampol-trini 2013).
13 Berti 2005, p. 124. I termini “bianco” e “terre bianche” venne-ro utilizzati per indicare l’ingobbio come dimostrato in Stiaffi-ni 2002.
14 Per la divisione dell’eredità di Sano si veda Berti 2005, pp. 124-125.
14 15
Le ingobbiate e graffite prodotte dalla metà circa del XV secolo
I documenti suddetti avevano spinto Graziella Berti a datare agli anni ’30-’40 del Quattrocento l’inizio della graffita a stecca e a punta a Pisa: questa ipotesi sembrava supportata dal rinvenimento di uno scarico con scarti di fornace di maioliche arcaiche e graffite a stecca e pun-ta sotto i pavimenti del chiostro dell’ex Convento delle Benedettine presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. In base alle conoscenze dell’epoca, Graziella Berti aveva ipotizzato che la maiolica arcaica smettesse di essere fab-bricata attorno alla metà del XV secolo15: rinvenire scar-ti delle tre classi ceramiche assieme, secondo la studiosa non solo confermava la realizzazione nella stessa bot-tega, ma permetteva di datare (con l’aiuto anche della fonte documentaria) le ingobbiate e graffite di entrambe le tipologie in un momento coevo appena precedente la fine della maiolica.
Tale ipotesi ha incontrato pareri contrastanti e non ha trovato conferme materiali: gli scavi stratigrafici cit-tadini che negli ultimi venti anni circa hanno indaga-to porzioni diverse del centro storico, hanno restituito contesti d’uso e scarti di fornace che permettono attual-mente di contestualizzare meglio l’applicazione delle di-verse tipologie graffite presso gli ateliers pisani16.
I dati provenienti dagli scavi di Piazza Consoli del Mare, del Museo di San Matteo, di via Facchini, di via Toselli, di Piazza delle Vettovaglie, di Palazzo Scotto, di San Michele in Borgo e, più recentemente, di Vil-la Quercioli17 (solo per citarne alcuni) concordano nel mostrare un’assenza di ingobbiate e graffite a stecca nel corso di tutto il Quattrocento, con prime rare attestazio-ni di materiali solo negli anni iniziali del Cinquecento18. L’unica classe graffita presente, seppure in quantità non eccessive rispetto all’ultima maiolica arcaica, è quindi la sola tipologia a punta.
Quest’ultima, seppure riprende alcuni motivi e for-me dei coevi prodotti lucchesi ed emiliani, in linea di massima rielabora i caratteri propri unendo le nuove conoscenze sul patrimonio morfologico e decorativo già presente nella maiolica arcaica. In questo modo si può, quindi, notare una lenta transizione tra l’una e l’altra classe, dove la nuova tecnica dell’ingobbio graffito si innesta su morfologie già in uso nella maiolica arcaica
15 Berti 2005.16 Giorgio, Trombetta 2011.17 Vedi paragrafi I.5 e I.6 in questo volume.18 Giorgio, Trombetta 2011, pp. 231-235.
tarda, della quale talvolta rielabora gli schemi decorativi quadripartiti19.
Ritengo quindi che i dati archeologici possano di-mostrare come risulti quantomeno poco realistica la spiegazione sinora data all’assenza della graffita a stecca nei rinvenimenti urbani quattrocenteschi: l’ipotesi pre-supporrebbe una fase iniziale di produzione di graffi-te a stecca volta non ad un mercato urbano, ma solo all’esportazione20. Per giustificare questa teoria in passa-to sono stati presentati i documenti tratti dal libro En-trata della Legathia datato al 1441-1443 dove si trovano i pagamenti in entrata ed uscita per le merci in transito a Pisa. In questo libro si vede come spesso il vasellame veniva venduto come “cotta” e direttamente imbarcato alla volta del Porto Pisano, cioè passando direttamente dalla bocca della fornace all’imbarcazione21.
Pur essendo presente in tale registro preziose infor-mazioni sulle ingenti quantità di prodotti che alcuni vasai (soprattutto tre) produssero ed esportarono (con medie di oltre 2.700 pezzi al mese per vasaio), i dati in esso contenuti non possono essere forzati per dimo-strare il precedente assunto. Infatti, ciò che possiamo evincere è l’enorme quantitativo di ceramiche che era possibile produrre ogni mese ad un singolo vasaio ed il fatto che l’intera infornata venisse venduta così come era infornata (quindi con manufatti che potevano o non potevano essere cotti nella maniera corretta), ma non chiarisce quali tipologie venivano esportate e se gli stessi oggetti esportati non erano immessi anche nel mercato locale. In più va detto che le “Entrate della Legathia” che si riferiscono a ceramiche sono relative nel 70% dei casi a soli tre ceramisti, quando i documenti ce ne atte-stano almeno 57 attivi a Pisa per quello stesso periodo.
Non escluderei quindi che alcuni, ma non tutti, i vasai potessero trovare economicamente vantaggiosa la vendita delle “cotte” direttamente per le esportazioni, ma non come unica fonte di reddito. Credo che sia più credibile che gli stessi manufatti prodotti in primis per il mercato locale, possano essere poi stati esportati, in quantità differenti a seconda degli interessi commerciali e del volume della produzione del singolo produttore. In quest’ottica l’assenza della graffita a stecca dai contesti pisani del XV secolo appare quindi facilmente spiegabile come una semplice assenza produttiva (non era prodotta e quindi non è presente nel sottosuolo nelle stratigrafie di
19 Giorgio, Trombetta 2011, pp. 235-238.20 Ancora recentemente essa è stata ripresa in Trombetta 2009, p.
12.21 Berti 2005, pp. 120-124; Berti, Renzi Rizzo 2000, pp. 136-
147.
16 17
questa fase e quindi non poteva essere esportata)22. Tale situazione si ribalta completamente durante il secolo suc-cessivo dove invece, sia i contesti d’uso, che i numerosi scarti di fornace, permettono di seguirne l’evoluzione e l’immissione sui mercati cittadini ed esteri.
Nel Quattrocento, quindi, le classi fabbricate dalle botteghe pisane sono la maiolica arcaica23 e, a partire dalla metà circa del secolo, la prima graffita a punta po-licroma.
I prodotti ceramici delle fabbriche pisane di XVI secolo
In base a quanto detto finora appare necessario com-prendere quali manufatti uscissero dalle botteghe dei vasai pisani nel corso del Cinquecento: in questa ma-niera sarà finalmente possibile rivedere il ritrovamento dell’ex Monastero delle Benedettine sotto una luce dif-ferente, al fine di comprenderlo e datarlo con maggiore correttezza.
Lo studio di alcuni contesti di scavo pisani editi nel 201124 aveva mostrato una tendenza comune, riscontra-bile anche in altri scavi urbani ed extra-urbani25. Come già detto nel paragrafo precedente, in nessuno di essi sono attestate graffite a stecca prima degli inizi del Cinque-cento ed in tutti la maiolica arcaica monocroma bianca, sopravvive sino alla seconda metà dello stesso secolo con quantità tali da poter ritenere che essa non sia semplice-mente residuale, come ritenuto in precedenza26.
È quindi evidente un attardamento produttivo dell’ultima maiolica arcaica sino alla fine del XVI secolo che viene confermato anche dai più recenti rinvenimen-ti di scarti di fornace.
22 Una prima veloce revisione sulle ceramiche pisane graffite a stec-ca presenti in contesti toscani ed extra-regionali (es. Sardegna) conferma l’introduzione della tecnica a Pisa a partire dall’inizio del XVI secolo e sembra confermarne un’esportazione sistema-tizzata solo dopo la metà del Cinquecento.
23 La maiolica arcaica, dopo un breve esperimento con la policro-mia in giallo, tende a perdere la decorazione e a limitare il pano-rama morfologico precedente.
24 Giorgio 2011a e Giorgio, Trombetta 2011: gli scavi ai qua-li si fa riferimento sono quelli di via Toselli (Ducci, Baldas-sarri, Gattiglia 2009), Piazza Consoli del Mare (Anichini, Gattiglia 2009; Gattiglia, Giorgio 2009), Museo Nazionale di San Matteo (Baldassarri 2007; Baldassarri et alii 2005), Piazza delle Vettovaglie (Alberti, Baldassarri 2004), Palazzo Scotto (Gattiglia, Milanese 2006).
25 Per i dati su Piazza dei Miracoli ed il monastero della Verruca si veda Alberti 2010.
26 I primi dati sulla cronologia dell’ultima maiolica arcaica sono in Giorgio 2009a e 2011a.
Gli scarti ceramici cinquecenteschi di Villa Quercio-li27 mostrano una produzione di maiolica arcaica atro-fizzata alla sola monocromia bianca e alla sola tipologia della ciotola emisferica, che continua ad essere fabbrica-ta in notevoli quantità sino al terzo quarto circa del XVI secolo28. Ad essa si affiancano la graffita a punta e, solo secondariamente, quella a stecca entrambe con morfo-logie che mostrano una transizione da forme medievali ad altre più nettamente rinascimentali molto più lenta di quanto pensato in precedenza29. Lo stesso abbassa-mento ed abbandono del piede ad anello si trascina lun-go tutto il secolo, seppure relegato al completamento esclusivo di catini e ciotole. È possibile, inoltre, datare alla prima metà del XVI secolo alcuni timidi esperi-menti in graffita a fondo ribassato, la cui produzione effettiva inizia solo attorno alla metà del 1500, ma con quantità nettamente minoritarie rispetto alle precedenti classi. Sino agli anni ’90 del ‘500 non è attestato alcun frammento di ingobbiata marmorizzata.
I primi dati che si possono ricavare dagli scarti di fornace di via Santa Apollonia, attualmente in corso di studio, confermano i precedenti e registrano un primo cambiamento nelle tipologie graffite solo nel passaggio al XVII secolo30 (fig. 1). Gli anni a cavallo tra Cinque e Seicento mostrano un primo graduale mutamento nelle forme e nei decori: le ciotole si schiacciano; i catini han-no vasche sempre più emisferiche con bordi ripiegati verso l’esterno; i piedi ad anello scompaiono in favore di quelli a disco e a ventosa; i decori delle graffite a stec-ca tendono a divenire leggermente più corsivi e meno accurati; le graffite a punta e a fondo ribassato iniziano ad utilizzare motivi araldici e con frutta e fiori centrali; si assiste ad un graduale aumento di contenitori ingob-biati monocromi e così via. L’introduzione dell’ultima tipologia ingobbiata, la marmorizzata, deve essere collo-cata dopo gli anni ’90 del Cinquecento e probabilmente nel primo decennio del Seicento, sulla scia di una moda
27 I primi dati sullo scavo nel giardino di Villa Quercioli sono in Giorgio 2011b e 2012c.
28 Vedi capitolo I.6 in questo volume.29 Giorgio, Trombetta 2011, p. 237.30 I primi dati sullo scavo nella canonica di via Santa Apollonia
sono in Andreazzoli, Baldassarri, Mirandola 2002. La ce-ramica è attualmente in corso di studio da parte di scrive per il dottorato di ricerca che si sta svolgendo presso l’Università di Pisa. Tale scavo va differenziato da quello eseguito lungo la stessa strada nel 1994 da personale del Laboratorio di Topografia della Scuola Normale Superiore (Corretti, Vaggioli 2003). Anche in quello scavo furono rinvenuti numerosi scarti di fornace che mostrano una sostanziale omogeneità con i contesti ceramici di Villa Quercioli e la canonica di Santa Apollonia.
16 17
decorativa scaturita dalla Controriforma che proprio in quegli anni troverà diffusione in molte arti decora-tive31.
Sulla base di quanto detto, e riprendendo in mano
31 I tempi della diffusione di questo gusto per le pietre dure e per l’effetto “marmorizzato” sono efficacemente riassunti in Moore Valeri 2005 e 2013. Fausto Berti data l’inizio della produzione marmorizzata a Montelupo fiorentino al 1540: a mio parere una cronologia di questo tipo risulta piuttosto precoce e poco proba-bile. Se davvero la produzione di marmorizzata iniziasse in tale momento, Montelupo f. sarebbe il primo e unico centro dove si produsse questa classe ceramica, e tutti gli altri curiosamente lo imiterebbero solo circa 50 anni dopo. Una cosa del genere ap-parirebbe quanto meno curiosa non solo in relazione a Pisa che ha un volume produttivo tanto grande e diversificato proprio in quegli anni, ma anche rispetto alla diffusione tanto rapida che la tecnica dell’ingobbiatura ebbe in questo periodo nei centri minori. Inoltre, la relazione evidenziata da Anna Morre Valeri tra la nascita delle ceramiche marmorizzate e la diffusione della marmorizzazione nelle arti decorative e nella legatoria italiana è una suggestione interessante ed efficace che non può essere facilmente messa da parte.
i dati editi da Graziella Berti nel 200032 per il recupero delle Benedettine, possiamo notare come esso abbia una composizione molto simile ai contesti Villa Quercioli e via Santa Apollonia: le maioliche arcaiche rappresenta-no circa il 70% dell’insieme dei manufatti recuperati e sono costituite quasi esclusivamente da ciotole mono-crome o in scarti di prima cottura33; le graffite a punta e a stecca si equivalgono e presentano le stesse morfo-logie di scodelle, catini e ciotole; non è presente alcuna graffita a fondo ribassato o ingobbiata marmorizzata34.
32 Berti, Renzi Rizzo 2000, pp. 127-131. In questo studio sono considerati i recuperi Be.I e Be.III: quest’ultimo effettuato in un’area diversa dagli operai che aprivano una trincea potrebbe essere di poco posteriore al primo.
33 Su 459 recipienti rinvenuti in Be.I solo nove sono relativi a boc-cali, da considerare forse come residui del ‘400.
34 Nella discussione dei dati presente in Berti, Renzi Rizzo 2000 sono elencati anche 6 recipienti ingobbiati monocromi e 23 contenitori a schizzi d’ingobbio dei quali non è specificato se relativi a Be.I o Be.III o rinvenuti in entrambi. Se i contenitori
Fig. 1. Catini ingobbiati e graffiti a stecca dallo scavo di via Sant’Apollonia del 2002, databili alla seconda metà del XVI secolo.
18 19
Il raffronto numerico e qualitativo permette, quindi, di osservare tale recupero con occhi differenti e di inqua-drarlo cronologicamente nel corso del XVI secolo. La notevole quantità di maiolica arcaica, fortemente supe-riore alle tipologie graffite, lascia supporre una maggiore anzianità del recupero rispetto a Santa Apollonia, ed il confronto con Villa Quercioli consente di inserirlo nel primo o secondo quarto del Cinquecento.
Una datazione di questo tipo è sicuramente più ri-spondente alle caratteristiche del contesto, se conside-rato come unitario, e non entra in conflitto né con le informazioni ricavate dalle fonti scritte né con i dati stratigrafici, con i quali risulterebbe perfettamente in linea.
Rivedendo i materiali editi dei vecchi recuperi di Lungarno Simonelli35 e dello scavo di Palazzo Vitelli36, si possono fare alcune considerazioni sulla base dei dati precedentemente illustrati.
Il recupero di Lungarno Simonelli comprende scarti di ingobbiate e graffite a punta, stecca e fondo ribassato. Già nel 1982 Graziella Berti e Ezio Tongiorgi notavano come “L’elemento di novità più significativo, di cui ci dà testimonianza la discarica di Lungarno Simonelli, è comunque rappresentato dalle forme nel loro quadro generale; in esse manca qualsiasi analogia con quelle della maiolica arcaica ed anche con quelle dello scarico dell’ex convento delle Benedettine”37. Questa conside-razione è di notevole importanza perché permette subi-to di differenziare tali oggetti come appartenenti ad una “evoluzione” della produzione e, nel confronto con le ceramiche delle Benedettine, offre spunti per un inqua-dramento cronologico posteriore. Anche il confronto con il vasellame degli scavi urbani permette effettiva-mente di cogliere delle differenze morfologiche e de-corative rispetto ai manufatti inquadrabili nella prima metà del Cinquecento, soprattutto per quel che riguar-da graffite a stecca e fondo ribassato che mostrano tipo-logie compatibili con l’ultimo quarto del XVI secolo.
Lo scavo di Palazzo Vitelli, effettuato tra la fine de-gli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 del secolo scorso, ha permesso di recuperare uno scarico di scarti di for-nace costituiti essenzialmente da graffite a stecca ed in maniera minoritaria da altre ingobbiate quali graffite a
a schizzi di ingobbio fossero relativi al solo Be.III, tale contesto potrebbe forse essere considerato di poco successivo al primo, in caso contrario entrambi i recuperi apparirebbero perfettamente coevi e similari.
35 Berti, Tongiorgi 1982; Berti 2005.36 Garzella, Redi 1980; Redi 1982.37 Berti, Tongiorgi 1982, p. 146.
punta, a fondo ribassato, ingobbiate monocrome e mar-morizzate38. L’insieme delle graffite a stecca39 è costitui-to da ciotole schiacciate ed emisferiche con piedi a disco o ventosa, catini emisferici con piede a disco o ad anello molto basso e scodelle apode con tesa lunga. Le tipologie decorative sono solo in parte associabili a quelle presenti attorno alla metà-terzo quarto del XVI secolo, mentre la maggior parte presenta decori meno ricchi che tendono a contrarsi sino alla semplice girandola centrale traccia-ta in maniera veloce ed allargata. Tali elementi, assieme alla presenza delle ingobbiate marmorizzate potrebbe far ipotizzare per tale scarico una datazione di poco suc-cessiva a quella di Lungarno Simonelli (fine XVI-metà circa del XVII secolo?).
Gli scavi pisani con scarti di fornace e scarti d’uso permettono quindi di confermare una prima fabbrica-zione di graffita a stecca a partire dagli inizi del Cinque-cento, alla quale, dopo alcune prime sperimentazioni, si affianca prima la graffita a fondo ribassato attorno agli anni centrali secolo, e dopo l’ingobbiata marmorizzata, a partire dagli anni finali del Cinquecento o i primissimi del Seicento.
Il riesame dei vecchi scarichi rinvenuti dai coniugi Tongiorgi, editi del tutto o in parte da Liana Tongiorgi e Graziella Berti nel corso degli anni, può attualmente es-sere rivisto alla luce dei nuovi dati stratigrafici preceden-temente citati. La crono-tipologia desumibile dagli scavi archeologici, quale ad esempio quelli di Villa Quercioli e via Sapienza, permette una prima risistemazione dei dati noti, che negli anni non avevano trovato una cor-retta collocazione cronologica e quindi un giusto signi-ficato all’interno della storia della ceramica pisana nel passaggio tra Tardomedioevo e prima Età Moderna.
In questo senso i recuperi dell’ex Convento delle Benedettine, di Lungarno Simonelli e Palazzo Vitelli possono ritenersi più recenti di quanto finora suppo-sto, componendo insieme agli scarti di Villa Quercioli, via Santa Apollonia e via Contessa Matilde40 una serie ininterrotta risultante dalla produzione che le fabbriche pisane effettuarono tra XVI e XVII secolo.
38 Purtroppo lo scavo non è stato mai edito completamente e su questo scarico esistono solo le poche notizie riportate in Redi 1982.
39 Delle due tesi che hanno studiato gli scarti di fornace, a tutt’oggi è consultabile presso la biblioteca di Filosofia e Storia dell’Uni-versità di Pisa solo quella sulla graffita a stecca della dott.ssa Del Chiaro (Del Chiaro 1984-85).
40 Lo scavo è attualmente inedito, ma una prima ricognizione presso i depositi della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana posti a Pisa ha potuto appurare una sostanziale omoge-neità degli scarti con Villa Quercioli e Santa Apollonia.
18 19
L’inizio della graffita a stecca al principio del XVI secolo come sintomo di ripresa produttiva
È opinione comune che l’esperimento della poli-cromia nella maiolica arcaica, così come l’introduzione della tecnica dell’ingobbio, possa essere il frutto di un tentativo di rinnovamento che le botteghe ceramiche pisane intentarono al fine di ridare vita alla secolare produzione smaltata ed invetriata che subiva, a partire dai primi decenni del Quattrocento, una forte concor-renza da parte del vasellame di Montelupo fiorentino. Quest’ultimo, introdotto in maniera massiccia a Pisa dopo la conquista fiorentina della città (1406), utiliz-zava schemi morfologici e decorativi nuovi, ispirati alle coeve maioliche di provenienza spagnola, con profusio-ni di colore su un corpo ceramico biancastro.
Se, quindi, può essere vero che si ebbe un “rinnovato impulso a specializzarsi nella fabbricazione di manufatti diversi da quelli prodotti in altri centri della regione”41, tale tentativo non ebbe una forza tale da impedire una contrazione della produzione ceramica.
Questa si può chiaramente leggere nei dati prove-nienti dalla documentazione scritta dove si può vedere come, a fronte di un numero di vasai che tende a cresce-re in maniera molto forte durante tutto il Trecento sino al secondo quarto del Quattrocento, durante la seconda metà del XV secolo è individuabile un’inversione di ten-denza con una riduzione dei ceramisti di rispetto al periodo precedente.
Se ancora nella prima metà del XV secolo Pisa attrae vasai dal contado, questo fenomeno si interrompe total-mente negli anni successivi, anzi già attorno agli anni ’20 dello stesso secolo si registrano le prime fuoriuscite di arti-giani (circa una decina) che si spostano verso Lucca, Savo-na e Faenza42. Tali partenze dovettero continuare durante tutto il secolo visto che si passò dai 66 vasai del primo quarto del Quattrocento sino a soli 18 nell’ultimo quarto.
L’annessione di Pisa allo stato fiorentino deve, quin-di, aver avuto una certa influenza negativa sulla fiorente attività delle botteghe pisane: si pensi al fenomeno di emigrazione che coinvolgerà in quegli anni soprattutto i ceti dirigenti, ma anche quelli artigianali, e al divieto di ingresso in città per gli abitanti del contado pisano43.
41 Trombetta 2009, pp. 7-8.42 Tongiorgi 1979, p. 19; Berti 1997, p. 266.43 Petralia 1991, p. 180: il timore di una sollevazione pisana
ossessionava Firenze e la misura del confino politico coinvolse centinaia di maschi adulti ed almeno un esponente di tutte le famiglie della tradizione politica comunale.
Si assiste, inoltre, ad un innalzamento della pressione fiscale che può aver favorito il declino di alcune mani-fatture e l’emigrazione dei suoi lavoratori. Non deve, infine, essere dimenticato che alcune delle fornaci cera-miche attive a Pisa tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo furono distrutte proprie dai fiorentini durante i primi periodi della dominazione su Pisa44.
La situazione politica ed economica incerta non sembra cambiare con l’avvento della Seconda Repubbli-ca Pisana: gli scontri con i Fiorentini possono aver reso il mercato cittadino instabile per coloro che possedeva-no o lavoravano presso alcune imprese artigianali, tanto da favorire un’ulteriore decrescita. Proprio tra l’ultimo quarto del ‘400 ed il primo quarto del ‘500 si osserva una nuova diminuzione nel numero dei vasai che pas-sano da 18 a 13.
Una prima timida inversione di tendenza è segna-labile nei primi tre decenni del Cinquecento, quando si registrano quattro nuovi ingressi di ceramisti a Pisa provenienti dal contado pisano e fiorentino: la rinnova-ta stabilità seguita alla riconquista fiorentina di Pisa può aver influito anche sulle attività artigianali cittadine che, dopo un periodo di crisi, ricominciano a veder crescere la produzione45.
Questa crescita trova riscontri materiali nella notevo-le quantità di rinvenimenti cittadini di ceramica in con-testi d’uso, ma soprattutto in quelli di scarti di fornace localizzati nel centro storico, soprattutto nella porzione nord-ovest (fig. 2). E forse è a questa fase che va ascritta la nascita della graffita a stecca a Pisa: l’unione di com-petenze vecchie e nuove, il nuovo avvento fiorentino ed il rinnovamento politico e culturale conseguente posso-no aver posto le basi per una rinascita della ceramica pi-sana che potrebbe essersi esplicitato anche con l’ingresso della graffitura a stecca tra le tipologie ingobbiate. Non si può, infatti, tralasciare il dato archeologico preceden-temente descritto che fissa proprio negli anni iniziali del Cinquecento le prime attestazioni di questi reperti.
44 Tongiorgi 1964. Inoltre, spesso le case e le botteghe rimaste vuote venivano abitate o messe a soqquadro dai soldati e poi distrutte o bruciate dagli stessi proprietari per liberarsi delle im-poste che gravavano su di esse (Casini 1965, p. 79)
45 Alla fine del conflitto con Firenze, Pisa è fortemente indeboli-ta sia economicamente che demograficamente (Mazzei 1991, p. 10). Una nuova crescita della popolazione pisana si avrà nei quattro decenni successivi alla riconquista fiorentina, arrivando a quasi 10.000 unità entro la metà del Cinquecento (Fasano Guarini 1991, p. 17). Questo incremento comportò un “mi-glioramento delle condizioni di vita, un’accelerazione delle atti-vità industriali e mercantili; una moltiplicazione delle possibilità di lavoro e di arricchimento.” (Fasano Guarini 1991, p. 17) tanto da far divenire Pisa nuovamente un polo attrattore.
20 21
La graffita a stecca segna quindi l’inizio di una ripre-sa per la manifattura ceramica pisana, che vedrà crescere il numero dei lavoratori per tutto il Cinquecento46. Sin-tomo di una nuova vitalità artistica, seppure rivolta a mercati di livello medio-basso, la produzione ceramica cinquecentesca comporterà la sperimentazione di nuove tipologie decorative nel corso degli anni, tramite una ricezione attenta e rapida dei cambiamenti tecnologici e di gusto che si innestarono nella mutata società me-dicea.
46 Vedi quanto scritto da Giuseppe Clemente in questo volume.
La collocazione delle fabbriche di ceramica nella Pisa del XVI secolo
A tutt’oggi non è possibile localizzare con certezza le fornaci da ceramica a Pisa, sia perché ancora poco si sa di questi impianti per il XVI secolo, sia perché non è stato possibile rinvenirne e scavarne una. Infatti, l’unica fornace individuata e scavata stratigraficamente è quella di via Sapienza (fig. 2, n.6), il cui impianto potrebbe essere cinquecentesco47 ma che i dati archeologici in nostro possesso riescono a datare solo per la fase seicen-tesca48.
Un contributo ci arriva ancora una volta dalle fon-ti documentarie che ci permettono di localizzare con buona approssimazione almeno altre tre fornaci nel corso del Cinquecento, di cui due sicuramente poste
47 Si veda il contributo di Daniela Stiaffini in questo volume.48 Si vedano i contributi di Antonio Alberti in questo volume.
Fig. 2. Collocazione delle fornaci (triangoli) e degli scarti ceramici di cottura (pallini) di XVI (pieni) e XVII (vuoti) secolo nel centro storico di Pisa.
20 21
a nord del fiume all’interno delle mura, nella zona est della città (fig.2, nn.15-16), un’altra invece situata nelle immediate vicinanze della cinta muraria e della Porta a Mare, nella cappella di San Paolo a Ripa d’Arno (a sud dell’Arno, nella parte ovest) (fig.2, n.19).
Per quest’ultima e per quella posta in via delle Con-cette, nei pressi della Porta a Piagge (fig.2, n.16), i do-cumenti ci riportano la localizzazione ed anche la pro-prietà, mentre quella posta nei pressi di piazza Mazzini (fig.2, n.15) è visibile solo in uno schizzo relativo alla localizzazione di altre proprietà poste nella stessa area49.
Le fornaci della zona nord-est risultano in contro-tendenza rispetto al quadro che era stato delineato in passato per i secoli antecedenti il XVI. Nel XV secolo è stato documentato, purtroppo attualmente ancora solo tramite le fonti scritte, uno spostamento delle manifat-ture ceramiche dalla zona di San Vito, a nord dell’Arno nella parte ovest della città, verso la parte sud-ovest della città fuori la Porta a Mare o nelle immediate vicinanze, nelle cappelle di San Paolo a Ripa d’Arno e San Giovan-ni al Gatano50. Proprio in quest’ultimo luogo si vanno a concentrare le fabbriche quattrocentesche, in una zona di poco fuori dalle mura della città, ma ad essa ben col-legata, posta lungo il fiume e le vie d’acqua che portano verso il mare.
Un posizionamento degli ateliers fuori della cinta muraria medievale nella parte più ad ovest della città ap-pariva come la normale conclusione di uno spostamen-to, iniziato nel Trecento, verso luoghi che garantivano spazi più ampi per le attività da compiere e che fossero ben collegati con le direttrici dei commerci marittimi. Senza dimenticare che alcune attività artigianali inizia-vano ad essere percepite come “malsane” e “pericolose” tanto da esserne sconsigliata la collocazione in zone for-temente urbanizzate.
Evidentemente la situazione è più complessa o co-munque leggermente diversa almeno per ciò che riguar-da il XVI secolo.
Se uniamo i dati archeologici alle prime rare infor-mazioni documentarie sulle fornaci possiamo subito notare come i numerosi rinvenimenti di scarti di forna-ce si vadano a collocare almeno in due zone ben distinte a nord del fiume: una prima tra via Santa Apollonia e Porta a Lucca che costituisce una direttrice nord-sud (fig. 2, nn.1-4), ed una seconda tra via dell’Ulivo e Lun-
49 Si veda la figura 7 del contributo di Giuseppe Clemente in que-sto volume.
50 Vedi quanto scritto da Giuseppe Clemente in questo volume con bibliografia ivi citata.
garno Simonelli (fig.2, nn. 7-9, 11-1251) che forma una linea est-ovest lungo l’Arno. Altri scarti fuori da questi areali più circoscritti sono stati rinvenuti sul lungarno Mediceo52 (fig.2, n.14) e attorno all’ex Convento delle Benedettine a San Paolo a Ripa d’Arno (fig.2, nn.18 e 20).
Grazie alla collaborazione del laboratorio MAPPA dell’Università di Pisa e all’aiuto di Gabriele Gattiglia, i dati sugli scarti sono stati uniti a quelli provenien-ti dall’indagine archivistica e interpolati con le aree a maggiore (in grigio chiaro) e minore urbanizzazione (in grigio più scuro: vanno considerate suburbane all’inter-no della città postmedievale) col fine di comprendere al meglio il potenziale informativo proveniente dalle varie tipologie di fonti (fig. 3). In bianco è l’area extraurba-na.
Alle zone con maggiore concentrazione di scarti (puntini neri) è stata fornita un’area di dispersione me-dia di 150 metri di raggio (areale degradante pixelato attorno ai punti neri), mentre le fornaci (i triangoli) sono stati mantenuti come dati puntuali. I ceramisti (cerchi) sono stati collocati sulla base della cappella di appartenenza, ma ad una maggiore concentrazione di attestazioni corrisponde un’areale più ampio.
La fonte documentaria mostra una concentrazione più alta di artigiani che risiedono presso le cappelle di San Giovanni al Gatano e di San Paolo a Ripa d’Arno (dove erano anche i luoghi di lavoro), come per il XV secolo, ma un numero altrettanto considerevole di cera-misti dimora, invece, tra le cappelle di San Niccolò, San Donato e San Giorgio in prossimità del Ponte Nuovo, nella parte occupata dagli scarti ceramici della direttrice est-ovest. Un altro gruppo considerevole di vasai, tutti però appartenenti allo stesso nucleo familiare53, è quella che si colloca nella cappella di San Pietro ad Ischia, nei pressi della direttrice di scarti nord-sud. Si evidenzia, quindi, come ad una maggiore concentrazione di vasai in alcune cappelle corrisponda una più alta densità scar-
51 I ritrovamenti nn. 8, 9 e 11 sono stati effettuati durante le assi-stenze archeologiche nei cantieri di Toscana Energia nel centro storico di Pisa (2012/2013): direzione scientifica della SBAT, funzionario archeologo per Pisa Andrea Camilli, assistenza sul cantiere di Antonio Alberti.
52 Il ritrovamento è stato effettuato durante le assistenze arche-ologiche nei cantieri di Toscana Energia nel centro storico di Pisa (2012/2013): Direzione scientifica della SBAT, funzionario archeologo per Pisa Andrea Camilli, assistenza sul cantiere di Antonio Alberti.
53 Si tratta dei ceramisti Payti o Paichi che potrebbero aver impian-tato in quella zona anche le fornaci da ceramica: se così fosse ad essi si potrebbero attribuire gli scarti ceramici di Villa Quercioli, editi in questo volume.
22 23
ti nella stessa area (si notino le sovrapposizioni tra gli areali pixelati e quelli in cerchi).
Sebbene non si possa dare per scontato che il luo-go di residenza fosse anche quello ove si collocavano gli impianti lavorativi, è anche vero che spesso poteva esse-re possibile, poiché almeno per il Medioevo l’artigiano tendeva ad abitare laddove esercitava la propria attività lavorativa54. Se così fosse stato ancora per il XVI secolo,
54 Renzi Rizzo 2004, p. 6. Tale considerazione è avvalorata dai dati di scavo, come ad esempio in Piazza Consoli del Mare dove sono stati scavati sia i luoghi di lavoro che la dimora dei fabbri del metallo (Gattiglia, Giorgio 2007).
sarebbe possibile mettere in relazione gli scarti ceramici rinvenuti in una data area di Pisa con una o più mani-fatture collocate nella stessa. Tale relazione è il risultato fornito dall’unione delle tre fonti (scarti, vasai, fornaci) sia nel caso della fornace posta a sud-ovest, prossima sia ad un’alta concentrazione di vasai che di scarti ceramici (quelli posti nei dintorni di San Paolo a Ripa d’Arno), sia per quella centro-orientale di Piazza Mazzini vicina sia agli scarti del Lungarno Mediceo che ai ceramisti residenti nella cappella di San Piero ai Sette Pini, che per quella centrale di via Sapienza55.
55 In quest’ultimo caso la fornace si sovrappone al vasaio residente
Fig. 3. Unione dei dati d’archivio (su ceramisti e fornaci) ai dati archeologici (sugli scarti ceramici) per il XVI secolo, interpolati con le aree della città a maggiore (grigio chiaro) e minore urbanizzazione (grigio scuro) col fine di comprendere al meglio il potenziale informativo
proveniente dalle varie tipologie di fonti (in bianco è l’area extraurbana).
22 23
Gli scarti ceramici si collocano in zone cittadine ad alta densità di ritrovamenti, tranne nel caso degli scarti occidentali di via Nicola Pisano e della fornace orientale di via delle Concette. Se i reperti di via Nicola Pisano però potrebbero entrare nell’area di afferenza delle con-centrazioni scarti/vasai posta nelle immediate vicinanze orientali, nel caso della fornace di via delle Concette la minore densità di ritrovamenti nella data area potrebbe spiegare l’assenza in quella zona di scarti attualmente conosciuti e riferibili al XVI secolo. Allo stesso modo, la carenza di citazioni di vasai nelle vicinanze della fornace può forse spiegarsi con un’analisi ancora non totalmente completa delle fonti archivistiche, soprattutto per l’ulti-mo quarto del Cinquecento.
Anche i vasai concentrati nelle cappelle di Santa Eu-frasia e San Iacopo agli Speronai si collocano in una zona ad alta densità di ritrovamenti archeologici urbani dove però non sono finora stati rinvenuti scarti di produzione o fornaci da ceramica: in questo caso le fonti archeo-logiche potrebbero essere ancora troppo poche e poco puntuali per poter collegare questi vasai ad una precisa manifattura oppure, avendo posizionato i ceramisti so-pra la cappella di afferenza, essi nella realtà possono aver risieduto nelle aree più marginali della cappella tali da poter associare questi operatori con limitrofe aree con scarti (es. l’area di San Pietro ad Ischia/via Santa Apol-lonia a nord e quella tra Santa Lucia e San Donato a sud-ovest).
Ad ogni modo, prendendo per buono questo assun-to, la dislocazione delle fornaci da ceramica nella Pisa del XVI secolo confermerebbe solo in parte un mante-nimento delle stesse nella zona di San Giovanni al Ga-tano e San Paolo a Ripa d’Arno, mentre mostrerebbe una dislocazione più centrale e settentrionale per alcune altre56 che vanno a raggrupparsi ad est ed ovest lungo il fiume Arno, nelle porzioni meno densamente urba-nizzate della città. Uscirebbe da questo schema solo il probabile impianto lungo via Santa Apollonia, che ri-sulterebbe posto a nord della città nelle vicinanze del fiume Auser.
Una collocazione centrale della fornace di via Sapien-za è quindi sicuramente “curiosa” in quest’epoca ma for-se non inusuale, come lascerebbero supporre i toponimi “via dei vagella”57 (parallela alla carraia di Sant’Andrea) e
in quell’area, al quale sappiamo dalle fonti che essa apparteneva. Inoltre sia la fornace che il vasaio rientrano nell’areale di disper-sione degli scarti ceramici rinvenuti nella stessa zona.
56 Che potremmo calcolare in numero di 5 o 6, almeno sulla base di quelle citate e sulle concentrazioni vasai/scarti.
57 ASF, Notarile antecosimiano, L 384, anni 1356-1359, c. 67 r.
“via delle fornaci” ancora presenti alla fine del seicento-inizi settecento tra San Pietro in Vincoli e San Paolo all’Orto58 e connessi anche con altre lavorazioni artigia-nali poste sempre in zone fortemente urbanizzate. Nel caso di via Sapienza la scelta di impiantare una fornace da ceramica in quel luogo forse può spiegarsi con la vici-nanza al fiume come via di comunicazione e di traspor-to per le materie prime necessarie alle lavorazioni, oltre che con le proprietà che il Bitozzi aveva acquisito nella stessa area59.
In generale, le aree di ubicazione delle fornaci sono poste ai confini delle zone urbanizzate o in aree netta-mente suburbane: sulla base dei dati provenienti dalla fornace della Sapienza, per le fornaci più centrali si po-trebbe ipotizzare che si tratti di piccoli impianti artigia-nali che quindi non necessitavano di grandi superfici ma che potevano sfruttare cortili interni e spazi esterni alle botteghe.
È quindi possibile che, a seguito delle distruzioni fio-rentine e al calo demografico60, l’area urbanizzata di Pisa (che possiamo immaginare in espansione sino alla fine del Trecento) si fosse contratta leggermente durante il Quattrocento, in maniera tale da giustificare un nuovo spostamento degli ateliers artigianali in spazi più centra-li ma non densamente abitati. Questo avrebbe permesso ai vasai di essere maggiormente vicini alle zone di mer-cato e di non allontanarsi eccessivamente dalle zone di approvvigionamento delle materie prime, concentrando ed incrementando la produzione nel rispetto dei mecca-nismi della “teoria del mercato denso”61.
L’approvvigionamento di argilla nel XVI secolo
Per quello che riguarda i luoghi di approvvigiona-mento dell’argilla, ad oggi restano valide le considera-zioni fatte negli anni precedenti, convalidate anche dal-le analisi archeometriche più recenti62, che prevedono l’utilizzo delle argille cavate presso gli argini dell’Arno. I documenti finora rinvenuti fanno riferimento a cavi di argilla nelle cappelle di San Marco, di San Giovanni al Gatano e San Michele degli Scalzi63 utilizzati essenzial-
58 Tongiorgi 1972, p. 126.59 Vedi quanto scritto da Daniela Stiaffini in questo volume.60 Vedi nota 45.61 Moretti 2013; Chen, Weisberger, Wong 2011.62 Vedi il contributo di Claudio Capelli in questo volume.63 Estimi delle cappelle di San Marco, San Giovanni al Gatano e
San Michele degli scalzi del 1559 e 1579-1580.
24 25
mente per la produzione di mattoni, ma che possiamo immaginare impiegati anche per la ceramica. Un cam-biamento nei luoghi di approvvigionamento potrebbe essere avvenuto dopo la metà del Cinquecento quando il governo mediceo vietò il prelievo dell’argilla sino a un miglio dalle mura della città, e dal centro urbano fino al mare64. A questo dato potrebbero raccordarsi alcuni dei risultati delle recenti analisi effettuate da Claudio Capelli sugli scarti ceramici di Villa Quercioli e via Sa-pienza che confermerebbero l’utilizzo di più terre, forse provenienti anche dalla piana del Serchio/Auser.
Questo divieto, volto a conservare e regimentare il tratto urbano dell’Arno, si spiega con una volontà di si-stemazione della rete fluviale granducale e coincide con un momento di ricrescita nel numero di vasai e mat-tonai. Questi ultimi, cavando argilla troppo vicini alla città, potevano influire negativamente sul volume di ac-qua trasportata dal fiume i cui argini, forse indeboliti da secoli di escavazione, potrebbero aver necessitato di una particolare attenzione. Il divieto, che rende “intoccabi-le” la piana verso il mare, può aver determinato non solo la concentrazione dei mattonai nelle porzioni orientali ed esterne della città, nelle cappelle di San Marco e San Michele agli Scalzi, ma anche la collocazione urbana delle botteghe della ceramica: si pensi ad esempio alle fornaci cinquecentesche di Piazza Mazzini e via delle Concette e, più recentemente, alla posizione delle for-naci sette-ottocentesche, tutte localizzate attorno alla Porta a Piagge o poco più lontane al suo esterno.
Nello specifico, la collocazione di alcuni ateliers di ceramica nell’area orientale di Pisa, ed una possibile nuova “urbanizzazione” di alcuni altri nelle aree nord-occidentali può forse mettersi in relazione con un avvi-cinamento delle manifatture ai mutati luoghi di approv-vigionamento ma anche ai luoghi di vendita urbani.
Il volume degli scarti di produzione ceramica nel XVI secolo come indice di crisi economica?
L’insieme considerevole degli scarti databili nel cor-so del Cinquecento non trova riscontro né nei ritrova-menti relativi ai secoli precedenti né in quelli del secolo successivo (solo tre recuperi di scarti attualmente sono attribuibili al XVII secolo, fig. 2, nn. 5, 10, 13).
Tralasciando momentaneamente il Seicento e con-
64 Berti 2005, p. 143. Nel 1576 i fornaciai di mattoni di San Mar-co chiedono che gli venga concesso di cavare argilla entro un miglio dalla città, in eccezione di quanto previsto dalla legge.
centrandoci sul periodo precedente al XVI secolo, si può supporre, sulla base della maggiore concentrazione di vasai e botteghe e delle stime provenienti dalle “Entrate della Legathia” degli anni ’40 del Quattrocento65, che il volume produttivo complessivo delle fornaci pisane di XIII-XV secolo fosse molto alto. A fronte di questa pro-duzione, che si configura come estremamente intensa, il ritrovamento in città di scarti ceramici cittadini relativi ai secoli XIII-XV è poco significativa e numericamente scarsa66.
Che le fornaci cittadine producessero un certo nu-mero di prodotti malcotti è dato confermato sia dal-le fonti materiali che scritte. Nel primo caso vanno annoverati gli scarti ceramici duecenteschi rinvenuti a Piombino nella copertura delle volte della chiesa di Sant’Antimo67: in questo caso gli scarti, sicuramente pi-sani (maiolica arcaica, invetriate e prive di rivestimento depurate) erano stati commercializzati al di fuori della città marinara ed utilizzati per il riempimento del tetto dell’edificio ecclesiastico. Nel secondo caso, si parla di scarti nell’accordo corporativo del 1419 che ci informa della presenza di essi nelle botteghe dei vasai e che, tra le tante informazioni contenute nel documento, ci mette al corrente delle norme che ne regolavano la vendita68.
Entrambe le fonti, quindi, documentano un com-mercio degli scarti ceramici che sembrerebbe far fuoriu-scire gli stessi dai confini cittadini in maniera piuttosto consistente.
Tale situazione appare ribaltata nel Cinquecento quando non si conoscono leggi che ne regolano la ven-dita69 e il numero totale dei ritrovamenti di scarti cera-mici aumenta tanto da rappresentare il 70% dei ritrova-menti totali documentati per i secoli XIII-XVII.
In oltre il 90% dei casi questi scarti sono serviti per rialzare i piani di calpestio sia all’interno di private abi-tazioni, che in esterno per creare una nuova base dove stendere i nuovi piani stradali. Gli scarti rinvenuti presso Lungarno Mediceo (fig.2, n.14), via Santa Maria (fig.2, nn. 8-9), via Trento (fig.2, n.11), Lungarno Simonelli (fig.2, n.12) sono tutti databili tra il terzo e l’ultimo
65 Vedi paragrafi iniziali.66 I rinvenimenti di scarti precedenti il XVI secolo si concentrano
nelle aree di Tegularia e Baractularia, ad ovest ed est della città, nelle zone storicamente ricordate per la produzione di ceramica, ma si tratta di non più di 5 o 6 recuperi in tutto che coprono i secoli dal XIII alla metà circa del XV.
67 Berti, Bianchi 2007.68 Fanucci Lovitich, Virgili 1984.69 Ma su questo attualmente può influire la ancora troppo scarsa
conoscenza delle fonti scritte dell’epoca su tale tematica.
24 25
quarto del XVI secolo e furono utilizzati per rialzare i piani pavimentali stradali di circa 50-60 cm. Questo dato trova una conferma nella notizia storica che fissa all’agosto 1577 il rialzamento delle sponde del fiume almeno dal Ponte della Fortezza sino al Ponte Vecchio (degli altri argini attualmente non sia hanno notizie, ma potrebbero aver subito gli stessi lavori, come risultereb-be dai dati archeologici)70.
Fino al secolo precedente tali rialzamenti pavimenta-li erano fatti con sabbia purissima sulla quale venivano posti i laterizi in piano o di taglio o, per le strade nei secoli precedenti, gli acciottolati e lastricati. Dal XVI secolo in poi la tipologia di strade che caratterizzerà il postmedioevo pisano sino al tardo ottocento sarà carat-terizzata da sottili battuti composti da ceramica e laterizi sbriciolati (che doneranno alla via un aspetto rossiccio) su un piano di malta di un paio di centimetri71.
L’aspetto più modesto di queste strade può essere il risultato di un impoverimento cittadino generale, in linea con la realtà politica ed economica della Pisa cinquecentesca che, seppure interessata dalle politiche medicee che ne faranno la seconda città di Stato, fatica a rimettersi in piedi.
In quest’ottica un materiale come la sabbia poteva risultare costoso, soprattutto da quando fu posto in vi-gore il divieto di cavare vicino alla città. Gli scarti, quin-di, abbondanti e disponibili, potrebbero essere stati un modo economico per poter completare i notevoli rial-zamenti con un materiale altamente drenante. In questa maniera si potrebbe spiegare l’abbondanza di ritrova-menti per tale secolo e comprendere il motivo per cui essi non fuoriuscivano dall’ambito cittadino.
70 ASP, Fiumi e Fossi, filza 69, carta 666 r.71 Durante le assistenze archeologiche, che chi scrive (in collabora-
zione con Monica Baldassarri e Giuseppe Clemente) ha effettua-to nel corso del 2011 nell’ambito del progetto “Riqualificazione Area Piazza delle Vettovaglie - Pisa”, è stato possibile documen-tare numerosi lacerti di questi battuti stradali su un’area compre-sa tra Via del Castelletto/Vicolo del Tidi sino a Piazza S. Gior-gio/via l’Arancio/via S. Simone. I ritrovamenti (ancora inediti) hanno permesso di comprendere come essi avessero vita piutto-sto breve e venissero continuamente ripristinati con rialzamenti anche solo di 5 cm.