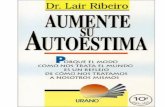Su un'inedita Favola di Orfeo del Cinquecento
Transcript of Su un'inedita Favola di Orfeo del Cinquecento
41
Cadm
o
Sped
izio
ne in
abb
onam
ento
pos
tale
50%
issn 1121-0621 isbn 978-88-7923-397-2 € 27,00
STU
DI
ITALIANI
41
STUDI ITALIANI
«Studi italiani»Semestrale internazionale di letteratura italiana diretto da
Riccardo Bruscagli, Giuseppe Nicoletti, Gino Tellini
anno XXI, fascicolo 1, gennaio-giugno 2009
S O M M A R I O
scrittoioFranca Strologo, I volti di Ferraù: riprese e variazioni fra la «Spagna in rima» e
l’«Innamoramento de Orlando» ..............................................................................................................Marco Villoresi, In lode dell’ icona. Su alcuni componimenti poetici di – e attribuibi-
li a – Castellano Castellani (1461-1519) .............................................................................................David Quint, Armi e nobiltà: Machiavelli, Guicciardini e le aristocrazie cittadine .........Luigi Blasucci, Per un commento a «La sera del dì di festa» .......................................................Philippe Simon, Rome vue par Aldo Palazzeschi dans «Roma» (1953) ....................................
archivioPierandrea De Lorenzo, Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento ...................Angelo Fabrizi, «Scontento» e «solitudine»: quattro lettere di Oriana Fallaci ....................
rubricaLaura Riccò, «Su le carte e fra le scene». Teatro in forma di libro nel Cinquecento ita-
liano, Roma, Bulzoni, 2008 (Fabio Bertini) ......................................................................................Carlo Goldoni, Memorie italiane. Prefazioni e polemiche. iii, a cura di Roberta
Turchi, Venezia, Marsilio, 2008 (Elisabetta De Troja) ..................................................................Lettere da due mari; Visita ai vinti; Pezzi di mondo, a cura di Simona Cigliana, Palermo,
L’Epos, 2008 (Jacqueline Spaccini) ........................................................................................................Antonio Saccone, «Qui vive | sepolto | un poeta». Pirandello Palazzeschi Ungaretti
Marinetti e altri, Napoli, Liguori, 2008 (Giorgina Colli) ...........................................................Valeria Della Valle – Giuseppe Patota, L’ italiano. Biografia di una lingua,
Milano, Sperling & Kupfer, 2006 (Guido Pugliese) ......................................................................
schedarioIl libro illustrato a Bologna nel Settecento (Angelo Fabrizi); Il tempo e la poesia. Un quadro novecentesco (Giuseppe Nicoletti)
informaticaIl progetto «Archivi di personalità. Censimento dei fondi toscani tra ’800 e ’900» all’ interno del «Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche» (SIUSA) (Simone Magherini)
collaboratori
Pag. 5
» 29 » 53 » 75 » 95
» 111 » 129
» 143
» 148
» 152
» 155
» 158
111
Pierandrea De Lorenzo
SU UN’INEDITA «FAVOLA DI ORFEO» DEL CINQUECENTO
Sfogliando i cataloghi delle cinquecentine italiane, non è raro imbattersi in testi di carattere letterario che furono stampati in un numero davvero esiguo di copie, per di più tutte in un’unica impressione: testi, quindi, che difficilmente hanno conosciuto un’ampia diffusione e che per diverse ragioni sono stati dimenticati, non più letti per secoli. Spesso si tratta di tutti quegli scritti cui esponenti della borghesia colta si sono dedicati per diletto, quasi per un dovuto esercizio letterario.
È questo il caso dell’opera presa in esame in questa sede, un poemetto intitolato La favola di Orfeo, scritto da Salvatore Massonio, medico, storico e poeta aquilano nato nel capoluogo abruzzese nel 1559 e morto a Napoli nel 16291.
Massonio aveva già composto una rappresentazione sacra in versi sciolti, La gloria di Susanna, dramma sicuramente recitato nella chiesa di Santa Maria di Piacenza nel 1582, e La Filenia2, commedia in tre atti rappresentata
1 Per tracciarne un quadro biografico esaustivo è indispensabile un confronto diretto di più fonti; risulta sempre utile il lavoro di L. Ferrari, Onomasticon: repertorio bibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850, Milano, Hoepli, 1943, tuttavia i testi di rimando non appaiono tutti affidabili: lo studio di M. Maylender, Storia delle Accademia d’Italia, Bologna, Forni, 19812, importante per in-quadrare storicamente e contestualmente i singoli autori, non fornisce indicazioni specifiche sulla vita del Massonio, così come il volume di N. Toppi, Biblioteca napoletana et apparato a gli uomini illustri in lettere di Napoli, e del Regno delle famiglie, terre, città e religioni, che sono nello stesso Regno: dalle loro origini, per tutto l’anno 1678, Napoli, Antonio Bulifon, 1678, riporta pochi cenni biografici e un catalogo delle opere certamente incompleto; più convincenti, invece, gli studi di F. Soria, Memorie storico-critiche degli storici napoletani, Napoli, Stamperia Simoniaca, 1781 (cfr. pp. 401-402) che pure difetta di completezza nel catalogo delle opere, e soprattutto A. Dragonetti, Le vite degli illustri aquilani, Bologna, Forni, 19702 (cfr. pp. 153-159), che fornisce una scheda bio-bibliografica esauriente. L’unico studio recente sulla vita e la personalità del Massonio è stato condotto da Raffaele Colapietra nel suo volume a commento del Dialogo dell’origine della città dell’Aquila, allegato in copia anastatica (stampato in un numero limitato di esemplari fuori commercio a cura delle edizioni Fotogramma di Roma in Cittadella nel 2002); Colapietra, in questa Introduzione, è attento a fornire precise indica-zioni di carattere storico, affrontando anche temi culturali contestuali alla figura del nostro autore.
2 A commento di questa commedia il Dragonetti scriverà: «Vi si trovano molte cose lodevoli ed i caratteri non sono mal tratteggiati. Ricordiamo ancora con piacere che il decoro e l’onestà non vi sono tenute in così vil conto, come in altre di quel secolo» (Le vite, cit., p. 157).
Pierandrea De Lorenzo
112
dagli Accademici Fortunati3 durante il carnevale del 1582, quando diede alle stampe il suo breve poema di argomento mitologico, nato sotto gli auspici delle due nobili famiglie romane patrocinanti (erano i Conti e i Cesi)4 e probabilmente come puro esercizio accademico; più tardi comporrà la sua opera più celebre, il Dialogo dell’origine della città dell’Aquila (nel 1594)5, poi la corona di tredici sonetti alla Vergine, altri sonetti in morte di Filippo II e le interessanti Rime6 inedite.
L’Orfeo, poemetto in ottave pubblicato nel 1582 e mai più edito7, che svi-luppa un tema mitologico particolarmente caro agli umanisti, ha attirato la mia attenzione per la sua data di composizione: siamo sul finire del Cinque-cento, un secolo in cui la mitologia di ascendenza ovidiana (ricordiamo che è soprattutto attraverso Ovidio che nella seconda metà del secolo si rilegge il mito)8 ha ormai attraversato con forza molti generi e sembra aver esaurito in qualche modo la sua vivacità, ancor di più se si pensa alle scritture teatrali e,
3 Massonio fece dapprima parte dell’aquilana Accademia dei Fortunati, spentasi verso la fine del Cinquecento e, successivamente, dell’Accademia dei Velati, di forte ispirazione gesuitica (fondata dal Rettore del Collegio dei Gesuiti nel 1599), che di fatto fu una restaurazione, in chiave più rigorosa-mente osservante, della vecchia Accademia dei Fortunati; Massonio era noto col nome “Avviluppato” (cfr. M. Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, cit., v, pp. 431-432).
4 Proprio la stessa Favola di Orfeo è dedicata al sig. Camillo Conti; il Dragonetti riferisce che «il Massonio compose questo poemetto in età assai giovanile per piacere al Duca Cesi suo proteggitore» (Le vite, cit., p. 157).
5 La prima stesura manoscritta del Dialogo, con dedica al cardinale Scipione Gonzaga, risale al 1589, ed è conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli insieme con le rime «composte ne gli anni de la sua gioventù per fuggir l’otio e la molestia de’ tempi» (la citazione è in R. Colapietra, Introduzione, cit. p. 9) e con un «umanissimo Miracoloso Natale di Gesù Cristo figliol di Dio a sfondo pastorale non meno che austeramente religioso» (ibidem).
6 La Corona di sonetti alla Sacralissima Regina del mondo fu stampata nel 1597; la Corona di sonetti in morte di Filippo II di Austria Re di Spagna fu impressa diversi anni dopo la stesura, nel 1601. Ben più interessanti le Rime, pubblicate a Vicenza nel 1604 e nuovamente nel 1627.
7 Si riporta l’esatta descrizione del frontespizio: la favola | d’orfeo, | fatta in ottava | rima, | Da messer Saluatore Massonio | Aquilano, | Detto L’Incostante Fortunato. | [fregio xilografico: aquila sormontata da una corona] | nell’aquila, | [linea tipografica] | Appresso Giorgio Dagano Savoiano, | Et compagni. M.D.LXXXII.; vogliamo dar fede, di fatto, alla data di stampa incisa sul frontespizio, per quanto il Colapietra faccia risalire l’impressione di questo testo al 1585 (cfr. Introduzione, cit., p. 7) riportando sostanzialmente, anche per le altre opere del Massonio, tutte le date già indicate dal Dragonetti (cfr. Le vite, cit., p. 157), non motivando, tuttavia, la ragione di questa differenza tra la data segnalata nel frontespizio e quelle addotta; poiché si tratta verosimilmente un testo prodotto in una sola edizione e in un’unica impressione tipografica (almeno è quello che si può addurre allo stato attuale delle ricerche) la possibilità di un confronto del mio esemplare di riferimento (conservato presso la Biblioteca Augusta di Perugia) con altri esemplari, peraltro assai rari, alla ricerca di eventuali correzioni di stampa, potrebbe non condurre ad alcuna delucidazione; si aggiunga, ancora, che in calce alla dedicatoria, a firma di Pompeo Struzzo, è riportata la data 28 Agosto 1582, stesso anno indicato nel frontespizio, e la numerazione delle pagine prosegue regolarmente in forma sequenziale.
8 Si legga su questo tema la stimolante relazione tenuta da Ettore Paratore al convegno dell’Acca-demia dei Lincei su «Manierismo, Barocco e Rococò», che ebbe luogo nel 1960, dal titolo «L’influenza della letteratura latina da Ovidio ad Apuleio nell’età del manierismo e del barocco», pubblicata in E. Paratore, Antico e nuovo, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia editore, 1965, pp. 243-355.
Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento
113
in senso più ampio, rappresentative9. L’interrogativo dello studio sarà allora questo: il mito, questo mito, poteva ancora servire da fonte cui attingere per creare del nuovo, oppure non poteva essere altro che pretesto per stanchi esercizi di scrittura di maniera?
Proviamo anzitutto a leggere questo poema, certamente non di rilievo assoluto quanto a valore letterario, ma che riserva dei tratti di interesse e che, forse, ci può fornire un valido esempio di scrittura su cui riflettere per ricavare considerazioni di respiro un po’ più ampio10.
Massonio si rapporta al mito classico con lo sforzo evidente di ritrovare dettagli da inserire in un tessuto narrativo che mira alla veridicità e alla ricchezza dei personaggi e dell’intreccio, pur nel calco di una storia, a tratti scopertamente virgiliana, che è ben riconoscibile nelle fonti classiche: un ossequio, quindi, alla tradizione umanistica di impronta polizianea, che vedeva nel sapiente incastro delle due fonti classiche maggiori, Ovidio e Vir-gilio, la realizzazione narrativa del mito11. È indubbio, infatti, che sul fronte della produzione pastorale, la lezione del Poliziano domina senza contrasto su tutta la tradizione mitologico-bucolica umanistica. Non sono pochi, tut-tavia, gli elementi nuovi che Massonio utilizza nella costruzione diegetica della sua favola Favola: Orfeo evocato come argonauta, anzitutto12, che apre il racconto lamentando dolori passati e godendo del presente lontano dalle insidie di Venere e Marte:
Or, dicendo, potrò goder quest’ombre,che diede il Cielo a sì felice parte,non temendo già mai ch’il cor m’ingombred’Amor il dardo, o ’l gran furor di Marte;restinsi pur a dietro i mostri, e l’ombre,il cui valor mi feo seguir già l’artedi Circe, fin che nova fiamma il coremi nudrì per Amilla13 in caldo umore.
9 Cfr. N. Pirrotta, Li due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, Torino, Einaudi, 1975.10 Un poemetto che, tuttavia, meritò le lodi del noto umanista sulmonese Ercole Ciofani, il quale,
per elogiare il “nascente poeta”, scrisse i seguenti versi: «Massonium vatem nigri qui regia adivit | tecta Dei, magno concinit ingenio: | Gratum opus hoc cunctis: at multo gratior illi | Cui tributi nomeen Caesia progenies» (come riportato da A. Dragonetti, Le vite, cit., p. 157).
11 Appare d’obbligo la lettura dell’ormai classico Ch. Segal, Orpheus. The myth of the Poet, Bal-timore, Johns Hopkins Univ. Press, 1989 (tradotto da Daniele Morante e pubblicato in Italia da Einaudi nel 1995).
12 Su questo tema cfr. i saggi di G. Iacobacci, Orfeo argonauta. Apollonio Rodio 1, 495-511, e di R. Luiselli, Contributo all’ interpretazione delle «Argonautiche orfiche»: studio sul proemio, nell’opera collettiva Orfeo e l’orfismo, Atti del Seminario Nazionale (Roma-Perugia 1985-1991), a cura di A. Masaracchia, Roma, gei, 1993, rispettivamente alle pp. 77-92 e 265-307.
13 Più precisamente si legge: A milla, una formula sintagmatica non convincente, peraltro priva di senso, e con un uso improprio della maiuscola; le ipotesi correttive e interpretative possono essere so-
Pierandrea De Lorenzo
114
Strinsemi di costei già un tempo il laccio,or da quel me ne vo libero, e sciolto,che posto a dietro ogni amoroso impaccio,in più novo desio mi trovo involto,anzi quanto di lei già dissi, taccio,e lascio l’amor suo noioso, e stoltoatto a turbarmi un stato sì felice,da cui perpetuo ben mi si predice.(ix-x, vv. 65-80)
Orfeo si presenta tuttavia come un amante deluso, nelle vesti ormai più che tradizionali di un pastore che rifugge l’amore: aspetto abbastanza pre-vedibile, se consideriamo il pesante lascito di tutte le esperienze di scrittura cinquecentesche che hanno reso ninfe e pastori perennemente inclini ai lamenti d’amore14; ma in questa prima sezione narrativa lo spazio riservato al pianto è solo allusivo: pochi versi per ricordare un Orfeo che ha un vissuto, doloroso sì ma anche maturo ed eroico, pieno di misteriosi tormenti d’amore. Il tanto emulato Seneca, certamente, non può non aver offerto un valido richiamo a questo tratto del mito15: nella Medea dava di Orfeo l’immagine di salvatore prima ancora che poeta16, e lo stesso mito guadagna ampio spazio anche nelle due tragedie intitolate ad Ercole17; tuttavia, nel corso del
stanzialmente due: a) che il riferimento sia ad A[r]milla, personaggio della pastorale cinque-secentesca evidentemente assai noto a giudicare dalle attestazioni, a cominciare dal Pastor fido del Guarini, che ri-cordiamo in quegli anni era già ben noto e circolava abbondantemente in forme manoscritte (cfr. l’in-troduzione all’edizione curata da Elisabetta Selmi, Venezia, Marsilio, 1999), pensiamo poi alle diverse canzoni e madrigali tardocinquecenteschi e secenteschi che narrano le vicende di questa ninfa (come il Floriano e Armilla del 1593, La pastorella Armilla di Giuseppe Olivieri del 1620, Il Dialogo Amaranta Clori Armilla di Giuseppe Cenci; in più compare nei madrigali di Falconieri, di Garzi, di Barbarino, di Boschetti, tutti composti nei primi decenni del Seicento), ai Sonetti e madrigali di Scipione Errico, e soprattutto all’idillio pastorale di Leandro Mieri, L’Armilla, (1614); potrebbe quindi trattarsi di un refuso avvenuto in fase di impressione; b) che la forma corretta sia a Milla: in questo caso il riferimen-to, certamente più convincente, sarebbe alla ninfa Milla che pure compare in molti testi più o meno coevi come ammaliatrice di estrema bellezza e virtù (non per ultimo citata da Berardino Rota nelle Pescatorie), tuttavia l’impianto sintattico non giustifica la presenza di a anteposta al nome, quindi si tratta di un’ipotesi da accettare solo se si ammettono due errori simultanei di composizione.
14 A tal proposito è sempre utile, per la mole di informazioni offerte, il classico E. Carrara, La poesia pastorale, Milano, Vallardi, 1904.
15 Cfr. A. Borgo, (Pseudo) Virgilio e (Pseudo) Seneca tra poesia e magia: il mito di Orfeo, nell’opera collettiva Miscellanea di studi in onore di Armando Salvatore, a cura di E. Flores, A.V. Nazzaro, L. Nicastri, G. Polara, Napoli, Pubblicazioni del Dipartimento di Filologia Classica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 1992, pp. 79-88, e ancora L. Landolfi, La sirena ammaliata e gli «ady-nata» di Orfeo (per l’ interpretazione di Sen. Med. 355-360), nell’opera collettiva Scritti a margine di letteratura e teatro antichi. Lo sperimentalismo di Seneca, a cura di G. Petrone, Palermo, Università di Palermo. Istituto di Filologia latina G. Monaco, 1999, pp. 49-76.
16 Alla presenza di Orfeo argonauta Seneca, nella Medea, dà particolare rilievo: dai brevi richiami dei vv. 228 sgg. ai versi 357 segg. sino alla completa caratterizzazione dei versi 625 sgg.
17 Nell’Hercules furens ad Orfeo sono dedicati ventitré versi (da 569 a 591); nell’Hercules Oetaeus ben sessantadue (da 1031 a 1094), come sottolinea Antonella Borgo nella sua disamina che pone a
Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento
115
secolo, è Luigi Tansillo del Canzoniere, probabilmente già noto al Massonio e più volte assunto a modello18, che ci riporta alla memoria, in una lunga digressione, un Orfeo che è stato soprattutto l’aedo consolatore, e lo fa pro-prio rievocando in terzine le stesse parole che il cantore rivolse ai compagni stremati dalle pene d’amore19.
Ma qui Orfeo di eroico non ha più nulla: indeciso, sofferente, umano tra le divinità, persino rabbioso di fronte al nuovo sentimento imperante, soffre e dispera per la perdita del suo stato di quiete e di felicità20:
Tosto si sveglia Orfeo tutto orgoglioso,e gira gli occhi in questa parte, e in quellané ha pur sol un momento di riposo,e traditor, qualunche vede, appella,che quanto prima fu lieto, e gioioso,tanto Fortuna a lui fassi or ribella;e s’ebbe di pensier già voto il petto,d’un più forte, e più grave or gli è ricetto.[…]Stassi non altrimente Orfeo davantea le timide Ninfe, che star suoleun superbo destrier, ch’alza le piante,e con sdegno, e furor le mostra al sole,mentre ripugna tante volte, e tantené sotto porre al suo Signor si vole,e poi convien che tutto umil consenta,e l’intera sua rabbia, al fin sia spenta.(lii, vv. 409-416; liv, vv. 425-432)
confronto proprio queste sezioni, dal titolo (Pseudo) Virgilio e (Pseudo) Seneca tra poesia e magia, saggio già citato.
18 È lecito supporre che il gusto petrarchesco che caratterizza la produzione poetica del Massonio (cfr. R. Colapietra, Introduzione, cit., p. 10), sia filtrato da esperienze liriche più vicine al suo am-biente di formazione, come ad esempio quelle degli stessi Luigi Tansillo e Berardino Rota; questo resta un aspetto, tuttavia, ancora da valutare attraverso un esame puntuale delle sue Rime.
19 Si legge nel Canzoniere: «Ma il buon Orfeo, che col medesimo legno, | arava il mar, così li conso-lava, | al suon cantando del suo curvo legno. | E l’aure e i pesci, mentre ch’ei cantava, | correan dietro a la poppa per udire, | e l’onda sotto i remi si corcava. | – Spirti illustri (dicea), che per desire | di nova gloria andate per vie nove | a tentar nove sorte di morire, | ite sicuri alle animose prove: […] Daran ricca vittoria brevi affanni: | sarete salvi al patrio suol ridutti; | e vivrete di fama a par con gli anni. | E s’alcun v’è tra voi (ma io credo tutti), | che sia prigion d’amor, deh, non si doglia: | ché tosto in riso cangerà suoi lutti!| Per lungo andar non tema, che si scioglia | dal petto di sua donna il dolce nodo: | Piuttosto volto cangerà, che voglia.–» (Capitolo iii, vv. 43-66; l’edizione di riferimento è L. Tansillo, Il canzoniere edito ed inedito: secondo una copia dell’autografo ed altri manoscritti e stampe, a cura di Erasmo Percopo, Napoli, Liguori, 1996; cito dal vol. i, pp. 102-103).
20 Aspetti caratterizzanti, questi, che saranno propri di Orfeo personaggio melodrammatico ba-rocco (si pensi, ad esempio, alla Morte di Orfeo di Stefano Landi o soprattutto all’Orfeo di Aurelio Aureli messo in scena da Sartorio, in cui la storia di Orfeo tende verso un progressivo e inesorabile distacco dalle fonti classiche del mito).
Pierandrea De Lorenzo
116
Euridice, di contro, è presentata quasi come una dea sopraffatta dalla voce di un misterioso cantore, al cui cospetto appaiono due ninfe fedeli, Clori e Clite (Clori stesso, principio dell’atto amoroso – di suggestione botticelliana – non a caso nella stilizzazione mitologica accompagna una dea); l’ingresso di Euridice sulla scena narrativa, immersa in un’aura di soavità bucolica e quasi trasfigurata in icona figurativa, è un elemento importante che ritroveremo in opere successive che hanno goduto di assai più ampi consensi21. Le divinità, quelle vere, non mancano: Flora, Diana, e soprattutto Amore, vero artefice dell’inganno amoroso, che muove incuriosito il destino dei due amanti. Il narratore, onnisciente osservatore delle vicende che racconta (ma che cede spesso la parola agli stessi personaggi), è più volte presente con pensieri moraleggianti, tanto che, a tratti, si potrebbe leggere una scoperta intenzione gnomica, espressa il più delle volte attraverso formule convenzionali:
Abi del viver uman caduco, e fralelieve, dice, al fuggir misera etade,che mentre pensa in alto spiegar l’ale,nel più bel fior de gli anni in terra cade,e se lunge talor esser del maleveder li par, (che spesso volte accade)s’accorge al fin che sottoposta siedepiù al mal celato assai, ch’al ben che vede.(cii, vv. 809-816)
e coglie tutta l’infelicità che si nasconde dietro questo innamoramento che sembra non aver nulla di soave:
E di timore, e di speranza armati ambe di libertà restan privati.(lvii, vv. 455-456)
Tuttavia, quando Orfeo incontra Euridice, tutto cambia: l’amore, pur indotto per sortilegio, sembra diventare autentico sentimento e si innesca il tradizionale registro amoroso di reminescenza tassiana:
«Ecco te sol dolce mia vita onoro,te solo ammirar devo, e te sol chieggio,godan pur gli altri ogni divitia loro,ch’io nulla a par te conosco, o veggio;
21 Si pensi, anzitutto, all’Euridice di Rinuccini (1600), in cui la figura della ninfa assume un contorno di rilievo in termini di presenza drammatica, anche considerando i tratti più autentici di caratterizzazione del personaggio.
Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento
117
tu cagion sarai sol, che gemme, et oroa disprezzar m’induca, il che far deggiopoi che sol tu quante ricchezze mai,ninfa, può dar Natura oggi mi dai».
A sì bel dire, a sì soavi accenti,di pietade Euridice arde, e s’infiamma,e sì l’impiaga Amor co’ suoi pungentistrali, cha la consuma a dramma a dramma;più risponder non può, ma tra gli ardentidesii rivolge l’amorosa fiamma,e contemplando stasse i bei sembiantidi chi sembra del Ciel gli Angioli santi.(lxiii-lxiv, vv. 497-512)
Ancora una volta è una dea che sconvolge la storia, Diana, che come Amore è realmente presente nei boschi ameni dove si muovono gli amanti, un’astante anch’essa: per non essere abbandonata dalle ninfe vuole uccidere Euridice, e ordisce il misfatto. Ma si pentirà, di fronte al dolore del citaredo: così chiamerà la ninfa Urania (omaggio alla figura pontaniana, forse) a cui chiederà di accompagnare Orfeo negli Inferi. La catabasi segue i canoni della tradizione nei suoi aspetti diegetici consueti: un canto che mostra però tutta la sua forza e non la dolcezza, e che nasce più dalla paura che dall’eroismo:
Così speranze, e tema lo travolve,e l’una, e l’altra a suo voler lo tira;al fin di seguir oltre si risolve,né più al timor, ch’a la speranza mira;onde sovente tra ’l pensier s’involvedi porsi al petto la sonora lira,e con l’uniche note, altere, e contefermar la barca, e giù prostrar Caronte.
Move dunque al cantor tosto le labbia,e sparge il suon de la dorata cetra;il canuto nocchiero arde di rabbia,né con forza seguir più l’opra impetra,tal che vinto, al cader, l’umida sabbiatoccar si sente, e sì il gran dorso arretra;che fin che del gran fiume il fondo tocchi,par che nel tetro Abisso il ciel trabocchi.(cxxxvii-cxxxviii, vv. 1089-1096)
Pierandrea De Lorenzo
118
Tutto si ferma al suono della sua voce, si arresta persino il corso dell’Ache-ronte, Caronte è vinto, Cerbero si addormenta, Plutone accondiscende alle suppliche di Proserpina che già cede al suo dolore. La dura legge dell’Ade (o è più giusto dire “dell’Inferno”) è imposta dallo stesso dio degli Inferi, ma quando una furia si avvicina con troppa veemenza ad Euridice, già vittima delle pene infernali, Orfeo cede al timore e si volta premuroso; Euridice, silente, diviene presto “lieve aura”, secondo il racconto virgiliano, e scompare per sempre ai suoi occhi:
Mille affamate Arpie, mill’altri Mostriscorrendo presso lor poscia sen vanno;e con artigli, e con aguzzi rostrischerzi infiniti ad Euridice fanno,perché averla desian ne’ ciechi chiostria suo gran male, a suo perpetuo danno:pur si sforz’ella di scacciargli, e tentaindietro ributtar chi la tormenta.
Se ne sforza ella, Orfeo gli ’l persuade,ch’ora è per uscir da l’empia porta,e per poggiar le lucide contrade,ove il pensier veloce lo trasporta;ma tosto un’empia Furia, di pietadenemica, e più de l’altre al male accorta,con tal forza ver lei osa avventarsich’Orfeo si vede astretto a rivoltarsi.
[…]
A pena dir s’udio l’ultimo vale;che liev’aura non lunge ella diventa,e tal furore il giovanetto assaleche di rapirla (benché invano) tenta;ora nel basso scende, or alto saleor il viso, or le braccia a l’aria avventae credendo seguirla in dietro ancorade lo speco si vede esser già fuora.(clxvii-clxix, vv. 1329-1360)
“Inferno” dicevamo, più che “Ade”, in quanto dell’oltretomba umanistica, di memoria polizianea, che tanto evocava il giusto mondo ultraterreno senza pene e senza tormenti di un’era intesa nella classicità più autentica22, di
22 Cfr. A. Tissoni Benvenuti, L’orfeo del Poliziano, Padova, Antenore, 1986, pp. 71-103 e com-
Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento
119
quell’Ade non resta nulla: l’Inferno è ormai definitivamente dantesco, con le sue presenze dannate, gli atroci tormenti:
Morte, sonno, fatica, et altre milleforme, ch’il vero esempio han di spavento,Idre, Gorgoni, Arpie, Cariddi, Scille,di duol Chimere armate, e di tormento,discordie, che d’ardenti atre favilleturban co ’l seme sparso ogni contento,e Briarei, c’han cento mani al bracciocon altri mostri assai, ch’io celo, e taccio.(cxliv, vv. 1145-1152)
Tutta l’attenzione che Massonio stesso rivolge all’accurata descrizione di questo mondo tenebroso ha il solo effetto di creare un fondale scenico ridon-dante che fatica a restituire alla catabasi mitica la sua dimensione più auten-tica. Orfeo, in preda al dolore e tentato di morire, sceglierà di vivere perché la vita stessa è la peggiore punizione per chi soffre di un dolore senza fine:
«Ma per che so che chi mortal vien natoconvien che mora; almen me si concedavita, ch’in questo mal caduco stato,ogni stratio ver me drizzar si veda;ch’al fin me n’andrò poi, qual merto, ingrato,ove fia che la pena il fallo ecceda,e vivo, e morto aver debbia mai sempresdegno, e dolor che l’esser mio con tempre».
E così brama or di restare in vitaet or privo di lei girne a l’Inferno;ma si risolve di non far partitase pria non ha vivendo oltraggio, e scherno.(clxxvii-clxxviii, vv. 1409-1420)
Questo suo chiudersi alla vita, ai sentimenti, alle emozioni, lo trasfor-merà in «insensibil pietra». L’epilogo, certamente nuovo, del tutto inatteso, che non trova attestazioni nelle fonti classiche del mito23, riconduce, in un ormai consueto intreccio di fonti, all’immagine dell’amante che paga il suo errore divenendo «un quasi vivo et sbigottito sasso», con riferimento alla
mento al testo.23 Resta ancora indispensabile, per confrontare le varie attestazioni del mito nelle fonti classiche, lo
studio di O. Kern, Orphicorum fragmenta, Berolini, Weidmannos, 1922.
Pierandrea De Lorenzo
120
celebre canzone petrarchesca «delle metamorfosi»24, icona ancora una volta di memoria ovidiana: nelle Metamorfosi è Niobe a trasformarsi in pietra, pur continuando a piangere il dolore della perdita dei suoi figli25, la stessa Niobe che compare proprio nelle prime ottave della Favola in cui Massonio elenca una serie di personaggi mitologici raffigurati all’interno di una splendida caverna, e lo fa sull’esatto modello sannazariano, come vedremo più avanti; anche Batto, sempre seguendo il racconto ovidiano, sarà trasformato in pie-tra da Mercurio per non aver saputo tacere26. Possiamo affermare senza gran-di esitazioni, quindi, che proprio nelle Metamorfosi ovidiane possono essere ritrovate le fonti di questo singolare epilogo; tuttavia è possibilie supporre che questi modelli ovidiani siano giunti al Massonio filtrati da esperienze letterarie più vicine, a cominciare dagli scritti di Berardino Rota, a cui va anche il merito di aver esteso alla lirica volgare alcune esperienze di scrittura del Sannazaro latino e quindi di essere «il ponte tra l’età del Sannazaro e quella del Tasso e del Marino»27, ruolo centrale soprattutto nell’ambito della poesia napoletana del secondo Cinquecento28. Il Rota, assai noto anche per la sua produzione in latino29, culturalmente influente nella Roma di metà Cinquecento che vide muovere i primi passi del giovane Massonio, aveva già composto il Liber Sylvarum, una rivisitazione dei miti metamorfici ovidiani, riutilizzati sulla scorta della tradizione pontaniana30: proprio il primo dei miti affrontati è quello di Camerota, punita dalla dea Venere (che ricordia-mo, nella Favola del Massonio, è la vera artefice degli intrighi amorosi) che la trasforma in pietra, condannandola in questo modo ad osservare per sempre il luogo di sepoltura dell’amante respinto31; un mito caro al Rota, che ne rie-
24 Cfr. RVF, xxiii, vv. 72-80.25 Cfr. Met., vi, vv. 146 e segg.26 Cfr. Met., ii, vv. 676-707. Proprio la raffigurazione di Batto trasformato in pietra comparirà nel
tempio della dea Pale, nella pagina ecfrastica sannazariana della Prosa iii dell’Arcadia.27 Cito dall’Introduzione all’edizione critica commentata delle sue Rime, a cura di L. Milite, Mi-
lano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 2000, pp. ix-xxxix: x, a cui rinvio per approfondi-menti bio-bibliografici.
28 Ricordato soprattutto come uno degli autori di maggior spicco del petrarchismo napoletano (A. Quondam, La locuzione artificiosa: teoria ed esperienza della lirica a Napoli nell’età del manierismo, Roma, Bulzoni, 1973).
29 Cfr. L. Milite, Introduzione alle Rime, cit., in particolare alle pp. xxv-xxxii; cfr. ancora M. Leone, Gemina Voces: poesia in latino tra Barocco e arcadia, Lecce, Congedo, 2007.
30 È stata pubblicata di recente la prima edizione commentata dei Carmina del Rota, a cura di C. Zampese, Torino, res, 2007.
31 È questo uno dei momenti di maggior pathos del racconto: «Mox et discerptos artus, inhumata-que membra | (quis putet) illacrymans (superos si flere putandum est) | colligit ac rupi, vastis quae pro-minet undis, | imposuit, collemque omnem dedit esse sepulcrum […] Unde etiam aeternum Palinuri a nomine nomen | servat adhuc, nautis procul adventantibus alto | vertice prospectans mare formidabile saxum | Sed voluti Nympham dignas dare crimine poenas. […] Jamque novum in scopulum versa est, jam saxea saxum | tota subit, saxumque intra nec poenitet acti, | quin e cospectu, tristi latissima casu, | aspicit aversam rupem, moleque sepulcri» (cito dalla celebre edizione Delle poesie del Sig. Berardino
Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento
121
voca l’epilogo in altre sedi32, sul modello ovidiano, peraltro in forme vicine all’evocazione del Massonio.
È anche la stessa tradizione pastorale d’area meridionale, napoletana, ad esercitare maggiore influenza sulla scrittura del Massonio; si pensi, anzitutto, all’attenzione con cui lo scrittore aquilano descrive lo sfondo paesistico in cui ha luogo la vicenda: il poemetto si apre con un’ampia e appassionata descrizione di questi luoghi ameni (protratta sostanzialmente per le prime otto ottave) che l’autore ha premura di identificare con la cara terra natia fornendoci precisi dettagli geografici: Orfeo appare fantasticamente perso in questo paesaggio idilliaco, si muove incerto guidato da un narratore che lo avvia verso l’antro ricco di splendidi fregi marmorei; la memoria corre ancora una volta alla scrittura del Rota che, già ispirato dallo stesso Sannazaro lati-no (il riferimento è alle Piscatorie), componendo le Egloghe pescatorie, aveva felicemente ambientato a Napoli le vicende di pescatori dalla vita semplice, personaggi che tanto avevano ereditato dai pastori della tradizione bucolica italiana33. È bene ricordare, tuttavia, che anche un altro interprete indiscusso del panorama poetico napoletano cinquecentesco, il già citato Luigi Tansil-lo, aveva composto una serie Pescatorie e di Pastorali, canzoni di carattere sostanzialmente bucolico-amoroso, in cui l’ambientazione è spesso esplicita-mente circoscritta all’area meridionale, delineate su un modello non molto dissimile da quello sannazariano34; in Tansillo, spesso, l’epicentro geografi-co si sposta lungo le tracce epiche dei classici percorsi omerici e virgiliani, evocando tuttavia un’atmosfera idilliaca dai chiari toni pastorali35. Si pensi, ancora, alla vocazione ecfrastica dello stesso Sannazaro, in cui immagini reali e immagini d’arte si mescolano in un’atmosfera quasi incantata36; allo stesso modo, nell’Orfeo Massonio, le cui sezioni descrittive hanno moltissimi punti di tangenza con quelle sannazariane, le statue che ornano la grotta di Orfeo occupano un spazio assai ampio: le descrizioni, condotte con sapienza
Rota cavaliere napoletano. Con le annotazioni di Scipione Ammirato su alcuni sonetti, Napoli, Muzio, 1726, pp. 238-239).
32 Si legge nelle sue Rime «Né fia novo però, ch’anchor un sasso | stillò lagrime un tempo: e s’io rimango | selce, piangerò selce i dolor miei. | Niobe, tu piangesti altri; ad un passo | gir non puoi meco, e ben ceder mi dei, | poi che me stesso eternamente io piango» (cxxxv, vv. 9-14).
33 Si legga, oltre al già citato lavoro di E. Carrara, La poesia pastorale, la più agile rassegna com-mentata delle maggiori favole pastorali dal Poliziano a Ludovico San Martino d’Agliè, curata da N. Cimmino, La favola pastorale, Firenze, Cardini Editore, 1980, e, soprattutto, la miscellanea, a cura di S. Carrai, La poesia pastorale nel rinascimento, Padova, Antenore, 1998.
34 Sono le canzoni xvi-xviii, che narrano del pastore Frisio e della ninfa Clorinda, e ambientano la vicenda narrata in un’area geografica compresa tra Napoli e la Puglia (si leggono in L. Tansillo, Il canzoniere edito ed inedito, cit., i, pp. 224-237).
35 Ciò avviene, in particolar modo, nelle Pescatorie xiii-xv, in cui il pescatore Albano canta il suo sfortunato amore per Galatea ai piedi del monte Lipari (ivi, pp. 203-224).
36 Il riferimento è in particolare alla Prosa iii dell’Arcadia, dove si legge la bellissima descrizione del tempio della dea Pale, ma anche agli elementi ecfrastici di cui è ricca le Prosa x.
Pierandrea De Lorenzo
122
narrativa per rendere il dinamismo dei gruppi marmorei, sembrano concede-re alle immagini la medesima funzione di ampliare la prospettiva fantastica dello sfondo paesistico:
Di questa apresso in pietra più forbitala bellissima Venere si scorge,che ’l vago Adone a bel riposo invita,dove un limpido fonte inonda, e sorge;ma perché mostra aver gioia infinitaquei, tosto che del cenno ivi s’accorge,ver lei s’invia, ma tra più lievi passiquasi morto cadere in terra fassi.
Segue indi un ricco, et ben ornato altare,che tra diversi fiori intorno sparsiPale sostiene, ove si può mirarepolver d’agnelli inceneriti, et arsi,e di secche festuche il fumo andarefin dove ’l sol può a mezo giorno alzarsi,et ivi, ove la fiamma è assai più chiarai pastori saltar sovente a gara.(xxiii-xxv, vv. 177-200)
Ma è quasi del tutto assente la levità delle immagini sannazariane: in Mas-sonio gli elementi ecfrastici, così come le descrizioni ambientali tanto minute, si appesantiscono del ricorso eccessivo al mito, evocato in modo pedante, quasi ostentato, al punto da ostacolare la lettura37. È il primo tratto preba-rocco della scrittura del Massonio: le forme spesso si avviluppano su se stesse, le figure mitologiche compaiono quasi a dar prova dell’abilità dell’autore nel richiamare immagini classiche e nell’inserirle abilmente nell’intreccio: Orfeo sembra un nuovo personaggio calato nella terra dei miti, in questo gioco di specchi convessi il cui solo effetto è quello privare il racconto di ogni tratto di immediatezza; molte le pedanterie descrittive e gli intermezzi di giudizi moraleggianti, ottenuti perlopiù attraverso il ricorso a stereotipi, anche sintag-matici, come nel caso della citazione petrarchesca «cosa bella e mortal passa e non dura»38. Appaiono eccessivi, e ancora di gusto prebarocco, gli elementi figurativi che investono anche la stessa figura semidivina di Euridice: tutta convenzionale l’immagine sovraccarica di aggettivazione della ninfa:
37 Non a caso è uno dei tratti peculiari anche della scrittura del Rota, sottolineato in più occasioni (cfr. G. Rosalba, Un poeta coniugale del secolo XVI: Berardino Rota, Torino, Loescher, 1895) e giusta-mente ricondotta da Luca Milite ad una tendenza diffusa che prelude al secentismo (cfr. Introduzione alle Rime, cit., p. xxi, nota 26).
38 Si legge al v. 564, ottava cviii.
Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento
123
Sparge a l’uscir la chioma a l’aure lieve,che di finissim’oro esser dimostra,e nel viso il color di bianca neve(cosa rara a veder) purpura inostra;poscia un arco sottil l’occhio riceveper ornamento, e cotal gratia giostranel viso tutto, ch’o sia lunge, o pressoha il primo onor del bel femineo sesso
Ma non men del bel viso ha di vermiglia purpura le sue labbra intorno tinteil cui vago color sembra, e somigliarose, c’ha Flora in suo giardin dipinte;[…]
Or debbo tacer’io de le due stelle,che fan gir di sua luce il sol negletto?velar debb’io le candide mammelle,c’han per fido sostegno il gentil petto?Debb’io non dir de le divine, e bellemani, del busto ben formato, e schietto?E passar con silentio ogn’altra partec’ha seco di Natura ogn’opra, e d’Arte?(lxxx-lxxxii, vv. 633-656)
È chiaro l’intento dell’autore, spesso giunto a buon esito, di aumentare il pathos intorno ai tratti dinamici della vicenda narrata: si dilunga a rac-contare la disgrazia che colpirà Euridice, un momento di alto dolore in cui persino gli elementi naturali tendono a inquietanti forme di comparteci-pazione:
Cresce intanto la rabbia ai venti, e al fiume,cadon folgori spesso, et abbandonagiove l’irata destra, ond’al costumeritornando talor lampeggia, e tuona;cede a le folte nubbi il chiaro lumee sol percossa d’aria intorno suona,onde ognun va fuggendo, e si ritirain parte ove del ciel non giunga l’ira.(xcvii, vv. 769-776)
Anche in questo caso appare di rilievo assoluto la partecipazione della natura agli accadimenti dei personaggi, che caratterizza uno sfondo paesag-gistico estremamente unito alla presenza umana al punto da formare quasi
Pierandrea De Lorenzo
124
un tutto omogeneo, e che è condizione indispensabile al canto stesso; questo è un tema portante che attraversa costantemente tutta la tradizione bucolica volgare39.
Massonio è molto attento alle forme di verosimiglianza del racconto (quasi in conformità alle regole tutte cinquecentesche di scrittura teatrale) e questo è evidente in particolar modo quando muove il suo Orfeo verso gli abissi: vi è, infatti, una grande attenzione a connettere spazialmente e temporalmente il momento della disperazione e del pianto di Orfeo sul luogo terreno della morte di Euridice e quello della discesa nell’Ade, anche attraverso raccordi diegetici; questo non è l’unico caso in cui si manifesta il desiderio di attendi-bilità narrativa e si mostra un certo movimento dell’azione che in molti tratti riesce a tener viva l’attesa del lettore attraverso un sistema di sospensioni del racconto e di rallentamento del tempo narrativo.
Non sono pochi i momenti d’impegno lirico del Massonio, pur oppressi da immagini sovrabbondanti, al punto che, a prescindere da osservazioni di carattere metrico, il componimento si potrebbe definire a tratti un “idillio mitologico” più che una favola pastorale vera e propria; questi slanci man-cano, tuttavia, di spontaneità, e difficilmente si raccordano senza fratture agli elementi narrativi. La stessa scelta metrica di adottare l’ottava, metro inusuale per questo genere di componimenti che trovavano ormai maggiore sviluppo in forme perlopiù madrigalesche (per quanto nella polimetria delle scritture teatrali cinquecentesche l’ottava rima sia ancora usata nelle sezioni narrative), è indicativa dell’intento di fare del mito un racconto di avventure.
Il nostro testo sembra essere a suo modo, insomma, un testimone della crisi dei generi: adotta saldamente la struttura del poema cavalleresco però per argomenti mitologico-pastorali che la tradizione aveva ormai affidato ad altre soluzioni metriche, sul prevalente modello tassiano, e declinato secondo canoni drammatici del tutto ignorati dal nostro autore (che pure si era già dedicato al genere rappresentativo).
Sin qui ho voluto tratteggiare brevemente le peculiarità di quest’opera ed evidenziarne i tratti di maggiore rilievo, pur sottolineandone i limiti più evidenti. Leggere attentamente questo poemetto può aiutarci a capire come fosse caratterizzata, sul finire del Cinquecento, una certa scrittura, frutto di velleità letterarie o di meri esercizi accademici più che di autentica vocazione artistica, tesa tra emulazione, intenti combinatori di più elementi della tradi-zione, carattere di novità. Il mito di Orfeo – e cerco di dare una risposta alla domanda posta all’inizio di questo lavoro – ha attraversato il secolo sfocian-
39 Come ben dimostrato, attraverso una breve serie lineare di attestazioni ben circostanziate, da S. Prandi, L’ecfrasi pastorale, nell’opera collettiva Ecfrasi: Modelli ed esempi fra medioevo e rinascimento, a cura di G. Venturi e M. Farnetti, Roma, Bulzoni, 2004, i, pp. 203-225.
Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento
125
do in una serie di esperienze letterarie, perlopiù di basso profilo (ricordiamo anche le tante opere anonime che ruotano attorno a questo tema); la stessa pastorale di matrice quattrocentesca, intrisa di mitologia, offre infiniti cano-vacci letterari, ben inseriti in un sistema di riuso, a cui ricorrere quasi esclu-sivamente in ambito musicale e rappresentativo40. Sembra di poter affermare, insomma, che questo materiale della tradizione umanistica possa essere utile a sperimentare nuovi generi, che quindi si avvalgono dell’autorità di elementi narrativi e di immagini già più che consolidate dalla tradizione per fare un passo in avanti nella direzione dello sperimentalismo (basti pensare alle prove musicali dei Bardi tra Cinque e Seicento). Non dimentichiamo che Orfeo, nel 1600, calcherà le scene del primo melodramma della storia41, scritto da un Rinuccini, la cui scrittura è sostanzialmente caratterizzata da una abilità raffinata di combinare elementi petrarcheschi e tassiani 42.
Un materiale, quindi, che sul finire del Cinquecento era già divenuto inevitabilmente stantio? Massonio tenta di darvi nuova linfa ma lo fa forse con l’intento di far apparire “colti” tutti gli elementi costitutivi del mito, col solo risultato di privarlo di naturalezza; il ricorso al modello petrarchesco senza dubbio c’è, come sarebbe scontato attendersi, anche se in forme tutto sommato modeste: questa tarsia di tasselli diversi, tuttavia, non costituisce un tessuto omogeneo senza fratture e gli stessi elementi della tradizione letteraria più alta, cui l’autore attinge in più d’una occasione, sembrano utilizzati talvolta solo per dare forza a singole immagini o a singoli momenti che, in questo modo, appaiono isolati (un esempio è dato dalla citazione petrarchesca «pur se lo spirto era da lei diviso | morte bella parea nel suo bel viso»43, verso dei Trionfi, qui privato della sua forza poetica). Non una serie di richiami colti a intessere immagini autentiche, come in Rinuccini, dove i prestiti contribuiscono scopertamente a creare atmosfere poetiche già note che ben si adattano alle nuove esigenze liriche44, ma un mescidare elementi antichi e nuovi in una scrittura che può essere definita “manieristica” senza
40 Cfr. A. Solerti, Gli albori del melodramma, Milano-Palermo-Napoli, Sandron, 1904.41 Un mito che attraverserà tutto il Seicento, con diverse ed anche impreviste soluzioni dramma-
tiche e musicali. Sono stati scritti molti saggi, anche di indiscusso valore, sulle singole opere musicali incentrate su questo tema, a cominciare dagli studi di Paolo Fabbri su Monteverdi; ad oggi, uno dei pochi tentativi di inquadrare trasversalmente tutte le varie attestazioni del mito di Orfeo nel melo-dramma italiano sei-settecentesco è stato condotto da G. Maggiulli, La lira di Orfeo. Dall’epillio al melodramma, pubblicato nel 1991 dal Dipartimento di Archeologia, Filologia classica e loro tradizioni dell’Università degli Studi di Genova, con un’ampia sezione dedicata all’evoluzione del mito dalle fonti classiche al Poliziano.
42 Cfr. N. Pirrotta, Li due Orfei, cit.43 Siamo al v. 728, ottava xci.44 Ho avuto occasione di approfondire questo tema in un mio saggio, La rinascita di Euridice,
(«Studi e problemi di critica testuale», 76, aprile 2008, pp. 103-122) a cui rinvio per ulteriori appro-fondimenti anche di natura bibliografica.
Pierandrea De Lorenzo
126
grandi esitazioni, di un manierismo però in massima parte sterile e già prote-so verso soluzioni barocche che mal si compenetrano dando vita a un ibrido dall’articolato profilo poetico e narrativo.
Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento
127
abstract
Su un’ inedita «Favola di Orfeo» del Cinquecento.Intorno alla metà del Cinquecento un medico erudita, Salvatore Massonio, scrisse un poemetto mitologico incentrato sul mito di Orfeo. L’opera, pubblicata nel 1582, non verrà mai più stampata e sarà quasi del tutto dimenticata. Il saggio, eviden-ziando le peculiarità di questo poema rispetto alla tradizione mitologico-pastorale umanistica, offre alcune considerazioni di carattere più ampio su un certo tipo di scrittura di maniera nata come dilettevole esercizio letterario.
On an unpublished «Favola di Orfeo» from the 16th century.In the late Sixteenth century, a learned doctor named Salvatore Massonio wrote a short mythological poem about the Orpheus myth. This work was published in 1582 and successively it was never printed and totally forgotten. The essay, point-ing out some peculiarities of this poem compared to the mythological-pastoral tradition of the humanistic age, suggests some broader remarks about a specific manieristic writing born as a delightful literary exercise.
Per i collaboratori: I contributi, uniformati secondo le norme editoriali della rivista, devono essere inviati alla Redazione (Simone Magherini, Dipartimento di Italianistica, Università di Firenze, piazza Savonarola 1, 50132 Firenze, email: [email protected]) in formato cartaceo ed elettronico (word per Windows o per Mac OS), assieme a una scheda con i recapiti dell’autore, compreso l’indirizzo email. Le norme editoriali (in formato .pdf) si possono richiedere alla Redazione. È previsto un solo giro di bozze esclusivamente per la correzione di eventuali refusi. Gli estratti (in formato pdf) vanno richiesti all’Editore.
Comitato di lettura internazionale: «Studi italiani» si avvale di un Comitato di lettura internazionale per la selezione scientifica dei contributi. La Redazione provvede a informare gli autori del parere espresso dal Comitato e di eventuali interventi che possano essere richiesti.
To contributors: All contributions must conform to the review’s publishing regulations and must be sent to the editorial office (Simone Magherini, Italian Studies Department, University of Florence, piazza Savonarola 1, 50132 Florence, email: [email protected]) in both paper and electronic form (Word for Windows or Mac OS), together with a file containing the author’s address as well as telephone number and email address. Publishing regulations (in pdf format) can be obtained from the editorial office. A single round of drafts is planned exclusively for correcting typographical errors. Contributors may apply to the publisher for extracts (in pdf format).
International Peer Review: «Studi italiani» makes a scientific selection of contributions by means of an international peer review. The editorial office notifies writers of the committee’s judgment and communicates any requests for their further involvement.
Abbonamento 2009: Italia ed estero € 50,00; un fascicolo € 27,00; da versare sul ccp. 29486503 intestato a Edizioni Cadmo s.r.l., via Benedetto da Maiano 3, 50014, Fiesole (FI)
Semestrale – Anno xxi, n. 1 – 2009Registrazione del Tribunale di Firenze n. 4256
del 05/08/1992Grafica e impaginazione: Lorenzo Norfini,
Società Editrice FiorentinaStampa: grafiche Cappelli – Sesto Fiorentino (FI)Finito di stampare nel mese di ottobre 2009
Subscription 2009: Italy and abroad € 50,00; one issue € 27,00 to be paid to Post Office account. 29486503 registered in the name of Edizioni Cadmo s.r.l., via Benedetto da Maiano 3, 50014, Fiesole (FI)
Six-monthly review – Year xxi, n. 1 – 2009Florence Court Registration n. 4256
05/08/1992Graphic design and layout: Lorenzo Norfini,
Società Editrice FiorentinaPrinting: grafiche Cappelli – Sesto Fiorentino (FI)Printing completed in October 2009
Direzione / Editorship: Riccardo Bruscagli (Università di Firenze), Giuseppe Nicoletti (Università di Firenze), Gino Tellini (Università di Firenze)
Comitato Scientifico Internazionale / International Advisor Board: Jane Everson (Royal Hollway, University of London), Denis Fachard (Université de Nancy II), Paul Geyer (Universität Bonn), François Livi (Université Paris-Sorbonne), Paolo Valesio (Columbia University), Winfried Whele (Universität Eichstätt)
Redazione / Editorial Office: Clara Domenici, Simone Magherini
Direttore responsabile / Managing Editor: Barbara Casalini
Amministrazione / Administration: Edizioni Cadmo, Via Benedetto da Maiano 3, 50014 Fiesole (FI), tel. +39 055 50181 [email protected]; www.cadmo.com
© Copyright 2009 by Edizioni Cadmo, Firenze - ISSN: 1121-0621 - ISBN: 978-88-7923-397-2
L’edizione elettronica è disponibile all’indirizzo http://digital.casalini.it/17241596. Ogni articolo online è provvisto di codice DOI (Digital Object Identifier).
The electronic version is available at http://digital.casalini.it/17241596. Each article is provided with a DOI (Digital Object Identifier) code.