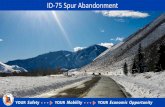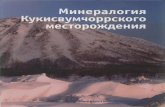Orfeo e Lucrezio nelle Georgiche, “Atti dell’Accademia Pontaniana”, 51, 2002, pp. 75-90
Transcript of Orfeo e Lucrezio nelle Georgiche, “Atti dell’Accademia Pontaniana”, 51, 2002, pp. 75-90
Alli Accademia Pontaniana, NapoliN.S., Val. LI (2002), pp. 75-90
Orfeo e Lucrezio nelle Georgiche
Nota di Paola Gagliardipresentata dai soci ord. reso Giovanni Polara e Ugo Criscuolo
Non mi pare sia mai stata approfondita, nello sterminato panorama critico fio-rito attorno all'Orfeo delle Georgiche, un'ipotesi di lettura che metta la figura delcantore in relazione con Lucrezio. Eppure spesso lo sfortunato personaggio virgi-liano è stato collocato, a vario titolo, in àmbito epicureo, ora come simbolo dellostultus, lontano dalla tXTCXpaçia del Giardino e dominato da una passione cieca,fonte della sua rovina; ora invece come personificazione del saggio teorizzato dalfilosofo di Gargetto, o perlorneno del poeta ideale ipotizzato dai suoi seguaci,capace di usare la sua arte in funzione rasserenatrice e purificatrice.'. Tali e tantedifferenze di valutazione, segno sì della poliedricità di questa creazione virgiliana,ma anche della confusione degli studiosi, originata non di rado dall'intento di inca-sellare il personaggio in un àrnbito filosofico rigidamente scolastico, restituisconoun'immagine piuttosto incerta di Orfeo e del suo significato simbolico, fondamen-tale per la comprensione dell'intero poema, di cui insieme con Aristeo costituiscela sintesi.
Ame pare che anche ad un'analisi sommaria non sia difficile individuare comenucleo centrale della storia di Orfeo la dementia, provocata da un amore incon-trollato, origine di tutti i mali e causa per due volte di un'illogica e rovinosa disob-bedienza. Prima infatti, dopo aver riottenuto Euridice, il mitico cantore contrav-viene al precetto di Proserpina, ben lieve rispetto al grande dono concessogli dalladea; poi, dopo la definitiva perdita dell'amata, alle leggi naturali e sociali del matri-
I Cfr. E. Paratore, «L'episodio di Orfeo», in AA. W., Atti del Convegno sul bimillenariodelle Georgiche, Napoli 1977, pp. 3\ ss.: solo in quest'articolo e solo in questo senso ho trovatoun accosta mento di Orfeo a Lucrezio, anch'egli giudicato dall'illustre studioso un poetasublime, dispensatore di serenità. Ma queste conclusioni, agli antipodi di quelle esposte nelpresente lavoro, trovano fondate obiezioni da parte di P. Domenicucci, «L'elegia di Orfeo nelIV libro delle Georgiche», in Giorn. [I. di Filol. 16, 1985, p. 248, al quale si rinvia anche perl'interpretazione di Orpheus stultus .
76 PAOLA GAGLIARDI
mania e della riproduzione che, nello sterile isolamento al quale si vota nel ricordodella sposa, rifiuta fino a scatenare la furia omicida delle Ciconum matres-.
Al contrario, nella vicenda speculare ed opposta di Aristeo il fallo del protago-nista (aver provocato, con il suo tentativo di violenza, la morte di Euridice), assaipiù grave di quello di Orfeo", trova perdòno proprio grazie alla stretta obbedienzaai comandi materni, prima nella ricerca delle cause della sua punizione, poi nell'e-secuzione del rito della bugonia per recuperare le api. Mi pare evidente che propriosul concetto di obbedienza, infatti, ruoti tutto il messaggio dell'epillio di Ari-steo/Orfeo e quindi delle Georgiche nel loro complesso, i cui precetti etici il poe-metto traduce in discorso narrativo: obbedienza agli dèi, garanti dell'ordine natu-rale, ma soprattutto obbedienza alle leggi della natura, immutabili e inesorabili,che è vera saggezza riconoscere e far proprie. In questo senso Aristeo, pur con isuoi limiti e le sue colpe, sembra essere il vero 'saggio' del poema, con la sua totaleaccettazione di cose più grandi della sua comprensione: senza porsi domande,senza discutere, egli esegue ciò che gli viene imposto, laddove Orfeo si lascia tra-volgere dall'istinto e si fa accecare da una subita dementia (v. 488) che gli fa per-dere Euridice nel momento in cui sta per riaverla definitivamente.
Ma il vero 'saggio' del poema -lo sappiamo dal finale del libro 11- è l'agricolaideale, fortunato perché vive in un mondo senza storia, a contatto solo con lanatura e i suoi ritmi, senza pretese di comprensione nè tanto meno di dominio diessa. La sua figura, dunque, sembra davvero anticipare quella di Aristeo, mentre
2 Virgilio parla significativamente di matres (v. 520), un termine la cui importanza, benrilevata da C. Segal, Orfeo. Il milo del poeta, trad. it., Torino] 995, p. 65, è spiegata da G.Barra, «La figura di Orfeo nel IV libro delle Georgiche», in Vichiana 4, 1975, p. 198: «Orfeosuscita la punizione ... delle matres dei Ciconi, che non sono, come pure si è cercato di spie-gare, le matronae, le donne in genere, ma con significato assai più pregnante ed intenso lemadri, naturali custodi e vindici dei legami nuziali e della sacralità dei matrimoni, che l'osti-nazione di Orfeo misconosce e rifiuta». on solo: con l'affidare la vendetta a delle madri-ritengo- il poeta ha anche voluto eliminare qualsiasi possibile implicazione di natura ero-tica e sessuale che generiche figure di donne avrebbero potuto suggerire, riconducendo lapunizione di Orfeo ad un àmbito più elevato di giustizia divina e di ristabilimento dei dirittinaturali. Una finezza sfuggita ad Ovidio, che nel riprendere il mito a Met. Il, 3 attribuiscel'uccisione di Orfeo alle nurus dei Ciconi (per un raffronto più articolato tra il personaggiovirgiliano e quello ovidiano, cfr. Barra, art. cit., pp. 195 ss.; W. S. Anderson, The Orpheus orVirgil and Ovid, in Orpheus: The Metamorphosis or a Myth, ed. J. Warren, Toronto ]979, pp.37-40).
3 Checché ne pensi J. Chornarat, «L'initiation d'Aristée», in Rev. É/. Lat. 52, ]974, pp. 199ss. (un articolo a volte un po' troppo ardito negli accostamenti di simbologie): nel tentativodi risolvere il problema dell'apparente sproporzione, per Aristeo e Orfeo, tra colpa e pena(Aristeo, responsabile di un fallo più grave, riceve una punizione ben più lieve di Orfeo), lostudioso giustifica la pena di Orfeo con l'avere egli infranto un divieto esplicito. La spiega-zione non convince: al di là della forma, la sostanza del suo gesto (essersi voltato a guardareEuridice) è di gran lunga meno grave di quella di Aristeo, colpevole della morte della fan-ciulla. In secondo luogo, anche il comportamento di Aristeo viola norme fondamentali, natu-rali e sociali. Piuttosto, la gravità vera del gesto di Orfeo è nel suo valore simbolico: se il signi-ficato del voltarsi indietro equivale a stabilire un contatto, egli istituisce, col guardare lasposa, un legame con i morti, violando per la seconda volta (dopo essere penetrato nell'Adeed averne ammansito con il suo canto tutti gli abitanti) la barriera che deve separare i dueregni. Sul senso del divieto postogli da Proserpina, cfr. M. Bettini, Antropologia e culturaromana, Roma 1986, p. 135, con ampia bibliografia.
(2)
(3) ORFEO E LUCREZIO NELLE CEORCICHE 77
non altrettanto agevole risulta riconoscere Orfeo nel felix ad essa contrapposto (enon solo avvicinato, come si tenterà di dimostrare). C'è -è vero- l'allusione allo stre-
pitum Acherontis avari a suggerire quest'identificazione, ma un'analisi più accuratapuò rivelare analogie assai più profonde e insospettate". Di qui l'opportunità diaccostare i due finali dei libri pari delle Georgiche, affini per molti versi nell'archi-tettura simmetrica di proemi ed epiloghi messa in atto con tanta cura nel poema,per verificare se il felix e il [ortunatus del libro II possano essere Orfeo ed Aristeo eper trame tutte le conseguenze del caso. Non bisogna infatti dimenticare che ilfinale del libro II è uno dei brani più complessi dell'opera, sia per i significati ideo-logici chiamati in causa, sia per il confronto esplicito di Virgilio con il grandemodello lucreziano: s'impone dunque, partendo dai w. 490 ss., una rilettura attentadell'intero passaggio relativo a Lucrezio (w. 475- 4945), uno dei più tormentati dallavorio degli studiosi.
Che il felix di 2, 490 rappresenti il saggio ideale lucreziano, capace di dominarela natura con il suo ingegno e di spazzar via' così paure e superstizioni, non v'è-credo- dubbio di sorta. E che questi versi? si attaglino alla perfezione anche adOrfeo, che senza timore piega il fato e affronta il regno dei morti, mi sembra altret-tanto evidente. La precisione del riferimento all'Ade e alla difficoltà di sottometterel'Acheronte avarus (l'aggettivo, nella pregnanza del doppio valore -vavido» /«avaro»-, pare posto a sintetizzare la grandiosità dell'impresa di Orfeo) suonaaddirittura quasi come un'anticipazione della [abula Orphei, ma è tutto 1'atteggia-men to del personaggio a ricordare 1'orgogliosa fiducia del felix del libro II nelle pro-prie capacità. Finanche la forza di quest'appellativo, sottolineata dalla posizione diapertura, si addice per antifrasi allo sventurato cantore, nei confronti del qualeacquista una sfumatura d'ironia tragica, alla luce del misero esito della sua sovru-mana missione nell'Ade: non la capacità di subicere pedibus i timori, nè tanto menola conoscenza delle cause del suo dolore gli assicurano il recupero della felicità per-duta, e quel Felix sembra quasi interrogativo, in relazione a lui, come se smentisseciò che in apparenza afferma. È davvero felice chi riesce a conoscere le cause deglieventi e a calpestare tutti i timori, il fato inesorabile e lo strepito dell'avido/avaroAcheronte? Nel caso di Orfeo la risposta, suggerita dai fatti, è negativa, il che ponein una luce insolita il brano, dando una sfumatura critica a quello che viene soli-
4 Già il Paratore, «L'episodio ...», cit., p. 31, riprendendo un suo vecchio lavoro «<Ancòradi Lucrezio e delle Georgiche», in Ann. Fac. di Magistero Univo di Messina 1940), equiparavale forze infernali ammansite dal canto di Orfeo ai metus omnes et inexorabile fatum ... strepi-tumque Acherontis avari.
5 L'esclusione dei versi successivi dalla nostra analisi non implica ovviamente il misco-noscimento anche in essi dell'impronta lucreziana, bensì la fine del confronto diretto tra dueideali, prima di poesia (vv. 475-489) e poi di vita (490 55.). Abbastanza chiara mi sembra,infatti, l'architettura del finale del libro: l'inizio (vv. 458-474) e la fine (vv. 495-540) dell'ex-cursus incorniciano il dialogo con Lucrezio, riducendo ad unità l'intero brano nell'analogiatematica della felicità della vita agricola.
6 Cfr. vv. 490-492 felix, qui potuit rerum. cognoscere causas / et metus omnes et inexorabile[atum / subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari.
78 PAOLA GAGLlARDI
tamente giudicato una semplice allusione al percorso lucreziano verso la felicità",accostato senza intenti polemici all'altro suggerito da Virgilio, quello del [ortu-natus.
Sull'assenza di scopi polemici, alieni dall'animo del poeta, non vi sono dubbi,ma che egli non condivida la soluzione lucreziana di ottenere la felicità attraversola comprensione dei segreti della natura mi pare dimostrato dal Iatto che accantoad essa ha avvertito l'esigenza di indicare la via diversa dell'accettazione pura esemplice delle leggi naturali", La scelta stessa dèi due aggettivi, felix e [ortunatus,pone su due piani mollo distanti i due ideali: accanto alla baldanzosa fiduciaespressa da felix, più modesto suona infatti il secondo termine, timida proposta diuna weltanschauung che si rivela invece la più valida. Perché se per il sapiens lucre-ziano la felicità è il premio dell'enorme travaglio intelletluale per impadronirsi deisegreti naturali, essa è a portata di mano per l'agricola che plasma la sua vita suiritmi della natura, libero dalle angosce della storia, dalle ambizioni e dai vanimotivi di affanno prodotti da desideri innaturali e smodati". Egli è dunque [ortu-natus, perché la realizzazione della felicità gli è facile, ma soprattutto è -ovvia-mente- Felix, anche se non lo sa, perché la sua gli sembra una condizione di vitanaturale e non la tappa finale di una lunga e dolorosa ricerca, e perché se rosse con-sapevole della sua situazione privilegiata sarebbe davvero [ortunatus Il i117 ium,come esclamava, significativamente Virgilio poco prima IO, depositario cioè diquella felicità perfetta che invece non è concessa agli uomini".
Ed è proprio per questo ritegno, per questa forma di pudore, quasi, che il poetanon osa definire felice tout court il suo agricola ideale, che pure (tutto il poema èteso a dimostrarlo) è la figura che più si avvicina ad una condizione di vita beata '2
7 Per l'interpretazione tradizionale dei vv. 490-492 come PUKUP'OPOç del saggio lucre-ziano, cfr. ad es., D. O. Ross, Background lo Augustan Poetry: Gallus, Elegy and Rome, Carn-bridge 1975, pp. 29 s. e nota I (lo studioso mette anche in relazione questi versi con Orfeo).
8 Senz'altro da scartare, dunque, !'interpretazione di J. P. Davis, «Virgil's Ascraean Song»,in A. J. Boyle (Ed.), Ranius Essavs 011 the Georgics, Berwick 1979, p. 24, secondo cui i dueideali del [elix e deljorlul1atus sarebbero sostanzialmente equivalenti. Se così fosse, la sceltastessa degli aggettivi per carauerizzarli li avrebbe posti su un piano di parità.
9 La condizione del [ortunatus, dunque, «non deriva da una ricerca intellettuale. Fonda-mento di questa sicurezza è un semplice dato materiale: al contadino la terra garantisce lasoddisfazione immediata e 'giusta' dei suoi bisogni. (così A. Barchiesi, '«Lettura del secondolibro delle Georgiche», in M. Gigante [Ed.], Lecturae vergiliauae, Napoli 1982, Il, P 67).
IO Cfr. v. 458 s. o [ortunatos nimiuni sua si bona norint / agricolas!Il Sull'identificazione del [ortunatus sono state avanzate ipotesi disparate e talora fanta-
siose, come quella di E. W. Leach, «Gcorgics 2 and the Poem», in Arethusa 14, 1981, pp. 35-48, che lo individua in un personaggio storico preciso, vale a dire Varrone; secondo M.Schmidt, Die Kompositiou VOli Vergils Georgica, Paderborn 1930, si trattava invece del poetastesso, da identificare evidentemente con l'agricola ideale. I più vedono nel [ortunatus il con-tadino (cfr. J. Conington, P. vergilii Maronis Opera, with a Cornmentary by J. C., London 1858,ad Georg. 2, 490; F. KJingner, Studien zur griechiscen und rontischen Literatur, Zurich-Stutt-gart 1964, p. 267; V.Buchheit, Der Anspruch des Dichters in Vergils Georgica, Darrnstadt 1972,p. 75) ma non specificano che bisogna pensare non all'agricola tout court , bensì solo a quelloche ha recepito il grande messaggio della natura.
12 Sulla matrice ideologica epicurea del [ort unat us concorda la maggior parte degli stu-diosi (cfr. ad esempio E. Paratore, Virgilio, Firenze 1971, pp. 224 ss.; A. La Penna, «Senex
(4)
(5) ORFEO E LUCREZIO NELLE CEORC/CI-/E 79
A maggior ragione insospettisce la forza dell'aggettivo felix attribuito con tantadisinvoltura al saggio lucreziano, tanto più che se per la categoria dei fortunati Vir-gilio può additare negli agricolae esempi concreti di realizzazione di una felicità siapure non compresa appieno, la prima affermazione resta sospesa a livello teorico."Beato chi è riuscito a conoscere le cause dei fenomeni naturali e a debellare pauree superstizioni»: certo, una condizione invidiabile, ma chi c'è riuscito realmente?Chi può essere indicato come esempio tangibile da accostare all'agricola? Noncerto Orfeo, che sul piano artistico e mitico ci prova, ma viene bloccato da qual-cosa di imprevedibile e di inspiegabile per la mente umana e tocca con mano l'in-sufficienza della sua volontà e delle sue doti eccelse e l'inutilità della conoscenza dicause e mezzi per riottenere la felicità perduta. Anche Lucrezio (vero destinatariodel ucocoprouéc) ha indagato i segreti della natura e bandito ogni timore nell'entu-siastica fiducia di raggiungere la felicità promessa da Epicuro; infatti sul pianologico il suo poema è impeccabile, ma non possono certo sfuggire alla sensibilitàvirgiliana quell'angoscia cupa e quell'inquietudine profonda che fanno da sotto-fondo a tutta l'opera e ne smentiscono le premesse (e le promesse) esplicite, accu-mulandosi proprio nel finale, quasi a rinnegare definitivamente la razionalità chenel corso dei sei libri ha tentato di controllarle. Né può passare inosservata ai suoiocchi la sensazione, comune a tutti i lettori attenti e più forte proprio nel finale,della vanità di tutti i tentativi di studio scientifico e di comprensione logica dellecose per consolare e rassicurare gli uomini della loro condizione+'. Anche per
Corycius», in Alli del Convegno virgiliano sul bimillenario delle Georgiche, cit., p. 48; Barchiesi,art. cii., p. 61 nota 25; G. D'Anna, Virgilio. Saggi critici, Roma 1989, p. 27, nota 16, e p. 111),a riprova che tutto il confronto con Lucrezio si muove in àrnbito epicureo, in polemica conle deviazioni lucreziane, inaccettabili per Virgilio, dal verbo del Maestro. Basterebbe a dimo-strarlo lo sfondo di otium sereno nel quale sono posti il [ortunatus e soprattutto Yinglorius div. 486 (traduzione poetica del Àa8E Bl(,)o(Xç), ma pure, ai vv. 495-512, con l'elencazione dei benispregevoli ai loro occhi, l'enunciazione della perfetta autosufficienza, il premio più grande,cioè, promesso da Epicuro e riservato a chi, come loro, riesce a liberarsi da falsi ideali e danocive ambizioni. In quest'ottica la descrizione fortemente negativa della città con i suoi falsialletta menti non rientra solo nella topica comune alle filosofie ellenistiche come emblema deibeni illusori disprezzati dal saggio, ma si configura come simbolo della storia, contrappostaalla natura nel grande dual isrno istituito da Virgilio in tutto il brano: sull'opposizione città /campagna nel senso di natura / storia, cfr. Barchicsi, art. cit ; pp. 56 e 68 ss., in particolare p.72; per una lettura alquanto diversa, ma altrettanto suggestiva, dell'intero finale del libr-o n,cfr. L. Nicastri «Res Romanae perit uraque regna (Ceorg. II 498). Un'indagine sull'idea diRoma in Virgilio», in AA. W., L'idea di Roma nella cultura classica (Atti del Convegno diSalerno, 15-16 ottobre 1996), Napoli 200 l, pp. 104 ss.: lo studioso, pur negando il topicocontrasto città/campagna, riconosce che Virgilio opera una netta distinzione li-a i dueambiti. prendendo una decisa posizione a favore di quello della natura incontaminata dallastoria. Mi pare logico leggere nel passo quell'antipatia e quella diffidenza per la politica cheè una delle più tenaci costanti del pensiero epicureo. A questa collocazione del [ortunatus nel-l'àrnbito del Giardino non si oppone -vedremo- il suo rapporto con gli dèi agrestes di v. 493.
13 A proposito del nostro brano nota bene G. B. Conte, Ceneri e lettori. Milano 1991, p.15: «Era d'altronde (se. Virgilio) profondo conoscitore del testo di Lucrezio: la serie d'imma-gini paurose (l'abisso dell'Acherontc, ma anche la vertigine cosrnica) lascia intendere, conmolto tatto, che la poesia di Lucrezio finisce per mettere a rischio proprio il suo stesso finerasserenante (forse, addirittura, un poema sui contadini e i loro tranquilli culti agresti, insi-nua Virgilio, potrebbe essere più epicureo che il De rerum. natura)».
80 PAOLA GAGLIARDI
Lucrezio, dunque, la superbia della ragione si scontra con una forza imponderabileche ne vani fica gli sforzi e priva di valore l'intento di dare certezze e serenità aglianimi angosciati del suo tempo, disperatamente in cerca di una parola consolato-ria e persuasiva nelle tempeste dell'ultima repubblica.
Per questi motivi a me pare più che possibile il parallelo tra Lucrezio ed Orfeo,istituito tacitamente da Virgilio a distanza nei due finali pari del poema: entrambisublimi poeti, non riescono però a trovare nella propria arte quella consolazioneche sembrava a portata di mano; entrambi persuasi di riuscire, con il loro ingegnoaltissimo, a dominare la natura, sono costretti a constatare, invece, il fallimento deiloro progetti e a ridimensionare la loro fiducia. Entrambi, soprattutto, sono postia confronto, loro malgrado, con qualcosa mai considerata prima, quell'elementoirrazionale e imponderabile che nel caso di Orfeo è l'istinto, ribelle a qualsiasi con-trollo, e nel caso di Lucrezio è quel quid illogico e ineliminabile dall'animo umano,la paura, l'incertezza verso l'incognita della morte, verso l'incomprensibilità deldolore e del soprannaturale, che nessuna dottrina razionale può illudersi di can-cellare completamente. Ma anche su un altro piano fondamentale, quello dell'ob-bedienza, così importante nel messaggio delle Georgiche, Virgilio istituisce unaprofonda affinità tra i due poeti, contrapponendoli a chi (l'agricola ideale, Aristeo,egli stesso) ha fatto una scelta di vita più umile, ma alla prova dei fatti più ricca disoddisfazioni. L'analisi di questo punto esige di allargare il discorso ai vv.475-489,alla prima parte cioè del confronto con Lucrezio, condotta sul piano estetico dellascelta di temi poetici, ma strettamente legata ai vv. 490-494, che di essa costitui-scono la sintesi, tradotta sul piano esistenziale. Ai due tipi di poesia enunciati cor-rispondono infatti i due modelli di vita del felix e del fortunatus e per tale ragionele analogie tra le due parti del confronto potranno suggerire più di uno spunto diriflessione e chiarire meglio l'orientamento virgiliano.
Nei vv.475-489, dunque, il poeta anticipa atteggiamenti e concetti ripetuti poinel raffronto felix / [ortunatus'": l'ammirazione per Lucrezio'>: il tono modesto perintrodurre il secondo termine di paragone; l'apparente imparzialità verso i dueideali proposti, scalfita però da sfumature dell'espressione e dal senso profondo delpensiero, a rivelare, nonostante tutto, le perplessità di Virgilio per la soluzione
14 Ecco il brano in questione (2, 475-489): Me vero primum. dulces ante omnia Musae, /quarum sacra [ero ingenti percussus amore, / accipiant caelique vias et sidera monstrent, / defec-tus solis varios lunaeque labores; / unde tremor terris, qua vi maria alta tumescant, /obicibusruptis rursusque in se ipsa residant, / quid tantum Oceano properent se tinguere soles / hiberni,vel quae tardis mora noctibus obstet. / Sin, has ne possim naturae accedere partes, / [rigidusobstiterit circum. praecordia sanguis, / rura mihi et rigui placeant in vallibus amnes, / fluminaamem silvasque inglorius. O, ubi campi / Spercheosque et virginibus bacchata Lacaenis / Tay-geta; o qui me gelidis convallibus Haemi / sistat et ingenti ramorum protegat umbra!
15 Palpabile nel tono grandioso dei versi più 'lucreziani' (vv. 475-482), oltre che nell'o-maggio resogli con la composizione di un brano perfettamente ricalcato sul suo stile. onriesco dunque a condividere il giudizio negativo di G. Beltrani, «Felix qui potuit rerum cogno-scere causas», in Ann. Fac. Lett. Napoli 15,1972-1973, pp. 56 s., che così definisce il brano:«l'arida elencazione di alcuni tra i più ovvii fenomeni naturali (...), affastellati l'uno dopo l'al-tro nei vv.478-482, mostra di essere concepita con un respiro molto meno ampio del branoprecedente» .
(6)
(7) ORFEO E LUCREZIO NELLE GEORGICHE 81
lucreziana e la sua preferenza per la seconda; l'esaltazione finale di una vita alienada grandi tensioni e in piena simbiosi con la natura; tutto accomuna i duemomenti del dialogo con un imprescindibile modello poetico e attesta quanto i vv.493 ss. sul fortunatus siano sintesi dei vv. 483-489. Si avverte nitidamente la pre-mura di Virgilio, un contemporaneo più giovane che si misura con la poesia dida-scalica, di prendere posizione rispetto alla grande lezione lucreziana e di manife-stare con ogni cautela le divergenze ideologiche da essa, senza sminuire i grandidebiti stilistici e artistici verso un modo nuovo ed esaltante d'intendere la poesiadidattica!". Di qui il tono dimesso nel presentare il proprio ideale poetico, ridi-mensionato dinanzi alla sublimità di quello del De rerum natura, anche per la con-sapevolezza della maggiore umiltà della materia georgica di fronte allo studio com-plessivo dei fenomeni naturali 17.
Non mi sembrano tuttavia solo queste le ragioni dell'ostentata modestia delpoeta: esistono nel brano elementi troppo precisi che permettono di collocarlo inuna sfera definita. Esaltazione ma al tempo stesso rifiuto della poesia lucreziana,con la motivazione della propria incapacità, e per conseguenza scelta di un generedichiarato inferiore, ma in realtà abbracciato con convinzione e descritto con tonientusiastici!" mi paiono infatti gli aspetti peculiari di quel nuovo genere di recusa-[io classica inaugurato proprio da Virgilio nell'ecloga sesta 19 e qui adattato a circo-
16 Indubbiamente frutto della sincera ammirazione per il grande predecessore (oltre chesegnale per orientare il lettore ne\l'individuazione dei soggetti del confronto) è la scritturadella prima parte del brano in perfetto stile lucreziano (procedimento che il Conte, op. cit., p.44, definisce "la cifra tradizionale di ogni complimento letterario»). Ma il mutamento di tono,nei versi successivi, su un registro addirittura bucolico, più che georgico (un'allusione a sestesso, dunque, alla sua prima opera, quasi un'autocitazione) mi pare intenda dare orgoglio-samente anche a\la scelta del poeta dignità pari a quella dell'elevata produzione di Lucrezio.
17 Il Barchiesi, "Lettura ...». cit., p. 61, sostiene a questo proposito: "... questa, più cheuna critica di Lucrezio, è una riduzione di Lucrezio». E poco oltre, a p. 62: "il nuovo poemavuole farsi piccolo. Essere colui che novit deos agrestes, o colui che sua bona novit, insomma,è qualcosa di meno che cognoscere i grandi segreti della natura».
18 In questo senso infatti va inteso il brano, e in particolare il culminante inglorius (cfT.,
p. es., Klingner, op. cit., p. 264) e non in quello negativo di pessimistico svilimento della pro-pria poesia, come lo legge G. Williams, Figures oi Thoughi in Roman Poetry, New Haven-Lon-don, 1980, p. 258. Centrata l'osservazione del Buchheit, op. cit., p. 62, che tale definizione ècostruita in contrapposizione agli ideali sublimi di Lucrezio.
19 Sull'argomento cfr. D'Anna, op. cit., pp. 14 e 79 ss. In particolare su\la recusatio / excu-satio augustea cfr. W. Wimmel, Kallimachos in Rom. Die Nachfolge seines apologetischen Dich-tens in der Augusteerzeit (Hermes Einzelschr. 16), Wiesbaden 1960; W. V. Clausen, «Callirna-chus and Latin Poetry», in Gr. Rom. Byr: St. 76, 1965, pp. 47-62; F. Cupaiuolo, Tra poesia epoetica, apoli 1980, pp. 50 ss. Si tratta della recusatio / excusatio, diversa da\la recusatioarcaica (come quella di Lucilio), caratterizzata da violenta polemica contro il genere rifiutato(l'epica, ovviamente). In età augustea, quando motivi di opportunità e di cautela spingono adusare toni ben più sfumati nel respingere le diretti ve imperiali che- indirizzano a\la rinascitadell'epica, la recusatio diventa excusatio: il poeta si schermisce dal comporre epica, motivandoil proprio rifiuto con la pochezza del proprio talento rispetto al genere elevato per eccellenza.Curiosamente, però, nel primo esempio compiuto di recusatio / excusatio (i vv. 3"12 dell'e"cloga sesta di Virgilio), interlocutore non è il princeps , ma Varo, destinatario del componi-mento. Un'anomalia la cui soluzione ritengo si possa individuare nel dialogo poetico conGa\lo, altro destinatario dell'ecloga; sul punto mi permetto di rinviare al mio "Le Talisieteocritee nell'ed. 6 di Virgilio», in U. Criscuolo (Ed.), Mnemosynon. Studi di letteratura e diumanità in memoria di Donato Gagliardi, Napoli 2001, p. 238, nota 7.
82 PAOLA GAGLlARDJ (8)
stanze anomale-", Nell'ecloga infatti -secondo la prassi della recusatio- il tipo dipoesia dichiarato irraggiungibile per le modeste doti del poeta e contrapposto allabucolica era l'epica, e proprio l'enorme distanza, sul piano estetico e ideologico, trai due generi posti a confronto giustificava il tono deciso, benché scherzoso, diApollo nel distogliere il poeta da un'impresa troppo superiore alle sue forze" (il cheovviamente non implicava una reale svalutazione della poesia pastorale, ma solol'indisponibilità di Virgilio a scrivere epica). Nel nostro brano mutano i termini delparagone: non più due generi, ma due modi di intendere lo stesso tipo di poesia;tra essi, per giunta, uno è un grande modello, non del tutto condiviso, ma profon-damente ammirato. Le differenze, pure profonde, si pongono dunque su pianidiversi: nei temi prescelti (sublimi quelli lucreziani, tenuia quelli di Virgilio); nelmodo di affrontarli (,dall'esterno' -per così dire- in Lucrezio, che aggredisce lanatura con le armi della scienza e della razionalità-": 'dall'interno' per Virgilio, cheaderisce pienamente alla materia, la ama e se ne appropria sul piano del senti-mento); nei fini (la comprensione logica dei fenomeni e dei segreti naturali perLucrezio, per debellare vane paure e superstizioni; l'amore della natura, in Virgilio,per imparare ad accettarne senza timori o dolore le leggi inesorabili). Si tratta cioèdi un confronto molto particolare, che esige una recusatio anch'essa fuori dalcomune, sia perché l'autore non deve respingere un genere poetico, ma solo unmodo di trattarlo, sia perché l'elemento ricusato è al tempo stesso un'opera gran-diosa, per non pochi aspetti fatta propria da Virgilio stesso nelle Georgiche. Di quila necessità di sfumare il rifiuto in un discorso ipotetico (cfr. w. 483-486) che allagrandezza della poesia non condivisa accosta la propria scelta, per la quale -è undato su cui dovremo tornare- recupera anche tratti del genere bucolico. In super-ficie niente lascia intuire la preferenza dell'autore, motivata con ragioni di neces-
20 Sono consapevole di avanzare qui un'ipotesi di lettura piuttosto lontana da quelle cor-renti, sostenuta solo dal Wimmel, art. cit., pp. l70-177 e ripresa per accenni dal Barchiesi,art. cit., p. 62, nota 27; entrambi però si limitano a notare l'ascendenza callimachea della ten-denza di Virgilio a ridimensionare il proprio genere rispetto a quello con cui si confronta,senza rilevare il dato quanto meno critico verso la poesia lucreziana che ciò comporta e ched'altronde è insito nella natura stessa della recusatio. Curioso il punto di vista del Beltrani,art. cit., p. 55, che ritiene sì il brano una recusatio, ma «di puro stampo ellenistico e neote-rico»: sarebbe dunque presente anche qui l'elemento di critica non di rado aspra contro ilgenere ricusato? Proprio la mancanza di questo aspetto, così poco consono all'animo virgi-liano, mi fa propendere per la considerazione del brano come una excusatio . Le altre inter-pretazioni di questi versi-chiave, e dunque del rapporto Virgilio / Lucrezio, si snodano attra-verso una vasta gamma di ipotesi, che va dalla parodia virgiliana all'adesione ammirata peril grande predecessore. Studiosi come P. Boyancé, «La religion des 'Georgiques' à la lumièredes travaux rècents», in Aufst. u. Niderg. d. Rom. Welt XXXI, Berlin-New York 1980, pp. 558ss., individuano nel brano convinzioni pitagoriche, mentre il Buchheit, op. cit., pp. 55-77 lolegge in funzione antilucreziana. Il Beltrani, art. cit ., passim, considera il passo un discorsoutopico di Virgilio e vi scorge riserve verso la riuscita di Lucrezio nel proposito di vincere lapaura della morte. Più equilibrata la valutazione del KJingner, op. cit., pp. 126 ss. e 265.
21 Cfr. ed. 6, 3-5 curn. canerern. reges et proelia, Cynthius aurem / vellit et admonuit: "Pasto-rem, Tityre, pingues / ducere oportet oves, deductum dicere carmen" .
22 Nel segno cioè acutamente inteso e descritto da Conte, op. cit., pp. 9-45, di duello quasiepico con i temi trattati, in un continuo sforzo per innalzare il lettore all'elevatezza dellamateria.
(9) ORFEO E LUCREZIO NELLE GEORGICI-IE 83
sità, non di libera scelta (egli semplicemente si dice non in grado di affrontare temicosì elevati); ma la collocazione stessa del confronto entro le laudes della vita agri-cola (vale a dire perfettamente a metà del poema, in chiusa della prima parte eprima del secondo proemio, al libro I1I) è eloquente per chiarire il pensiero del-l'autore e la sua considerazione positiva per la poesia georgico-bucolica. Nell'elo-gio del mondo contadino che segue al nostro brano, infatti, si inseriscono perfet-tamente la seconda parte del confronto poetico con Lucrezio (vv. 483 ss.), conl'aspirazione ad una poesia della natura, frutto di una vita serena nell'olium cam-pestre, e la figura del [ortunatus, che dà anzi il via ai versi finali del libro, il vero eproprio elogio della vita rustica. Ciò che rimane fuori dallo spirito del finale e vienedunque avvertito come termine di paragone estraneo è la parte 'lucreziana' delpasso. Anche il tono muta radicalmente: grandioso nell'elenco dei temi poetici diLucrezio (vv. 477-82), si fa più intimo e sereno nell'espressione del desiderio dipotersi dedicare finalmente alla vita e alla poesia della natura (vv. 485-89), il checostituisce un altro segnale importante per scoprire le simpatie del poeta=.
Ma è soprattutto la motivazione del rifiuto a trattare la materia di Lucrezio chesvela il pensiero intimo di Virgilio: la proclamata sfiducia nelle proprie capacitàfisiche di accostarsi a temi così sublimi implica a mio parere il dubbio sulla possi-bilità oggettiva per un essere umano di realizzare un progetto così ambizioso comela comprensione totale della natura?". Lincertezza sulle proprie possibilità mi sem-bra insomma incertezza sulle capacità umane, espressione di sfiducia di chi havisto il tentativo lucreziano fallire negli scopi prioritari e ha scoperto invece nellafusione intima (emotiva, non razionale) con la natura l'unica strada per trovare in
23 Di segno diametralmente opposto a questa è l'interpretazione da sempre sostenuta dalParatore e ribadita da ultimo in «L'episodio ... », cit., pp. 31 e 34 55.: partendo dall'affermazioneche Lucrezio è modello di Virgilio «in ciò che di più personale Lucrezio aveva distillato dalladottrina di Epicuro nel senso di un'adorante considerazione della natura come rivelatrice agliuomini di tutte le norme utili alla loro esistenza, e della poesia come loro rivelatrice» (p. 31),l'illustre studioso, che tralascia gli aspetti contraddittori del poema lucreziano. conclude cheGeorg. 2,475 ss., lungi dal rappresentare una polemica, è anzi l'esaltazione della poesia delDe rerunt natura e che i temi grandiosi lì elencati rappresentano «il vero mondo poetico cuiVirgilio nell'intimo intendeva dedicarsi» (p. 35). In tale ottica, Orfeo appare il simbolo di que-sta poesia lucreziana serenatrice, rappresenta l'artista ideale, capace di sublimare i propridolori in un canto consolatore immortale. Tutta la lettura del Paratore mi pare passibile diobiezioni: in primo luogo, se Virgilio esprimesse solo ammirazione per Lucrezio, non acco-sterebbe all'ideale del [elix (in questo caso esaustivo anche per lui) quello, più modesto mapiù attuabile, del [ortunatus, Né, se riconoscesse in quella lucreziana una poesia screnatrice,le porrebbe accanto il modello georgico al quale egli stesso si è dedicato, ma anch'egli rivol-gerebbe a quei temi tutti i suoi sforzi. E ancòra: se davvero intendesse fare di questa poesial'oggetto del suo canto futuro, non protesterebbe la propria inferiorità rispetto ad essa (loaveva già fatto nell'ecl. 6 verso l'epica, alla quale invece si sarebbe votato -è vero-, ma altempo delle Bucoliche non poteva sinceramente immaginare il suo futuro di poeta epico,mentre qui, a detta del Paratore, sarebbe già consapevole della futura scelta in senso lucre-ziano, che pure definisce superiore alle sue forze). Infine, la personificazione in Orfeo dellapoesia lucreziana non mi pare condivisi bile, non solo per i temi (erotici, e quindi aborriti daLucrez io). ma anche per l'atteggiamento verso la materia, dettato ad Orfeo da una passionecieca, a Lucrezio dalla volontà di comprendere e spiegare.
24 Non trovo per nulla chiara né persuasiva la spiegazione del Conington, ad /.: «Virgilgives a philosophic reason for his possiblc inaptitude to philosophy».
84 PAOLA GAGLlARDI (IO)
essa la serenità. E la preferenza per un rapporto non di dominio, ma di amore e disottomissione alla natura si chiarisce ancor meglio sul finire del con (Tonto (w. 485-489), nel volgere della poesia verso toni decisamente bucolici, intesi sì a recuperare-corn'è stato acutamente notato-è- un'identità per il poeta distinta da quella deivecopvoi, ma anche a privilegiare un rapporto puramente contemplativo con lanatura, un desiderio di annullamento in essa come strada verso la Ielicità-". Non acaso, lo stesso concetto tornerà nella chiusa del brano, nei versi dedicati al fortu-natus e al suo rapporto con gli dèi agrestes, a ribadire la convinzione profonda delpoeta, la sua scelta di vita, lontana dai tratti 'eroici' e 'missionari' dell'epicureisrnolucreziano. Ad un animo come il suo, travagliato e stanco delle atrocità di decennidi guerra e desideroso di silenzio e di pace, la parola di Epicuro non può offrirenulla di meglio che la prospettiva di una vita placida e appartata, orientata verso laaTapcd;ia e lontana da tensioni sublimi ma dolorose-",
Il generoso programma lucreziano di sanare con il verbo epicureo la crisi con-temporanea, interiore prima che istituzionale, aveva fallito il suo scopo agli occhidella generazione successiva, quella di Virgilio, e il Mantovano, testimone del defi-nitivo crollo della repubblica e dell'ultima cruenta fase delle guerre civili, nutritoanch'egli alla scuola del Giardino, aveva vissuto senz'altro con delusione quel falli-mento, né poteva più condividere la fiducia di Lucrezio -o di Cicerone, sul (Tonteopposto- nella filosofia e nella ragione (ma neppure nella religione o nella tradi-zione, come pretenderà Augusto) come soluzioni della crisi. Egli dunque respingel'aspetto 'eroico' e ottimistico dell'epicureismo, vano e ingannevole alla prova dei(atti, e della scuola conserva l'elemento forse più affascinante, quell'aspirazioneumbratile e rinunciataria ad una felicità caratterizzata in negativo come assenza diturbamenti, come rifiuto del superfluo e dei falsi piaceri. Ma un'altra amaralezione insegnava l'esperienza storica contemporanea con le sue assurdità, con il
25 Dal Barchiesi, art. cit., p. 57: nelle Bucoliche il fare poesia rientra in modo naturalenella vita dei personaggi, mentre nel mondo georgico il poeta non si identifica con i conta-dini di cui canta, che non hanno rapporto diretto con la creazione poetica. «Bisogna allorache il poeta dilati il mondo georgico per renderlo più simile a sé ... Accanto ai consueti valorigeorgici (lavoro, parsimonia, pietas) lo spazio descrittivo sconfina verso il modello bucolico:vita umbratile e otium sono anche condizioni fondamentali del far poesia».
26 L'esigenza di fusione con la natura e di accettazione delle sue leggi risolve a mio avvisoanche la dicotomia, da sempre fonte di tormento per i critici, tra la celebrazione del lavoronel libro I e l'idealizzazione di una vita agreste caratterizzata dalla spontanea generosità dellanatura qui nelle laudes del libro II (tra le disamine più penetranti sul tema, cfr. La Penna,«Senex Corycius», cit., pp. 39-5 J; Barchiesi, art. cit., pp. 45-55; Nicastri, art. cii., pp. 101 ss.).Se davvero (partendo da un atteggiamento 'bucolico', vale a dire contemplativo) si riesce adamare profondamente la natura e le sue leggi, abbracciandole senza chiedersene il perché,ma anzi comprendendone intimamente la necessità, non sarà difficile accettare anche illavoro, conseguenza necessaria e inevitabile dei ritmi naturali; esso dunque non avrà piùbisogno di essere giustificato o edulcorato per risultare meno duro.
27 A sfatare l'idea tradizionale di un substrato stoico nelle Georgiche, approdo di un cam-mino iniziato dall'epicureismo delle Bucoliche, e a rilevare l'importanza fondarnentale dellafilosofia del Giardino anche nel poema ha provveduto da tempo -corn'è noto- E. Paratore, «Aproposito del I. IV delle Georgiche», in Ann. Fac. Magistero Univo di Messina, 1939, pp. J 55.,
ripreso in «L'episodio ... », cit., pp. 31 5S., e poi in Virgilio, cit., passim e in «La problernat icasull'epicureismo a Roma», in Id., Romanae litterae, pp. 366-373 (in cui estende anche all'E-ueide la presenza di Lucrezio).
(lO)
e e di.485-
icon-occhidefi-
utritofalli-onte
tradi-inge
a deizionezadimaraon il
turaieconta-alloravaloriolico:
enna,1 ss.),ce adrché,
che ilà più
cam-della
re, «A1 SS.,
aticaall'E-
(l 1) ORFEO E LUCREZIO NELLE GEORGICHE 85
trionfo dell'irrazionale e dell'imprevedibile, con il capriccio del fato a guidare glieventi e a capovolgere le sorti di individui e di famiglie, di partiti e di Roma stessa:la rinuncia anche alla razionalità, inutile quando cerca di spiegare l'inesplicabile.Unica soluzione, in tanto sconvolgimento, la fuga dalla storia verso certezze immu-tabili come quelle naturali, da accettare senza vane obiezioni, per trovare in que-st'accettazione una prospettiva di serenità.
Da questo complesso di situazioni e di stati d'animo nasce pure, in Virgilio, lapersuasione dell'impenetrabilità e dell'incomprensibilità della natura, del fato,della divinità, della storia; la certezza dell'esistenza di una soglia, inconoscibile emisteriosa per l'uomo, oltre la quale risiede il senso ultimo della vita, la spiega-zione, invano cercata da sempre, del dolore, delle ingiustizie, di tutto ciò che lamente umana non riesce a concepire e giustificare. E in questo riconoscimento deilimiti umani e dell'arcano della natura, del significato ultimo delle cose consiste amio avviso la vera essenza della religiosità virgiliana, di quel senso del sacro cosìpalpabile in questa poesia, ma così difficile da definire concretamente e ancor piùda etichettare nell'ottica della religiosità tradizionale. Questo rappresentano,ritengo, gli dèi agrestes di v. 493, che tanto hanno turbato le ricostruzioni del nostrobrano in senso epicureo, dando luogo a spiegazioni di vario tenore ": sono le forzenaturali misteriose e primitive, imperscrutabili e inafferrabili, incomprensibili perchi non senta l'affiato più profondo con la natura e non pratichi la sottomissioneincondizionata alle sue regole, per chi non conosca ed accetti i limiti umani. Comel'agricola ideale del poema, come il senex Corycius, come le api, come tutte le figurepositive dell'opera; come Aristeo, come Virgilio stesso, contrapposto alla poesia'sublime' di Lucrezio-".
Proprio qui, nella percezione del sacro nell'esistenza umana e nell'accettazionedi esso senza pretese di impossibili spiegazioni, il pensiero virgiliano si scosta dallasua base epicurea per abbracciare due capisaldi dello stoicismo, gettando nelloscompiglio i critici che cercano una matrice unitaria per le sue convinzioni filoso-fiche e che non valorizzano il lavoro tutto personale di appropriazione delle ideedelle due scuole. L'ammissione dell'esistenza della divinità e la sottomissione alproprio destino, infatti, s'innestano sul fondo epicureo della formazione virgilianasenza smentirlo, ma anzi arricchendolo di quella sfumatura messianica che pro-viene ed attraversa la spiritualità del tempo. Dello stoicismo, a sua volta, Virgilio
28 Tra le tante, colpisce quella del Barchiesi, art. cit., pp. 62 s. (con i riferimenti biblio-grafici opportuni), per il quale gli dèi agrestes, essendo divinità minori, non contrasterebberocon il razionalismo lucreziano, in quanto rappresenterebbero <da realtà minuta della vitaagreste», «una forma 'ingenua' di contemplazione della natura». on è ben chiaro perché ilsolo fatto di essere divinità 'piccole' (ma pur sempre divinità) non dovrebbe urtare il razio-nalismo di Lucrezio.
29 Lo stesso concetto di fondo troveremo nell'Eneide: solo chi, come Anchise, Creusa,Elena e Andromaca, comprende il volere del fato e lo asseconda senza resistenze, trova la pro-pria serenità, se non la felicità (a parte il caso del protagonista, per il quale seguire il fatosignifica proprio rinunciare a ciò che più desidererebbe; ma per Enea e per il suo 'statuto' dipersonaggio, distinto da tutti gli altri, il discorso è diverso). La disperazione e la morte,invece, sono la meta obbligata di chi -come Didone, Amata o Turno- pretende di piegare ildestino ai propri disegni.
86 PAOLA GAGLIARDI (12)
respinge parecchi aspetti, in primo luogo quell'attivismo politico che a Roma avevaconsumato anch'esso il suo fallimento, nonostante gli sforzi di Cicerone; per lui lavia verso la felicità, meta comune delle due filosofie, continua ad essere quella delÀa6c; Blwaaç, del flumina amem silvasque inglorius, dell'ignobile otium, ma il viveresecondo natura (che non è -si ricordi- formulazione stoica, bensì base imprescin-dibile di tutte le scuole post-aristoteliche, e che Epicuro stesso raccomanda achiare lettere in più occasionr'") egli lo enfatizza fino ad includervi il fato e la divi-nità, in una visione che si avvicina a quella stoica, ma che in realtà fa propri soprat-tutto gli elementi comuni alle due dottrine. Perciò il pensiero virgiliano risultaimpossibile da definire scolasticamente, contesto com'è di influssi potenti, stoici edepicurei, piegati a convivere in una visione del mondo tutta personale, determinatadagli eventi e dalla loro presa su un animo di sensibilità superiore a quella comunee troppo provato dalla storia.
Per certi versi la condivisione delle due correnti filosofiche, inscindibili eimprescindibili in Virgilio, rappresenta il passato e il futuro nella sua vita e nel suosentimento, scaturita com'è per l'epicureismo dall'esigenza di un rifugio sicuronegli sconvolgimenti tragici delle guerre civili; per lo stoicismo dal desiderio dicontribuire alla fondazione della società nuova promessa dal regime augusteo eintesa dai contemporanei (almeno fino alla presa di coscienza, diversi anni piùtardi, della reale natura del nuovo governo-") sul modello di quella repubblicana.Ma in Virgilio (come in Orazio, d'altronde) l'entusiasmo per il nuovo corso e lavolontà di collaborare con il princeps non si trasformeranno mai in fiducia cieca:le insopprimibili diffidenze e le cicatrici troppo dolorose del passato lascerannointatta quell'aspirazione alla pace epicurea, per giunta così consona alla naturaintima del Mantovano-", E il fascino irrinunciabile del verbo di Epicuro consisteràsempre, ai suoi occhi, nell'esigenza, per trovare la serenità, di collocarsi al di fuori
30 Cfr., ad es., [rr. Val. 21 e 33; [rr. Usener 200-203,468, 548; il (r. Val. 33 e i [rr. Usener 20 Ie 468 sono citati (e condivisi) nelle sue lettere da Seneca, uno stoico, cioè, sia pure sui gene-ris, a conferma dell'appartenenza di questo aspetto del pensiero a tutte le filosofie ellenisti-che (si pensi alla teorizzazione estrema di esso da parte dei Cinici). Perfettamente calzanti alnostro discorso, benché riferite ai concetti di libertà e aÙTapKEw. le parole di La Penna,«Senex Corycius», cit.: «libertà ed aÙTapKEw non sono valori propri di singole filosofie elle-nistiche, ma valori ad esse comuni: le differenze consistono nelle vie per realizzarli. In parti-colare non va dimenticato che, se la filosofia è per i poeti augustei un nutrimento essenziale,generalmente però, non si pone per essi un problema di adesione a sètte, anzi neppure si poneun problema di ortodossia e di eresia: con la filosofia essi rispondono ad esigenze attuali chenon sempre sono durature».
31 Com'è noto, sarà solo la seconda generazione augustea, nata alla fine delle guerre civili(quella di Tibullo, Ovidio e Properzio, per intenderei) ad aprire gli occhi sul valore esclusiva-mente di facciata della proclamata restaurazione etico-politica promossa dal princeps . Masolo un secolo dopo uno storico coraggioso come Tacito (Ann. I, lO) avrà la franchezza di sfa-tare il mito del sovrano 'buono' per smascherare l'inganno del governo di Augusta e la cru-deltà dei mezzi impiegati dal princeps per giungervi.
32 Sulla lacerazione del pensiero virgiliano e sulla convivenza irrisolta, in esso, delle dueesigenze di partecipazione e di fuga dal presente, cfr. Paratore, Virgilio, cit., pp. 229 s. eancòra La Penna, «Senex Corycius», cit., p. 50, che avverte nel poeta «da un lato il bisogno diuna vita ordinata e operosa, ispirata dalla venerazione del passato e dalla fiducia nella storia;dall'altro il bisogno tenace, ineliminabile del rifugio, del porto epicureo dove ripararsi dalletempeste della storia, giacché la fiducia nella storia non era veramente rinata».
(13) ORFEO E LUCREZIO NELLE GEORGICI-IE 87
della storia: su questo punto, infatti, !'ideologia astratta s'incontra con il bisognopiù profondo dell'ultima generazione repubblicana, la fuga da una realtà dolorosa.E se la storia ha già infranto con la sua ingombrante realtà il sogno bucolico virgi-liano, ciò non impedisce al poeta di crederei ancòra e di riproporre quell'ideale nel-l'àmbito più maturo delle Ceorgiche, in squarci di un mondo senza storia comequesto finale del libro II, nella aÙTapKwx beata del senex Corycius, nell'appagantelaboriosità delle api o nell'ingenuo e fruttuoso entusiasmo di Aristeo.
Perciò egli non può condividere l'esperimento lucreziano di divulgare la filo-sofia epicurea e soprattutto di immetterla nel flusso della storia, proponendolacome soluzione della crisi della repubblica e come nuova base ideologica dopo ilfallimento dello stoicismo a Rorna ". Tutto ciò non può che apparirgli un tradi-mento dello spirito più genuino e più prezioso della scuola. Di qui evidentemente-a suo giudizio- anche il fallimento di Lucrezio, che nell'intento di strappare ladottrina epicurea dall'àmbito ad essa proprio della natura per collocarla in quelloopposto della storia, finisce per fraintendere pure la giusta visione della natura,non più amata come sfondo irrinunciabile per l'esercizio della <XT<Xpaçla, ma stu-diata come un forza ostile, nell'utopica pretesa di dominarla con la ragione. Effettoinevitabile di questo percorso deviato del pensiero, un'eccessiva fiducia nelle pro-prie capacità e la conseguente, dolorosa delusione, agli antipodi della promessaserenità epicurea, fondata su un senso della misura appreso appunto dai ritminaturali. È questo infatti il danno più grave della rinuncia al contatto con la natura:la perdita del senso dei propri limiti e con esso di quella lezione fondamentale cheprevede sì l'autosufficienza, ma entro e non fuori dai ritmi naturali.
Si tratta di un punto cruciale nel pensiero virgiliano e degli augustei in gene-rale, in questo senso autentici eredi del magistero etico delle filosofie ellenistiche;la continua insistenza del Mantovano sulla necessità di mantenere l'equilibrio inte-riore, che finisce per diventare il messaggio principale della sua opera (e delle Geor-giche in particolare) non deriva però solo da una lezione di scuola, ma dall'incon-tro del dato teorico con l'esperienza storica personale, testimone di eccessipericolosi e crudeli. Perciò qualsiasi deviazione da questo cammino, qualsiasirinuncia all'equilibrio razionale gli appare il temibile inizio della rovina, comedimostrano i suoi personaggi vittime di amore cieco, ad esempio, e com'è efficace-mente sintetizzato da Orfeo. E proprio su quest'elemento fondamentale il paralleloOrfeo I Lucrezio si fa più stretto e trova il suo senso più autentico: dalla smisuratafiducia nelle pur eccelse capacità entrambi giungono ad un atteggiamento di rot-tura e di disobbedienza (che sia agli dèi, alle leggi civili e naturali o ai precetti fon-damentali della propria scuola di pensiero, la sostanza non muta) che li condurràal fallimento e alla sofferenza, Perché solo nella serenità dello spirito, libero da pas-sioni eccessive e da pretese abnormi, la poesia può divenire fruttuosa, in primo
33 Giustamente Barchiesi, art. cit., p. 75, distingue il progetto lucreziano, di liberare gliuomini dalle superstizioni, da quello di Virgilio, il quale affranca l'umanità dall'angoscia dellastoria.
88 PAOLA GAGLIARDI (14)
luogo per l'animo stesso del suo artefice, e poi per i fruitori, da lui trascinati allacontemplazione del bello e del vero. E l'ideale di poesia serenatrice. in grado disublimare i dolori reali, può avverarsi solo in armonia con i precetti di vita epicu-rei: tradìto lo spirito della dottrina, nessuna promessa può più avere corso. È ciòche accade a Lucrezio, con il suo poema meraviglioso, ma riuscito solo a metànegli scopi: attraversato da una dolorosa e implacabile tensione, non riesce adonare al poeta né ai lettori la serenità assicurata da Epicuro, e anzi finisce persmentire se stesso in una spirale drammaticamente angosciosa. Lo stesso discorsovale per il personaggio-simbolo di Orfeo, per il quale il meraviglioso dono dellapoesia, ad un passo dal restituirgli miracolosamente la felicità, viene annullato dauna passione cieca, da una mancanza di controllo responsabile della disperazionee della morte, ma pure della crisi creativa.
Anche su questo punto, infatti, la simbologia virgiliana mi sembra trasparente:il concetto che il cantore, dopo la morte di Euridice e ancor più dopo il ritorno dal-l'Ade, appartatosi nei luoghi più impervi, trascorre le sue giornate cantando esclu-sivamente l'amata dall'alba al tramonto è martellato con insistenza-" e ripreso nel-!'immagine finale, patetica e un po' barocca, della sua testa mozza trascinata dalfiume, che ancòra dopo la morte, con la lingua ormai fredda, fa riecheggiare le rive
34 Cfr. Georg. 4, 464-466 ipse cava solans aegrum testudine amorem / le, dulcis coniunx, teS% in /itore secum, / le veniente die, le decedente canebat. Questi versi, riferiti al dolore di Orfeoprima della discesa all'Ade, sono tra i più 'elegiaci' dell'intero poernetto (non a caso G. Bru-gnoli, «Corneli Galli Fragmenturn», in Mus. Crit. 18, J 983, p. 236, li ritiene di Gallo; sull'in-dubbio colorito elegiaco dell'aggettivo du lcis , in particolare in questa espressione dulcisconiunx, cfr. E. Zaffagno, s. v. dulcis / dulcedo, in Enc. Virg. II 1985, pp. 151 s.): ma, a parte gliaspetti più tipici della poesia d'amore, che Virgilio potrebbe aver volutarnente riecheggiato(evidentemente in riferimento al cantore di Licoride), colpiscono le ripetizioni martellanti, l'a-nafora insistita di te e la struttura del v. 466, simmetrico nei due ernistichi, nell'omeoteleutodei participi e nelle sonorità che si richiamano grazie alla duplice allitterazione (te ... die, tedecedentei: per un'analisi formale del distico e per una ricostruzione della sua fortuna cfr; A.Traina, Poeti latini (e neolatini), 5, Bologna 1998, pp. 77 ss. Già qui, insomma, quando ancòrala poesia di Orfeo ha tutta la sua efficacia (subito dopo infatti si dirà di come essa gli consental'ingresso all'Ade e il recupero di Euridice), essa appare piuttosto limitata dal monoternatisrno(non escluderei un accenno di critica da parte di Virgilio per quest'unità esclusiva di argo-mento nell'insistita precisazione temporale veniente die / decedente). La sensazione si fa piùforte nel finale del poernetto, dopo lo a1l"apay~6ç di Orfeo ad opera delle Baccanti: tum quoquernarmorea caput a cervice revolsum / gurgite cum medio portans Oeagrius Hebrus / volveret,Eurydicen vox ipsa et frigida lingua, / a miseram Eurydicen! anima [ugiente vocabat / Eurydicentoto rejerebant [lumine ripae (w. 523-527). Anche qui il gioco delle ripetizioni, sia pure in uncontesto più articolato (manca, evidentemente, il riecheggiamento di brani elegiaci), sta adindicare l'ulteriore isterilirsi dell'ispirazione di Orfeo, ridotta infine al solo nome dell'amata.Mi pare questa \'interpretazione più persuasiva del finale della [abula, laddove quella propostada R. Coleman, «Gallus, the Bucolics and the Ending of Fourth Georgic», in Am. Journ. of Phi-/01.83, 1962, p. 68 (la lingua di Orfeo già ammazzato che continua a cantare simboleggerebbela poesia che vive oltre la morte) ritiene positiva un'espressione poetica a mio avviso discuti-bile come la ripetizione rnonocorde del nome di Euridice. Linterpretazione di Paratore, «Le-pisodio», cit., pp. 31 ss. (Orfeo come simbolo della poesia rasserenatrice dalle passioni, e dun-que in qualche modo vicino al saggio epicureo, ma al tempo stesso vittima di un'invincibilefollia amorosa) è posta validamente in discussione dal Domenicucci, art. cit., p. 248, che leggeinvece nell'ossessi va ripetizione del nome di Euridice dopo la morte di Orfeo il segno della ste-rilità di una poesia fossilizzatasi su un unico soggetto. Condivisibile anche la lettura di B. Otis,Virgil. A 5tudy in civilized Poetry, Oxford J 964, p. 205, che nell'esasperata iterazione del nomevede «the obsession wich was destroyed Orpheus' interest in life».
(14) (15) ORFEO E LUCREZIO NELLE GEORGICHE 89
rive
del nome della sposa. Lo stretto legame tra i due punti mi pare indirizzi decisa-mente verso una sola interpretazione, quella dell'inaridirsi della vena poetica diOrfeo, che si riduce ad un monotematismo ripetitivo e scarno, culminante nellanuda ripetizione del nome di Euridice. È il segno del danno prodotto dalla demen-tia (nel suo caso erotica) anche sulla produzione artistica, che è riflesso direttodello stato d'animo del poeta. La chiusura in se stessi e nella propria presunzionecreativa, la perdita di contatti con l'universo circostante, e soprattutto con l'equili-brio ispirato dalla natura, comporta anche una crisi nell'ispirazione poetica, adispetto delle doti eccelse persino di un artista semidivino come Orfeo. Fuor dimetafora, non mi sembra difficile leggere anche in questo un'allusione a Lucrezio,ovviamente in un contesto e con elementi mutati, perché se Virgilio può immagi-nare una fine simile per la poesia mitica del suo personaggio, la bellezza potentedel De rerum natura è troppo evidente per poter essere posta in discussione. Nonin un'analogia così stretta, dunque, va rinvenuto il legame con Orfeo su questopunt03S, ma nel concetto di fondo del fallimento della poesia, che se nel caso delcantore tracio avrebbe dovuto consolari o del dolore, laddove non fa che inasprirnele sofferenze con la nostalgia, per Lucrezio realizza un successo, sia pure gran-dioso, solo sul piano estetico e letterario, ma resta senza effetti su quello etico eideologico che tanto stava a cuore al poeta per la propria serenità e per quella deilettori.
Così al discorso esistenziale e filosofico si mescola quello letterario nell'analisivirgiliana, e la fabula Orphei si scopre metafora completa, tradotta sul piano nar-rativo, del confronto con Lucrezio nel libro II: le scelte di vita e di poesia si fon-dono e s'influenzano a vicenda, e gli errori delle prime si riflettono puntualmentesui risultati etici ed ideologici delle seconde. La rispondenza tra i due finali ne escerafforzata e il messaggio del primo si rivela tanto importante per Virgilio, che eglisente l'esigenza di ribadirlo in chiusa del poema. La figura e l'opera di Lucrezio,così presenti a diversi livelli nell'intero poema georgico, ne impregnano dunquenon solo il tessuto stilistico e formale, ma segnano anche il discorso ideologico,ponendosi come modelli di vita viziati da un iniziale errore di calcolo sulle possi-bilità umane e da un fraintendimento esiziale della sostanza più profonda dellafilosofia epicurea. A questo modello è contrapposta una nuova idea di poesia dellanatura, fatta più umile, ma pure più decisa, nella ricerca della felicità, dalle delu-sioni della storia. Dalla critica però, sempre velata e sommessa, benché convinta,non è mai disgiunta un'invincibile ammirazione per la grandezza artistica del pre-decessore che con tanto trasporto e con ingenium elevato ha saputo infonderenuova vita alla poesia didascalica, riscattandola dall' erudita freddezza alessan-
ente:dal-
selu-nel-dal
còrasentatismoargo-a piùoque
1verel,dicenin unta admata.posta{Phi-rebbescuti-, «L'e-dun-
cibileleggea ste-.Otis,
ome
35 Anche perché Orfeo -non si dimentichi- simboleggia in primo luogo la poesia elegiaca(io credo che adombri per più aspetti Gallo, come tenterò di dimostrare in un lavoro di pros-sima pubblicazione), per la quale la dedizione ad un unico amore totalizzante comporta ilnecessario ridursi delle tematiche del canto: insomma, la polemica con la poesia eroticaspiega i limiti, ben più gravi rispetto a Lucrezio, attribuiti all'ultima produzione del miticocantore.
90 PAOLA GAGLIARDI (16)
drina. L'accostamento al mitico Orfeo, simbolo del poeta per antonomasia, checostituisce il più elevato complimento letterario possibile, è prova eloquente diquest'ammirazione, ma anche l'innegabile simpatia per il personaggio-" tradisceun'analoga disposizione d'animo verso il tormentato autore del De rerum natura.Perché, se Virgilio può contestarne gli errori a livello ideologico, per tanti altriaspetti -letterari e umani- si sente profondamente vicino a Lucrezio: ne condividefondamentalmente la concezione di una poesia che non sia solo esercizio diestrema raffinatezza formale, ma che anzi di questa faccia l'involucro per unamateria intimamente sentita e trattata con entusiasmo. Soprattutto, figlio dellastessa epoca travagliata, di Lucrezio comprende la tormentata spiritualità e l'ansiadi riscatto affidata alla poesia, benché in una prospettiva a suo giudizio errata: eglistesso, in fondo, da un altro punto di vista, considera la sua arte una risposta allacrisi interiore del suo tempo. E se l'appartenenza alla generazione successiva dà alpoema georgico -nonostante le tante, volute ombre che lo attraversano- un fondodi serenità e di fiducia lontano dall'angoscia lucreziana e giustificato dalle gran,diose prospettive di pace e di gloria alimentate dal nascente regime augusteo, Vir,gilio si rende ben conto del suo privilegio rispetto a chi, come Lucrezio, non hapotuto vivere quelle speranze. Da questa consapevolezza la simpatia e la cornpren-sione per il grande poeta risultano senza dubbio accresciute e impregnano -iocredo- pure l'aspetto più 'umano' del personaggio di Orfeo: così anche dietro gliaccenti affettuosi verso il miserabilis Orpheus haudquaquam ob meritum si puòscorgere aneòra un riflesso, più delicato e simpatico, della grandiosa figura diLucrezio.
36 La grande differenza di trattamento tra i personaggi di Aristeo ed Orfeo, rilevabileanche ad una lettura superficiale, è stata posta in luce dall'Otis, op. cit., pp. 190-208, che defi-nisce la prima parte dell'epillio di Aristeo il pezzo più 'omcrico' dell'intera produzione virgi-liana (per lo stile, l'assenza di sentimenti dei personaggi e per l'atteggiamento distaccata,mente oggettivo dell'autore), laddove il poemetto di Orfeo si distingue per un'intensapartecipazione e uno stile decisamente soggettivo. Cfr. A. La Penna, «Il canto, il lavoro, ilpotere» (Introduzione a Virgilio, Le Georgiche, a cura di L. Canali, Milano 1983, p. 101: "Pochipezzi di Virgilio sono permeati quanto l'epillio di Orfeo dalla pietà del narratore espressaattraverso il commento lirico»). L'espediente strutturale per ottenere quest'effetto di com,mossa partecipazione e per giustificare il brusco mutamento di tono è ovviamente loschermo, che l'autore si crea, di un secondo narratore, Proteo, attraverso la cui voce può farsentire la propria in modo diverso dal racconto impersonale fin qui fatto. Anche perché Pro,teo, vittima della violenza di Aristeo, può apertamente manifestare la sua antipatia per que-st'ultimo e, per converso, la sua simpatia per Orfeo, danneggiato anch'egli da Ari .tco.