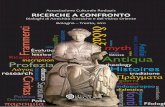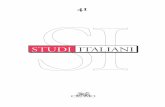Recuperi cristoforei, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata» n.s. 39, 1985, pp. 233-242
Orfeo nella ceramografia greca (Mythos 3, 2009, 13-32)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Orfeo nella ceramografia greca (Mythos 3, 2009, 13-32)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMODIPARTIMENTO DI BENI CULTURALISEZIONE DI STORIA ANTICA
Rivista di Storia delle Religioni
3 n. s.
2009(16 serie continua)
S A LVAT O R E S C I A S C I A E D I T O R E
In copertina:
Orphée chez les Thraces, anfora attica - Gela
disegno tratto da C. Daremberg - E. Saglio - E. Pottier, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines
IV 1 - Paris 1877-1919, p. 243, fig. 5430
ISSN 1972-2516
3n. s.2009
MYTHOS
SA
LV
AT
OR
E S
CIA
SC
IA E
DIT
OR
E
MYTHOS
Direttore responsabileNicola Cusumano [email protected]
Segretaria di redazioneDaniela Bonanno [email protected]
Comitato scientificoNicole Belayche (École Pratique des Hautes Études -
Section des sciences religieuses)Corinne Bonnet (Université de Toulouse - UTM)David Bouvier (Université de Lausanne)Antonino Buttitta (Università di Palermo)Claude Calame (École des Hautes Études en Sciences
Sociales - Centre L. Gernet)Giorgio Camassa (Università di Udine)Ileana Chirassi Colombo (Università di Trieste)Riccardo Di Donato (Università di Pisa)Françoise Frontisi-Ducroux (Collège de France -
Centre L. Gernet)Cristiano Grottanelli (Università di Firenze)Cornelia Isler-Kerényi (Universität Zürich)François Lissarrague (École des Hautes Études en
Sciences Sociales - Centre L. Gernet)Vinciane Pirenne-Delforge (FNRS - Université de Liège)François de Polignac (École Pratique des Hautes Études -
Section des sciences religieuses)Sergio Ribichini (CNR - Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche
e del Mediterraneo Antico)John Scheid (Collège de France - Centres Gernet-Glotz)Giulia Sfameni Gasparro (Università di Messina)Dirk Steuernagel (Universität Frankfurt)Paolo Xella (CNR - Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del
Mediterraneo Antico - Università di Pisa)
Comitato di redazioneDaniela Bonanno (Università di Palermo)Corinne Bonnet (Université de Toulouse - UTM)Marcello Carastro (École des Hautes Études en Sciences
Sociales - Centre L. Gernet)Maria Vittoria Cerutti (Università Cattolica - Milano)Nicola Cusumano (Università di Palermo)Ted Kaizer (Durham University)Gabriella Pironti (Università di Napoli Federico II)Francesca Prescendi (Université de Genève)
Prezzo del volume: Italia privati € 20,00 enti € 30,00 Estero privati € 30,00 enti € 40,00
Distribuzione: Salvatore Sciascia Editore s.a.s. - Corso Umberto I n. 111 - 93100 Caltanissetta
ISBN 978-88-8241-339-2
ISSN 1972-2516
© Salvatore Sciascia Editore s.a.s. Caltanissetta© e-mail: [email protected]© http://www.sciasciaeditore.it
Sede: Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Beni Culturali StoricoArcheologici Socio-Antropologici e GeograficiTel. + 39 091 6560301 - 302 - 303
Sezione di Storia Antica - Viale delle Scienze90128 Palermo - Tel. e Fax + 39 091 421737
Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Beni Culturali Storico-Archeologici Socio-Antropologici e Geografici (es. fin. 2009)
[email protected]/?id_pagina=617&id_menu_pre=611
Registrazione TribunaleAutorizzazione n. 28 del 18 dicembre 2009
IMPAGINAZIONE Fotocomp - Palermo
R iv i s ta d i S to r i a de l l e Re l i g i on i
MYTHOS 3
S A L V A T O R E S C I A S C I A E D I T O R E
numero 3 - 2009nuova serie(16 serie continua)
Università degli Studi di PalermoDIPARTIMENTO DI BENI CULTURALISezione di Storia Antica
4
I N D I C E
Dossier
Orfeo e Orfismo. Iconografia e culto
9 A. Bellia, Introduzione13 C. Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca33 M. de Cesare, Orfeo o Tamiri? Cantori traci in Sicilia55 T. Seebass, Über das Prinzip des Guten und Schönen in der griechischen antiken Ritualmusik: Wirklichkeit und
bildliche Darstellung
Varia
67 G. Camassa, Scrittura e mutamento delle leggi in quattro culture del mondo antico (Mesopotamia, Anatoliaittita, Israele biblico, Grecia)
93 E. Calcaterra, Ecate Signora dei limina. Una rilettura delle fonti più antiche117 E. Cavallini, Patroclo ‘capro espiatorio’: osservazioni sul libro XVI dell’Iliade131 L. Bricault, Un trône pour deux
Tra passato e presente. Metodologia e storia degli studi
145 F. Prescendi, La vittima non è un’ostia. Riflessioni storiche e linguistiche su un termine di uso corrente157 E. Montanari, Il concetto di “mistero” in Raffaele Pettazzoni
Recensioni e schede di lettura
171 C. Bonnet - S. Ribichini - D. Steuernagel (a cura di), Religioni in contatto nel Mediterraneo Antico. Modalità didiffusione e processi di interferenza, Pisa - Roma 2008 - Trivium 4 (2009) (D. Bonanno)
177 A.M.G. Capomacchia (a cura di), Animali tra mito e simbolo, Roma 2009 (D. Bonanno)180 X. Dupré Raventos - S. Ribichini - S. Verger (a cura di), Saturnia Tellus. Definizioni dello spazio consacrato in
ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico, Roma 2008. (G. Sfameni Gasparro)184 F. Frontisi-Ducroux, Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope…, Paris 2009 (V. Andò)186 G. Pedrucci, Cibele frigia e la Sicilia. I santuari rupestri nel culto della dea, Roma 2009 (N. Cusumano)188 G. Schörner - D. Sterbenc Erker (Hrsgg.), Medien religiöser Kommunikation im Imperium Romanum, Stuttgart
2008 (F. Van Haeperen)189 M.-C. Villanueva-Puig, Ménades. Recherches sur la genèse iconographique du thiase féminin de Dionysos des
origines à la fin de la période archaïque, Paris 2009 (N. Bonansea)
195 Lavori in corso (a cura di D. Bonanno)
205 Gli autori
207 Pubblicazioni ricevute
208 Istruzioni per gli autori
5
Dossier
Orpheus and Orphism. Iconography and Cult
9 A. Bellia, Introduction13 C. Isler-Kerényi, Orpheus in Greek Vase-Painting33 M. de Cesare, Orpheus or Tamyris? Thracian Singers in Sicily55 T. Seebass, The Good and the Beautiful as Governing Principles in Ancient Greek Ritual Music: Reality and
Pictorial Representation
Varia
67 G. Camassa, Writing and Laws Change in Four Ancient Cultures (Mesopotamia, Hittite Anatolia, Biblical Israeland Greece)
93 E. Calcaterra, Hekate as Mistress of Limina. A New Reading of Ancient Sources117 E. Cavallini, Patroclus as a Scapegoat: Some Remarks on Iliad XVI131 L. Bricault, A Throne for Two
Between Past and Present. Methodology and Modern Historiography
145 F. Prescendi, The Victim is not a Host: Historical and Linguistic Reflections upon a Common Term157 E. Montanari, The Concept of “Mistery” in Raffaele Pettazzoni
Reviews
171 C. Bonnet - S. Ribichini - D. Steuernagel (a cura di), Religioni in contatto nel Mediterraneo Antico. Modalità didiffusione e processi di interferenza, Pisa - Roma 2008 – Trivium 4 (2009) (D. Bonanno)
177 A.M.G. Capomacchia (a cura di), Animali tra mito e simbolo, Roma 2009 (D. Bonanno)180 X. Dupré Raventos - S. Ribichini - S. Verger (a cura di), Saturnia Tellus. Definizioni dello spazio consacrato in
ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico, Roma 2008. (G. Sfameni Gasparro)184 F. Frontisi-Ducroux, Ouvrages de dames. Ariane, Hélène, Pénélope…, Paris 2009 (V. Andò)186 G. Pedrucci, Cibele frigia e la Sicilia. I santuari rupestri nel culto della dea, Roma 2009 (N. Cusumano)188 G. Schörner - D. Sterbenc Erker (Hrsgg.), Medien religiöser Kommunikation im Imperium Romanum, Stuttgart
2008 (F. Van Haeperen)189 M.-C. Villanueva-Puig, Ménades. Recherches sur la genèse iconographique du thiase féminin de Dionysos des
origines à la fin de la période archaïque, Paris 2009 (N. Bonansea)
195 Work in Progress (a cura di D. Bonanno)
205 Contributors
207 Publications Received
208 Instructions for Contributors
C O N T E N T S
13MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
1 CALAME 2005; BURKERT 2005.2 ISLER-KERÉNYI 1990.
Orfeo e l’Orfismo sono temi ricorrenti nell’antichistica, riattualizzati negli ultimi annidal celebre papiro rinvenuto a Derveni, in Macedonia, in una tomba del IV secoloa.C., che espone, a quanto pare, una cosmogonia orfica1. Ricorrente è pure la discussione
dell’iconografia di Orfeo, recentemente trattata nel Lexicon Iconographicum MythologiaeClassicae (LIMC), strumento di lavoro di grandissima utilità, nel cui impianto si esprime peròil dilemma, onnipresente negli studi di antichistica, di dover conciliare l’imperativo di oggettivitàcon i condizionamenti dati sia dalla storia della disciplina, sia dal proprio tempo2. Una premessaimplicita di origine romantica è, per esempio, che la mitologia precede la storia a noi accessibilema ne conserva il ricordo. Anche gli eroi, fra i quali Orfeo più degli altri, avrebbero realmentevissuto in tempi primordiali e la loro memoria sarebbe ormai fissata e immutabile. Ne consegueche le fonti letterarie e quelle iconografiche si equivalgono e si possano usare le une – di solitoquelle letterarie – per interpretare le altre, cioè le immagini.
Orfeo nella ceramografia greca
Cornelia Isler-KerényiRiassuntoLa ceramografia greca del V e IV secolo a.C. ci presentaun’immagine di Orfeo che coincide solo parzialmente conquella nota dalle fonti letterarie. Con una sistemazione deivasi in ordine cronologico anziché tematico si mette inevidenza la relazione che pare sussistere fra gli episodi delmito scelti dai ceramografi e la forma – e con ciò la funzionee la destinazione – dei supporti delle immagini. Diventainoltre possibile agganciare almeno ipoteticamente l’icono-grafia vascolare alla situazione storica di Atene. Ne emergeinfine chiaramente che, ai ceramografi e alla loro clientela,Orfeo interessava in quanto prototipo del poeta musico,cioè del vate. Mancano invece, nella ceramica di Atene,indizi di un suo legame con riti iniziatici bacchici.
AbstractThe Greek ceramography of the V and IV century B.C. showsus an image of Orpheus just partially correspondent to theimage of the literary sources. A chronological, rather thanthematic, classification of the vases shows a possiblerelationship between the choice of mythological subjectsby the ceramists and the shape of the support of theimages – thus their function and destination. Furthermore,it is also possible to connect, almost hypothetically, theiconography of vase painting to the particular history ofAthens. The final conclusion is that the ceramists and theircustomers were interested in Orpheus as a prototype ofthe poet-musician and prophet. On the contrary, in theAthenian ceramic, traces of the relationship to the bacchicrituals are absent.
Parole chiave● Orfeo ● ceramica attica ● Atene classica ● musica ● oracolo
Keywords● Orpheus ● attic ceramic ● classic Athens ● music ● oracle
Noi partiamo invece dal presupposto che la realtà degli eroi – e Orfeo non fa eccezione –non è data dal fatto di essere realmente vissuti in tempi preistorici ma dalla circostanza che,come i personaggi della letteratura, danno corpo a certe esperienze umane fondamentali: sicollocano, come tali, fuori dalla storia e restano sempre attuali3. Ricordare, tramite le immagini– reali, come quelle sui vasi, o evocate dalla poesia nell’immaginazione – le vicende degli eroinon significava raccontare fantasie individuali, ma fare appello alle esperienze di coloro cuierano destinate, esperienze appartenenti ovviamente a determinati momenti storici in ambiticulturali definiti. Nel considerare l’iconografia di un personaggio mitologico è perciò impor-tante tener conto della cronologia e del supporto delle immagini, cioè dell’ambito di utilizzo.
La questione che ci poniamo nel riconsiderare l’iconografia di Orfeo dell’arte greca arcaicae classica, ben documentata soprattutto dalla ceramica, è la seguente: quale immagine di Orfeoavevano i decoratori dei vasi e i loro destinatari originali? Dai repertori a disposizione emergeimmediatamente una storia discontinua e spesso enigmatica, di difficile interpretazione4. Comespiegare, ad esempio, che nella ceramografia attica, pur ricca di attestazioni, manchi sia l’am-maliatore di animali tanto popolare presso i mosaicisti di età imperiale e tardo-antica, sia losposo sfortunato di Euridice? Per quale motivo la vendetta delle donne tracie venne rappresen-tata ben prima e più spesso della musica che ne era stata la causa? Il pubblico cui le varie cate-gorie di opere d’arte si rivolgevano aveva evidentemente concezioni di questa mitologia diversenon solo dalle nostre, ma inoltre variabili nel tempo. Pur utilizzando la raccolta messa a dispo-sizione dal LIMC, si adotterà perciò qui come criterio di sistemazione non il tema, ma la cro-nologia. Questo criterio permette assai più facilmente di osservare come un soggetto datovenisse gradualmente modificato o potesse talvolta subire cesure sintomatiche.
Preludio arcaico
Orfeo, menzionato per la prima volta da Ibico nella prima metà del VI sec.5, gode adAtene di particolare popolarità durante il quinto secolo a.C. Se ne conoscono peròantecedenti anche lontani, rivelatori del senso profondo della figura. I più antichi, i
suonatori di lira del repertorio cicladico sono purtroppo destinati a rimanere enigmatici6.L’idea che la musica possa toccare non solo gli umani ma anche gli animali e con ciò trascenderei limiti del vivere culturale risale invece in area greca almeno all’età micenea7. Lo dimostra unapittura parietale nel palazzo cosiddetto di Nestore a Pylos con un suonatore di lira seduto suuna roccia in prossimità di un grande uccello in volo8. Una raffigurazione meno laconica di unpersonaggio simile si trova inoltre su una pisside del minoico tardo rinvenuta in una tomba acamera presso Chania a Creta (Fig. 1): oltre al suonatore si vedono uccelli grandi e piccoli in
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
14 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
3 Così anche GRAF 1987, 100: “The reality Orpheus and his fellow-singers belongs to is mousiké, music and poetry”.4 GRAF 1987, 80 enumera, nelle attestazioni letterarie, cinque temi distinti: Orfeo perde la sposa e tenta di ricon-
quistarla, Orfeo incantatore della natura, morte di Orfeo per mano di menadi o di donne tracie, testa vaticinantedi Orfeo e Orfeo e gli Argonauti; LISSARRAGUE 1994, 269-272.
5 GAREZOU 1994, 81: si tratta della brevissima menzione onomáklyton Orfén da parte di Ibico, citata da Prisciano.6 THIMME 1976, 491 s., nri. 253-255.7 GROPENGIESSER 1977, 607 nota 116.8 BLEGEN 1956, tav. 41. 3.
un ambiente evidentemente sacrale9. È interessante notare che gli animali presenti in questeprime figurazioni di età micenea sono uccelli: esseri cioè che collegano la terra al cielo e chevenivano logicamente intesi in varie culture – basti pensare agli etruschi e ai romani – comemessaggeri divini. Non è, allora, forse un caso che gli uccelli sulla pisside siano raffigurati insenso verticale anziché orizzontale, cioè in ascesa o in discesa.
Alle figure nere del VI secolo appartengono tre raffigurazioni attiche interessanti anche sedubbie. La prima è una lekythos panciuta delle prime figure nere degli inizi del VI secolo a Hei-delberg con un suonatore di lira fra sirene (Fig. 2), considerata l’ottima conservazione certoproveniente da una tomba. Nella ben documentata lettura di questo vaso si mette giustamentein evidenza il legame, attestato a partire da Omero, delle sirene con la musica e nel contempocon la sfera funeraria10. Anche qui, allora, come già sulla pisside micenea, il musico è in gradodi trascendere i limiti mortali.
15MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
9 TZEDAKIS 1970, 111 s.: periodo tardo-minoico IIIB, cioè intorno al XII secolo a.C.10 GROPENGIESSER 1977.
Dossier
Fig. 1. [SOPRA]Pisside tardo-minoicada Chania (Creta) (daTZEDAKIS 1970, 111figg.1 e 2)Fig. 2. [A SINISTRA]Lekythos attica afigure nere.Heidelberg,Antikenmuseum desArchäologischenInstituts inv. 68/1(da GROPENGIESSER
1977, 602 fig. 28).
L’iscrizione “Xaire Orfeu”, cioè“salve Orfeo” su una oinochoe a figurenere degli anni intorno al 530 a.C. rin-venuta molto probabilmente in una ne-cropoli etrusca con un citareda inprocinto di salire su un podio11, se nonidentifica necessariamente la figura conOrfeo, dimostra però che a Orfeo si ri-chiamava chi si esibiva come musicista(Fig. 3): che cioè Orfeo era ben presentenel mondo mentale non solo del cera-mografo ateniese ma anche di coloroche, in Etruria, avevano acquistato labrocchetta per collocarla nella tomba diun caro defunto.
Sempre uccelli, come nelle immagini micenee, insieme a un cerbiatto – animale selvatico etipica preda inerme – sono gli animali in ascolto del suonatore di lira raffigurato molto som-mariamente su un piccolo piatto votivo a figure nere di fabbrica ateniese della fine del VI sec.a.C., oggi perduto e di provenienza ignota: unica e modestissima attestazione della presenza,nel mondo mentale, di un musicista d’eccezione12.
Nessuna di queste immagini racconta miti di Orfeo. Anzi, non sappiamo nemmeno se ilmusicista rappresentato è proprio Orfeo. Esse attestano però l’antichità dell’idea che la musicasia in grado di trascendere i limiti mortali. L’esistenza dell’eroe di nome Orfeo nell’immaginariocollettivo, attestata oltre che da Ibico dal fregio frammentario del tesoro dei Sicioni a Delfi conla nave degli Argonauti datato al decennio 570-560 a.C. e l’iscrizione ORFAS13, viene confer-mata dalla ceramografia al più tardi a partire dal 530 circa.
Immagini di Orfeo nel V sec. a.C.
La serie delle immagini vascolari attiche inizia verso il 480 a.C. L’ordine cronologicoanziché tematico è illuminante14 anche perché, nel periodo in questione, la datazione deivasi, seppure stilistica e quindi nei singoli casi talvolta discutibile, non può allontanarsi
molto da quella storica15.
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
16 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
11 GAREZOU 1994, 97 no. 176; GROPENGIESSER 1977, 606 fig. 30; LISSARRAGUE 1994, 271.12 GAREZOU 1994, 98 no. 191; LISSARRAGUE 1994, 270 s. e 290 fig. 1: potrebbe trattarsi anche di Apollo.13 GAREZOU 1994, 84 no. 6. Buona illustrazione: GROPENGIESSER 1977, 608 fig. 31.14 I numeri della lista sono quelli di GAREZOU 1994 con la rispettiva datazione, quelli con * o ° sono illustrati.
Quanto alla datazione dei pezzi con i dati ARV, si adottano quelle proposte da Zimmermann nell’articolo citato.Le sigle tematiche sono da leggere come segue: MdO: Morte di Orfeo, comprese le immagini abbreviate con unadonna tracia in corsa; Om: Orfeo musicista; TdO: Testa vaticinante di Orfeo. Le provenienze sono quelleindicate in LIMC. Quando il vaso è ben conservato si presume che provenisse da una tomba. Mancano i nri. 66e 67 di datazione discutibile, non verificabile.
15 BOARDMAN 1975, 210 s.
Fig. 3. Oinochoeattica a figurenere. Roma,Museo di VillaGiulia M 534 (daSCHOELLER 1969,tav. I.3).
32 Lekythos ariballica, Vaticano, Pittore di Brygos16: 480-470 MdO Sardegna? tomba?;65 (ARV 379, 156): Kylix, New York, Pittore di Brygos: 500-47517 MdO ?;55* Kylix, Adria, Pittore di Briseide: verso il 480 MdO Adria;33 Kylix, Cincinnati, Pittore del Louvre G 26518: 480-470 MdO ? tomba?;53 Kylix, Atene Acropoli, Pittore di Castelgiorgio19: verso il 480 MdO Acropoli;54* Kylix frammentaria, Heidelberg, cerchia del Pittore di Brygos: 490-475 MdO Etruria20;64* Lekythos, Stockholm, Pittore di Troilos: verso il 480 MdO tomba?;34° Stamnos, ex Basseggio, maniera del Pittore di Berlino: verso il 470? MdO ?;35* Stamnos, Basilea, Pittore della dokimasia: 470 MdO Vulci, tomba;36* Stamnos, Zurigo, Pittore della dokimasia: 470 MdO tomba?;39* Stamnos, Louvre, Hermonax: verso il 470 MdO tomba?;40 Anfora nolana, Oxford, Hermonax: 470-46021 MdO tomba?;38 Anfora nolana, Londra, Pittore di Oionokles22: 470-460 MdO Capua, tomba?;65 (ARV 551, 9): Cratere a colonnette, München, Pittore di Pan: intorno al 47023 MdO
tomba?;65 (ARV 642, 101): Lekythos, Palermo24 MdO Selinunte, tomba;65 (ARV 697, 19): Lekythos, Louvre, Pittore di Ikaros: 475-45025 MdO tomba?;30* Kylix a fondo bianco, Atene Acropoli, Pittore di Pistoxenos: 470-460 MdO Acropoli;41 Cratere a colonnette, Caltanissetta: 470-460 MdO Sicilia?;42 Anfora a collo (?), San Antonio (Tx): 470-460 MdO ?;37 Anfora a collo, Brooklyn, Pittore dei Niobidi26: 470-460 MdO Vulci, tomba?;28* Idria, Boston, Pittore dei Niobidi: verso il 460 MdO Foiano, tomba?;56* Cratere a calice frammentario, proprietà privata, Pittore di Blenheim: verso il 460
MdO ?;7* Pelike, Tartu, Pittore di Villa Giulia: verso il 460 Om Cerveteri, tomba?;22* Cratere a colonnette, Napoli, Pittore di Agrigento: verso il 460 Om Napoli, tomba?;29 Anfora con anse attorcigliate (non nolana), Vaticano, Pittore dell’idria di Berlino27 460-
450: MdO Vulci, tomba?;43* Cratere a colonnette, Ferrara, Pittore della Centauromachia di Firenze: 460-450 MdO
Spina, tomba;47° Stamnos, ex Braun, Gruppo di Polygnotos: verso il 450 (?) MdO Chiusi?;44* Anfora nolana, Napoli, Pittore di Napoli 3112: verso il 450 MdO Nola, tomba;45* Idria, Würzburg, manierista tardo: verso il 450 MdO Atene;
17MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
16 ZIMMERMANN 1980, 168 fig. 117 ZIMMERMANN 1980, 169 fig. 2.18 SCHMIDT 1973, 98-100, tav. 33.19 ZIMMERMANN 1980, 169 fig. 3.20 GAREZOU 1994, 87: un frammento attacca con uno nel museo di Villa Giulia.21 ZIMMERMANN 1980, 176 fig. 12.22 ZIMMERMANN 1980, 174 fig. 8.23 ZIMMERMANN 1980, 175 fig. 10.24 Datazione probabilmente come la seguente.25 ZIMMERMANN 1980, 175 fig. 9.26 ZIMMERMANN 1980, 179 fig. 14.27 ZIMMERMANN 1980, 180 fig. 16.
Dossier
52 Frammento forse di idria, Londra, “Earlier mannerist”28 MdO Mytilene;58* Skyphos frammentario, Boston, Pittore di Pantoxena: 450-425 MdO Pireo;8* Cratere a colonnette, Amburgo, Pittore di Napoli: verso il 450 Om Sicilia? tomba?;46 Lekythos, Boston, maniera del Pittore di Achille: 450-44029 MdO Sicilia? tomba?;48a* Anfora nolana, Louvre, Pittore della Phiale: 440-430 MdO Nola, tomba;48b* Anfora nolana, München, Pittore della Phiale: 440-430 MdO Italia meridionale, tomba?;48c* Anfora nolana, Basilea, Pittore della Phiale: 440-430 MdO ? tomba ?;23* Cratere a colonnette, Portland, Pittore di Tarquinia 707: verso il 430 Om tomba?;9* Cratere a colonnette, Berlino, Pittore di Orfeo: verso il 440 Om Gela, tomba?;26* Cratere a campana, New York, Pittore di Londra E 497: 440-430 Om tomba?;27 Cratere a calice (non a campana), Napoli, Pittore della Centauromachia del Louvre (?):
440-430 Om Paestum;10* Frammento di cratere a campana (?), Atene, Pittore della Centauromachia del Louvre:
440-430 Om Atene;11* Cratere a colonnette, Palermo, Pittore della Centauromachia del Louvre: verso il 430
Om tomba siciliana?;50 Cratere a campana, Harvard, Pittore di Curti: 440-43030 MdO tomba?;57* Idria, Princeton, Polygnotos: 450-420 MdO?;49* Oinochoe, Zurigo, Pittore di Shuvalov: verso il 430 MdO tomba?;12 Pelike, Londra, maniera del Pittore di Kleophon: verso il 430 Om?;24* Frammenti di cratere a campana, Corinto: verso il 430 Om Corinto;51* Lekythos panciuta, in commercio, maniera del Pittore di Marlay: verso il 430 MdO
tomba?;68* Idria, Basilea, Gruppo di Polygnotos: 440-430 TdO tomba?;25 Idria, Petit Palais, Pittore di Tarquinia 707: verso il 43031 Om tomba?;69 Idria, Dunedin, Pittore della testa di Orfeo: verso il 42032 TdO Attica, tomba?;13* Cratere a campana, Corinto: verso il 420 Om Corinto, tomba?;31 Kylix frammentaria, San Simeon: verso il 420 MdO Spina, tomba;14* Cratere a colonnette, Madrid: 425-400 Om Villaricos, tomba?;70 Kylix, Cambridge, Pittore di Ruvo 1346: verso il 41033 TdO Napoli, tomba?;59* Kylix, Jena, associato al Pittore di Jena: verso il 400 MdO Atene?;15* Cratere a calice, Atene: inizi del IV sec. Om Beozia, tomba?
Il primo gruppo di sei immagini è dedicato tutto all’uccisione di Orfeo da parte delledonne tracie. I supporti sono una lekythos e cinque kylikes, tutte del decennio 480-470 a.C. opoco prima, del Pittore di Brygos o della sua cerchia stilistica. Fra le provenienze è documentatasia la Grecia che l’Italia etrusca. I contesti sono vari: necropoli, un santuario (Acropoli), pro-babilmente un abitato (Adria). Il medaglione di coppa del Pittore di Briseide 55 mostra i pro-
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
18 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
28 Datazione non agli inizi del V secolo (GAREZOU 1994, 87), ma al secondo venticinquennio, cfr. ARV 562.29 ZIMMERMANN 1980, 180 fig. 17.30 LISSARRAGUE 1994, 305 fig. 13b.31 LISSARRAGUE 1994, 275 e 295 fig. 6.32 QUEYREL 1992, 669 no. 99*.33 LAMBRINUDAKIS 1984, 290 no. 872*.
tagonisti nel mo-mento culminante deldramma (Fig. 4). Trat-tandosi di un fram-mento non sappiamose anche l’esterno eradecorato a figure e sequeste erano le donnetracie. Fra gli scheminoti dell’episodio èquesto il più anticoper cui ci si domandaquale altro motivopuò averlo ispirato. Sipenserebbe anzitutto aPenteo, anche lui barbaramente ucciso da uno stuolo di donne, la cui iconografia inizia circadue decenni prima34. Ma la documentazione disponibile non ne dà conferma. L’analogia piùprossima è invece con il gruppo di Eos e Tithonos, metafora della morte precoce e inattesa, lecui attestazioni più antiche risalgono allo stesso momento35: con la differenza non trascurabileche la figura femminile insegue per amore e a mani nude invece di aggredire armata.
Fra le attestazioni più antiche, attribuita come la lekythos al Pittore di Brygos, va annoverataanche la kylix a New York 6536 con nel medaglione una donna tracia armata di una lancia incorsa verso destra, uno dei molti estratti della scena della morte di Orfeo, a dimostrazione diquanto nota fosse la scena completa già in questa prima fase dell’iconografia e inoltre dell’im-portanza attribuita dai ceramografi alle antagoniste tracie di Orfeo. Figure femminili nei me-daglioni di coppe, requisiti simposiali, non sono nuove. Alle figure nere risalgono le figure disposa-matrona di fronte a Dioniso che, seppure escluse dal simposio nella realtà, alludevanoallo statuto di fondatore potenziale di un nuovo oikos dei partecipanti ed erano perciò presentia livello mentale37. Ma come spiegare la scelta dell’assassina tracia? Ce lo indica un altro me-daglione di coppa dello stesso ceramografo con donna in corsa verso destra armata dell’ascia:evidentemente Clitemnestra che si appresta ad uccidere Agamennone38. Sempre tenendo pre-sente il legame concettuale del simposio con le nozze nella prospettiva maschile, si tratta allorain entrambi i casi di prototipi di moglie negativi. La somiglianza fra queste due mogli funestenon è casuale se si pensa all’analogia, manifesta nell’iconografia, fra l’uccisione del musicoOrfeo e quella del musico Egisto39.
Sulla terza kylix, molto frammentaria 53, la scena centrale si trovava invece su uno dei duelati esterni. Era in ciò analoga all’esempio relativamente più recente di questa serie e, consideratal’ottima conservazione, proveniente anch’esso da una tomba etrusca 33. Orfeo è qui circondato
19MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
34 BAZANT, BERGER-DOER 1994, 312 no. 39.35 WEISS 1986, 765 no. 136.36 ZIMMERMANN 1980, 169 fig. 2.37 ISLER-KERÉNYI 1999a, 554 s.38 Beazley Addenda 226 (378. 129).39 SCHMIDT 1973, 96 s.; sull’analogia iconografica fra Orfeo e Egisto: MORET 1975, 202.
Dossier
Fig. 4. Kylix atticaa figure rosse.Adria, MuseoNazionale B 496(da GAREZOU
1994, Orpheus55).
da molte donne tracie che lo assalgono armate di strumenti speciali a indicare la loro apparte-nenza a un mondo fuori dalla polis: lance, blocchi rocciosi, un’ascia, una falce, un martello40.Anzichè la scena culminante, come parrebbe logico, il medaglione mostra due donne tracieche, anch’esse armate e in un paesaggio roccioso, stanno dirigendosi verso sinistra in sostegnodelle compagne. L’acconciatura definisce tutte queste donne come non più giovanissime: ciòcorrisponde alla tradizione mitologica per la quale a uccidere Orfeo erano state le mogli deiTraci. La falce messa in evidenza sia nel medaglione sia al centro del lato B allude evidente-mente, come si evince dal confronto con l’iconografia di Perseo che decapita la Gorgone, alladecapitazione imminente di Orfeo41.
A questo primo gruppo si può aggiungere la lekythos del Pittore di Troilos 64, prossimo alPittore di Berlino e contemporaneo del Pittore di Brygos, il cui Orfeo in fuga assomiglia aquello ormai soccombente dello stamnos di Basilea 35.
Al secondo venticinquennio del V secolo è da ascrivere il gruppo di ventitré immagini,numericamente quello più importante. Può fare da ponte con il gruppo precedente il Pittoredella Dokimasia che, dopo aver iniziato la sua carriera decorando kylikes prossime a quelledel Pittore di Brygos, si perfeziona nel campo dei grandi vasi operando nella sua fase maturasulla scìa del Pittore di Berlino42. In quell’ambito troviamo non meno di quattro stamnoicon la stessa scena43. Il primo, con Orfeo tutto vestito come nel medaglione di coppa delPittore di Briseide già trattata, è prossimo all’opera tarda del Pittore di Berlino 3444. Fannoseguito gli stamnoi a Basilea 35 e a Zurigo 36 del Pittore della Dokimasia e quello di Her-monax 39, altro continuatore del Pittore di Berlino, al Louvre45. Di poco più recente parelo stamnos del Gruppo di Polygnotos 47. Ad eccezione della prima occorrenza Orfeo è pre-sentato inerme e vulnerabile, con l’himation aperto, o completamente nudo: la sua situazionedisperata di fronte alla crudeltà sfrenata delle donne si manifesta anche nella posizione ormaiinginocchiata46.
Trovare fra i supporti del soggetto della morte di Orfeo tanti stamnoi – cinque sui ventitrévasi della fase che va fino al 450 a.C. – è notevole se si tien conto del fatto che lo stamnos è untipo di vaso fra i più ricercati e probabilmente più costosi nella produzione a figure rosse delCeramico di Atene, paragonabile ai crateri a volute e a calice47. Nel suo repertorio sono infattirelativamente frequenti immagini uniche o particolarmente impegnative. Sulla sua funzionesappiamo che veniva usato, in Grecia come in Etruria, sia ritualmente in cerimonie dionisiachedomestiche, sia come urna: la nostra lista sembra darne conferma. Era poi, più di altri conte-nitori, connotato in senso anche femminile48: la morte atroce di Orfeo ad opera di donne in-vasate può essere servita da exemplum deterrente.
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
20 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
40 Cfr. le riflessioni di LISSARRAGUE 1994, 278-282, sulle armi insolite delle donne tracie.41 JONES ROCCOS 1994. Così anche LISSARRAGUE 1994, 280.42 ISLER-KERÉNYI 1977, 59 e 64; BOARDMAN 1975, 137.43 A questi sono da aggiungere uno stamnos del Pittore di Berlino con l’uccisione di Egisto nello schema di quella
di Orfeo (VERMEULE 1966, tav. 8) e, un ventennio dopo, lo stamnos del Gruppo di Polygnotos 47.44 Illustrazione parziale, più fedele per lo stile: SCHOELLER 1969, tav. 21.2.45 ZIMMERMANN 1980, 170 fig. 11 a-c.46 Cfr. MORET 1975, 127-132.47 ISLER-KERÉNYI 2009, 82 s.48 ISLER-KERÉNYI 2000, 126 s.
Il fatto di trovare lo stessosoggetto due volte e sullostesso supporto pregiato nel-l’opera dello stesso ceramo-grafo è un indizio notevoledella sua importanza. Duesono gli elementi tradizionali,presenti già nelle kylikes delPittore di Brygos e della suacerchia: l’ambiente roccioso,vale a dire selvatico, in cui sisvolge il dramma e il fatto chead affrontare Orfeo è unostuolo, una collettività didonne simile alle antagonistedi Penteo e alle menadi49. Darilevare il modo particolare incui il Pittore della Dokimasiatratta l’uccisione. Orfeo nonviene semplicemente colpito o trafitto: la donna che gli sta più vicina ne ha afferrato il capo egli punta la spada alla gola. In analogia al falcetto delle immagini sulle kylikes, e presente anchesu 34, tale gesto potrebbe accennare, più che a un rito perverso di immolazione, alla decapita-zione imminente dell’eroe50: come nella prima fase, l’idea di una testa di Orfeo senza corpo è,allora, implicitamente presente.
Sono poi illuminanti le modifiche dall’una all’altra versione. Con la premessa che lo stamnosa Basilea 35, più arcaizzante, precede cronologicamente quello a Zurigo 36, la cui composizioneè più monumentale e trasparente51, si constatano tre cambiamenti (Fig. 5). Le donne – alcunescapigliate, altre con l’acconciatura tipica delle mogli – presentano tatuaggi più appariscenti euna di loro indossa il tipico manto variopinto dei Traci: il ceramografo sottolinea con ciò chele assassine di Orfeo sono tracie. Orfeo stesso porta i capelli lunghi, è cioè più giovanile, e,fatto unico in tutta la sua iconografia, presenta il viso frontalmente: un modo per sottolinearnela morte imminente52. E infine, negli stamnoi più recenti, la lira, l’attributo che gli garantisce,dopo la morte, la fama, cioè una forma di immortalità, è messa in assai maggiore evidenza53.La versione di Hermonax 39 si distingue da quelle del Pittore della Dokimasia nel collocare lafigura di Orfeo in posizione più centrale e più delineata: la sua antagonista principale gli premeil piede sulla coscia, un gesto non comune che sottolinea la situazione senza scampo del perdentericorrente talvolta in raffigurazioni della gigantomachia di Dioniso della cerchia del Pittore deiNiobidi54.
21MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
49 LISSARRAGUE 1994, 286: i ceramografi intendevano però sottolineare la differenza fra la morte di Orfeo e quelladi Penteo.
50 Cfr. le varianti nella maniera di uccidere castigando presentate da VERMEULE 1966, tav. 5-7.51 ISLER-KERÉNYI 1977, 64.52 FRONTISI-DUCROUX 1995, 82.53 SCHMIDT 1973, 96.54 GASPARRI 1986, Dionysos 621, 639 e 640; VIAN 1988, Gigantes 375.
Dossier
Fig. 5. Stamnosattico a figurerosse. Zurigo,ArchäologischeSammlung derUniversität 3477(foto del museo,ringraziamovivamente ElenaMango).
Un altro gruppo di immagini, meno impegnative, di Orfeo o di donne tracie si trova suanfore nolane a partire da Hermonax (40, 38, 44) e su lekythoi (65), una tradizione che continuanel terzo venticinquennio con 46 e con il Pittore della Phiale (48 a-c): trattandosi di vasi didestinazione chiaramente funeraria la scelta del motivo come allusione alla morte violenta einaspettata non sorprende. Nell’opera degli stessi pittori corrisponde infatti all’episodio di Eosche insegue Kephalos o Tithonos.
La morte di Orfeo sui frammenti di una pregiatissima kylix del Pittore di Pistoxenos è degnadi nota non solo perché porta il nome dell’eroe, ma soprattutto per il luogo di rinvenimento,l’acropoli di Atene. Di provenienza ateniese sono anche, oltre la kylix 53 già trattata della primafase, l’idria di Würzburg 45 e i frammenti di cratere a campana 10 dall’Agorà e di skyphos dalPireo 58, di poco più recenti: la figura di Orfeo aveva evidentemente rilievo non solo per laclientela etrusca e magnogreca degli stamnoi e delle anfore nolane, ma anche per quella attica.
Poche e piuttosto tarde sono invece le anfore di dimensioni normali 37, 29, 42, la cui ico-nografia si ritrova su alcune idrie che precedono di poco il 450 a.C. (28, 45). La prima è delPittore dei Niobidi, contemporaneo più giovane di Hermonax55. La scena assomiglia a quellasullo stamnos di Hermonax, ma alle estremità viene incorniciata da giovani spettatori traci:quello a sinistra con il tipico copricapo, quello a destra con il manto ricamato. Anche qui as-sistiamo al momento culminante del dramma in cui Orfeo cerca di difendersi con la lira56. Lamorte di Orfeo nello schema abituale si trova inoltre su un’idria di qualità scadente e datazioneproblematica a Würzburg 45, mentre quella di buon livello 57, purtroppo frammentaria, at-tribuita a Poygnotos, “allievo” del Pittore dei Niobidi, presenta un particolare degno di nota:il copricapo tracio di Orfeo e l’abbigliamento esotico – con persino scudi a mezzaluna, comequelli delle Amazzoni – delle sue assassine.
I supporti caratteristici della seconda metà del secolo, con dieci esempi su ventisei, sono icrateri a colonnette e a campana, affini per livello artistico, funzione e iconografia. L’iconografiadominante di questi due tipi di vaso è, con infiniti komoi e thiasoi con e senza Dioniso, nonchérimandi all’atletica e alla guerra, molto generica. Le scene mitologiche, a parte qualche amaz-zonomachia, alcune gesta di Eracle e di Teseo o inseguimenti amorosi di Eos, sono invece lar-gamente minoritarie. Tanto più notevole è la presenza non trascurabile di Orfeo. Ma ancor piùsorprende il fatto che, all’iconografia ormai nota e ricorrente su supporti diversi, viene ad ag-giungersi una scena del tutto nuova e originale: quella di Orfeo musicista incantatore di Traci.Una sola attestazione di Orfeo musicista precede cronologicamente i crateri, una pelike del Pit-tore di Villa Giulia con Orfeo musicista di fronte a un unico ascoltatore tracio 7.
In questo gruppo Orfeo si presenta quasi sempre come efebo greco, anzi enfaticamentegreco, in contrapposizione con i suoi ascoltatori vestiti alla tracia. Fa eccezione il cratere 22dove indossa il tipico mantello tracio combinato però non con il relativo copricapo, bensì conun cappello da viaggio greco. Quanto alla corona del musicista, essa è normalmente di alloroe lo riferisce con ciò ad Apollo57. Orfeo è, fra gli eroi, ciò che Apollo è fra gli dei: non solo mu-sicista, ma cantore, cioè poeta. Il suono della lira accompagna il canto, non lo sostituisce comel’aulos: lo si vede bene sul celebre cratere di Berlino 9, dove Orfeo è rappresentato con il visoispirato e la bocca aperta.
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
22 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
55 Per una visione completa: SCHOELLER 1969 tav. 21.3. Sul motivo dell’afferrare per i capelli: MORET 1975, 202.56 Di livello, schema e datazione prossima a questa idria sono i frammenti di un cratere a calice 56.57 GAREZOU 1994, 99. Ma può essere anche di edera (9) o di mirto (7).
L’antichissima idea che l’incanto della musica si eserciti non solo sugli uomini ma anchesugli animali si manifesta su un unico cratere 8, quello ad Amburgo, in cui ad avvicinarsi èuna tartaruga (Fig. 6). Che sia proprio una tartaruga a rappresentare il mondo animale si spiegaprobabilmente con la sua sorte tragica, riferita dal ben noto inno omerico a Hermes che rac-conta l’invenzione della lira: la stessa che diventerà l’attributo di Apollo e in seguito del figlioOrfeo58. A questi precedenti oscuri della lira del nostro eroe accennano alcune versioni dellasua morte in cui la cassa di risonanza della lira è un guscio di tartaruga (55, 28, 56)59. La tar-taruga accanto a Orfeo musicista può, allora, aver alluso alla loro sorte comune: di assassinatiche sopravvivono nella musica60. L’allusione alla morte di Orfeo viene sottolineata dalla pietraaccanto alla tartaruga: con pietre tenta talvolta l’eroe di difendersi dalle donne tracie (59, 63)61.
Nemmeno in queste immagini c’è un rimando alcuno alla sposa di Orfeo. Quando ad ascol-tarlo c’è un satiro (22, 23, 24) serve anch’esso a sottolineare che la scena si svolge nella naturaselvatica. Con ciò vi si introduce un elemento esplicitamente dionisiaco, particolarmente adattoal cratere a colonnette che è, come nella seconda metà del V secolo anche quello a campana,una delle forme più correnti di vasi da simposio comunitari. Nella prospettiva della funzionedei supporti è comprensibile lo slittamento di Orfeo da figura tragica su vasi a destinazioneprevalentemente funeraria a musicista irresistibile su vasi di destinazione simposiale. Questecategorie vanno però applicate con discernimento: crateri a colonnette venivano infatti, proprioin Sicilia, da dove provengono tre dei nostri, usati anche – o dopo l’utilizzo simposiale – comeurna62. Per cui le immagini di simposio o di musica possono anche essere state lette in senso
23MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
58 LISSARRAGUE 1994, 273. L’invenzione della lira e la meraviglia dei satiri erano anche un soggetto di drammasatiresco: KRUMEICH, PECHSTEIN, SEIDENSTICKER 1999, 280-312; VOELKE 2001, 127 s.
59 Il motivo si ritrova su alcuni mosaici di età imperiale fra il II e IV sec.: GAREZOU 1994, Orpheus 94, 106, 110.60 Questa allusione scompare naturalmente laddove, come in ambito apulo, Orfeo suona la cetra.61 GAREZOU 1994, Orpheus 59 e 63. Cfr. il commento a p. 100; LISSARRAGUE 1994, 273.62 DE CESARE 2007.
Dossier
Fig. 6. Cratere acolonnette atticoa figure rosse.Hamburg,Museum fürKunst undGewerbe1968.79 (daGAREZOU 1994,Orpheus 8).
metaforico come augurio o speranza di un dopo-morte felice: in tal senso sembra, d’altronde,siano state adottate dai ceramografi apuli.
L’intensa concentrazione sulla musica è normalmente pacifica: nulla, se non, velatamente,l’unica tartaruga, prelude alla morte di Orfeo63. A considerare con attenzione la serie di imma-gini in cui compaiono satiri ci si domanda però se lo svolgimento tragico della situazione fosseinevitabile. A innescare il dubbio sono due crateri e un’idria. In quello a campana 26 l’ascol-tatore tracio di Orfeo si è messo a discutere con una donna non caratterizzata come tracia che,mentre gesticola con la destra, regge nella sinistra la falce che già conosciamo. Questa non sista avvicinando con furia irrazionale, ma sembra in attesa con un piede poggiato su un rialzodel terreno64. Il cratere a colonnette 23 fa invece parte del gruppo in cui all’ascoltatore tracioviene ad accompagnarsi un satiro65. Questo si trova, anche lui gesticolante con la sinistra, allespalle di Orfeo cui si avvicina, insieme al suo cavallo, un Trace. Questa scena diventa interessantese messa accanto a quella di un’idria di poco più recente 25 dove, subito dietro al satiro vediamoavvicinarsi, ma con passo tranquillo e braccio proteso come per attirare l’attenzione, una donnaarmata di un grande pestello come quello di due delle donne tracie che aggrediscono Orfeosullo stamnos a Basilea. Dietro all’ascoltatore tracio sta, in tranquilla attesa, un’altra donna conuna lancia, anch’essa in chitone corto66, ma senza connotazioni esotiche (Fig. 7). In conside-razione del ruolo di mediatori e conciliatori attribuito in età classica ai satiri sia dai ceramografi,sia dagli autori di drammi satireschi67, si può dubitare del fatto che l’esibizione di Orfeo dovessenecessariamente risolversi tragicamente e immaginare invece che, come in certi drammi satire-schi, l’intercessione di satiri potesse condurre a uno svolgimento felice68. Non è comunqueescluso che il dramma su Orfeo di Aristias, un contemporaneo più giovane di Eschilo apprez-zato soprattutto per i suoi drammi satireschi, appartenesse a quest’ultimo genere69.
La scelta dell’idria come supporto di una scena originale non è un caso isolato. Troviamoinfatti il supporto idria, ma combinato con il motivo assai raro della testa vaticinante di Orfeo,in altri due casi (68, 69) databili intorno al 430 a.C. (Fig. 8)70. La combinazione non è casuale.Il repertorio figurativo dell’idria, anzi della sua variante che chiamiamo kalpis, è, a partire dallametà del V secolo, sempre più connotato in senso femminile71. Non vi sono rare le figurazionidi Muse che, nell’immaginazione mitologica, sono il prototipo della donna colta. A entrambile scene menzionate con la testa vaticinante di Orfeo assistono infatti Muse, con un ruolo e un
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
24 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
63 In questo, dai crateri a colonnette e a campana se ne distingue uno a calice con decorazione a due fregi 27, dovealla scena musicale della fascia superiore, quella principale, viene contrapposta la minacciosa adunata delle donnenella fascia inferiore: SCHOELLER 1969, tav. 15.4.
64 Lato B: Scena anonima con giovane appoggiato a un bastone in conversazione con una donna e un barbato. Ailati, sotto l’attacco dei manici, donna seduta sul terreno.
65 Cfr. MORET 1975, 24 n. 1: versione satiresca della scena del canto?66 Come quella, raffigurata in corsa e armata di una bipenne, al centro del registro inferiore del cratere a calice 27:
SCHOELLER 1969, tav. 15.4.67 ISLER-KERÉNYI 2004, 61.68 KRUMEICH, PECHSTEIN, SEIDENSTICKER 1999, 36: “ So präsentiert das Satyrspiel….die Heldinnen und Helden
der Tragödie, demonstriert jedoch anhand ihres Schicksals nicht die tragische Gefährdung der menschlichenExistenz, sondern suggeriert die erfolgreiche Bewältigung aller Probleme”.
69 ROSSI 1995, 240; PRESSLER 1996, col. 1102; KRUMEICH, PECHSTEIN, SEIDENSTICKER 1999, 213 e 223;LISSARRAGUE 1994, 275.
70 Sulla lekythos GAREZOU 1994, 88 no. 66 e l’idria no. 67, di datazione problematica, la testa di Orfeo pare esserein mano a una donna tracia.
71 SCHMIDT 2005, 263 s.
atteggiamento che le contrappone in modo vistoso alle feroci donne tracie. La combinazionedella testa di Orfeo con le Muse è significativa: nella mentalità greca sono infatti le Muse a ga-rantire la veridicità del poeta. La verità è, allora, l’elemento che la poesia ha in comune conl’oracolo, il messaggio di Apollo.
Le immagini di Orfeo tendono, dopo il 420 a.C. a rarefarsi drasticamente. Poco dopo leidrie menzionate va datata la coppa a Cambridge 70 con lo stesso soggetto alla presenza diApollo72 e una novità rilevante per l’iconografia di Orfeo nel IV secolo a.C.: il motivo dellascrittura73. Il tema della morte di Orfeo torna negli ultimi decenni del secolo su altre due kylikes31, 59. Agli inizi del IV secolo, sul cratere a calice 15 proveniente dalla Beozia con l’ultimaimmagine nota di Orfeo musicista della ceramografia attica, l’eroe indossa ormai il costumeorientale.
25MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
72 Probabilmente Muse sul lato B, cfr. ARV 1401,1: “B, woman with lyre, and woman”.73 Cfr. CALAME 2005. Tema approfondito in C. Isler-Kerényi, Orpheus und die Buchrolle, in V. Dill - C. Walde
(Hrsgg.), Antike Mythen. Medien, Transformationen und Konstruktionen, Berlin-New York 2009, 453-468.
Dossier
Fig. 7. [SOPRA]Idria attica afigure rosse.Parigi, Petit Palais319 (daLISSARRAGUE 1994,295 fig. 6).Fig. 8. [A SINISTRA]Idria attica afigure rosse.Dunedin (N.Z.),Otago Museum E48.266 (daQUEYREL 1992,Mousai 99).
Cosa dicono le immagini di Orfeo della ceramica di Atene? Va anzitutto sottolineato, dopol’assenza quasi totale nelle figure nere e nelle prime figure rosse, l’interesse numericamente no-tevole per Orfeo a confronto con altri eroi castigati da donne dionisiache come Penteo e Li-curgo, ma anche con altri musici sfortunati come Tamiri, Lino e Egisto, dal 480 a.C. in poi.Le attestazioni si addensano marcatamente durante il secondo venticinquennio del secolo e in-cludono, come abbiamo visto, anche Atene. La scelta, nella mitologia di Orfeo, della sua morteviolenta cui fa seguito, almeno mentalmente, la raccapricciante decapitazione, non è casuale.In questi stessi decenni abbondano, nel repertorio dei ceramografi, soprattutto di quelli dicoppe, episodi simili: dai duelli dell’Iliade alla presa di Troia, dalle Amazzonomachie alle Cen-tauromachie. A favorire una visione tragica dell’età degli eroi può essere stata la situazione sto-rica: con appena scongiurata la minaccia persiana ma vivi nel ricordo i traumi delle battaglie edelle distruzioni fin nel cuore della città. La stessa atmosfera tragica domina nei frontoni deltempio di Zeus a Olimpia a differenza di quelli del Partenone, progettati intorno al 450 a.C.in uno spirito assai più ottimista per quanto drammatici siano gli eventi rappresentati. Pare al-lora sintomatica, poco prima del 460, anche la menzione della sorte sfortunata di Orfeo nelleBassaridi di Eschilo74: un indizio importante dell’attualità della figura e della sua sorte tragicaa prescindere dalla questione insolubile, e nemmeno tanto importante, di una possibile dipen-denza dell’iconografia dalla realtà scenica.
Ma si può forse andare oltre per spiegare l’attualità proprio di Orfeo sia a teatro, sia nell’artefigurativa nel secondo venticinquennio del V secolo. È noto che, nell’intento di respingere laminaccia persiana, Atene andava espandendo la propria influenza verso il nord dell’Egeo, fracui le sponde tracie dove si era creata una situazione nuova con il ritiro delle forze achemenidinel 479 a.C.75. Conosciamo d’altronde la tendenza degli Ateniesi a incorporare nella propriamitologia figure appartenenti a zone politicamente interessanti. Nel mondo mentale dei Grecila Tracia era sì barbara, ma anche vicina: non tanto o non solo antitetica al proprio mondo,ma piuttosto la materializzazione di una fase del divenire culturale superata, ma precedente dipoco la propria76. Lo scontro di Orfeo, che per i ceramografi attici del V secolo non era tracioma un tipico efebo greco, con donne selvagge che si comportano come quelle castigate da Dio-niso e la sua vittoria postuma nel segno della poesia e della musica potrebbero essere stati unmodo, tipico di una cultura ancora permeata del pensiero mitologico, di articolare una tensionepresente a livello culturale e politico e, nello stesso momento, di glorificare il proprio sistema77.
Non è, allora, un caso che, dopo il 450 a.C., raggiunta la pace con i Persiani e una treguacon gli antagonisti ellenici, assumesse altri connotati anche la vicina Tracia78. Si spiegherebbecosì perché l’interesse dei ceramografi andasse chiaramente spostandosi dalla morte di Orfeoall’idillio musicale con Orfeo incantatore di Traci. Verso la fine del secolo, con il generale ri-piegamento sul privato dopo la sconfitta della polis, alle allusioni di sapore politico va sosti-tuendosi, anche nel caso di Orfeo, una lettura del mito in chiave privata ed escatologica79:
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
26 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
74 GAREZOU 1994, 82.75 BREDOW 2002, 479.76 ISLER-KERÉNYI 1999b, 43.77 Già Dörig aveva osservato la frequenza in aumento di tematiche tracie nell’arte ateniese: BÄBLER 1998, 188.78 BÄBLER 1998, 183: „In der zweiten Hälfte des 5. Jhs. waren die Beziehungen zwischen Thrakien und Athen sehr
eng geworden“. Ipotesi espressa anche da GRAF 1987, 87.79 PAUL-ZINSERLING 1994, 10.
emerge così il motivo della testa vaticinante e della scrittura. Alla luce della situazione generalesi capisce poi che gli elementi tipicamente traci dell’immagine di Orfeo tendano a scomparireper far posto a un quadro genericamente orientale ed esotico, cioè altro80. Quadro che diventerà,come vedremo, la regola nel repertorio apulo, dove ad ascoltare Orfeo saranno, assai più spessodei Traci, gli inquilini dell’Ade.
Si pone invece il problema dell’assenza della sposa di Orfeo nel repertorio vascolare attico81,tanto più sorprendente se si tien conto della sua presenza nel celebre rilievo, copia di un origi-nale attico degli anni successivi al Partenone che, probabilmente insieme ad altri tre, facevaparte ad Atene di un monumento sconosciuto82. Il denominatore comune dei rilievi, tutti contre figure, era, così pare, il passaggio dalla vita alla morte che sottintende un possibile e deside-rato passaggio inverso, dalla morte alla vita83: come resta vuoto il calderone magico di Medeadal quale Pelia, ucciso dalle figlie, avrebbe dovuto riemergere ringiovanito, come Eracle riac-compagna sulla terra Teseo ma abbandona Piritoo nell’Ade, così Hermes prende per mano lasposa di Orfeo per ricondurla agli Inferi dopo che ne era stata liberata dall’eroe84. Nella cera-mografia i decenni fra il 430 e il 410 sono quelli in cui tornano tutti e tre i motivi – la mortedi Orfeo, Orfeo musico e la testa vaticinante di Orfeo – che ricordano tutti la fine tragica del-l’eroe ma, implicitamente, anche la sua immortalità particolare di poeta, di musico, di vocedella verità. Il messaggio dei ceramografi sarebbe, allora, antitetico rispetto a quello dello scul-tore che, con l’addio definitivo dei coniugi, mette invece in scena il fallire di Orfeo85.
Meritano qualche riflessione le provenienze. Come sappiamo, di tutti i vasi greci noti co-nosciamo la provenienza di meno della metà: nel caso dei vasi con raffigurazioni di Orfeo, consolo venticinque provenienze mancanti sui cinquantotto vasi attici elencati, la relazione è su-periore alla media. Ben rappresentate sono, per i crateri a colonnette, Sicilia e Magna Grecia,ma anche Spina e la Grecia (in due casi Corinto) per quelli a campana. Quanto agli stamnoi, èormai notoria la forte prevalenza dei siti etruschi o campani86, come di quelli campani per leanfore nolane87. Le kylikes e le idrie sembrano invece distribuite in modo più uniforme. Pos-siamo, allora, affermare con certezza che la vicenda di Orfeo era nota e apprezzata senza prefe-renze particolari in tutta l’area interessata dal commercio attico: egli era sentito come un eroegreco, simbolo di civiltà e di arte immortale, collocato al limite rischioso con un fuori – o unoltre – selvaggio.
Dal 480 a.C. in poi, al più tardi, era nota di Orfeo – e sottintesa anche in immagini paci-fiche – la morte tragica e la particolare forma di immortalità come testa vaticinante: e con ciòl’affinità con Apollo. Un accenno a Dioniso si manifesta al più nel fatto che le sue assassine sicomportano con lui come le menadi con Penteo e nella presenza probabilmente benefica di
27MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
80 MORET 1975, 154 e 156 nota 8.81 La denominazione Euridice resta ancora nel IV secolo dubbia: FONTANNAZ 2008, 50 s.82 BOARDMAN 1985, fig. 239: intorno al 420-410. SCHWARZ 1988, 99: intorno al 410 a.C.; ROLLEY 1999, 159
fig. 142: 430-420. Questa attestazione di Orfeo manca in GAREZOU 1994.83 ISLER-KERÉNYI 2000, 130.84 Resta enigmatica la scena con Eracle fra due Esperidi, seduto davanti al famoso albero.85 Ma l’esito tragico del viaggio infero di Orfeo, cioè la perdita definitiva della sposa, resta controversa: FONTANNAZ
2008, 50.86 ISLER-KERÉNYI 2009.87 MARTELLI 2006.
Dossier
satiri fra i suoi ascoltatori88. Ma non emerge traccia alcuna del suo ruolo di profeta bacchicoattribuitogli in base a graffiti frammentari del tardo V secolo a.C. trovati a Olbia sul MarNero89.
Il IV sec. a.C.: Orfeo in Magna Grecia
La ceramografia apula manifesta preferenze tematiche diverse anche se la continuitàesteriore con la tradizione attica è innegabile: lo attestano soprattutto le raffigurazionidella morte di Orfeo90. Molto più evidente che nella ceramografia attica è qui la somiglianza
con la morte di Penteo91 e con ciò la valenza dionisiaca dell’episodio. Le attestazioni note sonotutte datate agli inizi del IV secolo, e con ciò prossime alla serie attica, e cessano presto diinteressare i ceramografi apuli e i loro committenti.
L’altra scena che deriva dalla tradizione attica è quella di Orfeo circondato da ascoltatoriesotici92. Con l’unica eccezione del cratere a campana da Anagni del 430-420 a.C.93, Orfeonon è più un efebo greco, ma un cantore orientale fra orientali94. La scena non si svolge allimite critico fra mondo civile e selvatico ma in un paesaggio genericamente altro. La presenzadi Afrodite e Eros, di Muse, di Nike indica che l’atmosfera di felicità evocata dalla musica èquella di un’esistenza diversa e superiore a quella abituale.
In un caso, oltre a due orientali e a due Muse, ad ascoltare Orfeo è anche, in primo piano,un cerbiatto95: uno dei pochi rimandi all’Orfeo incantatore di animali tanto popolare nella pit-tura, nell’arte musiva e in altri generi artistici di età imperiale e tardo-antica. Come la tartarugapuò essere stata il riflesso metaforico del destino unico di Orfeo (8) – l’immortalità poetica emusicale oltre la morte violenta – così il cerbiatto, già incontrato sul piatto a figure nere96, nericorda il ruolo di vittima inerme. Sintomatica, comunque, la persistenza dell’antichissima ideadelle facoltà sovrumane della musica.
Le immagini apule più note di Orfeo sono quelle che, in uno schema del tutto estraneoalle tradizioni attiche, ce lo mostrano mentre, suonando la cetra, si avvicina danzando, nor-malmente da sinistra, alla dimora dei regnanti dell’Ade, come sui crateri a volute a Karlsruhe,Napoli e Monaco97. In un unico caso, al massimo due su sei, è presente anche la sposa98 a ri-mandare esplicitamente al mito relativo. Per i ceramografi Orfeo equivale sostanzialmente ad
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
28 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
88 Così anche LISSARRAGUE 1994, 285: “Jamais Dionysos, dans la série attique, n’est montré en rapport direct avecOrphée”.
89 GRAF 1982, 166 s.; CALAME 2002, 389.90 GAREZOU 1994, 87 nri. 60-63.91 Cfr. GAREZOU 1994, Orpheus 63 con BAZANT, BERGER-DOER 1994, 308 nri. 6 e 7; MORET 1975, 114 sul
passaggio dall’iconografia attica a quella italiota “…au thème de la passion du héros se substitue celui de la rési-stance”.
92 GAREZOU 1994, 84 nri. 16, 17, 18.93 GAREZOU 1994, 84 no. 16.94 MORET 1975, 154 e 156 nota 8.95 GAREZOU 1994, 84 no. 17.96 GAREZOU 1994, 98 no. 191.97 GAREZOU 1994, 88 nri. 72, 73, 74.98 GAREZOU 1994, 88 no. 80. Forse anche 83: PENSA 1977, 25.
altri eroi entrati e usciti vivi dall’Ade, come Eracle e Teseo99. Ai decoratori dei lussuosi crateria volute apuli con scene d’Oltretomba e ai loro committenti nell’entroterra anellenico di Ta-ranto interessava anzitutto darne un quadro complessivo e generico100.
Di grande importanza è la raffigurazione frammentaria, nota da poco, della separazione de-finitiva di Orfeo dalla sposa alle porte dell’Ade su un’idria proto-lucana degli anni intorno al400 a.C. Essa avrà un peso rilevante in discussioni future non solo perché precede chiaramentela serie menzionata dei crateri apuli, ma anche perchè proviene non da un contesto sepolcrale,ma da un santuario di divinità femminili della chora di Taranto: dal che la particolarità cheprotagonista della scena è non Orfeo ma la sua sposa101.
Con le immagini apule menzionate si pone il problema della particolare identità di Orfeocome fondatore di una corrente o setta religiosa la cui esistenza è attestata al più tardi da Erodotoma di cui l’antichistica moderna, in base alla connessione impropria di questi crateri apuli conle famose laminette auree rinvenute tutte in altre zone102, tende a sopravalutare l’entità103. Nes-suna di queste laminette nomina infatti Orfeo104. Dall’iconografia vascolare emerge chiaramenteche anche ad Atene erano le vicende terrene dell’eroe e della sua testa a interessare i ceramografi:mentre non vi è traccia della sposa, il motivo del suo viaggio nell’Ade. In Apulia non sono vi-ceversa poche le scene d’Oltretomba senza Orfeo105. L’argomento finora più forte per identi-ficare l’Orfeo delle scene d’Oltretomba con l’eroe fondatore di una particolare corrente religiosaè la nota anfora del Pittore di Ganimede a Basilea dove è raffigurata l’epifania di Orfeo all’in-terno dell’edicola tombale di un defunto barbato e munito di un rotolo106: emerge anche nel-l’iconografia apula il problema, che andrà chiarito in altra sede, della scrittura in relazione aOrfeo107.
Conclusioni
Aconclusione di questa rapida panoramica delle attestazioni ceramografiche di Orfeo neconstatiamo anzitutto la grande popolarità durante tutto il V secolo a.C. Ma, sia inGrecia, sia nella Magna Grecia e in Etruria, è, oltre all’attualità storica, il tipo del
supporto e la sua destinazione a condizionare la scelta dell’episodio all’interno di una vicendamitologica108. Il mito, infatti, che tutti conoscono, non ha bisogno di essere raccontato. Lo siusa invece per esprimere riflessioni, esperienze, speranze legate alle occasioni in cui il supportodell’immagine entra in funzione. Così si spiegano sia la preponderanza di immagini della
29MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
99 Ciò che interessava in epoca classica era il ritorno dall’Ade di Orfeo, non la sorte di Euridice: FONTANNAZ 2008,50: “…les textes de l’époque classique qui évoquent brièvement une catabase d’Orphée à la recherche de sonépouse ne s’intéressent pas à l’issue de l’entreprise”.
100 PENSA 1977, 86 s.101 FONTANNAZ 2008.102 PENSA 1977, 81.103 Così anche FONTANNAZ 2008, 60 s.104 PENSA 1977, 81; SCHLESIER 2001, 167. Per una critica di fondo si veda CALAME 2002.105 PENSA 1977, 23-31.106 GAREZOU 1994, 90 no. 88.107 CALAME 2005, 42 s. Vd. sopra la nota 73.108 Come conferma in modo lampante, per l’ambito magnogreco, l’idria di Saturo: FONTANNAZ 2008, 70.
Dossier
morte tragica di Orfeo rispetto alla sua causa, l’incanto della poesia e della musica, sia la scarsitàdi allusioni al suo amore per Euridice: ma chissà come cambierebbe il panorama iconograficose disponessimo dei tessuti creati dalle donne greche? L’uso mirato del mito e dei personaggimitologici spiega le divergenze sia fra l’iconografia vascolare attica del V sec. a.C. e quella apuladel IV, sia fra le tradizioni classiche e quelle di età imperiale romana. Nonostante risulti perlunghi tratti oscurata dalla sua morte tragica, l’immagine più longeva e influente che di Orfeotrasmette l’iconografia vascolare greca è quella che lo identifica con l’incanto sovrumano dellamusica e con la verità della poesia.
Cornelia Isler KerényiRankstrasse [email protected]
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
30 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
BÄBLER 1998B. Bäbler, Fleissige Thrakerinnen und wehrhafte Skythen.Nichtgriechen im klassischen Athen und ihre archäolo-gische Hinterlassenschaft, Stuttgart-Leipzig 1998.
BAZANT - BERGER-DOER 1994J. Bazant, G. Berger-Doer, s.v. “Pentheus”, LIMCVII.1, 1986, 306-317.
BLEGEN 1956C.W. Blegen, The Palace of Nestor. Excavations of1955, AJA 60 (1956), 95-101.
BOARDMAN 1975J. Boardman, Athenian Red Figure Vases. The ArchaicPeriod, London 1975.
BOARDMAN 1985J. Boardman, Greek Sculpture. The Classical Period,London 1985.
BREDOW 2002I. v. Bredow, s.v. “Thrakes”, DNP 12.1, 2002, col.478-484.
BURKERT 2005W. Burkert, La teogonia originale di Orfeo secondo ilPapiro di Derveni, in G. Guidorizzi - M. Melotti (acura di), Orfeo e le sue metamorfosi. Mito, arte, poesia,Roma 2005, 46-64.
CALAME 2002C. Calame, Qu’est-ce qui est orphique dans les Orphica?Une mise au point introductive, in RHR, 219-5 (2002),385-400.
CALAME 2005C. Calame, Pratiche orfiche della scrittura: itinerari
iniziatici?, in G. Guidorizzi - M. Melotti (a cura di),Orfeo e le sue metamorfosi. Mito, arte, poesia, Roma2005, 28-45.
DE CESARE 2007M. de Cesare, Crateri-cinerari figurati in Sicilia: imma-gini, rito e credenze religiose, in Sicilia Antiqua 4(2007), 9-31.
FONTANNAZ 2008D. Fontannaz, L’entre-deux-mondes. Orphée et Eurydicesur une hydrie proto-italiote du sanctuaire de la sourceà Saturo, in Antike Kunst 51 (2008), 41-72.
FRONTISI-DUCROUX 1995F. Frontisi-Ducroux, Du masque au visage. Aspects del’identité en Grèce ancienne, Paris 1995.
GAREZOU 1994M.-X. Garezou, s.v. “Orpheus”, LIMC VII.1, 1994,81-105.
GASPARRI 1986C. Gasparri, s.v. “Dionysos”, LIMC III.1, 1986, 414-514.
GRAF 1982F. Graf, Nachwort, in Orpheus. Altgriechische Mysterien,übertragen und erläutert von J. O. PASSMANN,Köln 1982, 161-175.
GRAF 1987F. Graf, Orpheus: A Poet Among Men, in J. Bremmer(Ed.), Interpretations of Greek Mythology,, London &Sydney 1987, 80-106.
GROPENGIESSER 1977H. Gropengiesser, Sänger und Sirenen. Versuch einer
Bibliografia
31MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
Dossier
Deutung, in Archäologischer Anzeiger (1977.4), 582-610.
ISLER-KERÉNYI 1977C. Isler-Kerényi, Stamnoi, Lugano 1977.
ISLER-KERÉNYI 1990C. Isler-Kerényi, Lexicon iconographicum mythologiaeclassicae, in Journal of Roman Archaeology, 3 (1990),205-210.
ISLER-KERÉNYI 1999aC. Isler-Kerényi, Frauen um Dionysos vom 7. Jahrhun-dert bis um 540 v. Chr., in Archäologischer Anzeiger(1999.4), 553-566.
ISLER-KERÉNYI 1999bC. Isler-Kerényi, Dionysos, la Thrace, la Mer Noire,in Pontica 32 (1999), 39-49.
ISLER-KERÉNYI 2000C. Isler-Kerényi, Immagini di Medea, in B. Gentili -F. Perusino (a cura di), Medea nella letteratura enell’arte, Venezia 2000, 117-138.
ISLER-KERÉNYI 2004C. Isler-Kerényi, Civilizing Violence. Satyrs on 6th-Century Greek Vases, Fribourg-Göttingen 2004.
ISLER-KERÉNYI 2009C. Isler-Kerényi, Retour au stamnos attique: quelquesréflexions sur l’usage et le répertoire, in Metis 7, 75-89.
JONES ROCCOS 1994L. Jones Roccos, s.v. “Perseus”, LIMC VII.1, 1994,332-348.
KRUMEICH - PECHSTEIN - SEIDENSTICKER 1999R. Krumeich - N. Pechstein - B. Seidensticker, Dasgriechische Satyrspiel, Darmstadt 1999.
LAMBRINUDAKIS 1984W. Lambrinudakis, s.v. “Apollon”, LIMC II.1, 1984,183-327.
LISSARRAGUE 1994F. Lissarrague, Orphée mis à mort, in Musica e Storia2 (1994), 269-307.
MARTELLI 2006M. Martelli, Arete ed Eusebeia: le anfore attiche nellenecropoli dell’Etruria campana, in F. Giudice e R. Pan-vini (a cura di) Il greco, il barbaro e la ceramica attica.Immaginario del diverso, processi di scambio e auto-rappresentazione degli indigeni III, Roma 2006, 7-37.
MORET 1975J.-M. Moret, L’Ilioupersis dans la céramique italiote.Les mythes et leurs expression figurée au IVe siècle.Institut suisse de Rome1975.
PAUL-ZINSERLING 1994V. Paul-Zinserling, Der Jena-Maler und sein Kreis.
Zur Ikonologie einer attischen Schalenwerkstatt um 400v. Chr., Mainz 1994.
PENSA 1977M. Pensa, Rappresentazioni dell’Oltretomba nella cera-mica apula. Studia archeologica 18, Roma 1977.
PRESSLER 1996F. Pressler, s.v. “Aristias”, DNP I, 1996, col. 1102.
QUEYREL 1992A. Queyrel, s.v. “Mousa, Mousai”, LIMC VI.I, 1992,657-681.
ROLLEY 1999C. Rolley, La sculpture grecque II, Paris 1999.
ROSSI 1995L.E. Rossi, Letteratura greca, Firenze 1995.
SCHLESIER 2001R. Schlesier, Dionysos in der Unterwelt. Zu den Jen-seitskonstruktionen der bakchischen Mysterien, in R.von den Hoff und S. Schmidt (Hrsgg.), Konstruktionenvon Wirklichkeit. Bilder im Griechenland des 5. und4. Jahrhunderts v. Chr., Stuttgart 2001, 157-172.
SCHMIDT 1973M. Schmidt, Der Tod des Orpheus in Vasendarstellungenaus Schweizer Sammlungen, in H.P. Isler - G. Seiterle(Hrsgg.) Zur griechischen Kunst. 9. Beiheft zu AntikeKunst, Bern 1973, 95-105.
SCHMIDT 2005S. Schmidt, Rhetorische Bilder auf attischen Vasen.Visuelle Kommunikation im 5. Jahrhundert v. Chr.,Berlin 2004.
SCHOELLER 1969F.M. Schoeller, Darstellungen des Orpheus in der Antike,Freiburg 1969.
SCHWARZ 1988G. Schwarz, s.v. “Eurydike I”, LIMC IV.1, 1988, 98-100.
THIMME 1976J. Thimme, Kunst und Kultur der Kykladeninseln im3. Jahrtausend v. Chr., Badisches Landesmuseum Kar-lsruhe 1976.
TZEDAKIS 1970G. Tzedakis, Minoïkos kitharodos, in AAA 3 (1970),111-112.
VERMEULE 1966E. Vermeule, The Boston Oresteia Krater, in AJA 70(1966), 1-22.
VIAN 1988F. Vian, s.v. “Gigantes”, LIMC IV.1, 1988, 191-270.
VOELKE 2001P. Voelke, Un théatre de la marge. Aspects figuratifs et
Cornelia Isler-Kerényi, Orfeo nella ceramografia greca
32 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009, 13-32
configurationnels du drame satyrique dans l’Athènesclassique, Bari 2001.
WEISS 1986C. Weiss, s.v. “Eos”, LIMC III.1, 1986, 747-789.
ZIMMERMANN 1980K. Zimmermann, Tätowierte Thrakerinnen auf grie-chischen Vasenbildern, in JDAI 95, (1980), 163-196.
AbbreviazioniBeazley Addenda: Beazley Addenda. Additional Refe-rences to ABV, ARV2 & Paralipomena. Second Editioncompiled by T. H. Carpenter, Oxford 1989.ARV: J. D. Beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters2,Oxford1963.DNP: Der Neue Pauly, Stuttgart-Weimar.LIMC: Lexicon Iconographicum Mythologicum Mytho-logiae Classicae, Zürich-Düsseldorf.
205MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009
Gli autori
Angela BelliaÈ dottore di ricerca in Musicologia e Beni musicali pressol’Università di Bologna, ha svolto attività di studio e diricerca presso l’Archäologisches Institut di Zurigo nel-l’ambito del Programma Marco Polo per la formazioneall’estero dei giovani ricercatori dell’Università di Bologna.Il suo principale interesse di ricerca verte sull’iconografiadella musica antica e, in particolare, sulla coroplasticacon raffigurazioni musicali in Sicilia, in Magna Grecia enel Mediterraneo di età greca, e sulla relazione tra musicae rito nel mondo antico. Si occupa inoltre dello studiodegli strumenti musicali e degli oggetti sonori in Siciliae nell’Italia meridionale (IX-III sec. a.C.). È vincitrice delPremio di studio “Giuseppe Nenci” istituito dalla ScuolaNormale Superiore di Pisa per la migliore tesi di dottoratodedicata a problematiche storico-archeologiche dellaSicilia (2007). Fra le sue pubblicazioni: Immagini dellamusica ad Akragas (2003), Gli strumenti musicali neireperti del Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”di Palermo (2009), Coroplastica con raffigurazioni musicalinella Sicilia greca (2009). Attualmente insegna Iconografiadella Musica antica presso l’Università di Palermo.
Laurent BricaultÈ professore di Storia Romana all’Université de Toulouseed è autore di opere relative ai culti isiaci: Atlas de ladiffusion des cultes isiaques, Paris 2001; Recueil desInscriptions concernant les Cultes Isiaques (hors d’Égypte),Paris 2005; Sylloge Nummorum Religionis Isiacae etSarapiacae, Paris 2008. È fondatore della collana “Biblio-theca Isiaca”, Ausonius Bordeaux, e organizzatore ecuratore dei convegni internazionali sui culti isiaci. Gliatti del IV convegno, dal titolo L’Egypte en Egypte, sarannopubblicati nel corso del 2010.
Emanuela CalcaterraÈ dottoranda in Tradizioni e Istituzioni religiose di ambientecircum-mediterraneo: Storia, Letteratura, Diritto pressol’Università degli Studi di Messina. Ha pubblicato, per laMiscellanea di Studi Storici dell’Università della Calabriaun articolo dal titolo “Per cena alle divinità”. Note sulculto privato di Ecate nella Grecia Antica ed è coautrice– con il Prof. Sergio Ribichini – di un contributo su AnnaPerenna in corso di pubblicazione.
Eleonora CavalliniÈ professore ordinario di Lingua e Letteratura Grecapresso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali del-l’Università di Bologna. Si è occupata soprattutto di liricagreca, ma ha trattato anche alcuni aspetti della storia,della filosofia e del diritto di età ellenistico-romana.Attualmente si dedica allo studio della storia dellamitologia classica, con particolare riferimento alla per-sistenza di temi mitologici nella civiltà moderna e con-temporanea. Tra le sue pubblicazioni: Saffo. Frammenti,Parma 1986; Luciano. Questioni d’amore, con introduzionedi Enzo Degani Venezia 1991; Ibico. Nel Giardino delleVergini, Lecce 1997; Il fiore del desiderio. Afrodite e ilsuo corteggio fra mito e letteratura, Lecce 2000. Direcente, ha curato l’edizione del volume miscellaneoOmero mediatico. Aspetti della ricezione omerica nellaciviltà contemporanea, comprendente il suo saggio CesarePavese e la ricerca di Omero perduto: dai Dialoghi conLeucò alla traduzione dell’Iliade, Bologna 2007. È respon-sabile della collana “Nemo: confrontarsi con l’antico”.
Giorgio CamassaÈ professore ordinario di Storia greca presso la Facoltàdi Lettere e Filosofia dell’Università di Udine. Si è inte-ressato della vita politico-religiosa e in genere dellacultura del mondo greco. Tra le sue ultime pubblicazioni:La lontananza dei Greci, Roma 2004; La Sibilla giudaicadi Alessandria. Ricerche di storia delle religioni, Firenze2005; Atene. La costruzione della democrazia, Roma2007; Forme della vita politica dei Greci in età arcaicae classica, Bologna 2008. Insieme con altri autori hacurato Idea e realtà del viaggio. Il viaggio nel mondoantico, Genova 1991; Paesaggi di potere. Problemi eprospettive, Roma 2000. Ha collaborato, fra l’altro, a IGreci e alla Storia d’Europa (Einaudi); nella Storia delMezzogiorno è apparso un suo saggio sui culti dellepoleis magno-greche. Fa parte del Comitato Scientificodi tre riviste: «Hesperìa», «Mythos», «Seminari Romanidi Cultura Greca». Inoltre, è uno dei membri del ComitatoScientifico Internazionale di «èstoria».
Monica de CesareÈ professore associato di Archeologia classica presso ilDipartimento di Beni Culturali della Facoltà di Lettere
206 MYTHOS • NUMERO 3, n.s. • 2009
dell’Università di Palermo. Ha condotto ricerche di archeo-logia e storia dell’arte greca, con particolare riguardo aproblematiche di pittura vascolare; ricerche archeologichee topografiche in Magna Grecia e Sicilia (Hipponion,Entella, Segesta); ricerche di storia dell’archeologiaclassica (aspetti della ricerca archeologica e del colle-zionismo in Magna Grecia e Sicilia tra Ottocento e Nove-cento). Ha pubblicato due volumi del Corpus VasorumAntiquorum (Vibo Valentia 1, 1991; Agrigento 2, 2005)ed una monografia dal titolo Le statue in immagine.Studi sulle raffigurazioni di statue nella pittura vascolaregreca, Roma 1997. Tra le sue ultime pubblicazioni Cera-mica figurata e mercenariato in Sicilia, in Atti delle quinteGiornate Internazionali di Studi sull’area elima (2006) eCrateri-cinerari figurati in Sicilia: immagini, rito e credenzereligiose, in Sicilia antiqua (2007).
Cornelia Isler-KerényiHa insegnato in diverse Università in Svizzera e in Italiae partecipato a campagne di scavo in Sicilia e in Grecia.Il suo campo principale di ricerca è l’interpretazionedelle testimonianze figurative nell’arte antica e la loroconnessione con il mondo religioso. Ha recentementepubblicato Dionysos nella Grecia arcaica: il contributodelle immagini, Roma-Pisa 2001 (trad. ingl. 2007),Civilizing Violence, Fribourg-Göttingen 2004 sull’iconografiadei Satiri. È Dottore honoris causa dell’Università di Pécs(Ungheria) e membro corrispondente dell’Istituto archeo-logico germanico (DAI). Dal 1993 al 2007 è stata membrodella commissione UNESCO Svizzera impegnandosi controil traffico illecito di opere d’arte dell’antichità.
Enrico MontanariÈ professore ordinario di Storia delle Religioni all’UniversitàLa Sapienza di Roma. Collabora all’annuale SeminarioInternazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma”e per le riviste Storia, Antropologia e Scienze del Linguaggio,Storiografia, Historia Religionum. An International Journal,
Iura Orientalia, Diritto e Storia, etc. Dirige, per i tipi diBulzoni Editore, la collana Mos maiorum, di studi sullaTradizione romana. Filoni privilegiati di ricerca sono lostudio della religione romana arcaica e della misticacomparata. Tra i suoi saggi: Categorie e forme nella storiadelle religioni, Milano 2001; La fatica del cuore. Saggiosull’ascesi esicasta, Milano, 2003; E. Montanari, Fumosaeimagines. Identità e memoria nell’aristocrazia repubblicana,Roma 2009.
Francesca PrescendiÈ professore associato di Histoire des religions, Sciencesde l’Antiquité presso l’Université de Genève. Dopo glistudi di filologia classica e antropologia all’universitàdi Siena, ha conseguito un dottorato in latino all’Uni-versità di Freiburg i.B. e uno in storia delle religioniall’Università di Ginevra e all’École Pratique des HautesÉtudes de Paris. Di recente pubblicazione: Décrire etcomprendre le sacrifice. Les réflexions des Romainssur leur propre religion à partir de la littérature anti-quaire, Stuttgart 2007 e insieme a Philippe Borgeaud,Religions antiques. Une introduction comparée, Genève2008. Il suo campo di ricerca comprende le religioniantiche (soprattutto quelle del mondo greco e romano)e la storia della disciplina.
Tilman SeebassDal 1977-1993 è stato professore presso la Duke University(Durham, NC USA) e fino al 2007 ordinario all‘Institutfür Musikwissenschaft dell’Università di Innsbruck. I suoiinteressi scientifici si concentrano sulla relazione tramusica e arti figurative, sull’Indonesia e su tematiche dicomparazione culturale. Le sue recenti pubblicazioni simuovono all’interno di questi ambiti. Al momento lavoraa un manuale di iconografia musicale e al catalogo deimanoscritti musicali precoloniali su foglie di palma aBali. È presidente della Società internazionale di musi-cologia.
Gli autori